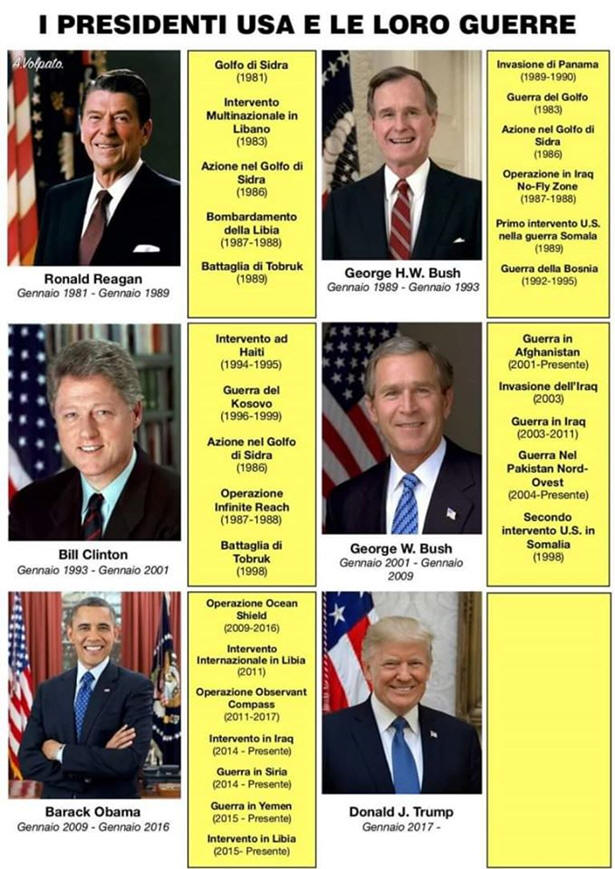Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Gli editori ed i distributori censori si avvalgono dell'accusa di plagio, per
cessare il rapporto. Plagio mai sollevato da alcuno in sede penale o civile, ma
tanto basta per loro per censurarmi.
I miei contenuti non sono propalazioni o convinzioni personali. Mi avvalgo solo
di fonti autorevoli e credibili, le quali sono doverosamente citate.
Io sono un sociologo storico: racconto la contemporaneità ad i posteri, senza
censura od omertà, per uso di critica o di discussione, per ricerca e studio
personale o a scopo culturale o didattico. A norma dell'art. 70, comma 1 della
Legge sul diritto d'autore: "Il riassunto, la citazione o la riproduzione di
brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se
effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali
fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica
dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica
l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non
commerciali."
L’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni
forma e modo (art. 12 comma 2 Legge sul Diritto d’Autore). La legge stessa però
fissa alcuni limiti al contenuto patrimoniale del diritto d’autore per esigenze
di pubblica informazione, di libera discussione delle idee, di diffusione della
cultura e di studio. Si tratta di limitazioni all’esercizio del diritto di
autore, giustificate da un interesse generale che prevale sull’interesse
personale dell’autore.
L'art. 10 della Convenzione di Unione di Berna (resa esecutiva con L. n. 399 del
1978) Atto di Parigi del 1971, ratificata o presa ad esempio dalla maggioranza
degli ordinamenti internazionali, prevede il diritto di citazione con le
seguenti regole: 1) Sono lecite le citazioni tratte da un'opera già resa
lecitamente accessibile al pubblico, nonché le citazioni di articoli di giornali
e riviste periodiche nella forma di rassegne di stampe, a condizione che dette
citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e nella misura giustificata
dallo scopo.
Ai sensi dell’art. 101 della legge 633/1941: La riproduzione di informazioni e
notizie è lecita purché non sia effettuata con l’impiego di atti contrari agli
usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte. Appare chiaro
in quest'ipotesi che oltre alla violazione del diritto d'autore è apprezzabile
un'ulteriore violazione e cioè quella della concorrenza (il cosiddetto
parassitismo giornalistico). Quindi in questo caso non si fa concorrenza
illecita al giornale e al testo ma anzi dà un valore aggiunto al brano originale
inserito in un contesto più ampio di discussione e di critica.
Ed ancora: "La libertà ex art. 70 comma I, legge sul diritto di autore, di
riassumere citare o anche riprodurre brani di opere, per scopi di critica,
discussione o insegnamento è ammessa e si giustifica se l'opera di critica o
didattica abbia finalità autonome e distinte da quelle dell'opera citata e
perciò i frammenti riprodotti non creino neppure una potenziale concorrenza con
i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore dell'opera
parzialmente riprodotta" (Cassazione Civile 07/03/1997 nr. 2089).
Per questi motivi Dichiaro di essere l’esclusivo autore del libro in oggetto e
di tutti i libri pubblicati sul mio portale e le opere citate ai sensi di legge
contengono l’autore e la fonte. Ai sensi di legge non ho bisogno di
autorizzazione alla pubblicazione essendo opere pubbliche.
Promuovo
in video tutto il territorio nazionale ingiustamente maltrattato e
censurato.
Ascolto e Consiglio le vittime discriminate ed inascoltate. Ogni giorno da
tutto il mondo sui miei siti istituzionali, sui miei blog d'informazione
personali e sui miei canali video sono seguito ed apprezzato da centinaia di
migliaia di navigatori web. Per quello che faccio, per quello che dico e per
quello che scrivo
i media mi censurano e le istituzioni mi perseguitano. Le letture e le
visioni delle mie opere sono gratuite. Anche l'uso è gratuito, basta indicare la
fonte.
Nessuno mi sovvenziona per le spese che sostengo e mi impediscono di lavorare
per potermi mantenere. Non vivo solo di aria:
Sostienimi o mi faranno cessare e vinceranno loro.
Dr Antonio Giangrande
NOTA BENE
NESSUN EDITORE VUOL PUBBLICARE I
MIEI LIBRI, COMPRESO AMAZON, LULU E STREETLIB
SOSTIENI UNA VOCE VERAMENTE LIBERA CHE
DELLA CRONACA, IN CONTRADDITTORIO, FA STORIA
NOTA BENE PER IL DIRITTO D'AUTORE
NOTA LEGALE: USO LEGITTIMO DI MATERIALE ALTRUI PER
IL CONTRADDITTORIO
LA SOMMA, CON CAUSALE SOSTEGNO, VA VERSATA CON:
-
accredito/bonifico al conto BancoPosta intestato a:
ANTONIO GIANGRANDE, VIA
MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA IBAN: IT15A0760115800000092096221 (CIN IT15A - ABI 07601
- CAB 15800 - c/c n. 000092096221)
-
versamento in bollettino postale sul
c.c. n. 92096221. intestato a:
ANTONIO GIANGRANDE, VIA
MANZONI, 51, 74020 AVETRANA TA
-
SCEGLI IL LIBRO
 PRESENTAZIONE SU
GOOGLE LIBRI
PRESENTAZIONE SU
GOOGLE LIBRI

 presidente@controtuttelemafie.it
presidente@controtuttelemafie.it
 Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta)
Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta) 3289163996
3289163996
 0999708396
0999708396
INCHIESTE VIDEO YOUTUBE:
CONTROTUTTELEMAFIE -
MALAGIUSTIZIA
-
TELEWEBITALIA
 FACEBOOK:
(personale)
ANTONIO GIANGRANDE
FACEBOOK:
(personale)
ANTONIO GIANGRANDE
(gruppi)
ASSOCIAZIONE CONTRO TUTTE LE MAFIE -
TELE WEB ITALIA -
ABOLIZIONE DEI CONCORSI TRUCCATI E LIBERALIZZAZIONE DELLE PROFESSIONI
(pagine)
GIANGRANDE
LIBRI
 WEB TV:
TELE WEB ITALIA
WEB TV:
TELE WEB ITALIA
 NEWS:
RASSEGNA STAMPA -
CONTROVOCE -
NOTIZIE VERE DAL POPOLO -
NOTIZIE SENZA CENSURA
NEWS:
RASSEGNA STAMPA -
CONTROVOCE -
NOTIZIE VERE DAL POPOLO -
NOTIZIE SENZA CENSURA
ANNO 2020
L’ACCOGLIENZA
SECONDA
PARTE
DI ANTONIO
GIANGRANDE

L’ITALIA
ALLO SPECCHIO
IL DNA
DEGLI ITALIANI
L’APOTEOSI
DI UN POPOLO DIFETTATO
Questo saggio è un aggiornamento temporale, pluritematico e
pluriterritoriale, riferito al 2019, consequenziale a quello del 2018. Gli
argomenti ed i territori trattati nei saggi periodici sono completati ed
approfonditi in centinaia di saggi analitici specificatamente dedicati e già
pubblicati negli stessi canali in forma Book o E-book, con raccolta di materiale
riferito al periodo antecedente. Opere oggetto di studio e fonti propedeutiche a
tesi di laurea ed inchieste giornalistiche.
Si troveranno delle recensioni deliranti e degradanti di
queste opere. Il mio intento non è soggiogare l'assenso parlando del nulla, ma
dimostrare che siamo un popolo difettato. In questo modo è ovvio che l'offeso si
ribelli con la denigrazione del palesato.
IL GOVERNO
UNA BALLATA PER L’ITALIA (di Antonio Giangrande).
L’ITALIA CHE
SIAMO.
UNA BALLATA
PER AVETRANA (di Antonio Giangrande). L’AVETRANA
CHE SIAMO.
PRESENTAZIONE DELL’AUTORE.
LA SOLITA
INVASIONE BARBARICA SABAUDA.
LA SOLITA
ITALIOPOLI.
SOLITA
LADRONIA.
SOLITO
GOVERNOPOLI. MALGOVERNO ESEMPIO DI MORALITA’.
SOLITA APPALTOPOLI.
SOLITA CONCORSOPOLI ED ESAMOPOLI. I CONCORSI ED ESAMI DI STATO
TRUCCATI.
ESAME DI AVVOCATO. LOBBY FORENSE, ABILITAZIONE TRUCCATA.
SOLITO SPRECOPOLI.
SOLITA SPECULOPOLI. L’ITALIA DELLE SPECULAZIONI.
L’AMMINISTRAZIONE
SOLITO DISSERVIZIOPOLI. LA DITTATURA DEI BUROCRATI.
SOLITA UGUAGLIANZIOPOLI.
IL COGLIONAVIRUS.
L’ACCOGLIENZA
SOLITA ITALIA RAZZISTA.
SOLITI PROFUGHI E FOIBE.
SOLITO PROFUGOPOLI. VITTIME E CARNEFICI.
GLI STATISTI
IL SOLITO
AFFAIRE ALDO MORO.
IL SOLITO GIULIO ANDREOTTI. IL DIVO RE.
SOLITA TANGENTOPOLI. DA CRAXI A BERLUSCONI. LE MANI SPORCHE DI
MANI PULITE.
SOLITO BERLUSCONI. L'ITALIANO PER ANTONOMASIA.
IL SOLITO
COMUNISTA BENITO MUSSOLINI.
I PARTITI
SOLITI 5
STELLE… CADENTI.
SOLITA LEGOPOLI. LA LEGA DA LEGARE.
SOLITI
COMUNISTI. CHI LI CONOSCE LI EVITA.
IL SOLITO
AMICO TERRORISTA.
1968
TRAGICA ILLUSIONE IDEOLOGICA.
LA GIUSTIZIA
SOLITO
STEFANO CUCCHI & COMPANY.
LA SOLITA SARAH SCAZZI. IL DELITTO DI AVETRANA.
LA SOLITA YARA GAMBIRASIO. IL DELITTO DI BREMBATE.
SOLITO DELITTO DI PERUGIA.
SOLITA ABUSOPOLI.
SOLITA MALAGIUSTIZIOPOLI.
SOLITA GIUSTIZIOPOLI.
SOLITA
MANETTOPOLI.
SOLITA
IMPUNITOPOLI. L’ITALIA DELL’IMPUNITA’.
I SOLITI
MISTERI ITALIANI.
BOLOGNA:
UNA STRAGE PARTIGIANA.
LA MAFIOSITA’
SOLITA
MAFIOPOLI.
SOLITE
MAFIE IN ITALIA.
SOLITA
MAFIA DELL’ANTIMAFIA.
SOLITO RIINA. LA COLPA DEI PADRI RICADE SUI FIGLI.
SOLITO CAPORALATO. IPOCRISIA E SPECULAZIONE.
LA SOLITA
USUROPOLI E FALLIMENTOPOLI.
SOLITA CASTOPOLI.
LA SOLITA MASSONERIOPOLI.
CONTRO
TUTTE LE MAFIE.
LA CULTURA ED I MEDIA
LA SCIENZA
E’ UN’OPINIONE.
SOLITO CONTROLLO E MANIPOLAZIONE MENTALE.
SOLITA SCUOLOPOLI ED IGNORANTOPOLI.
SOLITA CULTUROPOLI. DISCULTURA ED OSCURANTISMO.
SOLITO MEDIOPOLI. CENSURA, DISINFORMAZIONE, OMERTA'.
LO SPETTACOLO E LO SPORT
SOLITO SPETTACOLOPOLI.
SOLITO SANREMO.
SOLITO SPORTOPOLI. LO SPORT COL TRUCCO.
LA SOCIETA’
GLI ANNIVERSARI DEL 2019.
I MORTI FAMOSI.
ELISABETTA E LA CORTE DEGLI SCANDALI.
MEGLIO UN GIORNO DA LEONI O CENTO DA AGNELLI?
L’AMBIENTE
LA SOLITA AGROFRODOPOLI.
SOLITO ANIMALOPOLI.
IL SOLITO TERREMOTO E…
IL SOLITO AMBIENTOPOLI.
IL TERRITORIO
SOLITO TRENTINO ALTO ADIGE.
SOLITO FRIULI VENEZIA GIULIA.
SOLITA VENEZIA ED IL VENETO.
SOLITA MILANO E LA LOMBARDIA.
SOLITO TORINO ED IL PIEMONTE E LA VAL D’AOSTA.
SOLITA GENOVA E LA LIGURIA.
SOLITA BOLOGNA, PARMA ED EMILIA ROMAGNA.
SOLITA FIRENZE E LA TOSCANA.
SOLITA SIENA.
SOLITA SARDEGNA.
SOLITE MARCHE.
SOLITA PERUGIA E L’UMBRIA.
SOLITA ROMA ED IL LAZIO.
SOLITO ABRUZZO.
SOLITO MOLISE.
SOLITA NAPOLI E LA CAMPANIA.
SOLITA BARI.
SOLITA FOGGIA.
SOLITA TARANTO.
SOLITA BRINDISI.
SOLITA LECCE.
SOLITA POTENZA E LA BASILICATA.
SOLITA REGGIO E LA CALABRIA.
SOLITA PALERMO, MESSINA E LA SICILIA.
LE RELIGIONI
SOLITO GESU’ CONTRO MAOMETTO.
FEMMINE E LGBTI
SOLITO CHI COMANDA IL MONDO: FEMMINE E LGBTI.
L’ACCOGLIENZA
INDICE PRIMA PARTE
SOLITA ITALIA RAZZISTA. (Ho scritto un saggio dedicato)
Quei razzisti come Vittorio
Feltri.
Le oche starnazzanti.
La Questione Settentrionale.
Quelli che…ed io pago le tasse
per il Sud. E non è vero.
I Soliti Approfittatori Ladri
Padani.
Il Sud Sbancato.
La Televisione che attacca il
Sud.
INDICE SECONDA PARTE
SOLITA ITALIA RAZZISTA. (Ho scritto un saggio dedicato)
Tutti i “vizietti” dei maestri
degli antirazzisti.
Un mondo di confini spinati.
Quei razzisti come i Sammarinesi.
Quei razzisti come gli Svedesi.
Quei razzisti come i Norvegesi.
Quei razzisti come i Danesi.
Quei razzisti come i Tedeschi.
Quei razzisti come gli Spagnoli.
Quei razzisti come gli Svizzeri.
Quei razzisti come i Francesi.
Quei razzisti dei Paesi Bassi.
Quei razzisti come i Belgi.
Quei razzisti come gli Ungheresi.
Quei razzisti come i Rumeni.
Quei razzisti come i Kosovari.
Quei razzisti come i Greci.
Quei razzisti come i Giapponesi.
Quei razzisti come i Cinesi.
Quei razzisti come i Vietnamiti.
Quei razzisti come i Nord Coreani.
Quei razzisti come i Russi.
Quei razzisti come i venezuelani.
Quei razzisti come gli Argentini.
Quei razzisti come i Cubani.
Quei razzisti come gli Austriaci.
Quei razzisti come i Turchi.
Quei razzisti come gli
Israeliani.
Quei razzisti come i Libanesi.
Quei razzisti come gli Iraniani.
Quei razzisti come gli Arabi.
Quei razzisti come i Dubaiani.
Quei razzisti come i Qatarioti.
Quei razzisti come i Brasiliani.
Quei razzisti come gli Inglesi.
Quei razzisti come gli
Statunitensi.
Quei razzisti come gli
Australiani.
Quei razzisti come i Sudafricani.
INDICE TERZA PARTE
SOLITI PROFUGHI E FOIBE. (Ho scritto un saggio dedicato)
I Genocidi dimenticati: Gli zingari.
Srebrenica 1995, cronaca di un massacro.
Il genocidio silenzioso dei Dogon.
Shoah ed Antisemitismo.
Paragonare le foibe alla Shoah?
Il Giorno del Ricordo.
Gli Odiatori Responsabili: ora
Negazionisti e Giustificazionisti.
Non erano fascisti: erano D’Annunziani. Libertari, non libertini.
SOLITO PROFUGOPOLI. VITTIME E CARNEFICI. (Ho scritto un saggio
dedicato)
Immigrazione ed emigrazione.
Espatriati. In Fuga dall’Italia.
Il trattato di Dublino, spiegato.
La Sanatoria dell’Invasione.
Quelli che…lo Ius Soli.
La Cittadinanza col Trucco.
Il Soggiorno col trucco.
L’Africa pignorata.
La Tratta dei Profughi.
Porti Aperti.
Gli affari dell’accoglienza.
Morire di Accoglienza.
I famelici…
Lo Scuolabus dell’integrazione.
Quelli che…Porti Aperti.
Quelli…che Porti Chiusi.
Le “altre Lampedusa”.
Le Colpe in Libia.
Le colpe in Tunisia.
Le colpe in Algeria.
Le colpe in Siria.
L’ACCOGLIENZA
SECONDA PARTE
SOLITA ITALIA RAZZISTA. (Ho scritto un saggio dedicato)
·
Tutti i “vizietti”
dei maestri degli antirazzisti.
Vittorio Feltri su Indro Montanelli: "I teppisti che lo
attaccano tacciono sulla bimba di Maometto". Vittorio
Feltri su Libero Quotidiano il 20 giugno 2020. Non mi sorprende che la polemica
su Indro Montanelli non finisca più sui giornali e in televisione. Semmai
stupisce che sia iniziata ad opera di alcuni teppisti che hanno deturpato la
statua dedicata al grande giornalista. Cui si rimproverano fatti avvenuti circa
75 anni orsono. Vogliamo almeno dire che per dare il via alle accuse rivolte
allo scrittore principe i suoi nemici non sono stati molto tempestivi? Si sa da
sempre, per sua stessa ammissione, che Montanelli, ufficiale spedito in Africa,
ebbe laggiù un matrimonio con una ragazzina acquistata sul mercato delle spose,
secondo i costumi locali, dalla quale ebbe addirittura un figlio, il che
dimostra che lei, nonostante l'età, non era proprio una bambina, essendo già
pronta a concepire e a partorire. Intendiamoci, io, che nel Continente nero sono
stato una volta per lavoro e non ebbi tempo per distrazioni sessuali, non mi
sarei mai accoppiato con una fanciulla poiché ciò mi fa orrore. Ma non afferro
per quale motivo vari cretinetti si siano accorti soltanto ora che Indro ebbe
l'orrenda esperienza, benché egli ne avesse dato spontaneamente notizia allorché
era in vita. Il fatto è che processare i morti non è una operazione
apprezzabile, anche perché le salme non hanno facoltà di difendersi pertanto
chiunque le può impunemente insultare. Mi pare che su questo punto non ci sia da
discutere, i defunti vanno lasciati in pace, non sono in grado di reagire. E
invece assistiamo a una aggressione a Indro, violenta come gli attacchi che egli
ricevette allorché fondò e diresse per un ventennio il Giornale, il foglio più
anticonformista del secolo scorso, ostile alle mode ideologiche
dell'epoca, odiato dalla sinistra al punto che essa si accanì su Montanelli
dipingendolo come un orco. La musica cambiò quando questi lasciò la sua creatura
cartacea in contrasto con Silvio Berlusconi. All'improvviso i progressisti
adottarono Indro e lo trasformarono in una propria icona. Un brusco quanto
ridicolo cambiamento di rotta. Questa è storia. Adesso che il Cavaliere è
tramontato e Indro è stato sotterrato è ricominciato il bombardamento contro
l'illustre penna e il suo monumento. I bombardieri hanno rivangato il passato
remoto, attribuendo all'immenso cronista addirittura uno stupro che tale non fu.
Si trattò di un pessimo esercizio in voga (tuttora) in Africa, detestabile fin
che volete ma avvenuto in un contesto che non lo condannava. Tra l'altro nessuno
ricorda che Maometto a sua volta si unì a una bimba non ancora adolescente,
imitato poi dai suoi eredi islamici che nessuno deplora. Non è giusto
prendersela con uno e assolvere tutti gli altri.
Tutti i “vizietti” dei maestri degli antirazzisti.
Marco Gervasoni, 20 giugno 2020 su Nicolaporro.it. Difficile dire
guardandoli in volto, ma i primati che abbattono le statue in Usa e in Uk, e
quelli che le imbrattano in Italia, una cultura l’hanno. Certo, nel senso in cui
gli antropologi ne parlano quando studiano gli aborigeni o le popolazioni della
foresta amazzonica. Anche se, più che una cultura, la definirei una ideologia.
Essendo movimenti a pulsione nichilistica, l’ideologia vi assume un carattere
fondamentale – come ha insegnato Dostojevski, meno credi e più diventi fanatico
di una religione terrena e secolarizzata, appunto l’ideologia. E allora andiamo
a cercare da dove essa provenga Diversamente da quella comunista, nata dalle
lotte operaie e contadine, questa dei vari movimenti ispirati a Black lives
matter è un puro prodotto delle università e non ha alcun nesso con il mondo
reale – neppure quello delle comunità afroamericane. In Europa è una semplice
imitazione degli Usa – uno dei tanti fenomeni di americanizzazione – ma
l’ideologia dei campus americani a sua volta proviene dall’Europa, e
precisamente dalla Francia. È quella che viene chiamata French Theory e che
entrò nelle Università americane a partire dagli anni Settanta. I suoi autori
erano in larga parte francesi – Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jacques Derrida,
Jacques Lacan – e vennero a rinnovare un marxismo universitario esangue.
L’estrema sinistra se ne cibò subito anche se per somma ironia i maestri
filosofici della French Theory erano Nietzsche e Heidegger, due pensatori
solidamente di «destra». I campus americani hanno trasformato questa French
theory in una ideologia anti-occidentale: secondo loro tutta o quasi la cultura
europea e nord americane è da condannare in quanto figlia della dominazione
patriarcale, sessista, colonialista e razzista. La teoria francese è poi
ritornata in Europa, e anche nella stessa Francia, dove ha preso il nome di «indigenismo»
e «razzialismo», e gli atenei sono diventati luoghi di diffusione di questo
nuovo terrorismo «intellettuale». Anche se a ben vedere questi movimenti non
perseguono una politica ma solo moralismo ed è per questo che sfrogolano nella
vita privata dei personaggi storici di cui vogliono cancellare la memoria: nella
loro visione primitiva (da primate) il privato è politica. Ebbene, adottiamo per
un momento lo stesso schema e scorriamo in una serie di flash gli eroi dell’indigenismo
e del razzialismo «anti razzista» per vedere se essi rispettano i rigidi canoni
anti-patriarcali, anti-sessisti, anti-colonialisti, anti occidentali.
Cominciando da Marx. Anche se i BLM non sono marxisti perché Marx è troppo
difficile da leggere per loro, resta comunque una figurina del loro album. E qui
cominciamo male. Marx trattava più o meno da schiava la moglie, che pur adorava,
esercitava un controllo ferreo sulle figlie, possedeva insomma una mentalità
vittoriana, tranne che nei confronti della cameriera, ingravidata senza
riconoscere i figli. Mmmm, proviamo allora sul versante anti razzista e anti
colonialista. Anche qui non va bene. Marx era un grande sostenitore
del colonialismo e, come quasi tutti i marxisti dei decenni successivi, pensava
che il compito dei paesi europei fosse di civilizzare gli africani e gli
asiatici. Nelle sue cronache sulla guerra civile americana usò parole di fuoco
contro l’ipocrisia dei Nordisti. Teoria, si dirà. Ma quando la figlia portò a
casa il fidanzato, Paul Lafargue, poi uno dei più importanti marxisti francesi
di quel periodo, nato da famiglia creola a Cuba, quindi non certamente «nero»,
lo trattò freddamente e la sera scrisse una lettera al suo amico e sodale e
finanziatore Engels in cui fece capire di non apprezzare l’etnia del giovane;
anche se poi vi si affezionò – e comunque anche la coppia di sposini fu
mantenuta, come Marx, dal solito generoso Engels. Insomma, ci sarebbe materia
per una bella sverniciatura, di rosso ovvio, sulla tomba di Marx a Hyde Park. Ma
si dirà, l’Ottocento. Va bene e allora veniamo in tempi già recenti. Il teorico
della negritudine, Jean Paul Sartre, era stato vagamente neutrale nella Parigi
occupata dai nazisti, dove si rappresentavano regolarmente le sue opere
teatrali, tradiva ripetutamente la compagna, Simone De Beauvoir, anche con la
sorella di lei. Non risparmiava di raccontare a Simone le sue diverse conquiste,
che lei riportava sarcasticamente nel lettere agli amici: «siate fiero di
Sartre. Ha deciso che una Algerina neretta , una vera bionda e due false non
gli bastano, Cosa gli mancava? Una rossa. L’ha trovata» Un Don Giovanni però un
po’ freddo come amante ma soprattutto ossessionato dalla paura di essere
omosessuale, anzi un «pederasta» come scriveva lui stesso. Certo, dal nostro
punto di vista il dolo più grande di Sartre consiste nell’aver cercato di
spacciare i gulag per una menzogna borghese, ma certo per gli «anti razzisti»
non sarà un peccato, anche se nei gulag comunisti ci finirono anche gli
omosessuali e gli ebrei, cosi per dire. Invece un sodale di Sartre, lo psicologo
Frantz Fanon, francese martinico, diventò collaboratore del Fronte di
Liberazione dell’Algeria e dei suoi sanguinari attentati terroristici; ma
soprattutto, fu un grande sostenitore dell’Islam, non esattamente una religione
che predica la lotta al patriarcato. Così come islamico era Malcolm X, uno degli
eroi dei Blm: non era islamico invece Martin Luther King, in compenso, secondo i
rapporti della Cia, era ossessionato dal sesso, partecipava ad orge e il suo
tipo di approccio alle donne oggi non supererebbe la prova del Me too o, se
vogliamo stare in Italia, di Non una di meno – ma neanche quella del codice
penale per i reati di violenza sessuale. La stessa fascinazione per l’islam,
nelle sue forme radicali, colse il massimo pensatore della French Theory, Michel
Foucault, affascinato dalla rivoluzione islamica iraniana e dalla conseguente
rimessa in riga delle donne, che invece nell’Iran dello Scia potevano circolare
in mini gonna. Ma il vizietto del filosofo era ancora più grave, immaginiamo dal
punto di vista dei nostri indigenti all’amatriciana, e questa volta anche
nostro: teorizzava la pedofilia. Montanelli si è sposato con una ragazza etiope
di 14 anni, secondo le leggi e gli usi locali. Foucault, invece, nel 1977,
firmò una petizione rivolta al Parlamento francese in cui chiedeva di togliere
il limite d’età per i rapporti sessuali, e anche il sesso con una bambina (anzi,
dal suo punto di vista, con un bambino) di sei anni avrebbe dovuto essere
consentito: andava riconosciuto, come scriveva la petizione «il diritto del
bambino e dell’adolescente a intrattenere relazioni sessuali con persone a sua
scelta». Anche perché, come disse nel 1982 il leader del sessantotto francese, a
lungo eurodeputato verde, Daniel Cohn-Bendit in una trasmissione della tv
francese di grande successo (il video agghiacciante si può vedere ancora in
rete) «la sessualità di un bambino è fantastica». Dani il Rosso, che certo oggi
starà dalle parte degli indigenisdi, non firmò quella petizione, ma lo fecero,
tra gli altri, Roland Barthes, il grande teorico e critico letterario, un altro
dei maestri della French theory, Gilles Deleuze e il suo amico e co-autore Felix
Guattari, Jack Lang poi ministro della cultura di Mitterrand, Simone de Beauvoir
e Jean-Paul Sartre, (rieccoli) il nouveau philosophe André Glucksmann. Sempre
nel 1977, i medesimi pubblicarono su Le Monde una appello in difesa di tre
francesi condannati per aver avuto rapporti omosessuali con una ragazza di 13
anni. A 13 anni, scrivevano Foucault, Deleuze, Barthes, Guattari e gli
altri,«si è già di fatto una donna». Un anno in meno della sposa etiope di Montanelli.
Ma se sei Foucault, o magari Pasolini, cacciato dal Partito comunista friulano
per aver intrattenuto rapporti con i minori, almeno secondo l’accusa, te lo puoi
permettere, e anzi lo puoi teorizzare. Invece se to chiami Montanelli, devi
finire nella polvere. Marco Gervasoni, 20 giugno 2020
·
Un mondo di confini spinati.
Italiani Razzisti? Antonio Angelini
il 6 maggio 2020 su Il Giornale. Ospito per la seconda volta nel mio blog, un
fisico che lavora per lo Stato. In un settore particolare e che vuole mantenere
l’ anonimato. Si è occupato anche di immigrazione. Nel precedente incontro
abbiamo imparato una cosa importante: la Scienza, ovvero il metodo scientifico,
come ogni disciplina umana, non può darci risposte assolute ed univoche in ogni
campo, ma è in grado, in ogni settore delle attività umane, di dare importanti
indicazioni sulle scelte da fare e, aggiungiamo qui, è anche l’unico modo
corretto per poter fare delle scelte. Logica e deduzione. Ora cerchiamo di
rendere più chiaro in che modo la logica e la deduzione possono consentire al
cittadino comune di muoversi nel mare di notizie, contro notizie, informazioni e
tutto ed il contrario di tutto e cercare di astrarre da questo magma
“l’essenziale” in modo da farsi una idea più corretta di ciò che può esser
“vero” e ciò che non lo è certamente. Evitiamo di fare riferimento alle
indicazioni su come minimizzare l’impatto delle “fake news” sui social network
ovvero, ad esempio, utilizzare solo siti o fonti di informazione certificati;
diciamo che questo è dato per scontato. Tuttavia, come noto, anche da fonti
ufficiali noi siamo bombardati quotidianamente da pareri autorevoli che dicono
tutto ed il contrario di tutto, ad iniziare dalla politica, passando per
l’economia e persino in ambito scientifico. Pertanto qui ci troviamo in un
passaggio successivo in cui certamente le informazioni che vogliamo analizzare
non ci vengono da siti del tipo “complottisti.org” etc. ma da fonti ufficiali
(agenzie di stampa e telegiornali). Il processo logico deduttivo deve partire da
un presupposto non derogabile, ovvero chiarire il fatto, cioè stabilire con
certezza cosa sia avvenuto senza condizionamenti da parte di chi ha già
effettuato una sua analisi ed espresso una sua valutazione. Quando accertare i
fatti non è possibile, per qualsiasi ragione, occorre considerare in ogni caso
quel che viene rappresentato come un fatto e sulla base di esso iniziare il
processo logico deduttivo. Se il processo analitico sarà corretto, emergerà in
ogni caso che il “fatto” di riferimento fosse effettivamente quello oppure no,
perché non vi sarà alla fine un collegamento logico continuo, ovvero una
“coerenza” tra l’ipotesi e la tesi. Non è un caso che venga usato il termine
“processo” analitico avendo noi fatto riferimento ad argomenti forensi nel
precedente incontro; questo perché comprendere la dinamica di un evento di
qualunque genere è un passaggio logico di conseguenze, da un fatto ad un altro
fatto, che è esattamente quello che viene messo in pratica dai giudici e dalla
giuria (comuni cittadini) quando si deve decidere la responsabilità in un
processo penale. Ultima considerazione prima di entrare nel merito: è corretto
che il comune cittadino possa e debba farsi una propria idea su ciò che accade
intorno a noi senza condizionamenti esterni, ma è implicito che devono esistere
dei punti fermi dai quali non si può derogare, ovvero dei punti dove secoli di
storia, di conoscenza e di evidenze hanno ormai stabilito come “veri”. Elencare
tutti i punti fermi non è possibile ne in questa ne in altre sedi, ma per
evitare pericolose derive stabiliamo qui una volta per tutte che: la terra non è
piatta, è tonda e che le scie chimiche non esistono!
Quante volte negli ultimi anni abbiamo sentito dire “gli italiani
sono razzisti”? Si intende per razzismo la arbitraria persecuzione di intere
popolazioni sulla base di concetti astratti e senza ovviamente alcuna
giustificazione scientifica (a prescindere dal fatto che, come in tutte le
specie animali, la razza non discrimina in alcun modo un essere umano da un
altro). Nel nostro paese oramai si associa il termine razzismo alle leggi
razziali, vergognose, del 1938, come se nel mondo non esistesse altro che questo
e che la storia delle terribili persecuzioni nel mondo fosse tutta concentrata
in quella data.
Allora il quesito a cui vorremmo rispondere è: l’Italiano, o una
parte del popolo italiano, è razzista? Il dibattito politico degli ultimi tre
anni si è praticamente fossilizzato su questo tema per via dell’immigrazione
clandestina e per l’appartenenza o meno alla Unione Europea. Si tende
addirittura ad identificare i termini “sovranista” e “razzista” utilizzando
sillogismi e dati di varia natura. Il cittadino comune che ascolta il dibattito,
che sente elencare dati, numeri in un senso ed in un altro a chi deve credere?
Che idea si può fare sulla base di quanto viene quotidianamente detto da
esponenti politici ed organi istituzionali nazionali ed internazionali?
Proviamo in questo incontro a dar seguito a quanto detto
nell’incontro precedente, ovvero l’utilizzo del metodo scientifico, logica e
deduzione, per farci una idea su come effettivamente stanno le cose. Non
elencheremo dati su “indici” stimati da organizzazioni non governative o da
organizzazioni internazionali, perché tali dati vengono elaborati a monte e
forniti al pubblico successivamente, ed inoltre non tutti sono in grado di
accedere ad essi. Restiamo su un livello di informazione più basico, ovvero dati
storici. Intanto va ricordato che lo “schiavismo”, dopo l’impero Romano (ed in
quell’epoca schiavizzare i popoli vinti era prassi comune), nell’era moderna è
stato introdotto dapprima dal mondo arabo e successivamente dall’impero
ottomano. I primi a commerciare gli schiavi furono proprio questi due popoli, o
etnie, che per secoli schiavizzarono intere popolazioni di colore dell’africa
centrale. Ma qui siamo ad un livello di storia di molto antecedente a quello che
di fatto influenza ancora oggi il comune pensiero. Si è assunto che una parte
del popolo italiano è razzista per via delle vergognose leggi razziali stabilite
dal Fascismo nel 1938 e per via dell’Impero coloniale. E’ opinione comune che il
popolo italiano sia stato liberato da un giogo tirannico razzista, grazie
all’intervento di popoli liberi e democratici.
Ma questi popoli erano così liberi e democratici?
Tutti sanno chi è Rosa Park, e tutti sanno chi è Martin Luther
King. Senza entrare troppo nei dettagli è un fatto che in alcuni stati degli
U.S.A. leggi di segregazione razziale fossero ancora in vigore fino al 1970
(!!!).
L’India si rese indipendente dall’Inghilterra nel 1947. E in
India, ufficialmente fino al 1950, esisteva una segregazione in caste nella
popolazione.
L’Algeria si rese indipendente dalla Francia, dopo una sanguinosa
rivolta, inizialmente ferocemente repressa dall’esercito francese, nel 1962.
31 paesi membri dell’ONU non riconoscono, oggi, Israele come
stato sovrano per una ragione etnico religiosa, tra di essi paesi come l’Arabia
Saudita, gli Emirati Arabi, L’Algeria, il Marocco, l’Iran, la Tunisia etc.
Nel 1994 in Ruanda fu compiuto un massacro etnico che causò la
morte di quasi un milione di persone.
Tra il 1991 ed il 2001 nei paesi balcanici vi fu una feroce
guerra che causò genocidi etnici riconosciuti dall’ONU.
La Turchia perseguitò nel 1916, ed ancora oggi, anche se solo
politicamente, sia popolazioni armene che curde.
Se volessimo risalire più indietro nel tempo, indietro rispetto
ai giorni nostri, ma non tanto più indietro rispetto a quando nel 1938 furono
emanate le famigerate e vergognose leggi razziali in Italia, scopriremmo che
solo 50 anni prima del fascismo negli USA erano in vigore leggi che relegavano
in schiavitù (schiavitù…..altro che razzismo) popolazioni di origini africane.
Notoriamente ancora negli anni 50 (1950/1960) chi non ricorda quei bellissimi
film western in cui i “pellerossa” venivano descritti come dei selvaggi da
sconfiggere, mentre nel frattempo l’intera popolazione nativa americana viveva
in riserve, segregata, dopo essere stata massacrata dall’esercito degli USA, una
repubblica democratica, alla fine dell’800 (1876 l’uccisione del Generale Custer
nella “guerra” contro i Sioux…. Solo 46 anni prima del fascismo).
In Unione Sovietica negli anni 30 furono perseguitati non solo
opponenti politici, ma come noto cittadini di origine ebraica (non è un caso che
una importante quota di popolazione di Israele sia di origine Russa e, per
restare a citazioni accessibili a chiunque, persino nel favoloso film
“Schindler’s list” icona dell’olocausto, il soldato dell’Armata Rossa sconsiglia
il gruppo di sopravvissuti appena liberati dal lager, di andare ad est, dove non
sarebbero stati benvoluti…citazione tutt’altro che irrilevante).
Ovviamente non facciamo riferimento alla Germania Nazista o alle
persecuzioni nei confronti del popolo cinese da parte delle forze Imperiali
Giapponesi alla fine degli anni 30, perché sono fatti arcinoti.
L’elenco potrebbe essere ancora più lungo, eppure…eppure nel
nostro paese l’aver aderito a leggi razziali, di fatto dal 1938 al 1943, l’aver
avuto tre stati sovrani ridotti a colonia (due in effetti, la Libia fu “presa”
alla Turchia nella guerra Italo-Turca del 1911) per poco più di un ventennio, ha
spostato completamente l’attenzione da fatti clamorosi e altrettanto terribili
compiuti ad opera di praticamente tutta la popolazione mondiale di matrice
razzista, etnica o religiosa.
Solo basandosi su questo piccolo elenco di fatti storici
accertati ed indiscutibili, il cittadino comune alla domanda se il popolo
italiano abbia una indole razzista come dovrebbe rispondere?
I fatti dicono che praticamente tutta la popolazione mondiale ha
perseguitato, ucciso o discriminato altri esseri umani, per ragioni di etnia, di
religione o politiche negli ultimi 150 anni (grosso modo gli anni di vita della
Nazione “Italia”). Molti dei paesi che hanno combattuto il nazifascismo, in
quegli stessi anni avevano in vigore leggi razziali, o prevaricavano popolazioni
colonizzate ed hanno successivamente operato in senso razzista contro altre
popolazioni umane. Non è pertanto corretto come “logica” conseguenza affermare
che parte della popolazione italiana abbia una indole razzista superiore alla
media di tutti gli altri popoli. In effetti è tutt’altro che cosi.
Si potrebbe concludere che è stato il fascismo ad aver portato il
razzismo in Italia?
Il fascismo è stato in vigore dal 1922 al 1943, le leggi razziali
promulgate nel 1938, sono pertanto restate in vigore per 7 anni (considerando i
due anni di guerra civile successive all’armistizio). Se osserviamo la nascita
della Democrazia Statunitense, essa risale al 1776 con leggi razziali ancora in
vigore, seppur infinitamente più miti rispetto al passato, fino al 1970, ovvero
quasi 200 anni di leggi razziali, passate prima per leggi schiaviste. Dobbiamo
concludere da questo che la democrazia è portatrice di razzismo?
Le risposte sono NO ad entrambi i quesiti. Il razzismo, cosi come
è stato definito all’inizio, è qualcosa che ha fatto parte del sistema sociale
di tutto il mondo per moltissimi anni, per secoli, e con l’evoluzione del
pensiero, anche grazie al risultato del secondo conflitto mondiale, è sparito.
Restano ovviamente mentalità razziste in alcuni singoli individui e in molti
stati che ancora devono fare i conti con l’evoluzione sociale e del pensiero.
Queste non sono considerazioni filosofiche, ma di logica conseguenza dei fatti
storici ineluttabili elencati, che ciascun comune cittadino può semplicemente
valutare.
Perché allora nel nostro paese si da tanto risalto ad un pericolo
razzista e fascista ed alla liberazione avvenuta ad opera di paesi, che in ogni
caso avevano leggi o atteggiamenti razzisti o mentalità colonialiste? E perché
tale tema emerge in ogni situazione in cui si parla di immigrazione
incontrollata o libera e Unione Europea, addirittura associando il termine
“sovranismo” al “razzismo”? Discuteremo di questo nei prossimi incontri.
L’uomo che
conta i chiodi dei fili spinati nei confini tra Paesi.
Pubblicato venerdì, 03 gennaio 2020 su Corriere.it da Roberta Scorranese.
Berta, quante
sono «le spine» che ha contato finora?
«Sa che ho
perso il conto? Sono in viaggio dal giugno dell’anno scorso, ho incontrato
migliaia di persone, ne ho coinvolte a centinaia in questo progetto e alla fine,
più che il conteggio delle spine, quello che resta è lo sgomento. Lo sgomento
nel vedere quanto siamo ancora divisi, quanto vivi siano ancora i sentimenti
nazionalisti». Questa storia comincia nel 2015, quando Berta — artista
bergamasco — comincia a pensare ad un progetto che illustri le divisioni
internazionali. Da tempo riflette sulle tensioni nate dai confini, ma un’idea
come quella che sta portando avanti da giugno è un’idea complessa, anche
costosa. La svolta è arrivata con il premio ricevuto alla V Edizione
dell’Italian Council, quindi con il sostegno di Nomas Foundation di Roma come
ente promotore e della GAMeC di Bergamo. È nato così «One by One», un viaggio
attraverso Slovenia, Croazia, Macedonia, Turchia e molti altri Paesi del
Mediterraneo e dell’Europa dell’Est. Un work in progress che si tradurrà prima
in un video (la presentazione è prevista nell’aprile del 2020) e poi in una
mostra che debutterà alla Nomas Foundation e alla Prometeo Gallery di Milano.
Un «viaggio
collettivo», potremmo definirlo così?
«Sì, perché io
e la mia troupe arriviamo in un posto dove esiste un confine segnato da un filo
spinato, prendiamo contatti con la gente del posto, con le associazioni e con le
istituzioni. E poi chiamiamo tutti a contare le spine dei fili di divisione.
Grandi e piccoli, uomini e donne, ciascuno con la propria storia, perché il vero
cuore del progetto sono le vicende umane».
Ha coinvolto
anche i bambini?
«Certamente.
Anzi, nel video si vedrà la scena commovente di una bambina che al momento sa
contare solo fino a cinquanta e forse non si rende conto del fatto che davanti a
lei ci sono centinaia di spine. Ma ho incrociato le vite di tante persone».
Per esempio?
Per esempio,
in Slovenia, ho conosciuto un contadino che dall’oggi al domani si è visto il
terreno di proprietà diviso in due dal confine con il filo spinato. Ma lui non è
mai ricorso a toni da tragedia, anzi: mi ha raccontato che gli hanno permesso di
praticare un foro nella rete e così lui passa da una porzione all’altra del
terreno per poterlo coltivare».
Un viaggio, il
suo, che sta toccando numerose zone «calde» per la situazione geopolitica
attuale.
«Sì, penso per
esempio alla Turchia: lì è quasi impossibile avvicinarsi ai confini e portare
avanti un progetto del genere. Gli stessi poliziotti di frontiera avrebbero
rischiato se ci avessero aiutato. In Macedonia le stesse forze dell’ordine ci
hanno confidato che a loro fa male dover respingere i migranti. Ma ci sono
barriere invisibili che affiorano solo attraverso le persone: per esempio in un
piccolo villaggio bulgaro al confine con la Turchia ho incontrato un cantante
lirico che mi ha mostrato l’elenco delle canzoni “permesse” dal Governo».
Tra le
comunità che lei ha incontrato (e coinvolto nel progetto) ha riscontrato
sentimenti di condiscendenza a queste politiche divisive o piuttosto una
ribellione?
«Molti si
ribellano ai fili spinati, tante associazioni organizzano presidi o
manifestazioni pacifiche. Per esempio tra Croazia e Slovenia è stato segnato un
confine con il filo e c’è un simbolo importante come il ponte di Slavski Laz che
sta cambiando volto: un tempo era detto “il ponte degli innamorati” perché era
qui che uomini e donne appartenenti ad entrambi i territori si incontravano e
spesso nascevano matrimoni “misti”. Oggi quel ponte è circondato da filo
spinato».
La prossima
tappa sarà il Messico?
«Sì, una delle
zone simbolo dei cosiddetti “muri moderni”. Ma vorrei andare anche nella Corea
del Sud e a Cipro».
·
Quei razzisti come
i Sammarinesi.
San Marino, in una notte fatti fuori i vertici della
magistratura. Aldo Torchiaro su Il Riformista il 5
Agosto 2020. San Marino va presa sempre molto sul serio. È la lezione che
lascia Piero Calamandrei, che, insieme ad altri autorevolissimi giuristi
italiani, nell’ultimo secolo e mezzo offrì la propria scienza svolgendo
incarichi presso la Repubblica del Titano. Giovanni Guzzetta è tra questi
giuristi, e dopo aver rivestito il ruolo di componente e presidente della Corte
Costituzionale di quel paese è stato chiamato a dirigere il Tribunale. Quando,
improvvisamente, sul Monte Titano il maglietto della giustizia si è abbattuto
come una furia sulla giurisdizione che doveva rappresentare. E in una notte, il
24 luglio scorso, il Consiglio giudiziario si è riunito – con una composizione
parziale e contestata, dovuta a una legge retroattive approvata in febbraio –
per destituire una serie di figure. Il Consiglio giudiziario è convocato alla
presenza di soli 12 esponenti su 23. Diverse modifiche recentissime hanno
variato la sua composizione – forse non a caso – e le nuove norme sono
retroattive. Sono membri dell’organismo, oltre ai giudici, anche deputati di
maggioranza e opposizione. E la notte del 24 luglio avviene un po’ di tutto. Tra
le decisioni esiziali, quella sera, una che non era nemmeno all’ordine del
giorno: l’annullamento della revoca dell’incarico di presidente del Tribunale
per Valeria Pierfelici, risalente a due anni e mezzo fa: e Pierfelici si ritrova
così, di punto in bianco, a riprendere lo scranno che era di Guzzetta. Una
manovra voluta e attuata dai tre partiti che compongono la maggioranza di
governo sanmarinese: Dc, Rete e Motus Liberi. Votano in dieci (7 politici e 3
giudici), si astengono in 2: passano le modifiche. In altre parole: l’organo di
autogoverno della magistratura sanmarinese assume una decisione senza che di
fatto i giudici votino. Strano? Sì, ma non è tutto. Sentite questa: la neo
presidente Pierfelici rimane in carica solo qualche minuto. Giusto il tempo di
approvare alcune modifiche organizzative di peso per poi dimettersi lasciando
vacante il posto. Un intervento ruvido della politica nell’amministrazione della
giustizia che secondo alcune fonti non avviene per caso. E in effetti non sono
pochi gli interventi operati in fretta e furia: è stato azzerato il pool di
magistrati che ha indagato sul “Conto Mazzini”, uno degli scandali più clamorosi
sul Titano che ha portato alla luce milioni di euro di tangenti e coinvolto ex
ministri e Capi di Stato. Via il capo, Buriani, via Di Bona. Quelli che in
questi anni si sono occupati delle indagini sui vertici storici della Democrazia
Cristiana e del partito socialista di San Marino. «La politica entra molto
pesantemente con questa commistione nella vita giudiziaria e il presidio di
legalità della magistratura ne esce minacciato, con le conseguenze di una
lesione allo Stato di diritto», dichiara il costituzionalista Giovanni
Guzzetta, esautorato di peso dalla Presidenza del Tribunale di San Marino. «È
stato un colpo di mano del sovranismo giudiziario, un sorta di tentazione
autarchica, che tradisce la grandissima tradizione di rapporti con giuristi
stranieri. C’è una prossimità comunitaria che mette insieme politica e giustizia
senza far capire più dove finisce la prima e dove inizia la seconda». Ma neanche
Guzzetta ha il quadro chiaro di quel che è avvenuto. «A dieci giorni da quella
nottata, non sappiamo ancora quasi niente. Non sappiamo chi era presente, non ci
sono riscontri sui nomi dei componenti dell’organo. E non ci sono i resoconti.
Facciamo illazioni, in assenza di verbali. Quel che so è che mi è arrivata la
comunicazione della cessazione dall’incarico, con l’annullamento della mia
nomina senza che vi fosse alcuna motivazione in diritto dell’annullamento
dell’incarico. E senza che l’argomento dell’annullamento della mia nomina fosse
all’ordine del giorno di quella riunione”. Nominato un anno fa, il suo mandato
era quinquennale, doveva durare fino al 2024. Un ambizioso programma di
rinnovamento della macchina, con l’introduzione della telematica in tutti i
procedimenti e la promozione di San Marino, che sta negoziando l’associazione
alla Ue, come sede di un tribunale di giustizia europeo. E invece un colpo di
mano giudiziario cancella tutto, in una notte avvolta nel mistero. «Avevo
chiesto, essendo stato oggetto di tanti attacchi, che venisse messo in
discussione il mio operato nel merito», aggiunge Guzzetta. «E invece niente». A
Guzzetta non mancheranno comunque gli impegni, con le sue battaglie per le
riforme, a Roma. Ad altri è andata peggio. Alberto Buriani, fino a poco fa a
capo del pool che ha scoperchiato la tangentopoli nel Titano oggi si ritrova a
occuparsi di incidenti stradali. La sua collega Laura Di Bona è passata al
civile: tra i fascicoli che non seguirà più, un filone dell’indagine sul
senatore leghista Armando Siri.
·
Quei razzisti come
gli Svedesi.
La Svezia
aumenta le spese militari ed è sempre più vicina alla Nato.
Paolo Mauri su
Inside Over il 2 novembre 2020. La Svezia aumenterà le proprie spese militari
del 40% e raddoppierà il numero annuale dei coscritti entro i prossimi cinque
anni, ed il motivo è che Stoccolma teme l’aggressività di Mosca. Il governo
svedese è stato proprio estremamente chiaro in merito il mese scorso, quando il
ministro della Difesa, Peter Hultqvist, ha affermato che “abbiamo una situazione
in cui la Russia è disposta a utilizzare mezzi militari per raggiungere
obiettivi politici”, ha detto ai giornalisti “sulla base di ciò, abbiamo una
nuova situazione di sicurezza geopolitica da affrontare”. Hultqvist avvisa che
il nuovo piano di spesa prevede un aumento del budget militare di 27,5 miliardi
di corone svedesi (3,1 miliardi di dollari) entro il 2025 che si accompagnerà ad
un innalzamento del numero del personale militare sino a 90mila uomini (dagli
attuali 60mila) attraverso il raddoppio della coscrizione. La Svezia, infatti,
nel 2018 ha ristabilito il servizio militare anche se non a carattere
universale: le nuove leve vengono infatti selezionate tra 19 mila unità dopo
vari test psicologici e attitudinali sino a raggiungere il numero di 4mila
effettivi. Il ritorno della leva obbligatoria, abolita nel 2010, nasce dal
“cambiamento nel nostro vicinato…l’attività militare russa è una delle
ragioni” come aveva riferito l’allora portavoce del Ministero della Difesa,
Marinette Radebo, in occasione della decisione presa dal Governo di Stoccolma
avvenuto a marzo del 2017. Il servizio dura 12 mesi con l’obiettivo di formare
nuovi professionisti e di ingrossare le fila della riserva, struttura militare
di importanza vitale per la Svezia. La riforma è stata specificata meglio dallo
stesso Ministro Hultqvist che in quell’occasione disse “se vogliamo unità
militari ben addestrate ed efficaci, il sistema di volontari necessita di essere
accompagnato dal servizio di leva obbligatorio”. L’aumentata assertività
russa ha quindi spinto la Svezia verso il riarmo: Stoccolma ha infatti già
siglato un contratto con gli Stati Uniti per l’acquisizione dei missili da
difesa aerea con capacità Abm (Anti Ballistic Missile) Mim-104 Patriot del
valore di 1,3 miliardi di dollari nel 2018, proprio dopo averli visti “in
azione” l’anno precedente durante un’esercitazione congiunta, Aurora 2017, a cui
parteciparono Finlandia, Francia, Danimarca, Norvegia, Lituania, Estonia ed un
nutrito contingente di militari statunitensi. In generale la Svezia prevede di
rinnovare tutte le sue Forze Armate: la marina avrà un nuovo sottomarino e le
sue corvette saranno aggiornate, mentre è già noto l’impegno svedese nel
programma per il caccia di sesta generazione Tempest, a cui partecipa anche
l’Italia. Stoccolma ha quindi cambiato dottrina militare provvedendo ad
aggiornare i suoi piani di “neutralità armata” rispetto al recente passato. Già
a partire dal settembre del 2016 ha pensato a ristabilire una presenza militare
stabile nell’isola di Gotland, posizionata quasi al centro del Mar Baltico
davanti alla Lettonia. L’isola era stata completamente “smilitarizzata” nel 2005
con il ritiro delle forze navali, di terra ed aeree che sino ad allora vi
stazionavano in quanto considerata strategica dalla Svezia ma non solo: la sua
particolare posizione geografica ne fa un obiettivo particolarmente ambito per
chi volesse controllare la navigazione nel Mar Baltico e quindi gli accessi al
Golfo di Finlandia ed al Golfo di Botnia, quest’ultimo “sorvegliato” anche
dall’isola finlandese di Åland. Ma Gotland diventa anche un trampolino di lancio
(o fornisce copertura) per un possibile attacco anfibio “alle spalle” verso i
Paesi Baltici: l’ex Ministro della Difesa estone, Hain Rebas, ha infatti le idee
molto chiare in merito, sottolineando come l’isola sia ritornata prepotentemente
al centro degli interessi strategici dei Paesi che si affacciano sul Baltico. La
Svezia quindi sta spostando sempre più il suo asse dalla neutralità armata verso
gli Stati Uniti e la Nato proprio a causa dell’incremento dell’attività militare
della Russia lungo i suoi confini e per via di alcuni sconfinamenti di sue unità
navali: lo scorso 23 settembre due corvette sono penetrate nelle acque
territoriali svedesi provocando la dura reazione di Stoccolma. Anche la
crescente attività aerea russa ha contribuito a preoccupare il Paese scandinavo
tanto da averlo portato verso l’implementazione di Nordefco, un trattato di
cooperazione militare sottoscritto coi suoi vicini di casa Norvegia e Finlandia,
che prevede tavoli di pianificazione strategica comuni e miglioramento delle
capacità di interoperabilità. Già da qualche anno, infatti, la Svezia ha stretto
legami con la Nato: nel 2014 abbandonò lo status di “Paese non allineato” per
firmare un accordo di cooperazione militare con l’Alleanza; accordo che prevede
la possibilità per la Nato di poter schierare le proprie truppe sul territorio
svedese anche in tempo di pace oltre che in caso di crisi internazionale, che
rappresenta il vero fattore destabilizzante in ottica russa. Mosca infatti ha
reiterato più volte la propria ferma condanna in caso che Stoccolma entri
nell’Alleanza Atlantica: il presidente russo Vladimir Putin ebbe a dire, nel
2017, che “se la Svezia aderirà alla Nato, influenzerà negativamente le nostre
relazioni perché significherà che strutture della Nato saranno installate in
Svezia, quindi dovremo pensare ai modi migliori per rispondere a questa
ulteriore minaccia”. In particolare l’atteggiamento russo verso la Svezia
passerebbe da una “fredda amicizia” ad uno “status di nemico”. A complicare i
rapporti tra i due Paesi che condividono il Mar Baltico c’è anche il contesto
storico: la Svezia e la Russia hanno un passato caratterizzato da guerre per
l’egemonia su quel mare interno che portò Stoccolma a schierarsi,
sciaguratamente, con Napoleone durante la sua campagna di conquista europea
rivolta verso est. Pertanto, il ruolo della memoria storica svedese gioca un
ruolo negli attuali dibattiti sulla Nato, in particolare il trauma della perdita
dell’impero del Mar Baltico attraverso le varie guerre con la Russia che hanno
visto i confini imperiali gradualmente ridotti verso quelli attuali. La Svezia,
a differenza di altri Paesi dell’Est Europa, è forse l’unica su cui non ha
influito granché l’annessione della Crimea e la questione in Donbass per quanto
riguarda la percezione della minaccia russa: la preoccupazione di Stoccolma,
infatti, è precedente e riguarda proprio l’attività militare russa, soprattutto
navale (vedere “incidente” del sottomarino nel 2014), che ha dimostrato la sua
maggiore aggressività rispetto a un decennio fa. In questa situazione di
tensione anche i media svedesi stanno avendo la loro parte. La “stampa” tende ad
essere filo-Nato ed è in atto una “info war” non tanto per demonizzare la
Russia, quanto per guardare all’Alleanza come ad una polizza di assicurazione
contro una possibile aggressione. L’adesione alla Nato quindi ricadrebbe in una
strategia di sicurezza realistica, basata sul presupposto che la Svezia sia
strategica per la Russia, che mirerebbe a prenderne il controllo. Esistono
però voci critiche interne che si sollevano verso questa visione: alcuni
analisti svedesi ritengono che proprio l’adesione alla Nato farà annoverare la
Svezia tra i possibili obiettivi della Russia, stante il fatto che, attualmente,
Mosca non avrebbe alcun interesse verso il Paese e avrebbe tutto l’interesse a
che si mantenesse neutrale. L’opinione pubblica svedese sembra essere molto
attenta alle dinamiche di questa questione: mentre nel 2001 il 49% degli
intervistati pensava che fosse una cattiva idea entrare nell’Alleanza, nel 2012,
la percentuale era scesa al 45%. Nello stesso tempo, il sostegno all’adesione
alla Nato è aumentato dal 19% nel 2011 al 29% nel 2013. Dopo l’annessione russa
della Crimea nel 2014, circa il 50% degli intervistati svedesi pensava ancora
che gli interessi della Svezia sarebbero stati meglio garantiti restando fuori
dalla Nato (un aumento di 10 punti dal 2013), ma circa 1/3 era favorevole
all’adesione. Come detto le questioni più “vicine” hanno influito molto più
rispetto a teatri distanti come quelli ucraini: con la presunta incursione di un
sottomarino russo nelle acque dell’arcipelago di Stoccolma nell’ottobre 2014,
circa il 40% degli intervistati era diventato favorevole all’adesione
all’alleanza facendo segnare il più alto livello di sostegno sino ad allora. Si
sta quindi giocando una Information Warfare in Svezia, forse guidata dallo
stesso governo di Stoccolma, ma sicuramente sostenuta anche dagli Stati Uniti e
dall’Alleanza Atlantica, per arrivare ad una futura adesione alla Nato. Del
resto l’attività russa, come quella occidentale, è aumentata nel Baltico e lungo
le altre frontiere dal Grande Nord sino al Mar Nero, e il governo svedese non
può far altro che cercare di rafforzarsi militarmente. Se possiamo considerare
come vera l’affermazione che solo una eventuale adesione della Svezia alla Nato
la catapulterebbe tra i “nemici” di Mosca, è altrettanto vero che il linguaggio
diplomatico russo non è stato, e non è, affatto tranquillizzante: sconfinamenti,
voli di pattugliamento, esercitazioni hanno messo in allarme Stoccolma proprio
perché si vede chiamata in causa nonostante non faccia parte dell’Alleanza.
Esiste forse un problema di “linguaggio”, ma è ipotizzabile che al Cremlino
siano portati a pensare che la Svezia sia già una minaccia per la propria sfera
di influenza, potendo, potenzialmente, chiudere gli accessi al Baltico, e
pertanto, che entri nella Nato o meno, qualche anno fa si sia deciso di cambiare
il proprio atteggiamento nei confronti del Paese scandinavo: una decisione che
ha innescato una spirale di eventi che può essere fermata, ormai, solo se Mosca
tornerà a non farsi percepire come una minaccia da Stoccolma.
Svezia, le associazioni islamiche chiedono di cambiare la
costituzione. Roberto Vivaldelli il 14 settembre 2020
su Inside Over. Lo scorso 29 agosto, a Malmö, in Svezia, manifestanti islamici e
antirazzisti hanno messo a ferro e fuoco la città dopo che alcuni sostenitori
dell’estrema destra hanno bruciato un corano. Secondo quanto riportato dalla
stampa svedese, il leader dell’estrema destra danese e di Stram Kurs, Rasmus
Paludan, a cui è stato impedito entrare in Svezia per due anni, ha promosso
nelle ultime settimane manifestazioni anti-islamiche a Stoccolma e in altre
città svedesi dove vengono bruciate copie del Corano. Il 28 agosto, Paludan ha
attraversato il confine per recarsi proprio a Malmö, ma alla stazione di
Lernacken è stato accolto da un gran numero di agenti di polizia, che lo hanno
obbligato a lasciare immediatamente il Paese. L’obiettivo di Paludan è chiaro:
fermare l’islamizzazione del Paese. “L’obiettivo è fermare l’islamizzazione
della Svezia. Tornare ai livelli di islamizzazione ai livelli degli anni
Sessanta circa. Un milione di persone dovrebbe tornare nei Paesi musulmani di
provenienza o convertirsi a qualcosa di diverso dall’islam. È chiaro che questo
è l’obiettivo”, ha detto Paludan, promettendo di andare avanti fino a quando”
ogni islamico “avrà lasciato la Svezia”. Dalla fine di agosto, il partito
etno-nazionalista anti-islamico Hard Line ha bruciato diversi Corani in quelli
che descrive come i “ghetti svedesi”, in particolare a Malmö, nel quartiere di
Rosengård.
“Cambiamo la costituzione”. L’avvocato anti-islam danese non
demorde. Sabato scorso, la polizia ha respinto la richiesta di indire una
manifestazione presentata dal suo partito. Le autorità ritengono che esista il
rischio che si verifichi una situazione che comporti “gravi minacce all’ordine e
alla sicurezza pubblica”. Paludan scrive nella domanda che lo scopo è dimostrare
per la libertà di espressione e “deridere e umiliare” l’islam. Ora le
organizzazioni islamiche di Stoccolma, riporta il Dagens Nyhether, vogliono
cambiare la costituzione svedese e vietare il fatto che si possa prendere di
mira l’Islam e le altre religioni. “Non vogliamo che sia legale in Svezia
bruciare sacre scritture come il Corano o la Bibbia e allo stesso tempo dovrebbe
essere vietato deridere le varie religioni”, dice Hussein Farah Warsame.
“Vogliamo un cambiamento nella politica,” sottolinea Abdulla Ali Abdi, della
moschea di Tensta. Le manifestazioni anti-islam sono state condannate
dall’arcivescovo Antje Jackelén. Come riportato dal quotidiano Expressen, in
qualità di membro del Consiglio cristiano svedese, ha fortemente disapprovato le
“violazioni consapevoli della fede delle persone”. “Bruciare libri è barbaro.
Non ultimi libri che molti considerano sacri”, ha scritto il Consiglio in una
dichiarazione, avvertendo che queste azioni “alimentano la polarizzazione tra le
persone e contrastano gli sforzi di integrazione”. “Esprimiamo la nostra forte
solidarietà ai credenti musulmani nel nostro Paese”, ha concluso.
Lo scontro di civiltà in Svezia. Estremismo etnico e razzismo da
una parte, islamismo dall’altra: la Svezia fa i conti con una guerra culturale e
di religione che sta minando le basi della normale convivenza, soprattutto nei
quartieri più difficili. È (l’inevitabile) fallimento del modello
multiculturale. Gli esempi di questa convivenza impossibile sono molti. Secondo
una ricerca pubblicata dal giornale svedese Aftonbladet, le donne si
sentirebbero particolarmente insicure e preoccupate per la loro incolumità in
determinate zone del Paese. Si tratta dei quartieri dominati da immigrati, in
special modo islamici. Sono le tristemente celebri “no-go area”, dove nemmeno la
polizia può mettere piede. Come ha ammesso nel gennaio 2018 Dan Eliasson, capo
della polizia nazionale svedese, “il numero delle no-go-area ha raggiunto un
livello molto critico, sono salite da 55 a 61 in soli 12 mesi e rappresentano un
attacco alla nostra società”. E la situazione è drasticamente peggiorata. Basti
pensare al quartiere di Rinkeby, a Stoccolma, dove la percentuale di immigrati
arriva al 90% della popolazione, e dove le donne – come ha ben
documentato un’inchiesta di Katie Hopkins – hanno paura a uscire di casa per
timore di essere stuprate o aggredite. Lo scorso 4 settembre, un ragazzo di 11
anni a Malmö è stato aggredito da una banda da alcuni sconosciuti che lo hanno
definito un “maiale bastardo”. Motivo? Indossava un crocifisso. Nel mese di
agosto, dei vandali hanno profanato la chiesa evangelica luterana sempre a Malmö
per sette giorni consecutivi questo mese, rompendo finestre e demolendo una
statua di Gesù. Il sogno del multiculturalismo è diventato un vero e proprio
incubo.
Scontri a Malmo: ecco cosa è successo (davvero) in Svezia.
Roberto Vivaldelli il 30 agosto 2020 su Inside Over.
Nella serata di sabato, a Malmö, in Svezia, manifestanti islamici e
antirazzisti hanno messo a ferro e fuoco la città dopo che alcuni sostenitori
dell’estrema destra hanno bruciato un corano. Diversamente da quanto riportato
da alcuni giornali di orientamento progressista (come La Repubblica), infatti,
non sono stati gli “islamofobi” a scatenare il caos nella città del sud della
Svezia ma i loro “antagonisti”. Certo, gli estremisti di destra si sono resi
protagonisti di una provocazione molto grave e di un atto deprecabile,
offensivo, ma non sono stati loro i protagonisti dei vandalismi, come
erroneamente descritto da alcuni media liberal. Come riportato anche dal Daily
Mail, infatti, i manifestanti islamici, circa 300, secondo quanto riferito dalla
polizia, hanno lanciato pietre contro le forze dell’ordine mentre queste ultime
cercavano di allentare le tensioni. Immagini drammatiche mostrano pneumatici
bruciati, vetrine spaccate e una fitta coltre di fumo che si alza dalla città.
Corano bruciato: scontri con la polizia. Secondo quanto reso noto
la polizia e riportato dall’agenzia Agi, tra i dieci e i venti manifestanti sono
stati fermati prima di essere “tutti rilasciati”, come ha dichiarato il
portavoce della polizia, Patric Fors. Diversi agenti sono rimasti feriti.
Secondo la polizia citata dalla stampa locale, il Corano è stato bruciato da un
gruppo legato al partito danese di estrema destra Stram Kurs (Linea dura). Il
leader della di Stram Kurs, Rasmus Paludan, noto per le sue provocazioni
anti-musulmane, venerdì doveva recarsi a Malmo per organizzare una
manifestazione anti-islam in cui ha chiesto il rogo di un Corano ma le autorità
gli hanno impedito di entrare in Svezia, spiegando che c’è il “rischio che il
suo comportamento costituisca una minaccia per gli interessi fondamentali della
società”. Il provvedimento, tuttavia, non ha fatto altro che peggiorare le cose
quando molti dei suoi sostenitori hanno deciso di bruciare il corano. Da lì
l’escalation di violenza. La rivolta è iniziata intorno alle 19:00 ed è
continuata fino alle 3 del mattino. La polizia ha riferito a The Local che circa
13 persone saranno probabilmente accusate e che si stanno cercando alcune
persone sospettate di aver incoraggiato i giovani manifestanti a condurre atti
violenti. “Fa male”, ha spiegato sabato alla tv svedese Svt Salim Mohammed Ali,
un musulmano residente a Malmö da oltre 20 anni. “Le persone si arrabbiano e lo
capisco, ma ci sono altri modi per fare queste cose”, ha aggiunto. Samir Muric,
un imam di Malmö, ha condannato i rivoltosi sulla sua pagina Facebook. “Coloro
che agiscono in questo modo non hanno nulla a che fare con l’Islam”, ha scritto.
Malmo, città culla del radicalismo islamico. È da tempo che a
Malmö si sono raggiunti negli anni livelli altissimi di criminalità tanto che,
come ha ammesso lo stesso capo della polizia locale Jonas Karlberg, “abbiamo
avuto un numero straordinario di sparatorie nel 2016, nel 2017 e anche per parte
del 2018”. Anche l’estremismo islamico è un serio problema per il Paese nordico.
Secondo un articolo del Il Fatto Quotidiano del 2017, la “tranquilla” Svezia (a
quota 300) è al quinto posto di una classifica che vede drammaticamente in vetta
la martoriata Francia (che svetta con 2183, seguita dalla Gran Bretagna a 1700):
è la triste graduatoria che suddivide su base territoriale i cittadini europei e
i residenti nel Vecchio Continente coinvolti in network jihadisti. Svezia che
sta facendo i conti con i foreign fighters di ritorno. Come ha acclarato la
scorsa primavera la tv svedese SVT, 13 dei 41 foreign fighters di ritorno
avrebbe commesso reati di vario genere, alcuni dei quali molto gravi: un uomo di
31 anni, ex combattente dell’Isis, è stato filmato mentre aggrediva un vicino di
casa con un paio di forbici. Ora è agli arresti con l’accusa di tentato
omicidio. In questa situazione c’è davvero da stupirsi di opposti estremismi che
si fronteggiano violentemente e di tensioni sociali sempre più incontrollabili?
L’esperimento multiculturale della città svedese è fallito. E produce
estremismi, da una parte e dall’altra.
Cosa sta accadendo a Malmo. Emanuel
Pietrobon il 31 agosto 2020 su Inside Over. Per le strade di Rosengard,
quartiere periferico di Malmo (Svezia), la sera del 28 agosto si è combattuta
una guerriglia urbana fra centinaia di residenti di religione islamica e le
forze dell’ordine. Gli scontri, che sono terminati con l’arresto di quindici
persone, il ferimento di diversi agenti di polizia, il rogo di decine di veicoli
e la devastazione dell’arredo urbano, sono stati innescati dal deprecabile rogo
di un Corano da parte di alcuni attivisti di estrema destra, avvenuto in
giornata nel corso di una manifestazione non autorizzata. Le immagini delle
violenze stanno contribuendo a riportare l’attenzione sulla condizione
drammatica in cui versano alcune periferie multietniche delle grandi città
svedesi, luoghi in cui l’integrazione di determinate categorie di immigrati
continua a restare un miraggio, ragion per cui l’islam radicale e il crimine
organizzato hanno trovato terreno fertile su cui attecchire e proliferare,
ponendo dei gravi problemi in termini di pace sociale e sicurezza nazionale.
Il contesto degli scontri. Sebbene una parte della stampa
italiana sostenga che la guerriglia urbana sia stata combattuta da estremisti di
destra e forze dell’ordine, il materiale foto e videografico prodotto dalle
fonti svedesi e le opere di fact-checking ad opera di portali d’informazione
indipendenti e di media noti, come Open di Enrico Mentana, smentiscono
completamente questa ricostruzione, delineando un quadro radicalmente
differente. L’origine dell’intera vicenda è da far risalire ad alcuni eventi di
agosto. Due sono gli eventi sanguinosi che, in particolare, hanno spinto i
partiti di opposizione, sia moderati che di estrema destra, ad aumentare la loro
esposizione pubblica e mediatica per denunciare quanto sta accadendo nel Paese.
Il primo fatto è la tragica morte di una 12enne svedese, uccisa da un proiettile
vagante a Stoccolma, ennesima vittima della guerra tra bande che sta dilaniando
il Paese da diversi anni. La seconda vicenda, più recente, riguarda il rapimento
di due preadolescenti nella municipalità di Solna ad opera di due spacciatori,
dai quali sono stati torturati e violentati per diverse ore, la sera del 22, per
essersi rifiutati di acquistare degli stupefacenti. Il vortice di
microcriminalità e crimine organizzato che sta avvolgendo la Svezia sta venendo
cavalcato da ogni partito d’opposizione nell’aspettativa di guadagnare consensi,
dai Moderati di Ulf Kristersson ai Democratici di Jimmie Akesson. La situazione
è così grave che durante il tradizionale discorso alla nazione di fine
estate pronunciato dai capi dei due principali partiti, quest’anno incentrato
sulla pandemia, Kristersson ha voluto rompere il protocollo e parlare di un
altro argomento: l’emergenza violenza. Kristersson ha confutato la tesi
dell’esecutivo secondo cui la guerra tra bande sarebbe sotto controllo,
illustrando come da gennaio a metà agosto abbiano avuto luogo 210 sparatorie e
24 omicidi e accusando i criminali di essere “i terroristi domestici della
Svezia”. Dopo aver definito il fenomeno criminoso una “seconda pandemia”,
Kristersson ha aggiunto: “Lofven non sta agendo contro le bande. Prima non le ha
viste arrivare e adesso manca del potere e di politiche concrete [per
affrontarle]”. L’insieme di questi eventi, che ha mobilitato le stesse forze
politiche centriste e moderate, non ha potuto che fare il gioco degli elementi
più radicali, che il pomeriggio del 28 si sono dati appuntamento a Malmo per
protestare contro l’immigrazione di massa dai Paesi islamici su iniziativa
di Dan Park, un attivista noto nel panorama nazionale per le sue idee neonaziste
e islamofobe.
La notte di violenze. La manifestazione non autorizzata durante
la quale è stato bruciato il Corano avviene, quindi, sullo sfondo di un contesto
particolarmente sensibile e incendiario di cui i media non svedesi sembrano
ignorare l’esistenza, volutamente o meno. Nonostante la folla di dimostranti sia
stata composta soprattutto da svedesi, alcuni dei presenti sono giunti dalla
Danimarca e sono stati identificati come membri del gruppo neofascista “Linea
dura” (Stram Kurs) fondato dall’avvocato Rasmus Paludan. Quest’ultimo,
monitorato dalle forze dell’ordine di Copenaghen e Stoccolma, era stato bloccato
al valico dei due Paesi la mattina del 28 e trovato in possesso di un Corano
presumibilmente da bruciare. Dopo un rapido controllo, all’attivista era stato
impedito l’ingresso in Svezia, ma ciò non ha impedito che qualcun altro
compiesse quel gesto provocatorio al posto suo. Il video del rogo è diventato
virale nell’arco di poche ore, condiviso dai circuiti virtuali dell’estrema
destra all’intera rete, spingendo diverse centinaia di residenti di Rosengard,
il quartiere-ghetto più celebre della città, a scendere in strada e a dar vita
ad una guerriglia urbana durata l’intera sera. I manifestanti di estrema destra
avevano già rincasato, perciò la rabbia per il vilipendio commesso è stata
sfogata sull’arredo urbano, sui veicoli in sosta e sulle forze dell’ordine. I
tafferugli sono terminati con quindici arresti, decine di poliziotti feriti e
decine di autovetture distrutte dalle fiamme.
Rosengard, il quartiere ad accesso vietato. Il primo elemento che
traspare dai video in circolazione che documentano l’accaduto – confutando la
versione sostenuta da una certa stampa – è la ricorrenza del Takbir, ovvero
l’espressione “Allah akbar”, utilizzata come un vero e proprio grido di
battaglia dai rivoltosi di Rosengard in ogni fase dei tafferugli: dai primi
contatti con la polizia all’appiccamento degli incendi. Si tratta di un fatto
che non è possibile sottovalutare né trascurare perché è indicativo della
presenza di personaggi appartenenti all’islam radicale all’interno della rivolta
che, non a caso, è stata duramente condannata anche dai capi della comunità
musulmana cittadina, come l’imam Samir Muric. Rosengard ha una popolazione di
quasi 25mila abitanti e, per via dei numerosi record negativi che può vantare, è
considerato il ghetto per antonomasia di Malmo, la città più musulmana di Svezia
(il 20% della popolazione è di fede islamica). Non sono disponibili dati recenti
e aggiornati riguardanti la composizione etnica della popolazione; le ultime
cifre sono del 2012 e all’epoca era risultato essere di origine straniera
l’86% dei residenti, in prevalenza provenienti dal Medio Oriente, dall’ex
Iugoslavia e dall’Africa orientale. Il quartiere è noto per aver dato i natali
al calciatore di fama mondiale Zlatan Ibrahimovic, ma è anche la culla di Osama
Krayem, fedelissimo di Abu Bakr al-Baghdadi, il cui nome compare nei
fascicoli sugli attentati di Parigi del 13 novembre 2015 e di Bruxelles del 22
marzo 2016. Prima di giurare fedeltà allo Stato Islamico, Krayem aveva prestato
il volto ad un documentario realizzato a Rosengard, figurando tra gli esempi
di integrazione riuscita nel difficile quartiere. Krayem, come tanti altri
residenti di questo ghetto, è stato radicalizzato in una delle numerose moschee
clandestine che da oltre un ventennio operano nel quartiere e che sono gestite
da imam radicali collegati al jihadismo internazionale, la cui esistenza è stata
denunciata a più riprese, ma invano, dall’Università di Difesa della Svezia.
Rosengard, in breve, è uno di quei quartieri popolarmente ribattezzati “no-go
zone” (zona ad accesso vietato) che in Svezia vengono classificati come “aree
particolarmente vulnerabili”, “aree vulnerabili” e “aree a rischio”. In tutto il
Paese, stando all’ultimo rapporto delle forze dell’ordine, datato 2019,
esisterebbero ventidue aree appartenenti alla prima categoria, e Rosengard ne fa
parte. Capire il motivo di tale classificazione è semplice: il malcontento non è
nato il 28 agosto, ma risale agli anni ’90, quando la quota degli stranieri sul
totale della popolazione ha raggiunto la soglia critica, superando il 50%,
venendo accompagnata simultaneamente da un decremento della qualità della vita e
della mobilità sociale, sullo sfondo della proliferazione di moschee fai da te e
microcriminalità che, negli anni, hanno portato rispettivamente alla diffusione
di radicalizzazione religiosa e guerre tra bande per il controllo dei traffici
illeciti. Rosengard è anche il luogo in cui è avvenuta la prima rivolta urbana
di stampo etno-religioso nella storia della Svezia. Fra il 18 e il 20 dicembre
2008, centinaia di residenti musulmani, soprattutto giovani, si scontrarono con
le forze dell’ordine per protestare contro il mancato rinnovo del contratto
d’affitto ai proprietari del centro culturale “Islamiska Kulturföreningen”. Gli
scontri, ancora oggi ritenuti i “più violenti mai affrontati” dalle forze
dell’ordine svedesi, furono caratterizzati dall’utilizzo di esplosivi
artigianali, come i tubi bomba, e furono esacerbati dal coinvolgimento di decine
di appartenenti alla galassia Antifa, giunti sul posto per dare manforte ai
rivoltosi nonostante la consapevolezza che si trattasse di islamisti. Dalle
notti di quel lontano dicembre ad oggi nulla è cambiato: schermaglie tra bande
rivali, violenze contro le forze dell’ordine, inclusi attentati e atti
intimidatori contro il commissariato locale, focolai di islam radicale nascosti
all’ombra dei palazzi, e la periodica esplosione della polveriera.
·
Quei razzisti come
i Norvegesi.
Paolo
Valentino per il ''Corriere della Sera'' il 10 ottobre 2020. Un processo spacca
la Norvegia. Nell'aula 250 del Tribunale distrettuale di Oslo va in scena il
dramma di una nazione, che si voleva aperta e tollerante e invece scopre il
nocciolo duro di un razzismo profondamente incistato nella sua società. Rischia
16 anni di carcere Laila Anita Bertheussen, 55 anni, compagna di Tor Mikkel
Wara, ex ministro della Giustizia ed esponente del Partito del Progresso, la
forza populista e anti-migranti che è parte della maggioranza di governo.
Insieme a una ex viceministra, la donna è accusata di attacco ai più alti
vertici dello Stato e di aver inscenato attentati terroristici e false minacce
tentando poi di far ricadere la colpa su una piccola compagnia teatrale.
Dettaglio surreale e decisivo: i messaggi minatori, le scritte razziste sui muri
di casa e le azioni violente erano dirette contro il suo compagno di vita e
contro sé stessa. Possibile? L'accusa ne è più che convinta, anche se la donna
si dichiara innocente. All'origine di tutto c'è una pièce di teatro politico
sperimentale, messa in scena su un piccolo palcoscenico indipendente di Oslo
alla fine del 2018, dove si cercava di raccontare come e perché le idee
dell'estrema destra razzista si siano radicate nel cuore della società
norvegese. Con uno stile da documentario «Punti di vista», questo il titolo, non
le mandava a dire. Faceva nomi e cognomi della galassia estremista norvegese e
delle sue connessioni: bloggers, miliardari finanziatori e aziende di lobby come
First House, dove Tor Mikkel Wara ebbe un ruolo dirigenziale prima di
trasferirsi direttamente al ministero della Giustizia. A lui e Bertheussen lo
spettacolo dedicava molto spazio, mentre sullo sfondo correvano immagini esterne
della loro casa, senza indirizzo o persone riconoscibili, riprese di nascosto
con un cellulare. La prima reazione di Laila Anita Bertheussen, presente alla
prima, fu del tutto comprensibile: «La chiamano arte, io la chiamo invasione
della mia sfera privata», aveva scritto in una lettera pubblicata a doppia
pagina dal quotidiano popolare Verdens Gang . Ma il 6 dicembre 2018 ebbe inizio
qualcos' altro. Prima le croci uncinate e la parola razzista sui muri della casa
della coppia e sulla portiera dell'auto di famiglia. Poi le bombe artigianali
scoperte dalla polizia sul sedile posteriore dell'automobile dei
Wara-Bertheussen. Il 2 marzo una lettera di minacce indirizzata a lei, definita
«puttana del FRP», la sigla del Partito del Progresso nel quale anche lei
milita. Infine,il 10 marzo del 2019, l'incendio doloso della macchina,
parcheggiata all'ingresso del garage della loro villa. La Norvegia era in stato
di choc. Tor Mikkel Wara denunciò «l'attacco alla democrazia» in corso,
ricevendo solidarietà popolare e simpatia in quanto vittima di una campagna
violenta. Anche la premier, la conservatrice Erna Solberg, solidarizzò col suo
ministro e accusò la compagnia teatrale di rendere la vita difficile ai politici
norvegesi. La tesi che «Punti di Vista» avesse creato un clima incendiario di
odio incoraggiando degli estremisti ad agire, fu subito sposata dagli
opinionisti. Ma nella terra dell'immenso Ibsen, come in Casa di Bambola nulla è
come appare. Pochi giorni dopo il rogo dell'auto, Bertheussen venne interrogata
e subito dopo accusata di aver fatto tutto lei, per dare la colpa al gruppo
teatrale. Tor Mikkel Wara si dimise da ministro. Ora va in scena un'altra pièce
, dove dalle perizie calligrafiche, alla carta da lettera usata, ai messaggi sul
cellulare della donna, l'accusa ha un impianto solidissimo. «Le brave ragazze
vanno in paradiso, il resto di noi va dove vuole», aveva scritto Bertheussen in
una chat privata con la co-imputata, Ingwil Smines Tybring Gjedde, ex
sottosegretaria agli Interni. Probabilmente andranno entrambe in galera.
Il governo norvegese rischia di cadere per il rientro della
donna dell’Isis. Pubblicato martedì, 21 gennaio 2020
su Corriere.it da Michele Farina. Ci sono tre donne (e due bambini cresciuti
sotto l’Isis) al centro dell’incredibile (quasi) crisi di governo in Norvegia.
Ce ne vuole, per incrinare una coalizione di centro-destra come quella che dal
lontano 2013 guida (più o meno al completo) la nazione degli «sceicchi nordici»
con i loro salmoni e i loro giacimenti di petrolio. La premier Erna Solberg, 58
anni, partito Conservatore, è abbandonata dai Progressisti nazionalisti
capitanati dalla cinquantenne ministra degli Esteri Siv Jensen. La ragione
apparente è la terza donna della storia, una ventinovenne (di cui non si dice il
nome) cresciuta con la passione del calcio in una famiglia norvegese-pachistana
alla periferia di Oslo. Sette anni fa, mentre Solberg sale al potere, la ragazza
che amava il pallone parte per la Siria attratta dalle sirene del Califfato. Si
sposa due volte, con miliziani Isis: il primo, il norvegese-cileno Bastian
Vasquez, scompare nel 2015. Del secondo si perdono le tracce. Dai campetti di
calcio di Oslo la donna finisce nel campo profughi di Al-Hol, dove vivono
prigionieri migliaia di foreign fighter e loro familiari. Sabato «Emira» (così
la chiama Asne Seierstad, autore del libro «Two Sisters» sulle straniere finite
in Siria) è rientrata in Norvegia con i figli, un bambino di 5 anni e una
bambina di 3. «Motivi umanitari»: il primogenito era «gravemente malato». Al-Hol
è un inferno dove nel 2019 sono morti 517 profughi, di cui 317 minori.
L’operazione rientro è stata pianificata nell’ottobre scorso. «Avremmo voluto
rimpatriare solo il piccolo — ha detto la premier in conferenza stampa — ma
separarlo dalla madre si è rivelato impossibile. Dovevamo lasciarlo morire?
L’importante è che il presunto malato sia curato». Presunto? La premier Solberg
mette le mani avanti. La questione del rimpatrio di «gente dell’Isis» è materia
incandescente in mezza Europa. Roba da far cadere governi. Oslo ha una
legislazione rigorosa. In base al codice penale, crescere figli nel Califfato
equivale a far parte di un gruppo terroristico (6 anni di reclusione). Dei 140
partiti dalla Norvegia per unirsi al Califfato, 10 al ritorno hanno subito pene
severe. In Svezia, su 300 partenti e 150 «tornanti», solo due processati. Il
governo di centrosinistra finlandese dopo una lunga impasse ha scelto di
considerare i rimpatri «caso per caso». L’alleanza norvegese di centro-destra si
è dimostrata meno morbida dei vicini. Almeno finora (sostiene il partito
Progressista, l’ala più intransigente della coalizione): Emira e il suo bambino
«presunto malato» sono diventati il casus belli che ha portato Siv Jensen e gli
altri cinque ministri di estrema destra (compreso quello del petrolio) a
sfilarsi dal governo. La famiglia è sorvegliata in un ospedale di Oslo.
L’avvocato di Emira sostiene che vuole collaborare. «Non ha combattuto. Le
accuse ruotano sul fatto che era in Siria e ha avuto rapporti con persone legate
a gruppi terroristici». Ha sposato due combattenti, i suoi figli sono cresciuti
con il latte del Califfato. Elementi che la rendono perseguibile. Le basterà
sostenere, come fa dire all’avvocato, che «la sua vita in Siria è stata un
incubo?». Le basti pensare per ora che suo figlio viene curato. La premier ha
preso atto dello strappo degli alleati e va avanti con un governo di minoranza.
La legge non prevede elezioni anticipate. Le prossime saranno nel 2021.
L’estrema destra si smarca dalla coalizione. E per questo ringrazia Emira.
·
Quei razzisti come
i Danesi.
Andrea
Tarquini per "repubblica.it" il 20 ottobre 2020. Uno scandalo di ripetute
molestie sessuali fa tremare l'establishment politico danese, causa un terremoto
nella socialdemocrazia - il partito di governo della giovane premier Mette
Frederiksen - e riaccende il movimento #metoo con tutta la sua energia. Uno
degli esponenti politici più influenti e popolari del Paese, il 59enne sindaco
di Copenaghen Frank Jensen, si è dimesso oggi perché accusato di molestie
sessuali e palpeggiamenti impropri ai danni di almeno nove sue giovani
collaboratrici. Le accuse e le denunce contro Jensen, finora popolarissimo
perché ha guidato i grandi passi avanti di Copenaghen come capitale e metropoli
più verde e sostenibile d'Europa, sono state rilanciate dal
quotidiano Jyllands-Posten, segnando la fine della carriera di Jensen. "Mi hanno
chiesto di restare, ma ci ho dormito sopra e alla fine a mente fredda ho deciso
di gettare la spugna", ha detto Jensen. "Una scelta di ignorare le accuse e
restare in carica avrebbe inficiato il mio lavoro e sarebbe pesata come un'ombra
su tutti i grandi progetti di cui la nostra capitale ha bisogno e continua a
realizzare. Mi dimetto, e chiedo scusa alle donne che ho offeso". Ha così
lasciato dopo 11 anni di successi e buon governo l'incarico di primo cittadino,
e anche quello di numero due del partito socialdemocratico, che ricopriva dal
2015. La giovane prima ministra socialdemocratica Mette Frederiksen ha reagito
prontamente su Twitter, dichiarando che "ogni episodio del genere è
intollerabile e tutti noi della classe politica dobbiamo fare di tutto per la
chiarezza, il rispetto delle donne, la verità. Dobbiamo rimettere in ordine la
situazione e creare una nuova cultura nelle parole e nei fatti. E' ovvio che ci
sia qualcosa che non va sul tema nel mio partito, e ciò è inaccettabile, tra noi
socialdemocratici come ovunque". Desta sorpresa che la battaglia di #metoo si
riaccenda proprio in Danimarca, uno dei Paesi più avanzati al mondo anche in
tema di gender equality. Mette Frederiksen ha subito messo le mani avanti,
secondo i media piú critici, anche perché è incalzata sul tema da una crescente
mobilitazione dei movimenti femminili, e affronta scandali su ogni fronte. La
prima scintilla era venuta quando Sofie Linde, una delle principali e più amata
conduttrici televisive danesi, aveva rivelato in diretta che, dodici anni prima,
da debuttante, aveva ricevuto promesse di veloce carriera in cambio di
prestazioni sessuali da un alto dirigente della radiotelevisione pubblica, di
cui non ha voluto fare il nome. Poi si è venuto a sapere che nel mondo dei media
oltre il 20 per cento delle donne sono vittime di avances, promesse in cambio di
piacere, palpeggiamenti. Il leader del partito social-liberale Morten
Ostergaard, da anni paladino dei diritti, si è dovuto dimettere quando si è
scoperto che dieci anni fa aveva palpeggiato le cosce di una collega.
Guido Barbujani per ''Il Sole 24 Ore'' il 19 gennaio 2020. Sono
sempre più gli europei con la pelle scura. Non si allarmino i sovranisti, però:
non stiamo parlando di cose che possono riguardarli, ma della preistoria. In un
magnifico articolo uscito su «Nature Communications», i genetisti dell'
Università di Copenaghen descrivono il Dna di un danese del Mesolitico, di cui
si può dire con sicurezza che aveva la pelle scurissima, come quella degli
africani odierni. Era una donna (anche questo lo dice il Dna) vissuta 5700 anni
fa dalle parti dell' attuale Syltholm. Tutti gli europei del Mesolitico studiati
finora - in Spagna, Lussemburgo, Svizzera e Inghilterra, e adesso anche in
Danimarca - avevano pelle e capelli scuri, e quasi tutti, compresa la donna di
Syltholm, gli occhi azzurri. Una combinazione che oggi è rara, ma all' epoca, a
quanto pare, no. Piccolo passo indietro. Le nostre cellule producono due
pigmenti: l' eumelanina, più scura, e la feomelanina, più chiara. I colori della
pelle, dei capelli e degli occhi dipendono da quanti grani di pigmento ci sono
nelle cellule, e dalle percentuali di eumelanina e feomelanina nei grani. A
produrre le melanine ci pensa una settantina di geni, senza dimenticare che
conta anche quanto sole si prende: insomma, il meccanismo biologico è
complicato. Per fortuna, oggi ci sono algoritmi di intelligenza artificiale
(tecnicamente: machine learning) che permettono di ricostruire la pigmentazione
di uno sconosciuto, se si conoscono i suoi geni. E abbiamo messo a punto
tecniche di laboratorio sofisticate, che permettono di studiare il Dna anche in
individui di cui ci restano solo ossa fossili. Ciò che rende eccezionale la
scoperta dei genetisti danesi è il fatto che del corpo di questa donna o ragazza
non ci resta niente, neanche un osso. Quello che sappiamo di lei ci viene da un
pezzo di mastice di betulla masticata: un chewing-gum dell' età della pietra, in
cui attraverso i millenni si sono conservati minuscoli frammenti del suo Dna. E
non solo del suo, ma anche di quello proveniente da un suo pasto (nocciole e
germano reale: il chewing-gum doveva essere il dessert), e da molti batteri.
Questi ultimi ci dicono che quella donna aveva i denti in pessima salute e
soffriva di infezioni di streptococchi, una causa comune di polmonite. La
stupefacente capacità del Dna di resistere al tempo ci permette di dare un'
occhiata a fenomeni remoti su cui, fino a ieri, avevamo idee vaghissime, o
nessuna idea: come sono cambiati l' alimentazione, le condizioni di salute; e il
colore della pelle. Gli antenati degli europei hanno lasciato l' Africa 70mila
anni fa, e sembrava logico che la loro pelle si fosse schiarita piuttosto in
fretta. E invece no, è successo molto più tardi di quanto si pensasse. Ma
andiamo con ordine. La pelle non lascia fossili, e quindi, fino a che non si è
scoperto come studiare il Dna di gente morta da millenni, potevamo solo fare
delle congetture. Una grande esperta di questi temi, Nina Jablonski, ha proposto
che i nostri antenati africani, sei milioni di anni fa, avessero la pelle
bianca: come quella di scimpanzé e gorilla se si va a guardare sotto il pelo. Ma
noi siamo, come si sa, scimmie nude: e per chi non ha pelo, la melanina è
preziosa perché protegge dai raggi ultravioletti. Così, in Africa, attraverso
milioni di anni, le pelli sono diventate via via più scure. Poi certe
popolazioni si sono spostate verso Nord, arrivando in terre in cui, invece,
pelli più chiare permettono un migliore utilizzo della vitamina D, fondamentale
nelle gravidanze e nell' allattamento. Lì il fenomeno si è invertito, e sono
comparse pigmentazioni chiare in Asia e Europa. È la selezione naturale: un
fenomeno compreso e descritto da Charles Darwin un secolo e mezzo fa. Darwin
però non conosceva il Dna, e non poteva sapere che la selezione può cominciare
solo dopo che in un gene è avvenuta una mutazione. Finché tutti hanno la pelle
dello stesso colore non succede niente; ma se una mutazione ha conferito a
qualche africano una tonalità di pelle un po' più scura, lui e i suoi figli
avranno un piccolo vantaggio sugli altri, una maggior probabilità di
sopravvivere, che col tempo renderà più comune quel colore della pelle; e il
contrario sarà successo a quelli che dall' Africa sono passati nel Vicino
Oriente, e da lì in Europa e in Asia. Ma mentre la selezione fa diffondere
caratteristiche vantaggiose, le mutazioni capitano per caso: sono piccoli errori
nel Dna, che non arrivano necessariamente nel posto e nel momento in cui
potrebbero servire. Le conseguenze non sono banali. Latte e formaggio sono buoni
e fanno bene, ma non a chi è intollerante al lattosio. Le mutazioni che
permettono di digerire il lattosio anche da adulti sono arrivate in Europa, ma
in Asia no, ed è per questo che lì devono accontentarsi del tofu. Quanto alla
pelle, le mutazioni che l' hanno resa scura negli africani, e poi chiara in
Europa e Asia, le conosciamo da tempo, ma per dare loro un' età bisognava
ritrovarle in qualche fossile preistorico: e quando ci siamo riusciti sono
cominciate le sorprese. Le prime mutazioni per le pelli chiare (al plurale,
perché, come abbiamo visto, c' entrano decine di geni) sono documentate nella
regione del Caucaso, 15mila anni fa, e da noi arrivano solo parecchio più tardi.
Ci arrivano per migrazione; anzi, mi dice Gloria González Fortes, che ci sta
lavorando nel nostro laboratorio di Ferrara, in più ondate migratorie: portate
da gente migrata in Europa prima dal Sudest e poi dal Nordest. La selezione le
ha diffuse, e oggi gli europei sono quelli con la pelle bianca: ma, a quanto
pare, non lo erano fino a 5700 anni fa, neanche in Danimarca. E quindi la
combinazione di caratteri oggi tipica del Nord Europa, pelle e capelli chiari,
occhi azzurri, è in realtà un cocktail di ingredienti antichi (gli occhi azzurri
del Mesolitico) e recenti (pelle e capelli chiari venuti dall' Est). Non c' è
niente da fare: più lo si conosce, e più ci si rende conto che il Dna di ognuno
di noi è un mosaico di pezzi diversi per età e provenienza. Questo mosaico è l'
eredità lasciataci da tanti antenati, che venivano da tanti posti diversi. Oggi
si parla molto delle nostre radici, a proposito e più spesso a sproposito, ma la
genetica dimostra che la metafora funziona solo in parte. Se pensiamo a radici
come quelle delle carote, piantate in un solo punto, non le ha nessuno di noi.
Tutti invece abbiamo radici ramificate come quelle degli alberi, protese in
tante direzioni, che spesso arrivano a grandi distanze.
·
Quei razzisti come i Tedeschi.
Giorgio Dell'Arti per "la Repubblica" 21 dicembre 2020. Questi
frammenti sono tratti dal volume "La più breve storia della Germania che sia mai
stata scritta" di James Hawes, edito da Garzanti. Gloria della Prussia per il
fatto che a Waterloo, con Wellington, aveva vinto il generale prussiano Gebhard
Leberecht von Blücher. Blücher, accolto a Londra da trionfatore, che si guarda
intorno ed esclama: «Che splendida città da saccheggiare». La Germania al di qua
dell' Elba suddivisa in decine di staterelli. Concorrenza tra Austria e Prussia,
su chi debba orientare la vita di questi staterelli. Finisce con la guerra dei
prussiani contro gli austriaci, quella in cui i prussiani, a sud, hanno come
alleati gli italiani (1866). Gli italiani perdono, ma perdono anche gli
austriaci e gli italiani si pigliano il Veneto. I prussiani vincono e si
cominciano a prendere gli staterelli. «La sola cosa che univa le corone
austriaca e prussiana, ed entrambe agli altri re e principi d' Europa, era l'
odio per il nazionalismo. In quest' epoca il nazionalismo era considerato
progressista e politicamente liberale perché pretendeva che i popoli (definiti
su basi etniche) si autogovernassero». Il Piano Coburgo, perseguito dal principe
Alberto, consorte della regina Vittoria: «Con l'appoggio, tra gli altri, di
Leopoldo del Belgio, Alberto e i suoi consiglieri tedeschi proponevano che la
Prussia dovesse prima riformarsi seguendo il modello costituzionale inglese, e
poi unificare l'intera Germania, che sarebbe così diventata (per dirla con la
regina Vittoria) un utilissimo alleato per l' Inghilterra». «La razza germanica
è predestinata a dominare il mondo. È fisicamente e intellettualmente
privilegiata rispetto a tutte le altre, e metà della Terra le si è di fatto
assoggettata. Inghilterra, America e Germania: ecco i tre rami del possente
albero germanico» (dal settimanale Wochen-Blatt des NationalVereins, 7 settembre
1865)». «La Prussia, battuta l'Austria, conquista Schleswig-Holstein,
Assia-Kassel, Francoforte e il ducato di Nassau. S' annette anche l' Hannover,
lo riduce a provincia prussiana, e ruba le sue imponenti riserve auree, con cui
finanzierà il riarmo che precederà la I guerra mondiale». Ma «il dado non era
ancora tratto». Per completare il suo grande piano, lo junker Bismarck, divenuto
capo del governo, aveva bisogno di un attacco francese. Solo questo gli avrebbe
permesso di proporsi come difensore della Germania occidentale, invece che come
suo conquistatore. Napoleone III, andando dietro a un telegramma falsificato,
attacca i prussiani, senza sospettare che i prussiani non aspettavano altro.
Travolto, imprigionato, esiliato a Londra, mentre a Berlino si proclama la
nascita della Germania e dell' Impero tedesco. «Bismarck dichiarò quasi subito
guerra all' influenza sociale e politica della chiesa cattolica con quel che fu
chiamato Kulturkampf. Era necessario sottrarre le scuole al controllo
ecclesiastico, consentire i matrimoni civili e proibire ai preti di impegnarsi
in attività in qualche modo assimilabili a un' opposizione politica. Gli
osservatori stranieri erano perplessi: avviare senza motivo uno scontro con la
Germania meridionale appena annessa era un modo singolare per unificare il nuovo
impero. Ma Bismarck non voleva l' unificazione. Voleva l' assimilazione
prussiana, e i suoi cruciali alleati, i nazional-liberali, volevano il
progresso. Combattere la Chiesa cattolica era l' unica via sicura per collegare
queste aspirazioni politiche». «Lo straordinario boom economico era stato
costruito sull' oro rubato ai francesi. Finito quello, arrivò una crisi
altrettanto straordinaria». Ein Wort über unser Judenthum, saggio del 1880 in
cui Henrich von Treitschke getta le fondamenta dell' antisemitismo. Slogan:
«Ohne Juda, ohne Rom, bauen wir Germanias Dom» («Senza Giudei, senza Romani,
costruiamo la Chiesa di Germania»).
Roberto
Giardina per “Italia Oggi” il 24 novembre 2020. Leggo notizie catastrofiche
sulla scuola italiana, il 30% non saprebbe capire quel che legge, neppure
Topolino. E non si sa più scrivere. Nulla di nuovo. Trent' anni fa, mi
chiamarono per tenere otto lezioni a un corso di giornalismo medico scientifico.
Non ho mai capito bene a che servisse, ritengo che gli ospedali allora volessero
aprire degli uffici stampa. Era riservato a venti laureati in medicina. Quando
proposi come compito di riassumere in venti righe la mia lezione, mi guardarono
interdetti. Non si aspettavano che un futuro medico giornalista dovesse anche
scrivere. Ci riuscirono in due. Sarò stato troppo esigente. In Germania va
meglio, il che non significa che vada bene. Non c' è sera che sui due canali tv
pubblici, Ard e Zdf, o sulle reti regionali che trasmettono su tutto il
territorio nazionale, o su un' emittente privata, non venga trasmesso un krimi,
un telefilm giallo o noir che sia. I poliziotti, i commissari, la metà
rigorosamente donne, sono quasi tutti dei casi clinici, completamente fuori di
testa, alcolizzati e depressi, afflitti da capi sempre preoccupati di non
molestare il potente di turno, odiati dalla moglie e disprezzati dai figli.
Riescono a scovare il colpevole, che non sempre viene punito. I Polizisten non
sono eroi da imitare. Forse per questo in Germania non riescono a reclutare
poliziotti quando i vecchi vanno in pensione. Ne servirebbero diverse migliaia
ma è difficile trovare candidati all' altezza. Gli aspiranti, uomini e donne,
sono fuori forma, o non riescono a superare i test più facili. E, leggo sulla
Welt, non sanno scrivere. Basterebbe compiere un errore ogni sette parole per
essere idonei, ma non ce la fanno. L' anno scorso, il 20% degli aspiranti
poliziotti nei diversi Länder (la polizia, in Germania, è di competenza
regionale), non ha superato la prova del dettato. La colpa sarebbe anche della
Rechtschreibreform, la riforma del tedesco, decisa nel 2006, ma è l' anno in cui
i candidati sono entrati in prima elementare, quindi non hanno dovuto imparare
nuove regole di scrittura, decise a tavolino dai burocrati, alcune per la verità
astruse. In sintesi, in alcune parole composte si arriverebbe a scrivere tre «s»
di fila. Gli scrittori si sono ribellati, ma era troppo tardi. Fino all' ultimo
non avevano voluto credere che si facesse sul serio. La Bundespolizei, la
polizia federale, ha deciso di rendere più elementari le regole di reclutamento.
Ha portato gli errori «perdonabili» da 20 a 24 su un testo di 180 parole, cioè
una mezza paginetta al computer, in media un errore a riga. E si è deciso anche
di rinunciare alle classiche prove atletiche, al salto in lungo e alle
flessioni. Basterà dimostrare di avere un sufficiente equilibrio fisico. Già
adesso nei telefilm, quando un Kommissar deve inseguire un ladro o un killer di
solito si arrende con il fiatone. Così rassicurano i telespettatori in
sovrappeso. A volte ci riescono le colleghe, che ci tengono alla linea, non
bevono, e sono in forma. Ma è tollerabile che un Herr Kommissar non sia in grado
di superare l' esame di licenza elementare? È una domanda ipotetica, perché
questa prova in Germania è stata abolita da tempo.
DAGONEWS il 15 novembre 2020. Vi siete mai chiesti come mai in
Germania la nudità non è un tabù? Imbattersi in persone nude che prendono il
sole in un parco a Berlino è praticamente un rito di passaggio. Ma come mai? Non
c’entra molto il lato edonistico, ma è un esempio di Freikörperkultur, o
"cultura del corpo libero". L'FKK, come viene solitamente abbreviato, è
strettamente associata alla vita nella Repubblica Democratica Tedesca (Germania
dell'Est), ma il nudismo in Germania come pratica pubblica risale alla fine del
XIX secolo. E a differenza di togliersi la maglietta su una spiaggia in Spagna,
la FKK è un movimento tedesco più ampio con uno spirito distinto, il cui
significato è spogliarsi della propria essenza ed immergersi nel mondo naturale
come atto di resistenza e sollievo. «Il nudismo ha una lunga tradizione in
Germania - ha detto Arnd Bauerkämper, professore associato di storia moderna
alla Freie University di Berlino - All'inizio del XX secolo, la Lebensreform
("riforma della vita") era nell'aria. Si trattava di una filosofia che sosteneva
il cibo biologico, la liberazione sessuale, la medicina alternativa e una vita
più semplice e più vicina alla natura. Il nudismo fa parte di questo movimento
più ampio, che era contro la modernità industriale, contro la nuova società
emersa alla fine del XIX secolo». Secondo Hanno Hochmuth, uno storico del
Leibniz Center for Contemporary History Potsdam, questo movimento di riforma
prese particolarmente piede nelle città più grandi, inclusa Berlino. Durante la
Repubblica di Weimar (1918-1933), si crearono delle spiagge dell'FKK popolate
da "una minoranza molto, molto piccola" di membri della borghesia che prendevano
il sole. Secondo Bauerkämper, dava un «senso di nuova libertà dopo aver vissuto
in una società autoritaria e con valori conservatori soffocanti nella Germania
imperiale (1871-1918)». Nel 1926, Alfred Koch fondò la Scuola di nudismo di
Berlino per promuovere la nudità all'aperto capace di porci in armonia con la
natura. E se l'ideologia nazista inizialmente proibì l'FKK, considerandola
immorale, nel 1942 il Terzo Reich aveva ammorbidito le sue restrizioni sulla
nudità pubblica. Ma fu solo nei decenni successivi alla divisione del dopoguerra
della Germania Est e Ovest che l'FKK sbocciò davvero, in particolare nell'Est, e
non solo tra la classe borghese. Per i tedeschi che vivevano nella DDR
comunista, dove i viaggi, le libertà personali e le vendite di beni di consumo
erano limitati, l'FKK era una valvola di sfogo, un modo per scaricare la
tensione in un mondo pieno di restrizioni. Nel 1971 l'FKK venne ufficialmente
autorizzato di nuovo. Secondo Bauerkämper, sotto Honecker per la DDR sostenere i
nudisti era “un modo di far vedere che permettevano qualcosa”. Dalla caduta del
muro di Berlino, la cultura FKK è diminuita. Negli anni '70 e '80, centinaia di
migliaia di nudisti riempivano campeggi, spiagge e parchi. Nel 2019,
l'Associazione tedesca per la cultura del corpo libero contava solo 30.000
membri registrati, molti dei quali avevano tra i 50 e i 60 anni. Ma l'FKK ha
comunque lasciato una diffusa tolleranza in tutto il paese per gli spazi
dedicati alla nudità in pubblico vista come forma di benessere.
L'ultima follia tedesca: scrivere le leggi con i nomi al
femminile. La proposta della ministra Lambrecht divide
però il governo: una scelta incostituzionale. Daniel Mosseri, Mercoledì
14/10/2020 su Il Giornale. È possibile stendere un disegno di legge usando solo
termini al femminile? In Germania lo ha fatto l'ufficio legislativo di Christine
Lambrecht, ministra federale della Giustizia in quota al partito
socialdemocratico. Il testo di riforma del diritto fallimentare presentato da
Lambrecht ai colleghi del quarto governo di Angela Merkel contiene solo ed
esclusivamente termini come «imprenditrice», «impiegata», «consumatrice»,
«debitrice», «creditrice» e via discorrendo. Tutte le locuzioni che di solito
vengono usate in tedesco al maschile sono stati declinate al femminile. Alcuni
compagni di partito della ministra hanno trovato la novità interessante. «Trovo
positivo che finalmente si discuta di eguaglianza di genere nel linguaggio anche
nei testi legali», ha dichiarato la compagna di partito Katja Mast, numero due
della Spd per la Famiglia e gli affari sociali. Meno entusiasta si è invece
dimostrato il ministro federale degli Interni, Horst Seefoher. La stampa tedesca
ha ripreso la dichiarazione di un portavoce del dicastero in cui si apprende che
gli Interni chiederanno l'immediata revisione della bozza e la sua stesura nelle
forme classiche. La questione non è solamente di chiarezza o di tradizione: il
Viminale tedesco teme che la legge potrà trovare applicazione solo per le
persone del genere indicato nel testo. Una confusione che offrirebbe il fianco a
una sonora bocciatura del testo da parte della Corte costituzionale tedesca. Gli
esperti degli Interni hanno ricordato ai colleghi della Giustizia che in tedesco
la forma maschile si applica sia al genere maschile sia Femminile e che l'uso
del femminile non è ancora linguisticamente riconosciuto come una forma da
applicare a persone dei due generi. Se Seehofer si è affidato al linguaggio
burocratico per chiedere alla collega di tornare sui propri passi, il Consiglio
economico della Cdu non le ha mandate a dire. Parlando alla Augsburger
Allgemeine, il segretario generale dell'organizzazione che rappresenta gli
interessi di 12 mila pmi tedesche vicine alla Cdu ha accusato la ministra
Lambrecht di non prendere il proprio lavoro sul serio. «Il tempo per una riforma
del diritto fallimentare che crei trasparenza sta per scadere», ha affermato
Wolfgang Steiger. Il compito della ministra, ha ricordato Steiger «è evitare a
tutti i costi che un'ondata di fallimenti spazzi via le aziende sane. Il
ministero deve subito erigere delle dighe contro questa eventualità». Nominata a
giugno 2019 in sostituzione della precedente Guardasigilli Katarina Barley
eletta al Parlamento europeo, la ministra Christine Lambrecht è stata bacchetata
anche dalla Verein Deutsche Sprache (VDS), l'associazione per la tutela e la
promozione della lingua di Goethe. «Il fatto che fra tutti quelli che esistono,
sia proprio il ministero della Giustizia a non essere in grado di formulare un
testo giuridicamente vincolante è notevole», ha osservato impietoso il
presidente della VDS, Walter Krämer. Matematico e statistico di formazione, ed
economista di professione, Krämer ha poi ricordato che soprattuto i testi legali
devono essere a priva di fuoco laddove «questa formulazione ambigua sembra un
invito a contestare la legge». Il fatto che i testi legali dovrebbero riflettere
l'uguaglianza tra uomini e donne è una questione diversa, ha concluso Krämer «ma
il solo uso della forma femminile è privo di qualsiasi ragione e di ogni regola
linguistico-grammaticale».
Dagonews il 28 ottobre 2020. Quanti cuori vengono strapazzati
dalla politica e dal potere! Quel farfallone senza limitismo di Beppe Grillo e
la moglie iraniana, la bella Parvin Tadjk, dopo 24 anni di matrimonio e due
figli, si sarebbero allontanati, forse per sempre (pur condividendo ancora la
stessa villa di Genova). La goccia che ha fatto traboccare la loro relazione è
stata la vicenda giudiziaria in cui è coinvolto il figlio Ciro, accusato di
stupro. Ma se la vita da rubacuori di BeppeMao è stata sempre oggetto di
pettegolezzi, quella di Angela Merkel è sempre stata al di sopra di ogni
sospetto. Eppure, alcune malelingue esperte di questioni tedesche, hanno
riferito a Dagospia una storia che ha dell’incredibile. Ricordate quando, a
giugno 2019, la Cancelliera - durante una cerimonia con il presidente ucraino
Zelenskyj - ebbe una strana tremarella? Si parlò di disidratazione, poi di un
danno neurologico, addirittura di morbo di Parkinson. L’Europa impallidì
all’idea che la sua regina fosse “depotenziata” da un problema di salute. Nulla
di tutto questo. Dopo più di un anno, scopriamo che quei disturbi erano i
patimenti di un cuore spezzato: il marito, Joachim Sauer, l’aveva lasciata! Il
71enne professore di chimica all’Università “Humboldt” di Berlino aveva una
tresca con una sua ex allieva. La scoperta delle corna fu uno shock tremendo per
la 66enne Cancelliera. Lei, figlia di un pastore luterano, forgiata nell’austera
Germania dell’Est comunista, così fortemente legata al senso del dovere, si
ritrovò al di là di una crisi di nervi. Fu ostaggio di una tale depressione che
quasi “rinunciò” a governare la Germania per tre-quattro mesi. Alcuni medici,
forse centrando il bersaglio, sostennero che i tremori fossero dovuti all’uso (o
abuso?) di psicofarmaci, probabilmente usati in modo massiccio per contrastare
l’avvilimento e lo sconforto di quel periodo. Anche la donna più potente
d’Europa, si ritrovò con un fazzoletto intriso di lacrime a causa di un marito
infedele. Fu la passione per la politica a tirarla fuori dalla palude (e infatti
quei tremori non si sono più rivisti). Quella stessa politica che, prima di
allora, sembrava fosse sul punto di mollare a beneficio di Ursula von der Leyen
o di qualche altra “delfina” equivalente. Rituffarsi nell’agone è stato un
tonico salva-vita per l’umore della Cancelliera che da leader vicina alla
pensione oggi si ritrova presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea
alle prese con problemi enormi per la crisi pandemica. E il marito birichino? Il
professor Sauer, beccato con le mutande in flagrante, non ha smesso di dare
“ripetizioni” alla sua ex allieva. Porta avanti la sua liason extraconiugale,
all’interno di un accordo definito: finché Angela Merkel è sotto i riflettori,
ognuno fa la sua vita con discrezione e riservatezza.
"Angela Merkel non ci lasciare": i tedeschi non vogliono fare
a meno della Cancelliera. Inquietudine, ansia, paura.
In Germania si vive l’annunciata uscita di scena della "ragazza dell'Est" come
un salto nel buio. E tanti vogliono che cambi idea. Roberto Brunelli il 13
ottobre 2020 su L'Espresso. Angela Merkel è molto brava con i numeri, questo si
sa. «Ho semplicemente elaborato un modello di calcolo. A luglio avevamo 300
nuovi contagi, ora ne abbiamo 2400. Questo significa che in tre mesi le
infezioni sono raddoppiate tre volte: da 300 a 600, da 600 a 1200, da 1200 a
2400. E se continuasse così, nei prossimi tre mesi si passerebbe da 2400 a 4800,
da 4800 a 9600, a 19.200. Con questo volevo semplicemente sottolineare l’urgenza
dell’azione». Et voilà. Ecco di nuovo la cancelliera-scienziata, la mamma di
tutti i tedeschi, che spiega senz’ombra di pathos la chiave ineluttabile della
guerra contro il coronavirus. Parole scandite con sovrana tranquillità, la
giacchetta del tailleur questa volta è bianca, il video come sempre virale come
quello di un’influencer. E poi, dopo il suo discorso al Bundestag in cui parla
di “società aperta e libera”, subito è la Cdu - certo, il suo partito - a
twittare con entusiasmo: «È un bene che in tempi come questi Merkel sia la
nostra cancelliera». Il riferimento è alla pandemia, ma non solo: ci sono di
mezzo la svolta europea del Recovery Fund, praticamente una sua creatura,
l’antagonismo certo non dissimulato verso l’uragano Trump, la complicatissima
partita con la Cina di Xi Jinping, la difesa delle manifestanti in bianco e
rosso di Minsk e la sfida a Putin, resa incandescente dall’avvelenamento del
sommo dissidente Aleksei Navalny (non a caso - è lui ad esprimersi così -
salvato a Berlino).
Roberto Brunelli per espresso.repubblica.it il 13 Ottobre 2020.
Angela Merkel è molto brava con i numeri, questo si sa. «Ho semplicemente
elaborato un modello di calcolo. A luglio avevamo 300 nuovi contagi, ora ne
abbiamo 2400. Questo significa che in tre mesi le infezioni sono raddoppiate tre
volte: da 300 a 600, da 600 a 1200, da 1200 a 2400. E se continuasse così, nei
prossimi tre mesi si passerebbe da 2400 a 4800, da 4800 a 9600, a 19.200. Con
questo volevo semplicemente sottolineare l’urgenza dell’azione». Et voilà. Ecco
di nuovo la cancelliera-scienziata, la mamma di tutti i tedeschi, che spiega
senz’ombra di pathos la chiave ineluttabile della guerra contro il coronavirus.
Parole scandite con sovrana tranquillità, la giacchetta del tailleur questa
volta è bianca, il video come sempre virale come quello di un’influencer. E poi,
dopo il suo discorso al Bundestag in cui parla di “società aperta e libera”,
subito è la Cdu - certo, il suo partito - a twittare con entusiasmo: «È un bene
che in tempi come questi Merkel sia la nostra cancelliera». Il riferimento è
alla pandemia, ma non solo: ci sono di mezzo la svolta europea del Recovery
Fund, praticamente una sua creatura, l’antagonismo certo non dissimulato verso
l’uragano Trump, la complicatissima partita con la Cina di Xi Jinping, la difesa
delle manifestanti in bianco e rosso di Minsk e la sfida a Putin, resa
incandescente dall’avvelenamento del sommo dissidente Aleksei Navalny (non a
caso - è lui ad esprimersi così - salvato a Berlino). Il fatto è che la Germania
Anno Domini 2020 segue la sua cancelliera. È da mesi che, sull’onda della
pandemia, la sua popolarità veleggia intorno a un abnorme 80% dei consensi,
mentre il blocco Cdu/Csu di cui è espressione arriva a sfiorare il 40%, più o
meno sette punti più del 32,9% del 2017. Nella classifica “Deutschlandtrend” dei
politici più apprezzati Merkel stacca di dieci punti il secondo arrivato, ossia
il ministro alla Sanità Jens Spahn, e di venti punti il candidato
socialdemocratico alla cancelleria Olaf Scholz. Raramente una nazione si è
identificata con tanto trasporto in chi lo guida: lo dicono i sondaggi, lo
dicono le chiacchiere da bar, lo dice la politica. Numeri fantascientifici ad
altre latitudini, con la Germania del “Merkel IV” che sembra aver trovato una
centralità globale impensabile solo pochi anni fa, quando il Paese rimaneva
inchiodato all’aggettivo “riluttante” immancabilmente associato all’espressione
“egemone” utilizzata per definire il colosso al centro dell’Europa. L’ultimo
paradosso tedesco è tutto lì: la cancelliera più amata e più riverita nel mondo
tra un anno se ne va, lascia alla fine della legislatura. E immaginarsi la
Germania senza Merkel è un salto nell’ignoto. La cancelliera appare
insostituibile, e la sua mano ferma nella gestione della pandemia ha rafforzato
questa immagine una volta di più. Thomas Schmid, editorialista ed ex direttore
della Welt, quotidiano di riferimento del mondo conservatore, ricorre ad un
paragone storico: «Quando Adenauer si dimise dopo 14 anni da cancelliere, nel
1963, su un giornale tedesco apparve una caricatura che mostrava un uomo
anziano, con un berretto da notte in testa, il quale, aprendo le tende della sua
camera da letto, esclama: “Incredibile, siamo già da otto giorni senza Adenauer,
eppure il sole continua ancora a sorgere”. Ebbene, molti tedeschi si sentiranno
nello stesso modo quando Merkel non sarà più cancelliera». Così, da tempo corre
sottotraccia l’ipotesi di un inusitato quinto mandato targato Merkel, nonostante
lei abbia ripetuto fino allo sfinimento che non si ricandiderà. La domanda che
si ripete in tutta la Germania, anche in ambiti culturalmente lontanissimi dalla
cancelleria, è sintetizzata in maniera piuttosto efficace da un tweet
dell’autrice tedesca di origini turche Sibel Schick: «Non sono una fan di
Merkel. Ho semplicemente paura di quello che viene dopo. Perché certamente non
sarà meglio, ma molto peggio». Poi ci si sono i numeri. Numeri che passano di
mano in mano a Berlino, dove si è incerti se prenderli con gioia o con terrore,
e che dicono che l’addio della cancelliera aprirà una voragine: fino al 48%
degli elettori della Cdu potrebbe votare un altro partito se Merkel dovesse
davvero andarsene. Dice, inoltre, il rilevamento dell’istituto Forsa, che il 30%
di chi vota cristiano-democratico potrebbe rivolgersi ai Verdi, il 19% all’Spd,
il 18% ai liberali dell’Fpd e solo il 3% all’ultradestra dell’Afd.
«Potenzialmente un terremoto», si va sussurrando in casa Cdu. Dove si sa
benissimo che Merkel è il convitato di pietra delle prossime elezioni: perché se
non si candiderà si tratterà di riempire una voragine, mentre se rimanesse in
pista, lei che è al governo ininterrottamente dal 2005, si creerà un precedente
mai visto in una democrazia occidentale avanzata. «Però è evidente è con la sua
statura globale e la sua popolarità rappresenterebbe un asso formidabile alle
elezioni dell’autunno 2021», ci dice a microfoni spenti un deputato. Tutti a
Berlino ti ripetono che il terremoto di cui sopra si presta a scenari del tutto
impensabili neanche un anno fa, quando la cancelliera era ancora un’“anatra
zoppa”. Costretta alle dimissioni da leader di una Cdu alla frenetica ricerca
dell’identità perduta sotto i colpi della post-ideologia merkeliana che tanto
piace agli elettori di ambito progressista: la “politica delle porte aperte”
nella crisi dei migranti del 2015, prima ancora l’uscita dal nucleare, poi il
matrimonio tra persone dello stesso sesso e infine l’inaudito Recovery Fund da
750 miliardi di euro per i Paesi più colpiti dalla pandemia, giunto a
ristabilire nuovi standard nell’Ue dopo anni passati a stragiurare che mai e poi
mai Berlino avrebbe accondisceso alla condivisione del debito. La prima a
lanciare il sasso nello stagno è stata la Bild, poi è stato il ministro
all’Interno Horst Seehofer a evocare la possibilità che Merkel decida di restare
al suo posto. Lo Handelsblatt è stato più esplicito: «Si sta avvicinando il
quinto mandato», scriveva tempo fa il principale quotidiano economico tedesco,
puntando il dito soprattutto sulla debolezza dei possibili successori. In
effetti, si guarda con malcelata ansia al congresso della Cdu di inizio
dicembre. Non solo perché il partito che fu di Adenauer e di Kohl sotto la
coperta del merkelismo oggi appare lacerato, ma anche e soprattutto perché i tre
candidati “ufficiali” alla leadership - il capo della corrente di destra
Friedrich Merz, il governatore del Nord-Reno Vestfalia Armin Laschet e il
presidente della Commissione Esteri Norbert Roettgen - scontano la somma delle
loro debolezze, tanto che c’è persino chi arriva a temere una scissione. È che
nessuno dei tre sembra in grado di risolvere il rompicapo delle alleanze dopo il
voto federale dell’autunno 2021: la Spd - attualmente al governo con la Cdu
nella Grosse Koalition - non riesce a riemergere dagli abissi dei sondaggi, che
la inchiodano al 15%, mentre i Verdi di Robert Habeck e Annalena Baerbock,
stando agli istituti demoscopici, sono ormai la seconda forza politica della
Germania. Tanto che i più danno per scontata la loro alleanza con i
cristiano-democratici, che sarebbe una primizia assoluta nella storia politica
tedesca. Una Germania solidamente “nero-verde” al centro dell’Unione europea.
Una prospettiva, tuttavia, impossibile se a vincere dovesse essere
l’iper-liberista Merz, già presidente del consiglio di vigilanza di BlackRock
Germany, comunque abbastanza stridula sia con Laschet che con Roettgen.
Paradossalmente, quello con le maggiori chances sarebbe il ministro alla Sanità
Spahn, che tuttavia ha il piccolo difetto di non essere candidato. A bordo campo
si muove poi il governatore della Baviera, Markus Söder, leader dell’Unione
cristiano-sociale, il partito “fratello” della Cdu: astuto e con lo sguardo
lungo, Söder da tempo ha mostrato sensibilità per le tematiche ambientali, ma la
caratura storicamente più conservatrice della Csu rende più complicato un
abbraccio con i Verdi 2.0 di Habeck & Baerbock. «Infatti io credo che Söder
resterà in Baviera», commenta il socialdemocratico Matthias Machnig, considerato
lo stratega dell’ultima grande vittoria elettorale dell’Spd, quella delle
elezioni europee del 2014. Secondo Machnig, è proprio l’alleanza “nero-verde”
l’esito più plausibile dell’autunno 2021: «Tutt’e due i partiti vogliono questa
coalizione. La disposizione d’animo a realizzarla va ben oltre le persone, anche
se deve essere chiaro che si dovranno fare dei compromessi», mentre una
riedizione della Grosse Koalition «non è più considerata un’opzione realistica».
Impensabili accordi con l’Afd, dilaniata e schiacciata ai margini finanche dalla
pandemia, o con la sinistra della Linke, esili le prospettive dei liberali, che
con il loro 5% potrebbero persino rimanere esclusi dal Bundestag. In effetti, la
garante perfetta per un’alleanza nero-verde porta il nome di Angela Merkel, la
“Klimakanzlerin” che decise l’uscita dal nucleare, colei che non ci pensa due
volte a ricevere Greta Thunberg quando l’icona svedese si trova a Berlino. «Io
escludo che si ricandiderà», ribatte invece Ralph Bollmann, giornalista del
domenicale della Frankfurter Allgemeine nonché acclamato biografo dell’ex
“ragazza dell’est” con il suo “La tedesca: Angela Merkel e noi”. «Già all’altro
giro voleva smettere, poi è rimasta a causa dell’elezione di Trump, scelta di
cui si è pentita mille volte prima del virus». A meno che, ammette lo stesso
Bollmann, «una maggioranza chiara non ci sia e si riveli molto difficile la
formazione di un nuovo governo: allora Merkel si troverebbe nelle condizioni di
restare in Cancelleria, almeno fino a elezioni anticipate». Il punto è che la
figlia del pastore Kasner non solo ha abituato la Germania e il mondo a
improvvise svolte inattese, ma anche mostrato spesso di avere la stoffa
dell’araba fenice. Jeremy Cliffe, reporter del New Statesman e uno dei più acuti
osservatori di cose tedesche, si è divertito a mettere insieme un po’ di vecchi
titoli della stampa internazionale: “È in vista la fine dell’era Merkel”,
sostiene il Financial Times nel 2015. “Arriva la fine dell’era Merkel”, echeggia
il New York Times nel 2016. “La lunga e dolorosa fine di Angela”, è il verdetto
di Politico nel 2018. Oggi la storia è tutta un’altra. «La tormentata Germania
del 2005 sarebbe diventata la Germania più aperta e consapevole del 2020 senza
di lei? Sospetto di no», sibila su Twitter Cliffe, secondo il quale la
possibilità che Merkel si ricandidi «è del 10% se Trump dovesse vincere il voto
americano». Ancora ipotesi da Sudoku globale, ancora una battaglia di numeri.
Pane per i denti della scienziata di nome Angela.
Gloria Remenyi per “la Stampa” il 4 ottobre 2020. C'è una parola
che è risuonata chiaramente nella giornata del 30° anniversario della
Riunificazione tedesca. È «coraggio» il termine su cui hanno puntato il
Presidente della repubblica Frank-Walter Steinmeier e la cancelliera Angela
Merkel nei discorsi per le celebrazioni ufficiali che quest' anno si sono svolte
a Potsdam. «Anche oggi abbiamo bisogno di coraggio e possiamo averlo, proprio
come 30 anni fa» così Steinmeier ha voluto creare un ponte tra la Riunificazione
e le sfide del presente, dalla pandemia alla crisi delle alleanze
internazionali. Sulla stessa linea anche Merkel: «Dobbiamo avere il coraggio di
superare le differenze ancora esistenti tra Est e Ovest, ma anche di lavorare
per una vera coesione della società». Ma non sono stati soltanto gli appelli
della politica a dominare la scena di questo anniversario. Il 3 ottobre è stato
anche una giornata di manifestazioni in tutto il Paese, di cui circa 60 soltanto
tra Potsdam e Berlino. Il gruppo di sinistra Re:Kapitulation si è riunito per
contestare la narrazione dell'Unità tedesca propagata dalla politica e infarcita
di retorica e patriottismo. «Il 3 ottobre non c'è nulla da festeggiare» scrive
il collettivo sul proprio sito. Per Re:Kapitulation la Riunificazione non è una
storia di successo, bensì di ingiustizia e discriminazione. Lo dimostrerebbe -
secondo il gruppo - una serie di eventi che hanno segnato gli ultimi tre
decenni: dall'affermazione del mito escludente della nazione agli attentati
razzisti del dopo Riunificazione. Ad Alexanderplatz si è radunata l'associazione
socialista Unentdecktes Land (Terra inesplorata) che considera la Riunificazione
nient' altro che un'annessione della Ddr alla Brd: «Pace anziché esercito,
druzhba (in russo «amicizia») anziché nazisti, vita anziché sopravvivenza: la
Ddr era diversa» recitava uno degli striscioni esposti sabato. A scendere in
piazza sono stati però anche gruppi le cui istanze hanno poco a che vedere con
l'anniversario, ma che cercavano visibilità. Su tutti, gli estremisti di destra
che già da tempo hanno fatto del 3 ottobre un appuntamento fisso per occupare lo
spazio pubblico: contestati da centinaia di contromanifestanti e gruppi
antifascisti, a Berlino hanno sfilato neonazisti affiliati al partito Der III.
Weg e alla scena dei «Reichsbürger», estremisti di destra nostalgici dell'Impero
tedesco. Pure i negazionisti del Covid ne hanno approfittato: non sempre con
successo A Costanza il movimento Querdenken (Pensiero alternativo) aveva indetto
diversi cortei: ma stando alle prime stime, pare che su 15.000 persone attese se
ne siano presentate circa 1.000.
30 anni fa l'unificazione tedesca. Cosa
resta della Germania dell’Est, l’ex DDR "uccisa" 30 anni fa dall’unificazione
tedesca. Paolo Guzzanti su
Il Riformista il 6 Ottobre 2020. Sono passati trent’anni da quando la DDR,
Repubblica democratica tedesca, è stata cancellata dalle carte geografiche
assorbita dalla Germania Federale, di cui ha rappresentato per almeno un
decennio il maggior problema sociale e finanziario, quando le fu di fatto
imposta la riunificazione secondo le regole di mercato. Se un tempo ti rendevi
conto, in aereo, di quando passavi dalla Germania occidentale piena di luci a
quella comunista con poche luci giallastre, oggi sappiamo che l’effetto ottico è
finito, ma che una parte della vecchia anima e del vecchio malumore ancora
esiste. Chi aveva trent’anni allora oggi ha i capelli bianchi ma ricorda
talvolta con nostalgia. Nostalgia di che cosa? Probabilmente di una Germania
paradossalmente un po’ anarchica e libertaria malgrado il regime di polizia,
affamata di libertà ma per nulla convinta di voler far parte del sistema
capitalista. Diciamo che la DDR era l’unico Stato comunista, voluto dall’Unione
Sovietica, che abbia avuto successo. Inevitabile la battuta sul fatto che i
tedeschi, basta che tu gli dia un ordine e quelli eseguono, ma non è così. La
nostra memoria collettiva ha molti buchi e una riguarda la fine della DDR. Che
cosa ricordiamo, in fondo? Il Muro, le folle che liberate dalla prigionia
sciamano in occidente sulle piccole Trabant come canarini che hanno trovato la
gabbia aperta, ricordiamo il cancelliere della Germania occidentale Helmut
Khol gigantesco e immobile (“Sembra a un funerale” disse in diretta un cronista
della DDR), e poi la riunificazione, la fine di quel piccolo Stato che durò 41
anni, essendo nato formalmente nel 1949 e che aveva celebrato prima della caduta
del muro i quarant’anni di esistenza con una gigantesca “Parade” in cui i
soldati marciavano al passo dell’oca come ai tempi di Hitler, ma anche come ai
tempi dell’imperatore Guglielmo, figlio della regina Vittoria e che si sentiva
tanto inglese quanto Hohenzollern. Trombe e tromboni e colori sgargianti,
bambini biondi e generaloni con cappelli troppo alti e soldati dalle uniformi
verdi per far dimenticare il grigio-azzurrino del Terzo Reich. Ma – ecco un
punto interessante – quando l’Unione Sovietica mise al mondo questa Germania
satellite, pari a circa la metà di quella occidentale che riuniva le ex zone
d’occupazione americana, inglese e francese, volle che fosse una Germania molto
tedesca. Non russificata. La Germania pre-nazista aveva avuto un partito
comunista prestigioso come quello di Rosa Luxemburg (uccisa prima
che Hitler fosse in campo) e poi un partito comunista che era stato una
succursale del Pcus. Fu disegnata così, questa nuova Germania comunista:
conservatrice in fatto di tradizione. L’elmetto tradizionale dei soldati fu un
po’ allargato, ma la nuova Armee era più imperiale della Bundeswehr
tedesco-occidentale. Negli anni Settanta e Ottanta i tedeschi orientali
discutevano con gli occidentali sulla purezza della lingua, perché il tedesco si
stava culturalmente sdoppiando: quello dell’Est era ossessivamente purista,
degno di Kant e di Rilke; e quello occidentale deformato dagli americanismi.
Nella RDT i giovani comunisti che frequentavano i bar, i rari ristoranti e gli
auditorium erano autentici. Ricordo che per andare la sera al Teatro dell’Opera
a Berlino Est gli operai si aggiustavano la tuta con camicia bianca e qualcosa
che desse l’idea di un abito da sera. C’erano sempre molti giovani comunisti,
cosa totalmente diversa da quel che accadeva in Cecoslovacchia dove vissi il
mese drammatico della caduta del regime: o in Polonia dove i giovani erano sotto
una ferrea guida cattolica, a sua volta ferreamente sorvegliata dai servizi
segreti. In un recente documentario una vecchia militante
della Raf (organizzazione terroristica della Germania occidentale) passata ad
Est diceva: «Era chiaro che quando arrivarono quelli dell’Ovest, l’unico loro
scopo era distruggere la nostra DDR. Stavamo benissimo con due soli tipi di
yogurt, uno con le fragole e uno senza fragole, e adesso di yogurt ce sono
sessanta». E chi è stato l’ultimo rappresentante formale di quel piccolo Stato?
Una donna: una certa Angela Dorothea Kasner, una ragazza di Amburgo figlia di un
pastore protestante. Diventerà Merkel col matrimonio ma allora era una
studentessa di fisica molto brillante iscritta alla gioventù del partito che si
chiamava Movimento Giovanile socialista: parla bene, idee chiare e diventa una
delle migliori Aghitrop, il perfetto equivalente
dell’italiano Agit-Prop (attivista della sezione Agitazione e Propaganda) del
vecchio Pci. E diventò la portavoce del governo della RDT. L’ultima. Quella
donna quadrata, testarda, non indifferente alle emozioni ma convinta di quel che
pensa, è una laureata in fisica quantistica, che non è roba per tutti. Durante
la competizione spaziale negli anni della guerra fredda, girava una vecchia
battuta: «I fisici tedeschi dei russi sono migliori dei fisici tedeschi degli
americani». Quel fisico tedesco lì, Angela, passò nelle file occidentali
della CDU del cancelliere Helmut Kohl che la nominò ministro per le donne. A
quel punto era accaduto qualcosa che tendiamo a dimenticare. In Europa non erano
molti i fan alla riunificazione tedesca perché avevano tutti paura di una grande
Germania unita. Andreotti disse: «Adoro talmente i tedeschi che di Germanie ne
vorrei avere sempre almeno due». Fu allora che Kohl andò a Parigi per fare ai
francesi e gli altri europei la proposta che non si può rifiutare: se ci
autorizzate all’unificazione, noi in cambio daremo all’Europa il nostro Deutsche
Mark e lo chiameremo Euro. La fine è nota. La Germania Est formalmente
funzionava. Ma secondo quasi tutti gli storici ed economisti aveva i giorni
contati. Funzionava socialmente nel senso che tutti avevano una casa, un lavoro,
scuola e assistenza medica gratuita. Ma secondo la visione occidentale non
funzionava perché non produceva risorse, ma si limitava a consumarle.
Producevano nubi di nero fumo e spargevano gas. Tutto l’Oriente socialista era
inquinante cinque o sei volte l’Occidente. Resistenze ai cambiamenti,
burocrazia, diffidenza verso il nuovo. Ma nel quadro generale, la DDR era un
Paese di sogno rispetto agli altri “buffer States”, Stati cuscinetto con cui
la Russia di Stalin aveva deciso di proteggersi da eventuali invasioni,
ripetendo lo schema zarista. C’era la Stasi, ma è ridicolo che in Italia e
in Europa la Stasi sia diventata popolare soltanto per il film “Le vite degli
altri” che rivelava una realtà piatta, normale e comune a tutto l’Est: la Stasi
– come il KGB – non era soltanto una polizia segreta ma un’istituzione
totalizzante. La Stasi promuoveva carriere e concorsi, ingressi nelle scuole, un
nuovo appartamento e per questo, sempre come il KGB, aveva bisogno di sapere
sempre tutto su tutti, specialmente ciò che è insignificante. Lo scrittore
praghese Ivan Klima, che conobbi nella sua casa che somigliava a una discarica,
scrisse un bellissimo e premiato romanzo, “Amore e spazzatura”, ricostruendo
dagli scarti nei bidoni la vita erotica di persone depresse in una società che
non smaltiva rifiuti. A Berlino o a Lipsia era lo stesso. A Lipsia era la grande
sede tedesca del KGB sovietico di cui uno degli ultimi ufficiali è stato il
colonnello Vladimir Putin, che infatti parla un decoroso tedesco. Lì, Stasi e
KGB fondevano le loro strategie e conoscenze come ho già raccontato a proposito
delle imprese della banda di Carlos “lo Sciacallo” che aveva base a Budapest. Ma
la Stasi era una eccellente agenzia di intelligence che reclutava facilmente
nella Germania capitalista dove fece il colpo del secolo arruolando il
brillantissimo agente Gunter Guillaume che diventò il segretario personale
di Willy Brandt, prima sindaco di Berlino Ovest e poi cancelliere
della Repubblica federale tedesca. Lo storico russo naturalizzato inglese Boris
Volodarsky – ex colonnello del servizio segreto sovietico e oggi accademico
occidentale – mi mostrò le foto di sé stesso e dei suoi uomini travestiti da
soldati americani su un finto carro armato americano mentre se ne andavano a
zonzo nella Germania occidentale sotto la direzione della Stasi, beffando
la Nato. Quando arrivarono gli occidentali nella DDR dopo la caduta del muro nel
novembre del 1989 i dirigenti di quel Paese ormai orfano tentarono di ottenere
una autonomia formale insieme a un grande prestito con cui promettevano in
quattro anni di riciclare e rendere competitive tutte le industrie della
repubblica socialista per renderle competitive. Ma a Bonn non ne vollero sapere:
dovete buttare via tutto, prenderemo noi il controllo – risposero – e non
concederemo un solo marco. Ne seguì una crisi esistenziale catastrofica di cui
noi non sappiamo o ricordiamo nulla: manifestazioni di piazza, scontri con la
polizia, suicidi, disperazione. Per distruggere le vecchie imprese di Stato fu
mandato da Berlino un esperto liquidatore di aziende: un uomo massiccio e
benevolo dall’espressione comprensiva e triste di nome Detlev Rohwedder. Era il
presidente della Treuhand, società specializzata nello smembrare fabbriche
inutili e crearne di nuove. Intanto, tutti – o quasi – licenziati e in cassa
integrazione. Un rapporto integrale sullo stato dell’industria diceva che il
personale era assenteista e indisciplinato e i prodotti non competitivi con
quelli occidentali e senza mercato. Il cancelliere Kohl disse in televisione:
«Molti staranno meglio ma nessuno starà peggio». Ma gli uffici di collocamento
non smaltivano la lista d’attesa. Le donne furono le prime ad essere sbattute
fuori. E fu allora – eravamo nel 1990 – che tornò a farsi sentire la RAF,
l’organizzazione terrorista simile alle nostre brigate rosse. E Rohwedder fu
assassinato all’imbrunire con una operazione talmente perfetta da essere
considerata dagli esperti “di tipo militare”. L’omicidio fu rivendicato
dalla RAF che però non esisteva più da anni. Oggi, a trenta anni di distanza,
tutti gli analisti sostengono che l’eliminazione di Rohwedder fu l’ultima
operazione della Stasi, formalmente disciolta. Era il 2 aprile 1991
a Düsseldorf quando Detlev Rohwedder in piedi nel suo studio ebbe la schiena
spezzata da un colpo di fucile di precisione che attraversò i vetri della
finestra. Il liquidatore era stato liquidato dagli ultimi agenti della Stasi.
Oggi, a trent’anni di distanza tutti sono d’accordo nel dire che la Germania ha
vissuto il periodo di maggior crescita, influenza e potenza commerciale, senza
per questo diventare un pericolo per l’Europa e per il mondo. Angela, la piccola
giovane comunista diventata cancelliere, su questo argomento è stata e resta
perentoria: la sua Germania non intende mai usare le armi, neppure nelle
missioni di pace. Ciò manda in bestia gli americani che la accusano di sbafare
la costosa protezione militare americana e di spendere quanto risparmiato con
una produzione eccessiva che espelle dal lavoro gli operai americani. Questa è
la principale ragione dell’“America First” di Donald Trump che non ama
la Merkel e il sentimento è reciproco. Ma ancora oggi la grande Germania unita è
sotto il comando di una rodata agit-prop della gioventù comunista
della Repubblica democratica tedesca, a tempo perso laureata in fisica
quantistica.
Germania, sono 319 gli estremisti di destra nelle forze di
sicurezza. Pubblicato martedì, 06 ottobre 2020
da Tonia Mastrobuoni su La Repubblica.it. "I numeri sono piccoli": per il
ministro dell'Interno Horst Seehofer che ha presentato il primo rapporto
nazionale sull'estremismo di destra negli apparati di sicurezza in Germania "non
c'è un problema strutturale" di filonazismo nei servizi segreti o nella polizia.
"La stragrande maggioranza, ossia oltre 99% dei dipendenti, sono fedeli alla
costituzione" ha scandito in conferenza stampa. Il rapporto, riferito al periodo
che va dal 1 gennaio 2017 al 31 marzo del 2020, cita però 319 casi di sospetti
simpatizzanti dell'ultradestra rilevati negli uffici regionali, cui si
aggiungono 58 scovati negli apparati federali. Di questi ultimi, ben 44
estremisti erano nascosti nella polizia federale, sei nella polizia criminale e
altri nella dogana, ma anche nei servizi segreti interni ed esteri
(Verfassungsschutz e Bundesnachrichtendienst). Un capitolo a parte riguarda la
Bundeswehr: tra i soldati i servizi segreti militari avrebbero rintracciato ben
1064 sospetti estremisti. La stragrande maggioranza dei 319 casi rilevati negli
apparati di sicurezza riguarda lo scambio di messaggi razzisti o svastiche e
simboli antidemocratici nelle chat; solo una minoranza partecipa a riunioni o
gruppi o manifestazione estremiste. Resta il mistero sul perché il ministro
della Csu non ritenga necessario approfondire in particolare il tema del
razzismo nella polizia, dopo i clamorosi casi di neonazisti e nostalgici del
Reich riemersi nelle ultime settimane. "È un tema universale", si è schernito.
Aggiungendo soltanto che ogni caso di estremismo "è una vergogna". Il capo dei
servizi segreti interni, Thomas Haldenwang, gli ha fatto eco, definendo ogni
caso di radicalizzazione "un caso di troppo" e ha promesso una stretta
sorveglianza sull'estremismo bruno negli uffici di chi "ha giurato fedeltà alla
costituzione". Il capo della polizia federale, Dieter Romann, ha ricordato che
31 dei 44 neonazisti o nostalgici del Reich scovati tra gli agenti "sono emersi
grazie alla segnalazione dei colleghi: vuol dire che non vengono tollerati". Ma
Romann, dopo settimane di polemiche per l'emersione di casi gravi nella polizia
del Nordreno-Westfalia e dell'Assia, insiste che "non vediamo reti di estrema
destra" nella polizia. Il numero uno della Bundespolizei respinge "ogni accusa
di razzismo latente, anche l'argomento che avremmo un problema strutturale non è
fondato".
Neonazismo, rimosso il capo dell'intelligence tedesca.
La ministra della Difesa di Berlino manda via il numero uno
dei Servizi segreti: “Serve una svolta nella lotta all’infiltrazione estremista
nelle forze armate”. Gianluca Di Feo su La Repubblica il 24 settembre 2020.
È una marea nera, che sta contagiando le istituzioni tedesche: un’ondata
neonazista sempre più diffusa tra le polizie e le forze armate della Germania.
Per questo la ministra della Difesa ha deciso una misura drastica: la rimozione
del capo dei servizi segreti. Annegret Kramp-Karrenbauer, esponente di spicco
della Cdu e fino allo scorso febbraio candidata a succedere ad Angela Merkel, lo
ha decretato con una mossa improvvisa: Christof Gram sarà sostituito il prossimo
mese dalla guida dell’intelligence. La ministra gli ha riconosciuto l’impegno
nell’avere avviato riforme e migliorato il lavoro dei Servizi ma ha dichiarato
che la prossima fase della riorganizzazione richiede una svolta «che deve essere
visibile anche in termini di persone». Il governo federale infatti è sempre più
preoccupato per il dilagare delle adesioni a formazioni di ultradestra tra i
militari. Una situazione così grave da avere spinto nello scorso luglio a
sciogliere una compagnia delle forze speciali: le leggendarie Ksk create
all’indomani dell’attacco palestinese alle Olimpiadi di Monaco, diventate il
modello di tutte le teste di cuoio europee. «Si è permesso a una cultura di
estremismo di diffondersi dietro un muro di segretezza», aveva dichiarato allora
Annegret Kramp-Karrenbauer. I commandos incriminati non si erano limitati agli
slogan sul Reich e alle feste con saluti hitleriani: avevano fatto sparire dalla
caserma chili di esplosivo e 48 mila proiettili. Nessuno di loro ha collaborato
con le autorità, dimostrando l’esistenza «di una cultura tossica del comando». E
così la ministra ha ordinato la ristrutturazione dell’intero corpo speciale,
l’élite combattente della Germania moderna, impegnato in patria e all’estero
nella lotta contro il terrorismo. È dal 2017 che gli episodi di infiltrazione
neonazista vengono segnalati, spesso legati alla xenofobia contro gli immigrati.
Un soldato venne arrestato proprio mentre pianificava attentati che dovevano
essere falsamente attribuiti a sigle islamiche. Da allora ben 600 membri delle
forze armate sono finiti sotto inchiesta per i legami con gruppi della destra
radicale. Un fenomeno così esteso da spingere il governo a varare una legge per
semplificare il congedo dei militari sospettati di estremismo. Il compito di
bonificare le istituzioni è stato affidato ai servizi segreti. E Christof Gram
venne scelto da Angela Merkel nel 2015 dopo che erano emerse ombre anche sul
comportamento di agenti dell’intelligence: Gram era un esperto di diritto, che
ispirava fiducia perché esterno ai ranghi militari e delle polizie. Adesso
Annegret Kramp-Karrenbauer vuole qualcuno che conduca l’operazione di pulizia
con più determinazione: «Ora serve una scopa di ferro».
L’incubo della Germania: così la peste suina danneggia
l’economia tedesca. Federico Giuliani il 20 settembre
2020 su Inside Over. La peste suina africana (PSA) ha colpito in pieno
la Germania, provocando apprensione tra tutti gli allevatori dell’Europa. Era il
10 settembre quando il ministro tedesco dell’Agricoltura, Julia Kloeckner,
comunicava in conferenza stampa il primo caso dell’infezione mortale per i
suini. I test effettuati su un cinghiale trovato morto nel Land orientale di
Brandeburgo, nei pressi del confine con la Polonia, aveva subito fatto scattare
l’allarme. Anche perché la PSA, pur non colpendo gli esseri umani, è quasi
sempre letale per gli animali che la contraggono, ovvero maiali e cinghiali. Nel
recente passato la sua presenza è stata confermata in vari Stati europei,
provocando l’abbattimento su larga scala di interi allevamenti. La trasmissione
avviene in due modi: quando gli animali entrano in contatto con superfici, altri
animali o cibi infetti oppure attraverso le zecche. Gli effetti della malattia,
per lo più emorragie, sono letali e uccidono nel 90% dei casi. Al momento non
esistono vaccini. Tornando in Germania, nonostante le rassicurazioni del
ministro Kloeckner, Berlino deve fare i conti con il sensibile calo delle
esportazioni di carne di maiale, dovuto a blocchi e diffidenze varie. Come se
non bastasse, pochi giorni fa sono stati scoperti cinque nuovi casi di PSA,
sempre nel Land di Brandeburgo. Quattro cinghiali sono stati trovati morti nel
distretto Oder-Spree, mentre un altro animale, ancora vivo, presentava sintomi
della malattia ed è stato addormentato.
Il contraccolpo economico. L’annuncio di una eventuale epidemia
di PSA può creare allarme nel settore agricolo, come già avvenuto più volte in
più parti del mondo. Dopo la scoperta del primo caso tedesco, la Cina,
principale acquirente di maiale tedesco, ha vietato le importazioni di carne
dalla Germania. A ruota, anche Corea del Sud, Giappone e Brasile hanno preso
decisioni analoghe. Il governo brasiliano ha inviato a Berlino un comunicato nel
quale richiede alle autorità sanitarie teutoniche informazioni dettagliate sulle
misure di sicurezza biologica e alimentare adottate negli impianti industriali
tedeschi. Ricordiamo che nei primi mesi del 2020 Brasilia aveva importato 1.800
tonnellate di carne suina tedesca. Ma l’apocalisse perfetta – da alcuni
ridefinita Aporkalipse now – potrebbe consumarsi nel vero senso della parola se
Pechino dovesse continuare a sospendere le importazioni. Già, perché secondo
quanto riportato dal South China Morning Post, nella prima metà del 2020, la
Germania ha venduto al Dragone la bellezza di 233.000 tonnellate di carne di
maiale. Ovvero: più di un quarto delle sue esportazioni totali. Va da sé che i
danni economici rischiano di essere enormi.
Previsioni nefaste. Le previsioni degli analisti non sono affatto
positive. Gli esperti ritengono che il ritorno di fiamma della PSA in Germania
potrebbe non solo danneggiare gli allevatori tedeschi ma anche influenzare
i prezzi della carne di maiale in tutto il resto d’Europa. Peggio ancora, le
aziende di Berlino rischiano adesso di perdere notevoli quote di mercato in
favore di fornitori americani. La Cina, da questo punto di vista, gioca un ruolo
chiave. Il motivo è semplice: il gigante asiatico è il più grande consumatore
mondiale di carne di maiale. Per quanto riguarda i prezzi, venerdì scorso in
Germania abbiamo assistito a una riduzione da monitorare con estrema attenzione.
Calcolatrice alla mano, il costo di un chilogrammo di carne di maiale è sceso di
circa il 13%, passando a 1,27 euro. Una cifra troppo bassa, sottolineano in coro
gli allevatori.
Quel fiume di soldi alla Chiesa tedesca che Ratzinger voleva
eliminare. La Chiesa tedesca gode di uno status
particolare: è la tassa ecclesiastica versata dai cattolici a garantire
ricchezza. Ma i cattolici non ci stanno più. Francesco Boezi, Sabato 19/09/2020
su Il Giornale. La "tassa ecclesiastica" della Chiesa tedesca distingue il
contesto cattolico teutonico da tutti gli altri. È anche per questo che
l'episcopato tedesco ha più potere degli altri, ammettono i conservatori. Quelli
che sono da sempre favorevoli ad una revisione della regola. In qualche
modo, Joseph Ratzinger ci aveva provato. Ma l'abolizione della "decima" prevista
per i cattolici che risiedono in Germania è rimasta un tabù. Dopo il pontificato
del tedesco, a parte le affermazioni del "fronte tradizionale", non se n'è più
parlato. Il procedimento per questa tassazione è praticamente automatico. Per
essere sottoposti al regime di prelievo della Chiesa cattolica tedesca basta il
solo battesimo. Poi scatta un obbligo di versamento, che corrisponde all'8-9%
del proprio reddito lordo. Ne sa qualcosa il campione del mondo Luca Toni
cui, ad un certo punto, venne chiesta di punto in bianco una cifra pari a circa
un milione e settecentomila euro in quanto cattolico. Joseph Ratzinger non è mai
stato convinto della bontà di quella imposizione. Il Papa emerito è stato
piuttosto chiaro quando, da regnante, ha scritto proprio in riferimento alla
Chiesa tedesca che "gli esempi storici mostrano che la testimonianza missionaria
di una Chiesa distaccata dal mondo emerge in modo più chiaro. Liberata dai
fardelli e dai privilegi materiali e politici, la Chiesa può dedicarsi meglio e
in modo veramente cristiano al mondo intero, può essere veramente aperta al
mondo". Non c'è scritto "abolizione della tassa ecclesiastica", ma si può
dedurre. Il contesto ed i dettagli sono stati ripercorsi tempo fa dal
vaticanista Sandro Magister sul suo blog. E gli ambienti ratzingeriani sono
pronti a testimoniare: Benedetto XVI avrebbe voluto rivedere quella regola. Se
non altro perché le possibilità della Chiesa cattolica non dovrebbero essere
legata alla rendicontazione dei battezzati: "Non muovono da una dinamica di
fede. Credo che questo rappresenti il grande pericolo della Chiesa in Germania:
ci sono talmente tanti collaboratori sotto contratto che l'istituzione si sta
trasformando in una burocrazia mondana.... . Mi rattrista questa situazione,
questa eccedenza di denaro che poi però è di nuovo troppo poco, e l'amarezza che
genera, il sarcasmo delle cerchie di intellettuali". Queste sempre le parole di
Ratzinger, che in quel discorso ha ammesso tuttavia di non essere contrario in
sé e per sé alla "decima". Certo è che diviene difficile immaginare una profonda
riforma del sistema tedesco senza uno stravolgimento della sua norma principale,
la "tassa" appunto. E se qualcuno avesse ancora dubbi, basterebbe guardare cosa
hanno proposto i ratzingeriani in questi sette anni. Un esempio su tutti,
l'opera di monsignor Gregor Maria Hanke, il quale si è schierato apertamente per
l'abolizione. Il dibattito si è riaperto un minimo in funzione del "Sinodo
biennale" dell'episcopato tedesco, l'appuntamento mediante cui il fronte
progressista vorrebbe modificare alcuni temi dottrinali, che tuttavia sono di
stretta competenza della Chiesa universale (almeno alcuni). Il "fronte
tradizionale" è sceso in strada, in segno di contenuta protesta. E tra i punti
sollevati c'era appunto la scomparsa di una tassa considerata inopportuna. A
capitanare quel gruppo di fedeli, c'era mons. Carlo Maria Viganò. L'ex nunzio
apostolico che ha domandato le dimissioni di papa Francesco in funzione del caso
McCarrick. Ma la necessità dell'abolizione è condivisa anche da altre
personalità legate agli insegnamenti ratzingeriani. Gli effetti della
persistenza della tassa non sono neutri. Sono i numeri a fotografare la
situazione: ha scritto Emanuel Pietrobon su InsideOver che "272.771 persone
hanno deciso di abbandonare deliberatamente la Chiesa cattolica, in aumento
significativo rispetto alle 216.078 del 2018". E il dato vale solo per il 2019,
mentre la progressione del fenomeno rischia la mancata soluzione di continuità.
Non si tratta più tanto di evitare la "protestantizzazione", quanto di prendere
atto di un fenomeno che appare più urgente da analizzare: il sistema, così
com'è, non trova il placet di tanti cattolici, tedeschi o meno che siano ma
comunque residenti in Germania. Ratzinger aveva avvertito.
L'ultima dalla Germania: i gradi dei militari saranno anche
femminili. Esponenti di maggioranza e di opposizione
hanno reagito esortando il governo Merkel a pensare piuttosto ai problemi veri e
urgenti dell’esercito. Gerry Freda, Sabato 12/09/2020 su Il Giornale. Il governo
tedesco, nella persona del ministro della Difesa Annegret Kramp-Karrenbauer, ha
messo a punto una riforma intesa a rafforzare il "lessico femminile" tra i
ranghi delle forze armate nazionali. Il piano è appunto inteso a istituire dei
gradi militari di genere femminile, così da assicurare la parità dei sessi
all’interno della Bundeswehr e scongiurare qualsiasi discriminazione ai danni
delle donne in divisa. La svolta promossa dal ministero della Difesa di Berlino
al fine di cancellare il “maschilismo verbale” dal mondo delle forze armate non
sembra però al momento riscuotere ampi consensi. Nel dettaglio, il progetto
della Kramp-Karrenbauer è diretto a introdurre, accanto ai tradizionali gradi
militari di genere maschile, i loro equivalenti al femminile. Ad esempio,
affianco al tradizionale vocabolo “Bootsmann” (marinaio) verrà introdotto
l’equivalente femminile “Bootsfrau” (“marinaia”) e, inoltre, accanto
all’abituale grado di “Maggiore” spiccherà quello di “Maggioressa”. Finora, il
vocabolario degli ambienti militari ha costantemente utilizzato termini di
genere maschile indifferentemente per donne e uomini. Negli ultimi anni, le
donne in servizio nella Bundeswehr hanno iniziato a venire qualificate
premettendo i termini “Frau” (signora) o “Madame” al rispettivo rango militare,
declinato tradizionalmente al maschile (Ad esempio, “Frau Major” e “Madame
Major”, ossia “Signora Maggiore” e “Madama Maggiore”). La riforma del governo
Merkel per assicurare la parità di genere lessicale nella sfera militare
riprende un progetto messo a punto anni fa dalla Commissione federale per le
pari opportunità nell’esercito, mai tradotto però in provvedimenti concreti a
causa della forte opposizione da parte delle stesse donne in servizio nella
Difesa. Proprio queste hanno nuovamente alzato la voce contro il recente
tentativo della Kramp-Karrenbauer di imporre dei vocaboli femminili nel contesto
dei gradi militari. Le donne tedesche arruolate nell'esercito si sono appunto
ultimamente coalizzate contro l’apparente riforma femminista dell’esecutivo
Merkel lanciando sui social lo slogan “Gradi militari differenti in base al
genere non c’entrano niente con l’emancipazione”. Sul web, molte delle
promotrici della protesta hanno indicato numerose ragioni della loro contrarietà
all’iniziativa del ministero. Tra queste, il tenente Wiedke Hönicke ha scritto:
“L’uniforme non conosce colori della pelle o caratteri sessuali, ci rende tutti
uguali, tutti camerati. Ci unisce, così come il grado militare, che è lo stesso
per tutti”. La stessa ha poi concluso: “Per me, l’uguaglianza non significa
gradi militari distinti in base al genere delle persone, ma vuol dire solamente
uguaglianza di diritti e di doveri”. La proposta della Kramp-Karrenbauer ha
suscitato le critiche anche di molti esponenti politici, sia di maggioranza sia
di opposizione, che hanno reagito al piano di “femminilizzazione lessicale”
accusando l’attuale ministro della Difesa di trascurare, come il suo
predecessore Ursula von der Leyen, i reali bisogni dell’esercito tedesco per
concentrarsi su problemi futili. La von der Leyen era stata infatti criticata in
passato per non avere mosso un dito riguardo alla carenza di risorse e di
armamenti efficienti patita dalla Bundeswehr, preferendo al contrario
provvedimenti effimeri e meramente propagandistici come l’istituzione di
asili-nido nelle caserme e l’introduzione di orari di lavoro flessibili per il
personale militare. Tra i politici di maggioranza, contro la recente proposta
del ministero della Difesa si è inizialmente scagliato l’esponente
socialdemocratico Siemtje Möller, che ha tuonato: “Quando parlo con delle donne
in divisa, loro non si lamentano per i ranghi non declinati al femminile, ma per
la carenza di dispositivi di protezione adeguati, di stivali, di uniformi, e di
tute della loro misura. Dei gradi con desinenze al femminile potrebbero anche
sembrare carini, ma non risolvono il problema della carenza di equipaggiamenti,
che danneggia soprattutto le soldatesse”. Esortazioni affinché il ministro della
Difesa del governo Merkel si occupi di questioni militari più gravi e urgenti,
come appunto la scarsità di risorse adeguate per la Bundeswehr, piuttosto che di
rivoluzioni lessicali sono state avanzate anche da Agnes Strack-Zimmermann,
rappresentante della forza di opposizione Partito Liberale Democratico (Fdp).
Per il momento, la Kramp-Karrenbauer non ha reagito pubblicamente al coro di
critiche, ma dovrà prendere una decisione definitiva sul piano di riforma
lessicale delll'esercito non oltre la fine della prossima settimana.
Corruzione e tangenti: la Germania peggio dell'Italia.
La Germania passa per essere un Paese onesto, corretto, inflessibile. Ma i
numeri dicono il contrario: l'economia sommersa vale 351 miliardi di euro e le
tangenti 250, scrive Marco Cobianchi su “Panorama”. Essere tedeschi ha un
vantaggio: si è sempre dalla parte della ragione. È una certezza che Manfred
Weber, capogruppo del Ppe al Parlamento europeo, aveva stampata in volto quando,
replicando al discorso di inaugurazione del semestre di presidenza italiana
dell’Europa di Matteo Renzi, gli ha rinfacciato di “chiedere soldi in cambi di
riforme. E poi come facciamo ad essere sicuri che le facciate?” Dubbio
legittimo, ma non sempre la Germania è quel monolite di etica che si vuol far
credere. Ha un’immagine impeccabile e un volto sempre ben rasato, ma la Germania
è molto più simile all’Italia di quanto Weber non creda. E lo è in un campo nel
quale noi passiamo per specialisti, con un know-how consolidato: la corruzione.
Forse Weber non ricorda un episodio interessante capitato il 15 aprile di
quest’anno proprio al Parlamento europeo. Nikolaos Chountis, europarlamentare
greco di Syriza (lista Tsipras), riceve dal tedesco Martin Schulz, presidente
del Parlamento europeo e candidato del Pse alla presidenza della Commissione,
una risposta che non s’aspettava. Un anno prima la Commissione europea aveva
messo nero su bianco che tra i Paesi europei solo la Germania e l’Austria non
avevano ancora recepito nel proprio ordinamento né la convenzione
anti-corruzione europea né quella dell’Onu. Chountis prende carta e penna per
chiedere a Schulz di sapere se l’Europa avesse fatto, o avesse intenzione di
fare, pressioni su Berlino perché le adottasse. Voleva anche sapere quali
fossero le giustificazioni della Germania per non averlo ancora fatto e se era
vero quanto scritto dal settimanale tedesco Der Spiegel e, cioè, che il
presidente della Confindustria tedesca, Ulrich Grillo, era coinvolto in una
serie di pagamenti di tangenti in Grecia quando era a capo delle società
Rheinmetall e Stn Atlas. Dopo un anno la risposta di Schulz è stata lapidaria:
l’interrogazione “eccede le competenze della Commissione” quindi è
“inaccettabile”. Se avesse voluto rispondere, Schulz avrebbe dovuto mettere sul
banco degli imputati il suo Paese e approfondire verità imbarazzanti. Molto
imbarazzanti. Gli scandali Mose e Expo sembrano confermare la teoria “italiani
popolo di mazzettari”. Una teoria che porta dritto dritto verso una specie di
autorazzismo che vuole gli italiani “antropologicamente inferiori dal punto di
vista etico” rispetto, ad esempio, alla Germania che passa per essere il
Paradiso dell’etica pubblica. È così? Partiamo dai numeri. Uno dei più
importanti studi che comparano l’economia sommersa dei Paesi europei viene
pubblicato periodicamente a cura della Visa Europe, realizzato dalla società di
consulenza internazionale At Kearney, con la supervisione scientifica di
Friedrich Schneider, professore all’Università austriaca di Linz e massimo
esperto continentale della cosiddetta “shadow economy”. I suoi studi e i suoi
saggi sono alla base dei documenti dell’Eurostat e dell’Ocse che si occupano
della materia. I risultati dello studio sono qui e il dato più importante è che,
in valori assoluti l’economia sommersa tedesca è la più consistente di tutti i
Paesi europei: 351 miliardi di euro pari al “nero” di Gran Bretagna, Belgio,
Svezia, Irlanda e Austria messe insieme e superiore di circa 20 miliardi al
“nero” italiano che è stimato in 333 miliardi. Strano che la Germania passi per
essere come l’Eden degli onesti, perché i dati non dicono questo: dicono che
l'economia “non osservata” tedesca è la più grande d'Europa. Per “economia non
osservata”, familiarmente chiamata in italiano “nero”, si intende sia l'economia
criminale vera e propria sia, soprattutto, l'economia non criminale che sfugge
ai controlli (in particolare del fisco) come, ad esempio, il lavoro non
regolare, la mancata fatturazione o la sottofatturazione. Ma prendere i valori
assoluti non basta: vanno messi anche in relazione al Prodotto Interno Lordo di
un Paese perché è evidente che il 13% di economia sommersa della Finlandia non
equivale allo stesso 13% di economia sommersa della Germania: infatti nel primo
caso si tratta di appena 26 miliardi di euro e nel secondo di 351. L’Italia,
avendo un’economia più piccola di quella tedesca, ha un rapporto sommerso/Pil
più alto, cioè il 21% rispetto, appunto, al 13% tedesco. Il rapporto tra
economia sommersa e Pil dell'Italia è uno dei più alti e, d’altra parte, gli
scandali grandi e piccoli che emergono quotidianamente sono lì a dimostrare che
siamo il Paese più corrotto d'Europa mentre la Germania passa per essere
popolata da manager e dipendenti pubblici puri come gigli di campo. Friedrich
Schneider (unica fonte presa come riferimento in modo da non fare confusione con
altre metodologie di indagine su un tema così difficile da maneggiare) ha
valutato anche il peso della corruzione nei vari Paesi europei e il risultato è
che, nel 2012, le mazzette tedesche hanno pesato 250 miliardi di euro rispetto
ai 280 miliardi dell’Italia. La Corte dei Conti, però, valuta il valore della
corruzione italiana in 60 miliardi, non in 280. Peccato, però che il dato dei 60
miliardi sia praticamente inventato perché sono il risultato di una proporzione
tra il valore stimato della corruzione mondiale con il Pil italiano. Un
esercizio di pura matematica senza nessuna base scientifica, ma che continua ad
avere libera circolazione nel dibattito pubblico. Ma oltre alle statistiche
economiche anche quelle giudiziarie, sono interessanti. Secondo un recente
rapporto della Commissione europea le denunce per corruzione in Germania nel
2011 sono state 46.795: il triplo rispetto alle 15.746 dell'anno precedente. In
Nord-Westafalia i casi sono passati da 6089 del 2010 a 40.894 del 2011.
Ovviamente c'è una spiegazione. Se si va a vedere il testo originale del
rapporto si scopre che decine di migliaia di denunce riguardano un caso di
tangenti che ha coinvolto tutti i dipendenti, civili e militari, di una base
militare britannica e che vede coinvolti i dipendenti di una concessionaria
automobilistica in due distinti processi. Anche il dato del 2010 (15.746 casi) è
influenzato da singoli casi specifici. Bisogna andare al 2009 (quando non ci
sono stati casi anomali di corruzione che falsano il dato) per avere un numero
affidabile ed è 6.354 denunce e va confrontato con quello del 2012: 8.175. Un
bel numero, tantopiù se si considera che mentre le denunce di crimini aumentano,
le indagini diminuiscono: dalle 1.813 del 2010 si è passati alle 1.528 del 2011
fino alle 1.373 del 2012. Passiamo alle condanne: secondo l'Ocse tra marzo 2011
e il marzo 2013 di tutti i procedimenti anti corruzione, 33 sono stati
archiviati per mancanza di prove mentre in 21 processi si è arrivati alla
condanna nei confronti, complessivamente, di 141 persone. Di queste 141 persone,
43 sono state ritenute colpevoli di corruzione verso funzionari pubblici
stranieri e questo significa che, secondo la giustizia tedesca, appena 138
persone in due anni sono state ritenute colpevoli di aver pagato tangenti
all'interno della Germania. Un numero ridicolo se si pensa alla stima di
Schneider secondo la quale le tangenti in Germania pesano per 250 miliardi ed è
ancora più ridicolo se si pensa che in un solo anno, il 2012, le denunce per
corruzione sono state, come detto, più di 8mila. Il confronto con i dati
italiani è, a questo punto, d’obbligo. Nel 2011 le denunce per corruzione e
concussione e abuso d’ufficio sono state 1820 (1.587 nel 2012, ultimi dati
disponibili) mentre le persone condannate per peculato, malversazione,
concussione, e corruzione sono state 800. In Italia si denuncia meno, ma si
condanna molto di più. Come mai? Il rapporto della Commissione Europea sulla
corruzione sembra mettere in relazione abbastanza diretta questa differenza tra
denunce (molte) e indagini (poche) in Germania con il fatto che la magistratura
tedesca, a differenza di quella italiana, è soggetta al potere politico. In
alcuni specifici casi, infatti, il ministero della Giustizia di Berlino ha il
diritto di “istruire” il magistrato titolare di un’inchiesta su come condurre le
indagini e su quale particolare concentrare le sue attenzioni. E’, quindi,
possibile che i magistrati tedeschi siano indirizzati dal governo a trascurare i
casi di corruzione per concentrarsi su altri reati. E non sembra che questo
stato di cose scandalizzi più di tanto i magistrati stessi: solo il 50% di essi,
infatti, vorrebbe l’abolizione del potere di indirizzo delle indagini da parte
del governo. Certo, quasi tutti gli indici di corruzione, stando al rapporto
della Ue, sono migliori rispetto alla media europea, ma il rapporto fa notare
che l'Ocse ha più volte chiesto alla Germania di rendere esecutive le sentenze
(poche) che ricadono sotto il reato di corruzione visto che “la maggior parte
delle sentenze vengono sospese”. Strano, è la stessa accusa che si rivolge
all'Italia. Per di più il Greco, Group of States Against Corruption, nel suo
rapporto sulla Germania del novembre del 2012, ha criticato il paese di Frau
Merkel per le sue regole di finanziamento ai partiti poco rigorose (rafforzate
nel 2013), per la corruzione dei parlamentari e per gli scarsi progressi
nell'adozione delle raccomandazioni dell'organizzazione.
Corruzione e tangenti: il caso Germania. La seconda parte
dell'inchiesta sul sommerso e le mazzette in salsa tedesca, scritta da Marco
Cobianchi Su “Panorama”. Quello tedesco non sembra un popolo
“antropologicamente” onesto. Se l’Italia ha avuto Calciopoli, i tedeschi hanno
avuto il “caso Bochum”, dal nome della piccola procura tedesca che, nel 2007,
iniziò a indagare sulla Bundesliga. Ben presto l’inchiesta si allargò a tutta
Europa portando alla luce tre partite della Champion’s League truccate e 323
incontri manipolati in diversi campionati europei 69 dei quali in Germania per
un giro di mazzette di 12 milioni di euro a arbitri e dirigenti sportivi, oltre
a 175 milioni di “premio partita”. Sono state arrestate complessivamente 347
persone quasi la metà delle quali residenti in Germania. Il processo tenutosi in
Germania nel 2009 ha portato alla condanna di 3 sole persone (due a 5 anni e 6
mesi e una a 1 anno e 6 mesi), a 17 sanzioni disciplinari comminate dalle
autorità sportive mentre 12 persone, a 5 anni dall’inizio delle indagini, erano
ancora in attesa di una sentenza definitiva. Sempre a proposito della “società
civile”: nel 2013 l’associazione dei medici tedeschi ha accusato mille propri
iscritti di aver ricevuto regali (soldi, viaggi, beni di consumo) da case
farmaceutiche per prescrivere ai loro pazienti farmaci dei quali, spesso, non
avevano bisogno. Secondo il presidente dell’associazione Frank Ulrich
Montgomery, intervistato dal settimanale tedesco Der Spiegel più della metà dei
casi riguarda regali fatti dalla società israeliana Ratiopharm. Nel frattempo a
Leipzig due primari sono stati sospesi perché scoperti a manipolare i file dei
pazienti in attesa di trapianto in cambio di favori e casi simili sono stati
scoperti anche a Gottingen, Monaco e Regensburg. Ma l’anno nel quale i tedeschi
sono scesi con i piedi per terra e si sono resi conto di non essere affatto
immuni dal virus della tangente è stato il 2007 quando ben 6 grandi società sono
state accusate di corruzione. Il caso più clamoroso riguarda la Siemens, multata
per 600 milioni di euro per essere stata scoperta a pagare sistematicamente
mazzette in tutto il mondo per accaparrarsi contratti pubblici usando un fondo
nero alimentato da centinaia di milioni di euro ogni anno. Oltre ai 600 milioni
alle autorità tedesche, la Siemens ha pagato altri 800 milioni alle autorità
americane e ha versato altri 100 milioni a organizzazioni internazionali
noprofit che combattono la corruzione negli affari. Nel 2009 scoppia anche il
caso del colosso Man che paga 150 milioni di euro per risolvere un processo nel
quale veniva accusata di aver pagato tangenti per vincere contratti, anche
all'estero. Altri 500mila euro (andati in beneficenza) sono stati versati anche
dall'allora amministratore delegato, lo svedese Hakan Samuelsson, che si è
sempre dichiarato innocente. In seguito Samuelsson è diventato capo della Volvo,
carica dalla quale si è poi dimesso. Ma, per dare un'idea di come si alimenta un
luogo comune, il profilo di Samuelsson su Wikipedia non fa cenno né allo
scandalo tangenti, né alla multa né ai veri motivi delle sue dimissioni da capo
della Man, società che, sotto la sua guida, ha realizzato profitti record
assicurandogli una remunerazione di 7,2 milioni di euro nel solo 2009. Poi ci
sono le tangenti greche, quelle sulle quali Nikolaos Chountis ha chiesto,
inutilmente, lumi a Martin Schulz. A guardare gli archivi dei giornali sembra
che nessun affare concluso da aziende tedesche in Grecia sia esente dalla
mazzetta. Il caso più importante riguarda l'affare dei sottomarini, una storia
da 1,14 miliardi di euro che inizia una decina d'anni fa le cui indagini vennero
subito interrotte a causa, secondo i giornali tedeschi, “della scarsa
collaborazione da parte delle autorità greche”. All'inizio del 2014 lo scandalo
è riemerso in seguito all'arresto di due dipendenti pubblici greci accusati di
avere intascato mazzette per 23,5 milioni di euro. A pagare sarebbero state la
Hdv e la Ferrostaal. Non solo: per un altro affare di armi, a dicembre del 2013
è finito in carcere un ex alto dirigente del ministero della Difesa, Antonis
Kantas, con l'accusa di aver ricevuto 1,7 milioni di tangenti dal rappresentante
greco della società tedesca Krauss-Maffei Wegmann per la vendita di 170 carri
armati Leopard. Una volta in carcere ha ammesso non solo questa tangente, ma
anche altri 500-600mila euro provenienti sempre dall'affare dei sottomarini. Ma
nel passato accusate di aver pagato tangenti a dipendenti pubblici greci sono
state anche, oltre alla solita Siemens, anche la Deutsche Bahn e la Daimler.
Quella stessa Daimler che, citata in un rapporto del 2010 del dipartimento della
Giustizia Usa, viene definita come società con una “lunga tradizione in quanto
al pagamento di tangenti” a dirigenti pubblici stranieri. I dirigenti della
Daimler sono stati accusati di aver versato tangenti per decine di milioni di
euro a dipendenti pubblici di 22 Paesi del mondo compresi quelli di tutto il
Medio Oriente oltre a Cina e Russia. In Iraq avrebbe addirittura violato i
vincoli del programma Oil for Food delle Nazioni Unite. E nonostante le
indagini avessero fatto emergere violazioni anche di leggi tedesche, Daimler non
è mai stata messa sotto inchiesta in Germania e se l’è cavata pagando 185
milioni di euro alle autorità americane. E si potrebbe continuare per ore: il
presidente del Bayern Monaco finito in carcere per essere stato scoperto a
pagare mazzette; la società Bilfinger accusata dagli Usa di aver pagato tangenti
in Nigeria (multa di 32 milioni di euro); i dipendenti della Basf accusati di
avere accettato soldi in nero da dei fornitori per beni e servizi poi non
forniti, ma la differenza tra Italia e Germania è ormai chiara. Mentre da noi il
problema è vissuto come un difetto “morale” che attiene al “carattere”
nazionale, in Germania la corruzione è vista come un problema “amministrativo”
per le aziende (che pagano per chiudere ogni pendenza) e penale per i suoi
manager che (raramente) finiscono in carcere. Sui giornale tedeschi nessuno si
sogna di accusare uno scadimento morale ma, piuttosto, si preoccupano che le
mazzette, una volta scoperte, non interrompano la “normale” attività economica
di una società. La stampa tedesca, nel dare il giusto risalto a questi episodi,
ha comunque un atteggiamento assolutorio verso i manager tedeschi. La tesi, in
genere, è: non siamo noi corruttori che paghiamo le tangenti, sono i politici
stranieri che sono corrotti perché le accettano, o le pretendono. Può essere. Ma
secondo Markus Funk, copresidente della Aba's Global Anti Corruption Task Force,
“negli anni recenti la Germania è stata seconda solo agli Stati Uniti in quanto
a numero di casi di corruzione all'estero”. E, d’altra parte, anche i politici
tedeschi, in quanto a scarsa trasparenza, non scherzano. A gennaio
l’amministratore delegato delle ferrovie tedesche, Rudiger Grube, ha offerto al
braccio destro di Angela Merkel, Ronald Pofalla, un posto in consiglio
d’amministrazione (pagato 1 milione di euro l’anno) con il compito di occuparsi
di relazioni istituzionali. Nulla di illegale, per carità, tranne che passare da
capo di gabinetto del primo ministro a lobbista di una società pubblica non è
quello che ci si aspetterebbe da un popolo “antropologicamente” etico. Anche le
dimissioni del presidente federale Christian Wulff sono state raccontate come la
decisione di un uomo integerrimo che, sopraffatto dal senso dell’etica, decide
di abbandonare la poltrona per una piccole, umana, debolezza: essersi fatto
offrire un soggiorno di pochi giorni all’Oktoberfest. In realtà Wulff è stato
costretto a dimettersi nel 2012 perché ha tentato di depistare le inchieste
giornalistiche che indagavano su una donazione di 500mila euro proveniente da un
ricco amico della moglie quando era governatore della Bassa Sassonia. Wulff fu
costretto a dimettersi non per un peccato veniale, ma perché in una
corrispondenza, diventata pubblica, da presidente della Repubblica, ha
praticamente minacciato l'editore della Bild che stava per pubblicare la
notizia. Riguardo al caso Oktoberfest: quel soggiorno è stato pagato dal
produttore cinematografico David Groenewold a favore del quale, successivamente,
Wulff scrisse una lettera al Ceo della Siemens chiedendogli di finanziare un
lungometraggio che l'amico stava producendo. Due anni dopo la sentenza del
processo originato dall’ospitata fu di assoluzione: non è stata ravvisata alcuna
relazione tra l'invito all'Oktoberfest e la lettera di raccomandazione e Wulff,
assolto da tutte le accuse, ha scritto perfino un libro per raccontare la sua
versione dei fatti. Un risultato, quello dell’assoluzione, non dissimile dai
molti processi che hanno coinvolto politici italiani. Che, però in troppi hanno
interesse a dipingere, loro e tutti gli italiani, come persone corrotte
“dentro”.
Francesco Tortora per "corriere.it" il 21 agosto 2020. «I cani
non sono peluche. Hanno i loro bisogni, che devono essere presi in
considerazione». Con queste parole Julia Klöckner, la ministra dell’agricoltura
in Germania ha presentato la «Hundeverordnung» (norma sui cani), legge che
renderà obbligatorio portare a spasso gli animali almeno due volte al giorno.
In vigore dal 2021. Il nuovo regolamento, che sarà presto
presentato al Bundestag e dovrebbe entrare in vigore nel 2021, prevede che i
padroni siano tenuti a portare fuori i cani per almeno un’ora ogni volta.
Inoltre gli animali non dovranno essere lasciati soli a casa tutto il giorno e
dovrà esserci una persona incaricata di prendersene cura. Secondo la ministra
Klöckner la legge s’ispira a nuove scoperte scientifiche che dimostrano come i
cani abbiano bisogno ogni giorno di «un numero sufficiente di attività e di
stare a contatto con la natura». Inoltre anche legare i cani a una catena o al
guinzaglio per lunghi periodi è soggetto a un divieto assoluto.
Le critiche. Secondo la ministra la legge è necessaria perché ci
sono prove che dimostrano come almeno 9,4 milioni di cani di proprietà in
Germania non ricevano gli stimoli di cui hanno bisogno. Ma non tutti all’interno
della CDU, il partito di Klöckner, giudicano opportuno il provvedimento e anzi
c’è chi lo considera addirittura ridicolo: «Non porterò il mio Rhodesian
Ridgeback (cane di grande taglia spesso chiamato “cane africano cacciatore di
leoni” ndr) per ore in giro con temperature di 32 gradi, piuttosto faremo un
salto nel fiume per rinfrescarci» ha dichiarato il deputato Saskia Ludwig. Dello
stesso avviso il collega Walther Schweiz che ironizza: «Presto diranno ai
proprietari di gatti quanto spesso dovranno cambiare la lettiera».
Cani a spasso per legge. Ma così non è liberale.
La Germania sta per emanare una norma di legge che renderà
obbligatorio portare a spasso i cani due volte al giorno per un totale di almeno
un'ora. Oscar Grazioli, Venerdì 21/08/2020 su Il Giornale. La Germania sta per
emanare una norma di legge che renderà obbligatorio portare a spasso i cani due
volte al giorno per un totale di almeno un'ora, come minimo. «I cani non sono
peluche e hanno i loro bisogni e le loro esigenze» ha affermato Julia Klöckner,
la ministra dell'agricoltura teutonica. Il progetto di questo nuovo regolamento,
che sarà presto presentato al parlamento federale, prevede anche altre norme,
tra le quali il divieto assoluto di legare i cani a catena o guinzaglio per
lunghi periodi e il divieto di lasciare un cane da solo in casa tutto il giorno.
Occorrerà la presenza di una persona che se ne prenda cura. Secondo la ministra
Klöckner la legge si rende necessaria a seguito delle nuove scoperte etologiche,
secondo cui i cani hanno necessità, ogni giorno, di attività fisica e di stare a
contatto con la natura. Che ci siano molti cani sacrificati all'artrosi e
all'obesità a causa delle abitudini pantofolaie di padroni che passano il tempo
libero su un divano mangiando pop corn e guardando partite di calcio e
telenovelas, è un dato di fatto. Se poi questi cani appartengono a determinate
razze (penso ai poveri Beagle) che hanno bisogno di correre per chilometri ogni
giorno e spegnere la loro inesauribile vitalità, viene da pensare che le
riflessioni della ministra siano più che opportune. Ma c'è anche il rovescio
della medaglia, che ha provocato non pochi mal di pancia nella stessa ala
politica della Klöckner. Uscire una o due ore al giorno a passeggiare quando la
giornata è torrida e l'umidità blocca il respiro è estremamente pericoloso per i
cani brachicefali (quelli «tamponati» come Bulldog e Carlini) e può essere
doloroso per quelli anziani pieni di artrosi. La deputata dell'Unione Cristiana
Democratica Saskia Ludwig ha scritto su Twitter: «Non porterò il mio Rhodesian
Ridgeback per due giri di passeggiate con una temperatura di 32 gradi, piuttosto
faremo un salto nel fiume per rinfrescarci». Se penso poi al nostro paese fatto
di casette antiche senza ascensore e con le scale di pietra e agli anziani del
secondo piano che si godono il loro piccolo affetto abituato a farla nella
lettiera, come i gatti, con tutto il rispetto per gli etologi sono certo che non
stiano male né i cagnolini né le loro amate «mamme». Anche nel lockdown della
casa, fresca e in ombra.
Luciana Grosso per it.businessinsider.com il 3 agosto 2020. Salo
Muller, 84enne sopravvissuto ad Auschwitz ed ex fisioterapista della squadra di
calcio dell’Ajax, ha citato in giudizio le ferrovie tedesche che, a suo dire, si
sono rese complici delle deportazioni di migliaia di ebrei nei campi di
concentramento nazisti. In base ai fatti storici, infatti, la Deutsche
Reichsbahn, l’autorità ferroviaria tedesca in tempo di guerra, era responsabile
del trasporto fino alla morte di circa 107.000 ebrei olandesi con un viaggio che
le vittime erano costrette a pagare di tasca propria. Il profitto che la DR
avrebbe ottenuto da quei viaggi terribili, secondo alcune stime, sarebbe
l’equivalente di circa 16 milioni di euro di oggi. In una lettera al cancelliere
tedesco Angela Merkel, l’avvocato di Muller scrive che gli eredi delle ferrovie
tedesche in guerra hanno l’obbligo morale e giuridico di riconoscere il loro
ruolo nella sofferenza degli ebrei, dei sinti e dei rom: “Incolpo la compagnia
ferroviaria per il trasporto consapevole degli ebrei nei campi di concentramento
e per l’uccisione di quegli ebrei lì in un modo terribile”, ha detto Muller al
programma televisivo olandese Nieuwsuur. “Non posso arrendermi perché mi fa male
ogni giorno. Ogni giorno devo pensarci e mi fa male. E voglio che quel dolore
finalmente passi. ” L’anno scorso, Muller ha intentato una causa simile contro
le ferrovie olandesi, ottenendo un risarcimento fino a € 50 milioni per i
sopravvissuti ai trasporti, le loro vedove, vedovi e bambini.
Da ilmessaggero.it il 25 luglio 2020. Richiesta danni poco meno
di anni dopo i fatti. La giunta comunale di Nemi ha votato una delibera per
chiedere i danni alla Germania per la distruzione delle due navi romane
dell'Imperatore Caligola che, ritrovate nel secolo scorso tra il 1928 e il 1932,
vennero «dolosamente e intenzionalmente bruciate» la notte del 31 maggio 1944
dal 163° Gruppo Antiaereo Motorizzato tedesco che occupava la zona ed era in
ritirata. E chiama in causa Angela Merkel.
La delibera. «E adesso, per Nemi, la Germania deve pagare. Si
ritiene - dice il sindaco Alberto Bertucci - di sottoporre a giudizio
risarcitorio nei confronti della Repubblica Federale di Germania per i danni
morali e materiali subiti dalla collettività di Nemi a causa dell'irreparabile
danno causato a un bene archeologico di inestimabile valore». Dunque quel danno
irreparabile non fu il risultato di una imprevedibile azione bellica ma, spiega
il sindaco Bertucci, «un consapevole gesto di sfregio. Per questo chiediamo il
risarcimento - incalza il primo cittadino - Abbiamo ritrovato relazioni, ampie
documentazioni, testimonianze: i nazisti allontanarono tutti i residenti e il
custode. Decisero di dare alle fiamme quei tesori. Non c'è dubbio». Il sindaco
(che guida una lista civica di centro) però va oltre: «Noi non chiediamo
semplicemente i danni. Vorremmo che, con un gesto significativo di spirito
europeo, le autorità tedesche collaborassero con noi per ricostruire ciò che
emerse delle due navi ricorrendo alle nuove tecnologie di riproduzione. Grazie a
un libro dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato del tempo, abbiamo una
grande mole di dati, misure, immagini per procedere a un'opera di riproduzione,
in concorso col governo tedesco e magari con la mediazione del nostro ministero
per i Beni e le attività culturali».
E i
ministri della Merkel litigano sulla "schedatura razziale".
La polizia
perseguita i neri? Per l'Interno "sono solo calunnie", per la Giustizia
"vedremo". Partiti divisi. Daniel Mosseri, Martedì 07/07/2020 su Il Giornale. Si
chiama «racial profiling», si traduce come «schedatura razziale» e sta facendo
litigare i ministri del governo di Angela Merkel. La schedatura razziale è il
fenomeno per cui nei paesi occidentali la polizia si accanisce nei controlli su
alcuni gruppi etnici, fermando soprattutto persone con la pelle scura. La
quantità di melanina e non il comportamento del fermato è insomma la
discriminante del controllo. Anche nella Germania multietnica, la Polizei
sarebbe caduta nel vizio del racial profiling. Il condizionale è d'obbligo ma il
sospetto c'è visto che lo scorso 12 giugno i portavoce di ben due ministeri
avevano sollecitato uno studio in materia. Per prima era stato il dicastero
della Giustizia a sostenere che «una ricerca del genere dovrebbe essere
condotta». Era seguita la replica del Viminale tedesco secondo cui «Interni e
Giustizia stanno lavorando allo sviluppo di un concetto per uno studio sulla
profilazione razziale nella polizia». L'unico ostacolo era il tempo: «Poiché
l'esatto progetto di studio non è stato ancora determinato, non è ancora
possibile fornire dettagli specifici su ulteriori dettagli». A cambiare le carte
in tavole ha provveduto invece l'energico ministro degli Interni, il
cristiano-sociale bavarese Horst Seehofer. Un suo portavoce ha fatto sapere che
uno studio del genere «non è necessario» per una ragione molto semplice: la
schedatura razziale delle persone è illegale e vietata dalle pratiche della
polizia. E se in passato si è registrata qualche evenienza di profiling
razziale, si è trattato di «casi assolutamente eccezionali». Insomma, la polizia
ha la coscienza a posto, ha concluso il portavoce del ministro. Un'uscita a
gamba tesa che ha lasciato interdetta la ministra socialdemocratica della
Giustizia, Christine Lambrecht. Apparsa sul primo canale della tv pubblica
(Ard), la guardasigilli ha promesso che «parlerà di nuovo con il collega»
sull'utilità di uno studio del genere per i poliziotti, «che sono pilastri del
nostro ordinamento». La questione spacca anche i partiti: la ricerca era stata
sollecitata dalla co-presidente del partito socialdemocratico Saskia Esken,
scesa in campo «contro il razzismo latente delle nostre forze di polizia». Esken
ha anche chiesto l'istituzione di un ufficio a livello federale per raccogliere
le lamentele contro la polizia. Qua Lambrecht ha fatto quadrato con Seefoher nel
respingere tanto le accuse quanto la richiesta della leader Spd. Alla quale ha
risposto indirettamente il portavoce del ministro degli Interni. «I singoli casi
di discriminazione vengono già chiariti e sanzionati tempestivamente». Critiche
contro la decisione di Seehofer di bloccare lo studio sul nascere sono piovute
da Verdi e socialcomunisti. In sua difesa si è espresso invece Friedrich Merz,
il candidato della destra interna del partito di Angela Merkel, in corsa per
diventare il nuovo leader della Cdu al prossimo congresso del partito a
dicembre.
(ANSA il 29 giugno 2020) - Nell'inchiesta sulla rete di pedofili
partita dalla città di Bergisch Gladbach, in Germania, ci sono oltre 30 mila
sospettati. Lo ha affermato il ministro della giustizia del Land del
Nordreno-Vestfalia Peter Bisenbach a Duesseldorf, secondo quanto riportano
alcuni media tedeschi fra cui la Dpa. Gli inquirenti hanno rivelato come molti
di questi soggetti si scambino informazioni in alcuni forum sul web, dandosi
anche consigli su come rendere accomodanti i bambini. Si tratta di una rete
criminale internazionale che ha il suo epicentro nelle regioni di lingua
tedesca. Nelle chat, stando agli inquirenti, i pedofili, che dopo gli abusi
mettono su internet i video delle loro violenze, si incoraggiano a vicenda. Fino
ad ora, nel caso della rete scoperta a partire da Bergisch Gladbach erano stati
identificati 72 sospettati. Le indagini erano iniziate lo scorso ottobre con un
arresto a Bergisch Gladbach, vicino Colonia. A maggio era stato arrestato un
soldato di 27 anni. "Non avevo mai sospettato neppure lontanamente questa
dimensione del fenomeno degli abusi in rete. Dobbiamo ammettere che questi
crimini sono molto più diffusi di quanto immaginassimo", ha affermato il
ministro della giustizia del Land.
Monica Ricci Sargentini per il ''Corriere della Sera'' il 30
giugno 2020. Una rete di pedofili formata da decine di migliaia di persone che
si scambiano consigli su come sedare i piccoli e renderli docili. È incredulo e
sconcertato il ministro della Giustizia del Nordreno-Vestfalia Peter Biesenbach
(Cdu) mentre racconta alla stampa i risultati dell'inchiesta partita
nell'ottobre del 2019 quando la polizia ha arrestato un uomo di 43 anni a
Bargish Gladbach, nelle vicinanze di Colonia, con l'accusa di aver abusato della
figlia da bambina. Durante la perquisizione dell'abitazione gli investigatori
avevano sospettato l'esistenza di un network di condivisione delle violenze. Da
quella traccia è cominciato tutto. Gli inquirenti, però, non sapevano che
stavano per scoperchiare un vaso di Pandora. Un mondo popolato da orchi di
lingua tedesca che si estende fino alla Svizzera e all'Austria. Gente che non
solo parla di pedofilia ma ne rivendica l'assoluta normalità. «Non mi aspettavo
minimamente che gli abusi fossero così diffusi, parliamo di più di 30mila
sospettati - ha spiegato il ministro - e speriamo non siano di più». Gli utenti,
ha precisato Biesenbach, non si connettono attraverso il dark web ma usano una
normale messaggistica «in cui si scambiano istruzioni su come abusare dei
piccoli, come se fosse una cosa naturale». Alcuni sono alle prime armi, dicono
che avrebbero sempre voluto farlo ma non hanno mai avuto il coraggio, così
vengono incoraggiati da quelli con più esperienza. «Un'atmosfera di questo tipo
- ha sottolineato il ministro - può stimolare ad agire anche persone che in
mancanza di un contesto del genere sarebbero intimorite». Chi indaga deve essere
veloce a salvare le chat prima che siano cancellate. Ma il problema più grosso è
l'anonimato degli internauti. In Germania le norme ancora non permettono di
registrare i dati di collegamento di persone che spesso agiscono sotto
pseudonimo. Su questo punto, nelle scorse settimane, c'è stato uno scontro
politico e alla fine la ministra della Giustizia (Spd), inizialmente più
garantista, ha annunciato un irrigidimento delle pene anche sulla
pedopornografia. «Il maltrattamento dei bambini non può essere punito come il
furto in una bancarella» ha commentato il ministro dell'Interno del
Nordreno-Vestfalia Herbert Reul. Il primo luglio il ministero della Giustizia
lancerà una task force speciale contro la pedopornografia. Si chiama Zac
(Zentrale Anlaufstelle Cybercrime) ed è guidata da Markus Hartmann. Fino ad oggi
sono 72 le persone identificate, uno di loro, un soldato di 27 anni, è stato
condannato a 10 anni di prigione per aver violentato 4 minori tra cui i suoi
figli, altre 11 sono state arrestate. Sono, invece, 44 i bambini individuati
come vittime. Fra questi c'è un neonato di tre mesi. Gli investigatori sono alle
prese con una grande quantità di materiale che li sommerge di lavoro e rischia
di rendere l'indagine molto lenta. È una lotta contro il tempo per evitare che
gli abusi proseguano e catturare tutti i pedofili. Una sfida che gli agenti del
cyber-crime vogliono vincere nonostante le difficoltà psicologiche. Molti di
loro, infatti, vengono affiancati da psicoterapeuti per riuscire a sopportare
gli orrori che vedono. Per le indagini, nel solo mese di giugno, sono stati
coinvolti fra i 120 e i 140 investigatori al giorno. Di pedofilia in Germania si
era parlato all'inizio di giugno quando Christian Brückner è diventato il
principale sospetto per la scomparsa di Maddie McCann, la bambina inglese di 3
anni svanita nel nulla nel maggio del 2007 durante una vacanza in Portogallo con
i genitori. L'uomo, che ha 43 anni, sconta 17 condanne per pedofilia,
pedopornografia, furto, violenza e altri reati. A turbare l'opinione pubblica
c'era stato, poche settimane fa, l'arresto di undici persone a Münster, nel
Nordreno Vestfalia, dopo che in una cantina era stato rinvenuto materiale
pedopornografico. Ma lo scandalo che più ha agitato la Germania è stato quello
avvenuto in un campeggio a Lügde, in Nordreno-Vestfalia, tra il 1998 e il 2018
dove furono abusati 40 bambini tra i tre e i 13 anni. (Ha collaborato Christina
Ciszek)
I tedeschi fanno i furbetti (con più di mille euro sotto il
cuscino). Andrea Massardo il 28 luglio 2020 su Inside
Over. I Paesi del Nord Europa si sono contraddistinti nelle ultime settimane per
la dura battaglia nei confronti dei Paesi del Sud maggiormente colpiti
dalla pandemia di coronavirus e per la volontà di controllare le loro politiche
economiche qualora decidessero di accedere ai finanziamenti europei. Questo,
soprattutto in virtù della possibilità che i fondi europei venissero utilizzati
in modo inappropriato e non in linea con l’indirizzo di Bruxelles. Paesi come la
Grecia, la Spagna e l’Italia sono però già molto avanti per quanto riguarda le
misure volte alla lotta al malcostume nell’utilizzo dei finanziamenti pubblici,
possedendo un limite all’utilizzo del contante – che, per l’Italia, dallo scorso
1° luglio è sceso a duemila euro. Al contrario, invece, sono proprio Paesi come
la Germania, la Danimarca, la Svezia e l’Austria a non avere nella propria
normativa un tetto all’utilizzo dei contanti, favorendo in questo modo
l’evasione fiscale e il mercato – anche transfrontaliero – del nero.
Ogni tedesco possiede 1364 euro in contanti. Secondo quando
riportato dal quotidiano tedesco DerSpiegel, ogni tedesco possiederebbe
mediamente 1364 euro all’interno delle proprie mura domestiche. Questa tendenza
– molto più elevata nella popolazione anziana e più ridotta nella popolazione
giovanile – evidenzia un grosso rischio per la possibilità che vengano commessi
reati legati all’evasione fiscale nelle trattative di compravendita. A renderlo
noto è stata la stessa Bundesbank, che con una nota diffusa negli scorsi giorni
si è soffermata particolarmente sul problema, auspicando a degli ammodernamenti
normativi volti a prevenire questo rischio. Anche nella rigorosa Germania,
dunque, la popolazione non vede di buon grado l’utilizzo di strumenti
tracciati di pagamento, preferendo il caro vecchio contante alle più
tecnologiche soluzioni digitali odierne. E soprattutto, denota una cultura
ancora fortemente legata al commercio brevi manu e che si caratterizza per un
accresciuta propensione all’evasione fiscale – particolarità, questa che è
invece sempre stata criticata all’Italia, molto più avanti comunque di Berlino
sulla questione.
Contante o carta, questo è il dilemma. Benché siano molteplici
gli economisti che nel corso degli anni si sono schierati a favore
dell’incentivo dell’utilizzo del contante – tra gli altri, anche la
rivista Forbes – è fuori discussione che il loro utilizzo implichi
necessariamente un aumentato rischio di evasione fiscale. Il contante, infatti,
è difficilmente tracciabile e soprattutto può essere occultato, questione di
fatto – quasi – impossibile con i saldi dei conti correnti e quando i pagamenti
vengono veicolati da intermediari di pagamento e dall’utilizzo delle carte di
credito. E il fatto stesso che a “macchiarsi” del loro utilizzo più elevato
siano proprio quelle economie che si considerano all’avanguardia nella lotta
all’evasione apre a molti scenari di dubbi che adesso persino le istituzioni
nazionali hanno “scoperto” essere necessarie di approfondimento. In conclusione,
dunque, benché la questione sia stata e continui ad essere lungamente dibattuta,
è impossibile non sottolineare come proprio coloro che predicano bene – i Paesi
“frugali” e il blocco del Nord Europa – siano in realtà quelli che peggio
mettono in atto le direttive. In uno scenario che, ancora una volta, evidenzia
come esista una profonda spaccatura anche di fiducia all’interno dell’Europa,
dove determinati atteggiamenti sono considerati accettabili se svolti nelle
economie più forti e deplorevoli se messi in atto in quelli più in difficoltà.
Con l’utilizzo del contante che, comunque, è soltanto una delle sfaccettature
dei problemi storici ed irrisolti all’interno dell’Unione europea.
L. Ram. per ''Il Messaggero'' il 4 agosto 2020. Il ministero
dell'Economia tedesco, guidato da Peter Altmaier e deputato alla supervisione
delle attività di revisione dei bilanci, ha aperto un'indagine sulla società
Ernst & Young nell'ambito dello scandalo Wirecard. Lo rivela il quotidiano
economico Handelsblatt, citando un documento «classificato», quindi non
accessibile al pubblico di cui però ha potuto leggere il contenuto. Da quanto
emerge dal documento il collegio dei revisori (Apas) già nell'ottobre 2019 aveva
avviato indagini preliminari sui revisori di bilancio inviati dalla Ernst &
Young. Gli ispettori dell'Apas avevano il compito di sorvegliare grandi aziende
di interesse pubblico, tra cui le aziende quotate ufficialmente e comprese nel
Dax (l'indice principale della Borsa tedesca) come Wirecard. La critica di cui è
oggetto ora l'Apas è che per anni (secondo la Procura di Monaco fin dal 2015) ha
lasciato approvare i bilanci di Wirecard non conformi al reale stato di salute
dell'azienda. La società di servizi finanziari online ha dichiarato fallimento a
fine giugno scorso dopo che è venuta alla luce la sparizione di 1.900 miliardi
di euro, contabilizzati ma di cui non c'erano riscontri in cassa. Che l'indagine
sul caso Wirecard si stesse allargando ad altri soggetti era parso chiaro già
prima della fine di luglio. «Adesso dobbiamo tutti dare un contributo per
chiarire tutto e trarne le necessarie riforme», aveva dichiarato il ministro
delle Finanze, Olaf Scholz, in occasione dell'audizione davanti alla Commissione
Finanze del Bundestag sul caso Wirecard. «Quando l'emozione del momento si sarà
calmata, quando l'attenzione non sarà più così tanta su questo tema, allora non
si avrà più la forza e il coraggio necessari per queste riforme», ha aggiunto
Scholz, perorando la causa di sfruttare l'occasione per modificare le regole sul
controllo della vigilanza sulle banche. Durante l'audizione, protrattasi per
alcune ore, il ministro aveva più volte spostato l'attenzione sulla pars
costruens della vicenda Wirecard. «È stata una discussione buona e necessaria in
molti dettagli» aveva concluso il ministro, rispondendo ad una domanda dei
giornalisti mentre usciva. «Ora proseguo le vacanze, ma la vicenda non finisce
qui», aveva poi aggiunto il ministro lasciando i giornalisti. Wirecard,
considerata per anni un gioiello del fintech tedesco, tanto da aver provocato la
nascita in Europa più di una società gemella, a causa del fallimento ha subito
l'onta peggiore: il suo titolo in pochi mesi è crollato del 98%. Il fondatore ed
ex-ceo Markus Braun è stato arrestato, così come altri dirigenti della società.
Resta irreperibile, invece, l'ex-coo Jan Marsalek, sospettato di legami con
alcuni servizi di intelligence, si troverebbe in Russia ed è considerato dai
media tedeschi una figura centrale nella truffa.
Matteo Civillini e Gianluca Paolucci per “la Stampa” il 5 agosto
2020. Bet Uniq era una società di scommesse che si era inventata un modo
ingegnoso per aggirare la normativa italiana sul gioco d'azzardo. Il sistema si
reggeva su due elementi: la 'ndrangheta e i servizi di Wirecard, l'ex colosso
tedesco del fintech, franato nel giugno scorso con un buco di due miliardi e una
storia opaca ancora in gran parte da scrivere. BetUniq funzionava così: una
fitta rete di agenzie camuffate da internet point dove, in teoria, i clienti
avrebbero dovuto creare un proprio profilo online e scommettere senza
l'intermediazione del centro. In realtà, le agenzie accettavano scommesse in
contanti che venivano poi caricate su un unico conto gioco alimentato da un fido
concesso da Uniq Group. Società maltese a capo di BetUniq, Uniq Group disponeva
di un conto corrente aperto presso Wirecard che veniva utilizzato per il
trasferimento di soldi dai centri scommesse in Italia alla casa madre. Nel 2014
erano transitati su questo conto circa 3,9 milioni di euro, che secondo gli
investigatori della Dda di Reggio Calabria rappresentavano una parte degli
incassi illeciti derivanti dalla raccolta fisica delle scommesse. Betuniq non
esiste più dal luglio 2015, spazzata via dall'operazione Gambling della Dda
reggina. Il processo d'Appello per 22 imputati si è chiuso un anno fa con sedici
condanne e sei assoluzioni. Tra i reati contestati l'intestazione fittizia di
beni, l'associazione per delinquere e l'associazione mafiosa. A controllare il
gruppo era Mario Gennaro, ai tempi espressione delle più importanti cosche
reggine della 'ndrangheta e oggi pentito. Proprio a una serie di famiglie di
Ndrangheta facevano riferimento le agenzie di BetUniq messa in piedi da Gennaro.
Tra le tante ombre del caso, oltre alla incapacità di regolatori e controllori
di intervenire malgrado i numerosi allarmi, anche la disinvoltura con la quale
Wirecard si è prestata a regolare transazioni di clienti ai limiti del legale -
dal porno estremo al trading di prodotti finanziari ad alto rischio. Fino alle
organizzazioni criminali vere e proprie. Perché quello di BetUniq non è un caso
isolato e le cosche reggine non sono le sole, tra le organizzazioni criminali,
ad aver testato l'efficienza di Wirecard per raccogliere e trasferire denaro
derivante da attività illecite. Tra i suoi clienti c'era anche Centurionbet,
società di gambling controllata dalla famiglia Martiradonna, vicina alla
criminalità organizzata barese. Wirecard processava i pagamenti degli
scommettitori sul sito Bet1128. Marchio che all'apice della propria espansione
commerciale vantava diverse decine di centri scommesse in tutt' Italia e un
fatturato stimato in oltre 100 milioni di euro. Il rapporto tra Wirecard e
Centurionbet è proseguito fino al maggio 2017, quando l'azienda maltese ha
chiuso i battenti in seguito a un'inchiesta della Dda di Catanzaro. Schermata
dietro una serie di scatole vuote a Panama e alle Isole Vergini Britanniche, la
proprietà di Centurionbet era nelle mani di Francesco Martiradonna. Condannato
l'anno scorso a 11 anni e 4 mesi per concorso esterno per aver fatto affari nel
gioco d'azzardo con il clan Arena di Crotone. Del legame tra Wirecard e
Centurionbet ha scritto nei giorni scorsi il Financial Times. Un ex dipendente
dell'azienda tedesca ha riferito al quotidiano britannico che Wirecard avrebbe
svolto una revisione interna su Centurionbet dopo che erano emerse infiltrazioni
mafiose in un altro operatore maltese. L'analisi di compliance avrebbe avuto
esito positivo sulla base di garanzie fornite dall'azienda. Ad affidare i propri
soldi a Wirecard è stata in passato anche Sks365, un'altra azienda nota alle
cronache giudiziarie. Nel novembre 2018 le procure di Reggio Calabria, Bari e
Catania hanno accusato l'azienda di aver stretto alleanze, almeno fino al 2017,
con clan di Cosa Nostra, Sacra Corona Unita e 'ndrangheta. Ponendo così le basi
per costruirsi una solida posizione nel mercato. Oggi la gestione di Sks365 è
passata a un nuovo management estraneo ai fatti incriminati. Ma all'epoca la
proprietà era nelle mani di manager poi arrestati per associazione mafiosa,
riciclaggio e truffa aggravata. Dalle carte dell'indagine emerge che tra
numerosi conti correnti in mezza Europa, Sks365 ne aveva anche due con Wirecard,
nei quali alle fine del 2015 erano custoditi oltre un milione e mezzo di euro.
Wirecard, trema il governo tedesco.
Andrea Massardo il 18 luglio 2020 su Inside Over. Era chiaro sin dal principio
che lo scandalo che ha coinvolto la società finanziaria Wirecard non si sarebbe
limitato ad avere ripercussioni solamente sull’asset societario. Dopo aver reso
evidenti delle gravissime carenze all’interno dell’organo di vigilanza
finanziario tedesco – la Bafin – e gettato nella sfiducia l’intero comparto
finanziario della Germania, adesso lo scandalo potrebbe coinvolgere anche gli
alti vertici del governo. Come riportato da Agenzia Nova, infatti, l’opposizione
tedesca – nella persona del politico liberaldemocratico Florian Toncar – avrebbe
richiesto un’indagine nei confronti del sottosegretario alle Finanze Joerg
Kukies. L’accusa sarebbe quella di aver incontrato in segreto l’ex
amministratore delegato di Wirecard, Markus Braun, per ben due volte lo scorso
autunno. E a preoccupare il parlamento tedesco ci sarebbe l’eccessivo silenzio a
riguardo di Olaf Scholz, ministro delle Finanze e considerato troppo distaccato
dall’accaduto, considerando le implicazioni dello scandalo.
I documenti dei due incontri sono riservati. Secondo quanto
riferito dal quotidiano tedesco Der Spiegel, i documenti relativi agli incontri
tenutisi tra Kukies e Braun sarebbero stati etichettati come riservati e,
dunque, visibili soltanto dai parlamentari ma non disponibili per l’esibizione
pubblica. Tuttavia, il fatto che tali incontri siano avvenuti nello scorso
autunno hanno aperto a molti scenari interpretativi, compreso quello che porta
ad ulteriori ombre sul sistema di vigilanza finanziario della Germania. Stando
infatti alla fonte, in quel periodo la società incaricata di revisionare i
bilanci societari per il Dax – l’indice azionario di Francoforte – ossia
la Kpmg, sarebbe stata al lavoro proprio sui bilanci della società con sede ad
Asscheim. Secondo la ricostruzione, di conseguenza, sarebbe possibile che lo
scopo della discussione potesse essere quello di dissuadere il ministero delle
finanze tedesco e la Bafin dall’approfondire le criticità che sarebbero state
messe in evidenza, come successo già a seguito delle denunce passate di un fondo
americano. E se le cose fossero davvero andate in questo modo, il fatto stesso
che la società non abbia avuto problemi sino alla scorsa primavera potrebbe
significare che il piano di Braun sia andato in porto. Ma per quale motivo il
ministero delle finanze tedesco avrebbe dovuto supportare l’emittente di carte
prepagate Wirecard, considerando tutte le complicazioni e lo scandalo che
avrebbero avuto luogo dallo scoppio della bolla? Ancora una volta, la risposta
sarebbe da ricercarsi – secondo quanto riferito sempre dal Der
Spiegel – all’interno del ceto politico tedesco, nella figura dell’ex ministro
per l’Economia e la Tecnologia Karl-Theodor zu Guttenberg.
Una società strategica per le mire di Berlino. In quanto
registrata in più Paesi come istituto di moneta elettronica autorizzato
all’emissione di valuta digitale e di carte prepagate, Wirecard possedeva la
strumentazione e la tecnologia per poter entrare, all’occorrenza, in qualsiasi
mercato internazionale. E uno in particolare, secondo la ricostruzione, sarebbe
stato particolarmente vantaggioso sia per la società gestita da Braun, sia per
il governo tedesco e sia per il tramite dell’operazione, l’ex-ministro
Guttenberg: la Cina. All’avanguardia per quanto riguarda le forme innovative di
pagamento, la Cina rappresenta un mercato molto redditizio per le società che
operano tramite i pagamenti digitali. Non a caso, infatti, nel novembre 2019
presso i palazzi di Asscheim venne festeggiato l’ingresso della società nel
mercato cinese, ottenuto grazie al tramite dell’ex ministro tedesco e della sua
società registrata regolarmente negli Stati Uniti.
Il governo sapeva ed ha taciuto? A seguito dell’acquisizione, la
stessa Germania possedeva così una società operativa sul mercato dei pagamenti
della Cina, potendo vantare di essere l’unico Paese europeo in possesso di
questa prerogativa. E in questo scenario, l’intermediazione dell’ex-ministro –
nome molto noto all’interno del mondo finanziario cinese – sarebbe stata
fondamentale per la chiusura dell’accordo, anche con lo scopo di migliorare i
rapporti bilaterali tra i due Paesi. Tuttavia, la breve distanza temporale che
separa gli incontri segreti con il sottosegretario Kukies e l’acquisizione
della società cinese getta molte ombre sulla vicenda, considerando come Berlino
potrebbe aver scambiato il “silenzio” sui bilanci di Wirecard con l’ingresso sul
mercato dei pagamenti digitali di Pechino. In questa situazione, dunque, appare
chiaro come lo stesso governo federale, per via di alcuni suoi componenti,
potrebbe essere stata al corrente della bomba ad orologeria che rappresentava il
colosso finanziario anche per i piccoli risparmiatori. E con la decisione di
tacere, infine, si sarebbe reso complice del più grande scandalo finanziario
della Germania dalla sua riunificazione, compromettendo al tempo stesso l’intera
credibilità del sistema tedesco.
Wirecard Papers. Andrea Massardo il
26 luglio 2020 su Inside Over. Era considerata una delle società finanziarie più
promettenti dell’Unione europea la Wirecard Ag, l’emittente di carte
prepagate con la sede nella città di Asscheim, in Baviera, che nell’arco di meno
di 20 anni era riuscita a gestire un portafoglio di gran lunga superiore a
quello di molte banche europee. Considerata uno dei primi e riusciti “unicorni”
della Germania, la società guidata dal 2010 dall’amministratore delegato Markus
Braun aveva creato un impero operativo non soltanto nel vecchio continente ma
anche in Asia (Cina compresa, dal 2019). Tuttavia, la situazione si è
bruscamente invertita in questo 2020 e non a causa della pandemia di
coronavirus come si potrebbe pensare. Bensì, a causa di un ammanco di 1,9
miliardi di euro dichiarati in conti fiduciari inesistenti nelle Filippine. Da
quel momento in avanti, per Wirecard AG, la Dax di Francoforte, l’istituto di
vigilanza finanziaria tedesco (la Bafin) e per lo stesso governo di Berlino è
iniziato un inferno destinato a cambiare per sempre il volto della finanza della
Germania. E con loro, forse, anche lo stesso modo in cui viene gestita
l’operatività degli attori finanziari a livello comunitario.
"Quei soldi, probabilmente, non esisteranno". “Il Consiglio di
amministrazione della Wirecard AG, in base ai dati in possesso, ha valutato che
che gli 1,9 miliardi di euro precedentemente dichiarati come saldi in conti
fiduciari molto probabilmente non esisteranno”. Era il 22 giugno 2020
quando, con questa frase, il nuovo consiglio di amministrazione della società e
il nuovo amministratore delegato nominato in sostituzione di Braun si
sono arresi all’evidenza di uno scandalo troppo grande per essere coperto.
D’altro canto, non c’erano le possibilità economiche e neppure il tempo per
poter coprire un ammanco da oltre due miliardi di dollari, dopo la smentita da
parte delle stesse banche filippine dell’esistenza dei conti fiduciari
dichiarati presso i loro istituti. Ma com’è stato possibile che in dei bilanci
per anni revisionati dalla stessa società di revisione – la Ernest&Young – di
punto in bianco siano stati considerati così falsi da non poter essere
approvati? E soprattutto, come hanno fatto per anni la stessa E&Y, la società di
revisione incaricata dal Dax – la Kpmg – e soprattutto l’istituto di vigilanza
tedesco della Bafin a non accorgersi che le cose non stessero andando nel verso
giusto? Erano passati infatti appena quattro giorni dal 18 giugno, quando il
bilancio approvato dal consiglio di amministrazione guidato ancora da Braun e
comprendendo un altro importante attore della vicenda, Jan Marsalek, era stato
respinto dalla E&Y. Quattro giorni che, però, sono bastati ai due personaggi per
dimettersi dai rispettivi incarichi e, nel caso di Marsalek, per far perdere le
proprie tracce (disperso, secondo le fonti, tra le Filippine, la Cina, la Corea
del Sud e la Bielorussia). E soprattutto, quattro giorni che hanno tenuto il
mondo politico e finanziario tedesco col fiato sospeso, conscio che a seguito
dello scandalo nulla sarebbe mai più stato come prima.
L'arresto di Braun e la fuga di Marsalek. Era la notte tra il 22
e il 23 giugno quando l’ex amministratore delegato della società Markus Braun si
era costituito alla procura di Monaco di Baviera, a seguito del mandato
d’arresto per lo scandalo del colosso finanziario Wirecard AG. Interrogato per
tutta la notte, è stato liberato nella giornata successiva, a seguito del
pagamento di una cauzione di 5 milioni di euro. Tuttavia, dal suo interrogatorio
non sono emerse quelle certezze che la procura stava cercando ed era chiaro che
l’uomo che si stavano trovando di fronte non poteva essere la mente dietro alla
peggiore frode finanziaria che la Germania abbia mai affrontato. Il vero autore
– identificato in quel momento nella persona di Jan Marsalek – era ancora in
libertà ed aveva fatto perdere le sue tracce. E a differenza di Braun , non è
stato sufficiente emettere un mandato d’arresto per farlo uscire allo scoperto.
Nonostante ciò, il suo interrogatorio e l’analisi degli ultimi andamenti del
titolo azionario (che nell’arco di pochi giorni aveva perso oltre il 90% del
proprio valore) erano bastati per capire come l’operatività di Wirecard, in
realtà, fosse semplicemente una copertura per il vero business di Braun e
Marsalek: la speculazione finanziaria. Una pratica fraudolenta, soprattutto
perché attuata sulla loro stessa società e con l’unico obiettivo di pomparne gli
utili per aumentare il suo valore di borsa, anche a costo di dichiarare attività
di bilancio inesistenti, come nel caso dei conti fiduciari delle Filippine. E
soprattutto, protrattasi per anni, in grado di innescare una bomba ad orologeria
pronta ad esplodere da un momento all’altro: esattamente come accaduto lo scorso
18 giugno, a seguito della bocciatura del bilancio da parte di E&Y.
Com'è possibile che la Bafin non si sia mai accorta di nulla? A
sconvolgere l’intero panorama politico e finanziario sono state le grandissime
omissioni dei controlli sulla Wirecard AG, imputabili esclusivamente
all’istituzione che dovrebbe teoricamente garantire la qualità delle aziende
attive sul territorio tedesco: la Bafin. Nonostante le accuse siano state
inizialmente respinte da parte dello stesso capo dell’istituto di vigilanza, è
chiaro ed evidente come uno sguardo più attento ai bilanci societari avrebbe
potuto evitare alla situazione di gonfiarsi sino al punto in cui è arrivata a
cavallo tra il 2019 e il 2020. Soprattutto, poiché nel corso degli anni erano
state molteplici le segnalazioni di operazioni fraudolente e di supporto
all’evasione fiscale messe in atto dalla società e soprattutto effettuate da più
voci indipendenti tra di loro. Tra queste, un noto fondo d’investimenti
americano che aveva avanzato perplessità riguardo agli utili della compagnia e
in modo analogo anche una denuncia da parte degli economisti del Financial
Times. Tutte segnalazioni che, però, sono cadute nel dimenticatoio: in parte per
gli interessi – possibili – delle parti in causa e in parte per l’estrema
fiducia che anche l’istituto di vigilanza tedesco riponeva in Braun, conosciuto
da tutti con il nome di “Mr. Wirecard“. Tuttavia, a seguito di queste gravi
mancanze non è stato soltanto il governo federale a chiedere spiegazioni alla
Bafin: la stessa Unione europea è scesa in prima linea per avere maggiori
dettagli riguardo all’accaduto. Dopo aver seguito l’evoluzione dei fatti,
infatti, Esma (European Securities and Markets Authority) per la prima volta
nella sua storia è arrivata a mettere sotto inquisizione un organo di vigilanza
nazionale, assestando un duro colpo d’immagine a Francoforte.
Vendite allo scoperto e supporto all'evasione: il vero business
di Braun e Mrsalek. Come messo in luce dal proseguimento delle indagini, è
diventato evidente come, in realtà, l’emissione e la gestione delle carte
prepagate fosse in realtà soltanto una parte (e nemmeno la più redditizia) del
business portato avanti dalla società finanziaria con sede ad Asscheim. Secondo
quanto già evidenziato negli anni passati dalla stampa, infatti, gli interessi
della società spaziavano dal mercato del porno, al supporto all’evasione fiscale
per le agenzie clandestine del gioco d’azzardo alla “semplice” messa a punto di
strumentazioni volte a favorire l’elusione fiscale. Una macchina da soldi, in
sostanza, che per buona parte fondava però il proprio piano d’azione su
operazioni al limite – se non al di fuori – della legalità. Ma se questa prima
parte rientrava all’interno dell’operatività dell’azienda, un altro aspetto è
quello che ha invece reso guadagni da capogiro a Marsalek e Braun: la
contrattazione delle azioni della Wirecard AG. Secondo infatti quanto messo in
luce dal DerSpiegel, la coppia avrebbe per anni perpetrato la compravendita nel
breve delle azioni dell’azienda tramite società di comodo per guadagnare
dall’incremento del valore delle azioni. Spesso tramite lo stesso indebitamento
degli attori (come nel caso del mutuo di Deutsche Bank, che non diventerà una
sofferenza soltanto grazie alla sua cartolarizzazione già negli scorsi mesi,
prima dello scoppio della bolla) e spesso tramite la vendita allo scoperto del
titolo azionario. Ultimo dei quali, secondo gli inquirenti, proprio poco prima
della dichiarazione circa l’ammanco di oltre 2 miliardi di dollari dai bilancio
societari: una vendita allo scoperto parsa come una sorta di spettacolo
pirotecnico finale, prima che il circo chiudesse i battenti.
Il governo tedesco, la Bafin e la Dax probabilmente sapevano.
Sempre secondo quanto riportato dal DerSpiegel, c’è un alta possibilità che la
politica e la vigilanza finanziaria della Germania sapesse esattamente quello
che stava succedendo all’interno dei palazzi di Asscheim. In modo particolare, a
causa del filo rosso che legava Markus Braun all’ex-ministro dell’Economia e
della Tecnologia della Germania Karl-Theodor zu Guttenberg e e il segretario
odierno del ministero della finanza Joerg Kukies. In modo particolare, la
presenta di documentazione resa segreta sub incontri avvenuti tra Braun e Kukies
all’interno del ministero avrebbero scandalizzato il parlamento tedesco, che ha
richiesto chiarimenti e indagini sull’accaduto; generando un terremoto
potenzialmente in grado di arrivare sino alla cancelliera Angela Merkel. La
cancelliera, infatti, nel 2019 si sarebbe recata in Cina assieme a importanti
imprenditori tedeschi e con lo stesso Guttenbergs col fine di promuovere la
collaborazione tra i due Paesi. Quest’ultimo, su mandato della Wirecard AG,
avrebbe concluso delle trattative volte a fare entrare la finanziaria tedesca in
operatività anche dentro al mercato della valuta digitale cinese: quasi
esclusivamente di competenza di Pechino fino a quel momento.E in questa
situazione, la sensazione che la stessa cancelliera Merkel fosse all’oscuro
delle operatività del gruppo è alquanto improbabile, soprattutto se si considera
l’importanza strategica di Wirecard all’interno del piano di espansione
commerciale di Berlino in Cina. Scenario che, a ragion veduta, avrebbe potuto
garantire lo sguardo rivolto da un’altra parte su delicate questioni che
avrebbero potuto incriminare la società.
Marsalek, il vero cartaio di Wirecard. Come già sottolineato, il
proseguire delle indagini ha sempre messo più in evidenza la figura di Jan
Marsalek, azionista ed ex-Cfo di Wirecard AG, all’interno delle logiche
criminali della società. In modo particolare, come riportato per la prima volta
dalla testata giornalistica britannica Financial Times, egli avrebbe perpetrato
per anni tentativi – spesso andati a buon fine – di manipolazione del
mercato per convincere potenziali acquirenti ad investire sulla sua società. E
per fare questo, egli avrebbe sempre cercato di mostrare la sua figura come
quella di un uomo potente con agganci presso le più alte élite mondiali; in
possesso – come riscontrato – della documentazione sul velenosissimo novichok e
di file importanti appartenenti al ministero degli interni austriaco. In questo
modo, egli per anni avrebbe ostentato una solidità della propria società basata
anche sull’appoggio del ceto politico asiatico ed europeo, fornendo così
garanzie – mendaci – aggiuntive riguardo alla stabilità del titolo azionario.
Tuttavia, anche in questo caso si è trattato principalmente di frodi finanziarie
nei confronti di fondi d’investimento e di privati, messi in atto da una mente
che appare sempre di più il vero cartaio dietro alle mosse della società di
Asscheim.
Sandra Riccio per ''la Stampa'' il 10 luglio 2020. I guai per le
banche tedesche non finiscono mai. Nel mirino ci sono soprattutto Deutsche Bank,
primo istituto del Paese, e Commerzbank, numero due. Le recenti vicende hanno
visto la prima multata dalle autorità americane (150 milioni) per aver chiuso
più occhi sulle transazioni «sospette» del finanziere Jeffrey Epstein.
Commerzbank, invece, è alle prese con l'ennesima ristrutturazione in arrivo. In
questi giorni, il grande fondo americano Cerberus, che è scontento dei flop
dell'istituto, è riuscito a disarcionare i vertici della banca. Secondo i media
tedeschi, il nuovo management dovrà mettere mano a un profondo riordino e
l'ipotesi è di una chiusura delle metà delle filiali. A impensierire il mercato
è anche la vasta galassia delle Landesbanken tedesche, le «piccole» banche
locali che messe insieme fanno numeri da giganti: le prime sei totalizzano un
attivo patrimoniale di circa 90 miliardi (il 60% circa degli asset di DB). In
primo piano c'è la stabilità del sistema finanziario tedesco, in un periodo in
cui la Germania ha la presidenza di turno dell'Ue. Due sono le debolezze del
sistema. «Da un lato i grandi colossi sono alle prese con una redditività bassa
che sarà ulteriormente appesantita dalla crisi Covid - spiega Roberto Russo, ad
di Assiteca Sim -. Dall'altra parte, le Landesbanken combattono con le
conseguenze dei crediti concessi con generosità a partire da inizio anni 2000».
Nonostante i maxi-aiuti da 238 miliardi arrivati dallo Stato tedesco per
sostenere il sistema tedesco, le banche del Paese continuano a essere in
difficoltà. A tenere con il fiato sospeso è però la bomba a orologeria dei
derivati in pancia alle big. Si tratta di strumenti di investimento ad altissimo
rischio che scommettono con la leva. Numeri ufficiali non ce ne sono. Secondo
alcune analisi, Deutsche Bank da sola ne avrebbe in pancia per 43 mila miliardi
di dollari (16 volte il pil tedesco). Un vero elefante nella stanza dei
cristalli che si muove pericolosamente soprattutto nelle fasi di crisi economica
e di volatilità sui mercati finanziari. Il rischio è che travolga l'intero
sistema europeo. Su questo punto si è soffermata Fitch che a marzo ha declassato
il rating di Deutsche e di Commerz. In più ha abbassato tutte le previsioni
relative agli altri istituti tedeschi, considerandoli a rischio. Certo, il
momento non è favorevole per il settore bancario di nessun Paese. Dalla Germania
però potrebbero potenzialmente partire shock molto più pericolosi. Lo sa anche
la cancelliera tedesca Angela Merkel che sta spingendo sul via libera al
Recovery Fund che servirà a far ripartire l'Europa. A sperare sono anche gli
istituti tedeschi: in vista della data decisiva di metà luglio quando si riunirà
il Consiglio, i titoli di DB e di Commerzbank hanno preso a salire. Restano però
ancora lontani i recuperi: i due titoli, nei 10 anni sono ancora giù tra l'80 e
il 90%.
"Così Epstein pagava le modelle russe". E Deutsche Bank
finisce sotto accusa. Deutsche Bank ha reagito
all’offensiva delle autorità newyorchesi annunciando investimenti per rafforzare
i propri apparati di vigilanza interna. Gerry Freda, Mercoledì 08/07/2020 su Il
Giornale. Le autorità di New York hanno di recente inflitto a Deutsche Bank una
sanzione milionaria a causa dei legami intercorsi tra l’istituto di credito e il
magnate Jeffrey Epstein. Il dipartimento per i Servizi finanziari dello Stato di
New York ha infatti comminato tale multa al gigante tedesco accusando
quest’ultimo di non avere adeguatamente monitorato le operazioni finanziarie
opache condotte dall’uomo d’affari incriminato dal 2013 al 2018. La sanzione
citata è il primo provvedimento adottato nel mondo da un ente di vigilanza
finanziaria contro un istituto di credito responsabile di complicità con
Epstein, morto in carcere lo scorso 10 agosto mentre attendeva di essere
processato per traffico di minori. Il dipartimento statale ha, nel dettaglio,
comminato ultimamente a Deutsche Bank una multa di 150 milioni di dollari. Alla
base della condanna della banca tedesca vi è stata, da parte delle autorità
locali, la constatazione del fatto che il colosso finanziario avrebbe chiuso un
occhio su molteplici movimenti di denaro effettuati in vita da Epstein per scopi
poco leciti. In particolare, il gigante teutonico avrebbe accordato al
chiacchierato magnate di effettuare centinaia di transazioni milionarie opache,
principalmente dirette a chiudere le vertenze legali di Epstein e a “pagare
donne”. L’uomo d’affari newyorchese, secondo l’agenzia statale, avrebbe infatti
ottenuto da Deutsche Bank, dal 2013 al 2018, finanziamenti di oltre 7 milioni di
dollari diretti a tacitare le controversie giudiziarie in cui egli era
implicato, nonché trasferimenti di denaro superiori ai 2,6 milioni per fare
piaceri e regali a delle donne. Tra le operazioni finanziarie opache del
presunto pedofilo accordategli in passato dalla banca tedesca vi erano, per la
precisione, alcune intese a “pagare modelle russe”. La principale colpa della
banca, ad avviso del dipartimento dello Stato di New York, sarebbe stata quella
di commettere gravi mancanze nelle istruttorie propedeutiche alle frequenti
erogazioni di denaro a beneficio di Epstein. Un comunicato della medesima
autorità chiarisce con le seguenti parole le responsabilità dell’istituto di
credito: “Se quei finanziamenti e quei movimenti di denaro siano o meno serviti
a Epstein per coprire vecchi suoi crimini, per perpetrarne di nuovi o per
qualche altro scopo lo dovranno stabilire le autorità penali. Tuttavia, il fatto
che quei movimenti di liquidità fossero in sé sospetti e rischiosi doveva
apparire evidente al personale della banca, in qualsiasi livello fosse
inquadrato. L’incapacità dell’istituto di credito di riconoscere quei rischi
costituisce una grave mancanza alle proprie regole di condotta e di
trasparenza”. Deutsche Bank ha reagito alle contestazioni avanzate nei propri
confronti dal dipartimento citato ammettendo di avere commesso “un errore”
nell’avere intrattenuto rapporti con Epstein a partire dal 2013. La medesima
azienda ha contestualmente comunicato di essere profondamente “dispiaciuta” per
avere avuto a che fare con il presunto pedofilo e per avere condotto delle
istruttorie “carenti” riguardo ai movimenti di denaro effettuati da
quest’ultimo. Il colosso finanziario ha infine evidenziato di avere deciso, al
fine di non ripetere gli sbagli commessi nel caso del magnate incriminato,
investimenti di circa un miliardo di dollari nel rafforzamento dei propri
apparati di vigilanza sulle operazioni rischiose o sospette. Obiettivo della
banca sarà appunto evitare che si verifichino in futuro altri scandali
suscettibili di danneggiare l’immagine aziendale, attualmente sotto attacco,
oltre che per la vicenda-Epstein, anche per il presunto scambio di favori con al
centro lo stesso istituto di credito e il Cremlino.
Riccardo Barlaam per ilsole24ore.com l'8 luglio 2020. Pagamenti
ai presunti complici. Bonifici a modelle russe. Prelievo in contanti da 100mila
dollari per «mance e spese di casa». Quando Jeffrey Epstein chiedeva di
effettuare operazioni finanziarie, la filiale americana di Deutsche Bank, il più
grande istituto bancario tedesco, non faceva molte domande né effettuava i
controlli necessari su transazioni giudicate «sospette» e «ad alto rischio» per
un cliente di cui erano noti i trascorsi legati a crimini sessuali. In un
accordo giudiziale appena annunciato, la banca tedesca ha accettato di pagare
una multa di 150 milioni di dollari al New York Department of Financial Services
(Dfs) per chiudere l’inchiesta aperta nel 2019 sui rapporti bancari con il
finanziere. Il New York State Department of Financial Services ha spiegato che
la banca tedesca è stata multata perché «non ha controllato in modo appropriato
le attività bancarie condotte in nome» di Epstein dal 2013 al 2018. A causa
della mancata supervisione, «la banca ha approvato centinaia di transazioni per
milioni di dollari che avrebbero dovuto portare a un controllo aggiuntivo, alla
luce della storia di Epstein». Tra le transazioni, alcune riguardano pagamenti a
persone accusate di coinvolgimento negli illeciti di Epstein. Sotto la lente
sono finiti anche i rapporti di Epstein in cui ha fatto da tramite Deutsche Bank
con le banche corrispondenti Danske Bank Estonia e Fbme Bank. Epstein, arrestato
nel maggio 2019 con l’accusa di sfruttamento di minorenni e abusi sessuali, si è
suicidato impiccandosi nell’agosto scorso nella cella dove era recluso a New
York. Il finanziere era amico dei presidenti Donald Trump e Bill Clinton così
come del principe Andrea d’Inghilterra, finito anch’egli nel turbine
dell’inchiesta per gli abusi sessuali sulle minorenni. La sua ex compagna
Ghislaine Maxwell, accusata di aver gestito per anni l’agenda degli appuntamenti
con le minorenni, è stata arrestata pochi giorni fa in New Hampshire. Rischia
fino a 30 anni di prigione: molti temono che possa raccontare le sue verità,
verità che potrebbero essere imbarazzanti per molti “potenti”. Epstein nel 2008
era stato condannato in Florida per sfruttamento della prostituzione su ragazze
minorenni. «Il comportamento criminale e gli abusi sessuali del signor Epstein
erano noti da anni, ma le grandi istituzioni bancarie hanno continuato a
ignorare la sua storia e hanno prestato la loro credibilità e i loro servizi in
cambio dei guadagni finanziari», ha scritto il governatore dello stato di New
York Andrew Cuomo in una nota. Gli inquirenti hanno stabilito che Deutsche Bank
non è riuscita a monitorare correttamente le transazioni di Epstein nonostante
le «ampie» informazioni pubblicamente disponibili sulla sua condotta sessuale.
Ciò ha portato la banca a effettuare senza controlli centinaia di transazioni
per Epstein che avrebbero dovuto spingere maggiore cautela, compresi i pagamenti
alle vittime, i presunti complici e gli studi legali che rappresentano Epstein e
i suoi complici. Nei rapporti con Danske Estonia, coinvolta nel 2018 in uno
scandalo legato al riciclaggio di denaro dalla Russia da 150 miliardi, e Fbme
Bank, gli inquirenti hanno affermato che Deutsche Bank non è riuscita a
monitorare adeguatamente le banche corrispondenti e le società di compensazione
del cambio con il dollaro. L'amministratore delegato di DB Christian Sewing in
una nota interna ha scritto che è stato un errore accettare Epstein come cliente
nel 2013. La banca ha anche riconosciuto carenze nei controlli su Danske Estonia
e Fbme. «Dobbiamo tutti contribuire a garantire che questo genere di cose non si
verifichi più». In tarda serata Deutsche Bank ha diffuso il seguente
comunicato: «Riconosciamo il nostro errore nell’accettare Epstein come cliente
nel 2013 e le debolezze dei nostri processi, abbiamo imparato dai nostri errori
e dalle nostre carenze. Immediatamente dopo l'arresto di Epstein, abbiamo
contattato le forze dell'ordine e offerto la nostra completa assistenza nelle
indagini. Siamo stati completamente trasparenti e abbiamo affrontato queste
questioni con il nostro regolatore, adeguato la nostra tolleranza al rischio e
affrontato sistematicamente i problemi. Abbiamo investito circa 1 miliardo di
dollari in formazione, controlli e processi operativi e abbiamo allargato il
nostro team contro i crimini finanziari a oltre 1.500 persone. La nostra
reputazione è la nostra risorsa più preziosa e ci rammarichiamo profondamente
per i nostri rapporti con Epstein».
(ANSA il 24 giugno 2020) - Bayer ha raggiunto un patteggiamento
da 10,5 miliardi di dollari per risolvere decine di migliaia di azioni legali
negli Stati Uniti sul Roundup, il diserbante di Monsanto accusato di causare il
cancro. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, Bayer ha ereditato il
Roundup quando ha acquistato Monsanto nel 2018.
Paolo Balduzzi per ''Il Messaggero'' il 7 luglio 2020. Una volta
fiore all'occhiello di ogni paese, fulcro dello sviluppo industriale e snodo
cruciale per la trasmissione della politica monetaria, nonché prospettiva per
una carriera lunga e ricca, il sistema bancario negli ultimi quindici anni è
entrato fortemente in crisi. Come spesso accade, sostegno pubblico (più o meno
esplicito), potere di mercato e ingenti disponibilità di risorse non sono segno
di grande efficienza bensì a volte proprio il contrario, e mascherano enormi
problemi che possono emergere solo nel lungo periodo o a seguito di fatti
straordinari. E i primi vent' anni del nuovo secolo, in tutto il mondo, sono
stati certamente testimoni di eventi eccezionali, specialmente in campo
economico e bancario. Basti pensare al terremoto innescato dalla crisi
statunitense dei mutui subrime, poi trasferitasi in Europa contagiando bilanci
pubblici e stato dell'economia, fino all'entrata in recessione. Recessione cui
ne ha fatto seguito un'altra, a dieci anni di distanza, questa volta per le note
cause sanitarie. Vale quindi la pena di capire come si sono evoluti il sistema
bancario italiano ed europeo in questo periodo, come hanno reagito a queste
tensioni e in che stato di forma si trovano ad affrontare le conseguenze
dell'attuale pandemia. La debolezza italiana è a tratti comune con quella di
altri paesi europei: in generale, i problemi nascono da una eccessiva diffusione
del credito, resa possibile anche grazie alla diminuzione dei tassi d'interesse
a seguito alla creazione dell'Unione monetaria europea. In tutto il mondo, la
concessione di prestiti senza la verifica di adeguate garanzie (la solvibilità
dei debitori, il valore di immobili gonfiato da bolle speculative) ha dato luogo
a insolvenze e perdite. Esemplare da questo punto di vista il caso di Lehman
Brothers nel 2008. Nel nostro paese, il problema è di fatto esploso più tardi,
intorno al 2013 e legato soprattutto al deterioramento dei conti aziendali per
effetto della recessione. Banca Etruria, Banca Marche, Carige sono alcuni tra i
soggetti coinvolti dalla crisi. Ma in realtà, secondo i dati della Banca
d'Italia, gran parte del sistema risultava deteriorato: il 22% dei prestiti
risultava infatti a rischio di mancato rimborso. Nel caso del Monte dei Paschi
aveva inciso anche un'errata politica delle acquisizioni. Lo Stato è intervenuta
innanzitutto direttamente, attraverso l'assorbimento di debiti privati
all'interno del bilancio pubblico: le risorse messe a disposizione nel periodo
2013-2018 sono state ingenti, anche se poi parzialmente recuperate: fino a 20
miliardi, secondo i conti fatti dall'Osservatorio sui conti pubblici italiani
dell'Università Cattolica di Milano. Inoltre, diversi sono stati gli interventi
legislativi: per esempio, la riforma della normativa sulle banche popolari e
delle banche di credito cooperativo; oppure, l'introduzione a livello europeo
della procedura di bail-in in caso di un aiuto di Stato (applicato in Italia per
la prima volta con banca Etruria, Banca Marche, Cari Ferrara e Cari Chieti): una
scelta molto costosa soprattutto per gli azionisti, di fatto imposta da
Bruxelles e che oggi nessuno ripeterebbe più. Oltre agli interventi pubblici
diretti, gli istituti bancari hanno operato in maniera più o meno autonoma
diverse strategie di reazione, che hanno comportato fusioni e maggiore
concentrazione. In particolare, secondo Bankitalia il numero di banche e
istituti finanziari è passato da 760 a 485 (che però diventano 343 se si
considerano le 142 banche di credito cooperativo riunite in Iccrea) tra il 2010
e il 2019 e l'indice che misura la concentrazione degli istituti di credito è
cresciuto tra il 2015 e il 2019 del 48%, da 435 a 643 (dati Bce). Anche se
parlare di concentrazione spesso fa torcere il naso agli amanti della
concorrenza, non bisogna dimenticare che in economia l'efficienza richiede anche
il raggiungimento di dimensioni di scala opportune. In questo caso, la scala
degli istituti, italiani ma non solo, è sempre stata troppo piccola, e le
fusioni hanno permesso - o dovrebbero permettere - di avere le risorse
necessarie per gli indispensabili investimenti in infrastrutture digitali e in
analisi dei dati. L'aumento della concentrazione, in un settore che comunque
conta ancora numerosi soggetti, ha avuto poco effetto sulla competitività. I
margini di ricavo, anche alla luce di una prospettiva di tassi estremamente
bassi, lascia poche alternative per aumentare la redditività, vale a dire il
taglio dei costi. È così che, sempre tra il 2010 e il 2019, in Italia si è
passati da quasi 34.000 filiali aperte sul territorio a poco più di 24.000 e da
circa 330.000 addetti a circa 280.000 (fonte Bankitalia). Certo, le debolezze
permangono e il sentiero è ancora lungo, ma la direzione sembra essere quella
giusta e il colpo l'acceleratore dato dal Tesoro agli ultimi casi in sospeso (la
Popolare di Bari e il Monte dei Paschi) rendono ancora più visibili i progressi
compiuti. Tanto è vero che l'Italia, in questo campo, non può essere certo
definita maglia nera d'Europa. Basta uno sguardo ai dati per capire che il
sistema bancario è parcellizzato un po' ovunque: 36.000 filiali aperte e 400.000
addetti in Francia e 24.000 filiali e 173.000 addetti in Spagna, nonostante
indici di concentrazioni più elevati che in Italia (rispettivamente pari a 654 e
1.110). Va segnalato che tra i paesi con minore concentrazione di istituti
bancari, spiccano il Lussemburgo (indice pari a 277), il Regno Unito (ora fuori
dall'Unione, indice pari a 349) e l'Austria (369). Ma il caso probabilmente più
eclatante è quello tedesco, dove le banche operanti sono ancora circa 1.800, le
filiali quasi 27.000, gli addetti circa 580.000, più del doppio dell'Italia; e
l'indice di concentrazione è il più basso in Europa, pari a quello del
Lussemburgo. Di queste banche, la quota più piccola è costituita da banche
private, mentre il restante è composto da banche popolari, casse di risparmio
locali e banche pubbliche regionali, le cosiddette Landesbank. Inoltre, le due
principali banche private, Deutsche Bank e Commerzbank, sarebbero sull'orlo del
fallimento, se contassero solo i fondamentali economici e non la politica, con
un rapporto tra costi e ricavi tra i peggiori in Europa (Svizzera e Regno Unito
compresi). La quarta banca regionale, la NordLB, è stata salvata con un aiuto di
Stato che ha sostanzialmente ignorato le vigenti regole di bail-in (applicate
invece ovunque altrove in Europa). E lo scorso novembre, l'agenzia di rating
Moody' s ha rivisto al ribasso (da stabile a negativo) l'outlook sul sistema
bancario tedesco. Una brutta gatta da pelare per Angela Merkel e per il paese,
che per anni ha vantato un surplus commerciale con l'estero che però ha di fatto
obbligato le banche tedesche a cercare allocazioni di capitale fuori dai confini
nazionali, anche ricorrendo a investimenti piuttosto rischiosi. Tanto è vero che
proprio molte banche tedesche risultavano imbottite di titoli tossici americani,
quelli della famosa crisi del 2007. Secondo la Bce, tra il 2008 e il 2014 la
Germania aveva già sostenuto il proprio sistema bancario con oltre 250 miliardi
di euro di aiuti lordi, a fronte per esempio dei soli 4 miliardi messi in campo
dall'Italia nello stesso periodo. Forse non saranno i soldi degli italiani che
salveranno le banche tedesche ma è evidente che la tenuta della stabilità
finanziaria dell'Unione, soprattutto nei prossimi anni, si dovrà basare su
dinamiche e flussi redistributivi diversi e meno scontati. Probabilmente anche
per queste ragioni la rigorosissima Germania ha abbandonato quasi subito le
proprie posizioni di chiusura nei confronti del Recovery Fund, addirittura
diventando uno dei fan più accesi: la creazione di sentimento continentale di
solidarietà diffusa, in fin dei conti, potrebbe tornarle molto utile, nei
prossimi anni.
La Germania
prova a salvare la faccia.
Andrea
Massardo il 6 luglio 2020 su Inside Over. Dopo quanto successo all’istituto di
moneta elettronica Wirecard AG – in uno dei fallimenti più sonori della storia
della Germania – adesso Berlino starebbe lavorando ad un progetto volto a
migliorare gli strumenti in mano alla vigilanza finanziaria tedesca, la Bafin. A
renderlo noto è il quotidiano Der Spiegel, il quale ha sottolineato come le
lacune messe in evidenza all’interno dell’operatività e dell’operato di
Francoforte sul Meno abbiano contribuito in modo predominante alla crisi che ha
cancellato dal giorno alla notte il colosso finanziario operativo in tutta
Europa. Nello specifico – ed essendo state messe in evidenza le difficoltà che
ha dovuto affrontare la Bafin – il Ministero dell’economia starebbe studiando
delle migliorie volte a velocizzare i controlli. Tuttavia, come sottolineato
dallo stesso ministro tedesco Olaf Scholz, tale situazione è stata generato
anche dall’enorme complessità nell’analisi dei bilanci societari di quelle
aziende operanti in più mercati e tramite le proprie controllate. Ed è in questo
scenario, appare chiaro come l’unica via d’uscita sia quella che conduce ad una
semplificazione delle procedure operative, necessarie a velocizzare i lavori e
permettere che tali criticità vengano alla luce in tempo utile per agire.
Germania, buon
viso a cattivo gioco? Quanto accaduto a Wirecard AG ha messo in luce tutti i
limiti degli organi di vigilanza della Germania, oltre alla poca affidabilità
anche delle agenzie che si occupano della revisione dei conti per le società
quotate in borsa. E soprattutto, l’accaduto ha messo anche in cattiva luce
l’intero comparto finanziario tedesco, evidenziando infatti il rischio che ben
più di una società abbia potuto mettere in pratica gli stessi “trucchi”
di Markus Braun e dell’azionista Jan Marsalek. In fin dei conti, però,
Francoforte era consapevole già da tempo di avere un sistema di vigilanza che
faceva letteralmente acqua da tutte le parti e cui riscontro si può osservare
anche nell’operatività del colosso bancario Deutsche Bank, spesso al limite del
lecito. Tuttavia, nessuna mossa davvero efficace è stata mai preso dal ministero
dell’economia, continuando con lo stesso canone di controlli che più di una
volta si sono rivelati insufficienti. La domanda dunque sorge spontanea: ma la
Germania è davvero così intenzionata a migliorare il proprio sistema di
vigilanza? In fin dei conti dalle sue lacune nei controlli e in un sistema
normativo decisamente più semplificato rispetto a quello degli altri Paesi
europei, le società tedesche sono sempre riuscite a trarne dei vantaggi – i
quali si sono riflessi anche sul Pil della Germania. Andare a smuovere le
fondamenta di questo sistema significherebbe mischiare nuovamente le carte in
tavola, con la possibilità che molte aziende scelgano di migrare verso altre
realtà oppure vedano ridotte le proprie positività di bilancio. E questa
situazione, in fondo, non sarebbe auspicabile neppure per la stessa Berlino, che
mai come in questo periodo ha bisogno di dimostrare la propria solidità
economica.
L’obiettivo è
salvare la faccia. Stando alle premesse e considerando le ripercussioni
dell’accaduto, appare chiaro come per la Germania la preoccupazione maggiore in
questo momento sia quello di salvare la faccia e la propria credibilità
internazionale. Il fango gettato dalla vicenda che ha coinvolto Wirecard AG e la
Bafin rischiano infatti di diventare un terremoto per i comparti tecnologici e
finanziari di Francoforte che sarebbero difficilmente gestibili da parte di
Berlino. La decisione di intervenire sul sistema di vigilanza, in fondo, è fine
a se stessa se ad essa non fanno seguito una serie di norme attuative volte a
trasformare in “reali” le semplici direttive governative. Ma la loro discussione
e soprattutto la loro introduzione sarebbero fondamentali per permettere alla
Germania di “prendere tempo” e sperare che il tempo ripari da solo alla crisi
che si è creata. Il tutto, ovviamente, avendo dimostrato – almeno a parole – di
essersi mossi sull’accaduto. Ancora una volta, infatti, il rischio e quello che
la Germania – dall’alto della sua immagine rigorista – faccia buon viso a
cattivo gioco, cercando di vendere al mondo un ideale di “perfezione” che non è
però stato raggiunto. E soprattutto, facendo leva sulla sua potenza commerciale
per convincere gli investitori circa la propria stabilità, sebbene gli ultimi
accadimenti abbiano dimostrato che gli scheletri nell’armadio esistono anche in
Germania.
Cipro multa Commerzbank: un altro scheletro nell’armadio
tedesco. Andrea Massardo il 5 luglio 2020 su Inside
Over. Sembra non avere fine l’elenco di scandali e tentativi di manipolazione
dei mercati portati avanti dai colosso bancari e finanziari della Germania. Dopo
la pluri-indagata Deutsche bank e i recenti avvenimento che hanno coinvolto
l’istituto di moneta elettronica Wirecard AG, anche Commerzbank è finita sotto
la lente degli investigatori, questa volta ciprioti. Secondo quanto riportato
infatti dall’agenzia di stampa Reuters, la seconda banca di Germania con la sede
a Francoforte sul Meno è stata raggiunta da una multa di 650mila euro per aver
manipolato i titoli di una defunta banca cipriota, la Laiki, con la quale aveva
portato avanti in simbiosi movimenti finanziari altamente speculativi.
Commerzbank è alla base della crisi cipriota del 2013? Secondo
quanto dichiarato dalla sentenza, Commerzbank e Laiki avrebbero portato avanti
investimenti strutturati dal 2008 in avanti, spostandosi quindi su una serie di
azioni speculative sulle stesse azioni della seconda banca cipriota nel 2011.
L’operatività finanziaria è però risultata discriminante nel fallimento
dell’istituto di credito di Cipro, entrato in amministrazione controllata nel
2013 e ancora soggetto a diretto controllo delle autorità. Anche per questo
motivo, infatti a subire la multa da parte dell’autorità di vigilanza azionaria
di Nicosia è stata la banca tedesca, col fine di non danneggiare ulteriormente i
già vessati azionisti e correntisti della Laiki. A seguito del fallimento
dell’istituto di credito nel 2013, la parte grecofona dell’isola del
mediterraneo era stata colpita da una profonda crisi economica generata dalla
sfiducia dei mercati nel suo indice azionario e a causa delle ripercussioni
sulla clientela del default bancario. Stando alle normative europee, infatti,
soltanto i depositi sino a 100mila euro sono stati tutelati, generando in questo
modo una crisi cui effetti non sono ancora completamente spariti. E in questo
scenario, come emerso dalle indagini, parte della colpa è detenuta dalla tedesca
Commerzbank e dalle sue operazioni volte a drogare – in accordo con i dirigenti
ciprioti – il valore azionario della Laiki.
La Germania è al centro degli scandali finanziari. È impossibile
dimenticarsi la durezza con la quale in quegli anni la cancelliera
tedesca Angela Merkel si era rivolta a Paesi come l’Italia, la Grecia e Cipro.
In particolar modo, con le volontà di rallentare gli aiuti nei confronti di quei
Paesi che stavano attraversando gravi crisi economiche e che avrebbero avuto
bisogno di meno rigore e di più sostegno. Tuttavia – e come evidenziato anche
dagli ultimi accadimenti – buona parte della crisi soprattutto greca e cipriota
è da additarsi proprio alla stessa Germania ed alle attività illecite portate
avanti dai propri istituti di credito in campo finanziario. Insomma, un po’ come
dire “la colpa è nostra, ma adesso a rimediare tocca a voi”. Soprattutto, però
non si può negare nemmeno quanto il modus operandi portato avanti dalle società
tedesche – e garantito dal basso livello di sorveglianza attuato dalla Bafin –
stia mettendo in pericolo la totalità dell’Europa. Con gli ultimi scandali –
come quello di Wirecard – e i comportamenti fraudolenti – come quelli di
Deutsche Bank e Commerzbank – l’intero comparto finanziario europeo sembra
improntato esclusivamente alle pratiche illecite. E in un momento di crisi
economica come quello che il mondo sta attraversando e con la sostanziale
sfiducia ancora dei mercati, gli ultimi accadimenti non sono sicuramente un
impeccabile biglietto da visita.
Gianluca Paolucci per ''la Stampa'' il 29 giugno 2020. Con 45
bonifici tra la fine di gennaio e novembre del 2015, Wirecard ha inviato oltre
150 milioni di dollari nel conto personale di un avvocato francese basato in
Lussemburgo, presso la Cayman National Bank dell'Isola di Man. La società
tedesca, che nei giorni scorsi ha chiesto la dichiarazione d'insolvenza dopo
essere stata travolta da uno scandalo contabile multimiliardario, è al centro di
un caso internazionale che mostra ancora una volta la debolezza dei controlli
sulle operazioni finanziarie. Ma se dal lato della frode contabile è già emerso
molto, i documenti consultati da La Stampa mostrano come la piattaforma di
Wirecard sia stata anche uno strumento per attività ai limiti del legale,
consentendo la movimentazione di enormi masse di denaro con scarse possibilità
di controllo. Tutto parte il 26 gennaio del 2015, quando Sebastien Limat,
avvocato francese che esercita in Lussemburgo, apre quello che sembra a tutti
gli effetti un conto personale - l'indirizzo di registrazione è quello di un
piccolo paese nei pressi di Thionville, ai confini con il Granducato - presso la
Cayman National Bank and Trust dell'Isola di Man. Quattro giorni dopo, il 30
gennaio, Wirecard Bank Ag invia su quel conto 5,548 milioni di dollari. Al 27
novembre del 2015, il totale dei bonifici ricevuti è di 152,19 milioni di
dollari. L'attività dell'avvocato non passa però inosservata. La piccola banca
dell'Isola di Man utilizza come "banca corrispondente" per tutta una serie di
attività National Westminster Bank, nota come Natwest, una delle principali
banche del Regno Unito e parte del gruppo Royal Bank of Scotland (Rbs),
controllata dal Tesoro britannico. A sua volta, Natwest si appoggia a Jp Morgan
per regolare sul mercato bancario le operazioni in dollari. Ed è proprio Jp
Morgan a trovare l'attività sul conto dell'avvocato quantomeno sospetta e a
chiedere alla sua corrispondente Natwest una serie di chiarimenti. Le lettere,
che fanno parte di un leak di dati della Cayman National Bank ottenuto dagli
attivisti di Ddos e rese disponibili da Occrp (Organised Crime and Corruption
Reporting Project), chiedono di rendere note le finalità e i destinati reali dei
fondi recapitati sul conto dell'avvocato che, secondo replica la Cayman
National, agisce non in proprio ma come trustee (fiduciario) di una serie di
società, che a loro volta si appoggiano a Wirecard per ricevere i pagamenti. Un
elenco delle società viene allegato alla risposta fornita a Jp Morgan e consente
di far luce su una parte assai redditizia del business di Wirecard: i pagamenti
per i servizi online dalla scarsa reputazione. Porno, scommesse, trading di
titoli ad alto rischio, appuntamenti e altro. Tra i clienti di Limat - e di
Wirecard - figurano un sito di incontri chiuso nel 2018 e una società di trading
di opzioni binarie (Banc de Binary), travolta da sospetti di frode, la cui
licenza è stata revocata dalle autorità cipriote. Cinque su 35 società
dell'elenco hanno sede allo stesso indirizzo dell'isola di Guernsey, paradiso
fiscale nella Manica. Secondo quanto ricostruito, l'interposizione di un
soggetto terzo consentirebbe di "schermare" le reali attività per consentire
l'operatività anche verso clienti di quei paesi dove queste attività sono
proibite, come il porno in molti paesi islamici o le scommesse in alcuni stati
americani. Cnb risponde a Jp Morgan che le attività condotte sono legali e che
il cliente (Limat) è un soggetto affidabile. Nel database c'è però anche una
lettera della funzione di controllo di Rbs dell'aprile del 2016, indirizzata a
Cnb, nella quale la banca britannica spiega di aver compiuto un esame sui conti
di Limat, in seguito al quale l'istituto, senza fornire altri dettagli, ha
deciso di non consentire più l'utilizzo del conto di corrispondenza di Cnb
presso la sua controllata Natwest per le operazioni dell'avvocato francese.
Quel filo rosso che lega Markus Braun a Deutsche Bank.
Andrea Massardo il 26 giugno 2020 su Inside Over. Sono giorni
difficili quelli che stanno attraversando l’istituto di moneta elettronica
tedesco Wirecard e il suo ex amministratore delegato Markus Braun, nell’occhio
del ciclone da quando è stato reso noto un ammanco di bilancio di quasi due
miliardi di euro. Tuttavia – da quando il vaso di Pandora è stato scoperchiato –
sono sempre più oscure le notizie e gli avvenimenti che stanno circondando la
vicenda e che vedono come attore principale proprio l’uscente Ceo della società
finanziaria. E in questa vicenda, adesso, sembra avvicinarsi anche lo spettro di
un altro volto noto agli organi di vigilanza della Germania per le sue
operazioni molto spesso al limite del legale, ossia il colosso bancario
tedesco Deutsche Bank.
Braun e DB: un legame da 150 milioni di euro. Stando alle
indiscrezioni riportate da Il Sole 24 Ore, nel corso del 2017 Braun avrebbe
ottenuto un finanziamento di 150 milioni di euro da Deutsche Bank, mettendo a
garanzia buona parte dei titoli in suo possesso (il 7%, fino a pochi giorni fa)
della società da lui amministrata. In questo modo, egli si è potuto garantire la
liquidità necessaria in un’operazione di margin call, coprendo il finanziamento
con il doppio della cifra in azioni. Il gioco, in fondo, è molto semplice: più
cresceva il valore azionario di Wirecard, minori erano le azioni impegnate a
copertura del finanziamento e soprattutto maggiori erano in margini di guadagno
tramite la compravendita delle azioni. Un gioco relativamente semplice da
effettuare se si possiedono sia la liquidità che la conoscenza idonea delle
operazioni finanziarie (ed è con questa chiave di lettura che, forse, va
interpretato parte dello scandalo che ha avvolto la società). Tuttavia, col
tracollo delle azioni dal finire della scorsa settimana anche il prestito
contratto con Deutsche Bank sembrerebbe risultare scoperto. Esatto, sembrerebbe,
perché in realtà quell’indebitamento non è più nelle mani nella banca di
Francoforte.
Deutsche Bank ha cartolarizzato il debito. Tramite un’operazione
di cartolarizzazione nota con l’acronimo di Clo (Collateralised loan
obligations) Deutsche Bank si era liberata già da mesi del proprio credito nei
confronti di Braun. Sentore che qualcosa non stesse funzionando o semplice
operazione volta a “liberarsi” del peso di un grosso indebitamento per impegnare
al meglio il capitale? Difficile a dirsi e soprattutto sull’argomento sono
necessarie ulteriori indagini da parte degli inquirenti (e degli organi di
vigilanza tedeschi, che per l’ennesima volta hanno dimostrato di fare acqua da
tutte le parti); tuttavia, il debito contratto dall’ex amministratore di
Wirecard sono adesso nella pancia dei fondi d’investimento. Tramite l’utilizzo
del Clo (notoriamente composto in buona parte da prodotti “junk“), infatti,
Francoforte sul Meno ha ripartito in piccole quote l’indebitamento di Braun,
distribuendo a tappeto le perdite che proverranno dall’operazione finanziaria,
“salvando” in questo modo il proprio attivo. Tuttavia, per l’ennesima volta la
mossa di Deutsche bank ha fatto circolare titoli potenzialmente tossici sul
mercato, che si tradurranno in una perdita da parte degli investitori che
possiedono azioni dei fondi d’investimento.
La vigilanza tedesca barcolla, ma Moody’s rimane all’occhio. Già
negli scorsi mesi – a seguito della pandemia di Covid-19 – la società di
rating Moody’s aveva minacciato di tagliare buona parte delle stime di rating
riguardo al prodotto, in quanto particolarmente volatile in situazioni di crisi
come quelle che sta attraversando il mondo finanziario in questo momento.
Soprattutto, il messaggio era stato infatti lanciato chiaramente nei confronti
della Deutsche Bank e in generale del mercato tedesco, particolarmente avvezzo
all’utilizzo della pratica. In questo scenario, con lo scoppio della bolla
Wirecard e tenendo presente la posizione presa nei confronti della stessa
Wirecard, difficilmente Moody’s ritirerà la promessa fatta soltanto poche
settimane fa. E con essa, rischiano di arrivare anche pesanti stime negative nei
confronti dell’intero comparto finanziario della Germania, considerando le
enormi mancanze e le grandi lacune dimostrate nelle settimane appena trascorse.
Tonia Mastrobuoni per ''la Repubblica'' il 24 giugno 2020. Con il
suo perenne maglioncino nero a collo alto, Markus Braun sperava di somigliare al
re del nuovo mondo, al guru di Apple Steve Jobs. Ma è stato arrestato a Monaco
per lo scandalo Wirecard, per crimini da archeologia della finanza: falso in
bilancio e manipolazione dei mercati, cui potrebbe aggiungersi nei prossimi
giorni il reato di truffa. Dopo una notte in carcere e dopo aver pagato una
cauzione da 5 milioni di euro, l'ormai ex amministratore delegato dell'azienda
bavarese è tornato ieri in libertà, ma la Procura di Monaco sta anche cercando
uno dei consiglieri, Jan Marsalek. Il top manager sarebbe a Manila. Non in fuga,
sostiene, ma per raccogliere importanti documenti che possano scagionare la
società dalle accuse pesanti formulate dai magistrati, che riguardano due conti
filippini inesistenti. I grandi millantatori dell'ex start up bavarese sembrano
essere finiti in guai seri. Saranno torchiati da una procuratrice d'acciaio come
Hildegard Bäumler- Hösl, famosa per aver scoperto il mega scandalo di corruzione
della Siemens e per aver costretto il re della Formula Uno Bernie Ecclestone a
pagare 100 milioni di dollari alle casse della Baviera. Braun, il "visionario"
austriaco che era stato festeggiato per anni persino dall'autorità di vigilanza
Bafin come il Faust dell'high tech in salsa teutonica, come il deus ex machina
in grado di riscattare la Germania dai suoi ritardi sull'economia digitale, si è
rivelato un ladro e un truffatore. Peraltro, la testarda cecità della Bafin
dinanzi alle palesi incongruenze nei conti di Wirecard sta sollevando anche una
bufera politica. Alcuni parlamentari chiedono la testa dei vertici
dell'autorità. E persino il ministro delle Finanze Olaf Scholz, che aveva difeso
l'azienda monacense fino a lunedì, si è prodotto in una spettacolare inversione
a U. «Sia i revisori dei conti sia le autorità di vigilanza non sembrano essere
stati efficienti», ha ammesso. Il capo della Bafin, Felix Hufeld, ha tuonato che
il caso Wirecard «è una vergogna per la Germania». Ma la prossima settimana
dovrà spiegare in Parlamento perché non se n'è mai accorto. Undici anni fa Braun
aveva fondato Wirecard in periferia di Monaco. Una start up fintech che aveva
esordito in un angolo oscuro del web, quello dei giochi online e del porno,
offrendosi come intermediaria per i pagamenti. E in poco tempo il gioiellino
fintech era diventato la risposta tedesca a Paypal, utilizzato anche da catene
di ipermercati e venditori mainstream. All'ultima assemblea degli azionisti un
investitore ha raccontato entusiasta di aver investito tutti i soldi della
figlia in azioni Wirecard: «Me ne sarà dannatamente grata, mi creda», aveva
esclamato. Un anno fa quelle azioni valevano 150 euro. Ieri hanno chiuso a 17.
Il Financial Times , cui va il merito di una testarda serie di inchieste sulla
creatura di Braun - che aveva risposto con pesanti querele - ha rivelato ieri
che anche un altro mito dell'azienda, quello dell'uso spasmodico
dell'intelligenza artificiale per analizzare i dati dei clienti, era, appunto,
un mito. I dipendenti scartabellavano primitivi fogli elettronici per dedurre
dettagli sugli acquirenti. Tutto doveva servire ad alimentare l'immagine di
un'azienda all'avanguardia. E il merito del quotidiano finanziario è stato
quello di aver acceso per primo un faro sulle incongruenze nei conti e nelle
operazioni finanziarie di Wirecard. Lo showdown c'è stato giovedì scorso, quando
il revisore dei conti, Ernst&Young, si è rifiutato di certificare il bilancio di
Wirecard. L'appuntamento per la presentazione dei conti è slittato così per la
terza volta, scatenando una pioggia di vendite che ha affossato il titolo
dell'80% in due sedute. In particolare, E&Y ha sollevato il velo su 1,9 miliardi
di euro che sarebbero dovuti essere su due conti correnti nelle Filippine. Ma
quando i guardiani della contabilità hanno chiesto dettagli direttamente alle
banche, hanno scoperto che i conti erano inesistenti. «Quando ci hanno mostrato
il cosiddetto certificato è stato subito chiaro che si trattava di un falso», ha
dichiarato alla Reuters Cezar Consing, presidente della Bank of the Philippine
Islands (BPI), una delle due dove Wirecard sosteneva di avere una montagna di
denaro.
Arrestato ex Ceo della tedesca Wirecard dopo la colossale
frode contabile. Da "huffingtonpost.it" il 23 giugno
2020. È stato arrestato Markus Braun, l’ex amministratore delegato di Wirecard
al centro di uno scandalo che sta scuotendo gli ambienti finanziari tedeschi. Il
19 giugno Braun, conosciuto anche come lo “Steve Jobs” tedesco, si era dimesso
dopo che la società fintech ha rivelato nei suoi conti un ammanco di 1,9
miliardi di euro. Questa cifra, che si pensava fosse custodita in due istituti
bancari delle Filippine, in realtà non esiste. Si tratta di una colossale frode
contabile in quanto la società avrebbe esibito nei bilanci una presunta montagna
di liquidità. Le indagini in corso mostrano che “la condotta dell’accusato
giustifica il sospetto di una presentazione imprecisa e di una manipolazione del
mercato”, ha dichiarato il pubblico ministero di Monaco di Baviera.
Il tracollo della star Wirecard «Una vergogna per la
Germania». Lo scandalo dei conti fantasma, spariti 1,9
miliardi. Nuovo tonfo in Borsa (-44%). Giuliana Ferraino per il "Corriere Della
Sera" il 23 giugno 2020. Nuove tecnologie, vecchi vizi. E la Germania, alle
prese con uno scandalo finanziario miliardario, è costretta a fare i conti con
la Parmalat di casa sua. Wirecard, la fintech di Monaco di Baviera specializzata
nei pagamenti elettronici, ieri ha ammesso dopo aver quasi azzerato la sua
capitalizzazione di mercato nelle ultime 3 sedute di contrattazione in Borsa a
Francoforte, che «molto probabilmente» i fondi che si supponeva fossero in conti
fiduciari in due banche nelle Filippine «non esistono», lasciando intuire un
buco in bilancio da 1,9 miliardi. Lo scandalo ha spinto a scendere in campo
perfino il governatore della banca centrale filippina, che ha dichiarato che «i
soldi mancanti non sono mai entrato nel sistema finanziario delle Filippine».
Alla fine Wirecard ha ceduto davanti all'ipotesi sempre più concreta di frode e
ha ritirato il bilancio 2019, che il revisore Ey non aveva voluto firmare,
scatenando il crollo in Borsa la settimana scorsa, con un crollo di oltre l'80%
tra giovedì e venerdì, quando il ceo Markus Brown, primo azionista con il 7%, ha
annunciato le dimissioni. La società bavarese ha ritirato anche i conti
preliminari del primo trimestre di quest' anno, la stima dell'Ebitda per
l'intero esercizio e la guidance al 2025 su volume delle transazioni, ricavi ed
ebitda. Felix Hutfeld, presidente di BaFin, la Consob tedesca, ha definito il
caso «un disastro completo e una vergogna per la Germania». Ma lo scandalo si
allunga alla stessa BaFin, accusata di aver sempre respinto come speculazioni le
voci crescenti su presunte pratiche illecite della fintech, sulle quali aveva
acceso un faro un'inchiesta del Financial Times, cominciata fin dal febbraio
2019 sulle sue operazioni in Asia. Come spesso accade, il tempismo dei
controllori non coincide sempre è sempre perfetto, così Moody' s solo ieri ha
ritirato il rating di Wirecard, mentre la polizia di Monaco ha lanciato
un'investigazione criminale. Il problema è «serio e riguarderà tutti noi», ha
ammesso Christian Sewing, ceo di Deutsche Bank, la prima banca tedesca,
intervenendo al Financial Summit di Francoforte. Lo scandalo mette a dura prova
la fiducia dei risparmiatori. E la difesa del ministro dell'Economia, Olaf
Scholz, che si è affrettato ad assolvere le autorità di controllo, affermando
che hanno «fatto il loro lavoro», non basta a tranquillizzare gli investitori.
Ieri il titolo è precipitato di nuovo in Borsa, perdendo un altro 44%, a 14,35%.
E' un tonfo senza precedenti rispetto al record di 158,85 euro toccato
nell'ultimo anno dalle azioni, dopo il volo messo a segno tra l'inizio del 2017
e l'estate 2018, quando il titolo Wirecard è quasi quintuplicato e gli analisti
all'unanimità scommettevano su ulteriori aumenti di prezzo. Nel frattempo la
capitalizzazione si è ridotta a 1,78 miliardi, dai 17 miliardi di inizio 2019,
che l'avevano portata agli stessi valori di Deutsche Bank, il primo gruppo
bancario costretto a una drastica ristrutturazione dopo essere finito al centro
di innumerevoli scandali. Il bond da 500 milioni invece scambia al 27% del
valore nominale. Fondata nel 1999 per gestire le transazioni per l'industria del
porno e dei giochi online, Wirecard è diventata uno dei principali operatori non
solo in Germania, ma anche in Asia e in Nord America, dove è entrata nel 2016
rilevando il servizio di carte prepagate di Citigroup. Il suo mestiere:
garantire i pagamenti per le transazioni effettuate online da società,
incassando un premio per il rischio. All'apice del successo, nel settembre 2018
aveva scalzato dall'indice Dax la Commerzbank, seconda banca in Germania con 150
anni di storia.
Vito Punzi
per “Libero quotidiano” il 19 maggio 2020. Ach Italien, il titolo del book on
demand (su Amazon al costo di 14,99) scritto da Inge Adams, fresca pensionata
tedesca della Renania, ma per 43 anni a servizio dello Stato italiano, nella
fattispecie della sua diplomazia in terra di Germania, è un modo per richiamare
le tante perplessità con le quali tanti in Germania guardano all' Italia.
Assunta come traduttrice, Inge ha lavorato, facendo in realtà di tutto, prima
presso l' Ambasciata di Bonn, poi nel Consolato di Colonia, quando Berlino tornò
ad essere la capitale tedesca. In quasi mezzo secolo ha visto passare ben dodici
ambasciatori: una lunga storia di diplomazia italiana in un Paese il cui popolo
vive da sempre con quello italiano un rapporto che è fin troppo facile definire
di amore e odio. Il libro, ricco di episodi curiosi, divertenti, addirittura
incredibili, è scritto in tedesco per il semplice motivo che Inge, «metà
italiana e metà tedesca», traduttrice e interprete diplomata, non se la sentiva
di scrivere il libro in italiano. Episodi incredibili come quello avvenuto nel
2005 ad Aquisgrana: c' era da preparare la visita del Presidente della
Repubblica, Azeglio Ciampi, per la consegna del Premio Carlo Magno. Come d' uso,
qualche giorno prima ci fu il sopralluogo di una folta delegazione italiana (una
trentina di persone) e fu nella cattedrale della città che a Inge arrivò l'
imbarazzante richiesta del capo di protocollo della Presidenza della Repubblica:
«Chieda al vescovo di Aquisgrana di spostare quella "cassa", perché impedisce la
visuale al Presidente». «Ma com' era possibile», scrive Inge, «si trattava
nientedimeno che del sarcofago dell' imperatore Carlo Magno!». In realtà, e lo
si capisce molto bene ascoltando un' intervista rilasciata qualche mese fa dalla
Adams a Radio Colonia, questo libro-memoriale è un attestato di riconoscenza e
d' amore all' Italia. Tanto più che non le sono mancati gli apprezzamenti da
parte degli ambasciatori ancora in vita, compreso Luigi Vittorio Ferraris, che
ricoprì l' incarico dal 1980 al 1987, il quale, morto nel 2018, è riuscito
comunque a leggere in bozze il capitolo che lo riguardava. L' idea di un
libro-memoriale come questo non è derivata tanto dal desiderio di togliersi
qualche sassolino dalle scarpe (come qualcuno ha scritto). Fu il padre di Inge,
dall' inizio, ascoltando i suoi racconti a cena, a suggerirle di scrivere quanto
aveva vissuto a servizio della diplomazia italiana. Covata per 40 anni, la
scrittura è iniziata solo tre anni prima del pensionamento. Nell' ufficio stampa
dell' Ambasciata capitò per esempio che la sua traduzione di un testo su Giulio
Andreotti venne "cambiata": «Ha a che fare con la mafia» fu sostituito con:
«Andreotti eccellente rappresentante della politica italiana». Adams ricorda
anche quando il cancelliere Helmut Schmidt, usando un tedesco del nord della
Germania, raccontò una barzelletta su di un carro armato italiano con una marcia
in avanti e tre retromarce.]Uno dei due ambasciatori che non hanno potuto
leggere il libro della Adams è Silvio Fagiolo (l' altro è stato Corrado Orlandi
Contucci), in servizio a Berlino dal 2001 al 2005, gli anni del II governo
Berlusconi: un uomo non sempre allineato con gli indirizzi governativi. E Inge
ricorda nel libro la reazione seccata di Fagiolo alla richiesta del Cavaliere di
inoltrare all' allora cancelliere Schröder l' invito a fare vacanza nella sua
villa in Sardegna: «Questo proprio non posso farlo», si sentì rispondere la
Adams. Non mancano certo gli appunti alla macchina burocratica italiana, ma
nella citata intervista Inge ha dimostrato di non avere dubbi: «Nonostante i
tanti ostacoli e le tante insufficienze, soltanto l' Italia è in grado di
funzionare così come funziona. Negli anni in cui le crisi di governo si
susseguivano a distanza di poche settimane, i giornalisti tedeschi mi chiedevano
continuamente: come fa a funzionare l' Italia senza un governo? Ma io ho sempre
risposto: l' Italia non ha bisogno di un governo, funziona da sola». Alla
domanda poi se non abbia mai pensato di lasciare quel posto a contratto a
servizio della diplomazia italiana, la Adams ha risposto senza tentennamenti:
«Mai. Non l' ho mai pensato. Fin dall' inizio, quando venni posta davanti all'
alternativa: amministrazione olandese o tedesca, oppure amministrazione
italiana, non ho avuto dubbi. Lavorare per olandesi o tedeschi sarebbe stato
noiosissimo, triste, "pallido". Un' amministrazione italiana ha un aspetto
spettacolare, di commedia, in senso positivo. Un altro elemento che mi ha fatto
rimanere così a lungo a servizio dell' Italia», ha aggiunto Inge, «è stata la
flessibilità. In Germania, una volta entrati in un contesto di lavoro con una
qualifica precisa si è rinchiusi per 40 anni lì, dentro quella funzione. Nelle
strutture italiane, invece, sono stata chiamata non solo a fare la traduttrice,
ma a sbrigare pratiche private per il capo, a preparargli il caffè, a
predisporre la rassegna stampa, ad organizzare grandi eventi, addirittura a
scrivere messaggi politici».
Roberto Brunelli per agi.it il 25 aprile 2020. La Germania ha
“un’immagine distorta e fatale dell’Italia”, un’immagine che finirà per “fare a
pezzi l’Unione europea”. Lo scrive oggi in un lungo editoriale lo Spiegel, che
lo pubblica addirittura in apertura del proprio sito. Un articolo molto duro nei
confronti della classe politica tedesca: Thomas Fricke, che firma il pezzo, non
esita a parlare di “tutta questa arroganza tedesca che - non solo adesso, ma
soprattutto adesso – è particolarmente tragica”. E non solo perché “la solita
lagna tedesca ha a che fare con la realtà della vita degli italiani quanto i
crauti hanno a che vedere con le abitudini alimentari dei tedeschi”. A detta
dello Spiegel, la lite sull’eventuale partecipazione dei tedeschi agli eurobond
“è imbarazzante”, perché si preferisce “fantasticare sul fatto che gli italiani
avrebbero dovuto risparmiare prima”, fantasie che “spiegano la mancanza di zelo
da parte della Germania nel far partire al vertice Ue di questa settimana una
storica azione di salvataggio”. Ed ecco l’affondo: “L’Europa rischia di
sprofondare nel dramma, non perché gli italiani sono fuori strada, ma a causa di
una parte predominante della percezione tedesca”. E ancora: “Forse è per colpa
dei tanti film sulla mafia”, scrive il settimanale tedesco ironizzando sui
rispettivi stereotipi tra i due Paesi, “forse è solo l’invidia per il fatto che
l’Italia ha il clima migliore, il cibo migliore, più sole e il mare”. Secondo
Fricke, “se lo Stato italiano in una crisi come questa finisce sotto pressione
dal punto di vista finanziario, dipende – se proprio deve dipendere dagli
italiani – dal fatto che il Paese ha una quota di vecchi debiti pubblici, ossia
dai tempi passati. Solo che questo ha poco a che vedere con la realtà della vita
di oggi, ma con una fase di deragliamento degli anni ’80, il che ha a sua volta
a che vedere con gli interessi improvvisamente schizzati in alto”. Lo Spiegel fa
anche un paragone storico sempre molto scottante per la Germania: “Se noi
tedeschi non avessimo avuto all’estero amici tanto cari che nel 1953 ci
abbuonarono una parte dei nostri debiti, staremmo ancora oggi con un pesante
fardello in mano. E come va a finire quando le persone devono continuare a
pagare debiti nati storicamente, la Germania lo ha dimostrato alla fine della
Prima guerra mondiale, quando alla fine il sistema si rovesciò, come da anni
rischia di succedere anche in Italia”. Inoltre, l'editoriale del settimanale
ricorda che “da 30 anni lo Stato italiano spende meno per i suoi cittadini di
quello che prende loro, con l’unica eccezione dell’anno della crisi finanziaria
mondiale 2009. Questo vuol dire risparmi record, non sperperare”. Il giornale
cita anche gli investimenti pubblici “tagliati di un terzo dal 2010 al 2015”,
così come “si sono rimpicciolite le spese per l’istruzione e la pubblica
amministrazione”. Insomma: “Dolce vita? Stupidaggini. Gli investimenti pubblici
dal 2010 in Italia sono calati del 40%. Un vero e proprio collasso”. Questo
mentre in Germania, la spesa pubblica “è cresciuta quasi del 20%”, ossia “lo
Stato spende a testa un quarto di più di quello che spende in Italia. Il che in
queste settimane si percepisce dolorosamente”. Una situazione che con l’attuale
crisi da pandemia del coronavirus si tramuta “in un dramma incredibile”: “In
Italia sono mancati i posti letto e sono morte tante persone che oggi forse
potrebbero essere ancora in vita. Non è direttamente colpa dei politici
tedeschi, ovvio. Ma sarebbe ben giunto il tempo di smettere con folli
lezioncine, e di contribuire a far piazza pulita delle cause del disastro, caro
signor Schaeuble (già ministro alle Finanze negli anni più caldi dell’eurocrisi,
ndr). O di dire “scusateci” almeno una volta”. E invece “con assoluta serietà”
si continua ancora a parlare della “dipendenza da credito” degli italiani,
continua lo Spiegel. “Ma anche qui, un piccolo suggerimento fattuale: i debiti
privati, commisurati al Pil, in quasi nessun Paese dell’Ue sono così bassi come
in Italia”. Infine: “È giunta finalmente l’ora di mettere fine a questo dramma,
e magari proprio con gli eurobond, quali simbolo della comunità del destino
della quale comunque facciamo parte sin da quando abbiamo una moneta comune”,
conclude Fricke. “Ancora i tedeschi hanno tempo di raddrizzare la curva dopo le
contorte settimane scorse: altrimenti l’Unione europea nel giro di qualche anno
non sarà più un’unione. In Italia come in Francia arriveranno al potere delle
persone che, come adesso già fanno Donald Trump o Boris Johnson, non hanno
nessuna voglia di stare al gioco: quel gioco sul quale la Germania da decenni
costruisce il proprio benessere”.
“In Italia la mafia aspetta i soldi dell’Europa”, l’affondo
durissimo dalla Germania sugli aiuti. Redazione de Il
Riformista il 9 Aprile 2020. “In Italia la mafia aspetta soltanto una nuova
pioggia di soldi da Bruxelles”. Lo dice senza mezzi termini il quotidiano
tedesco ‘Die Welt’, confermando la sua netta contrarietà all’ipotesi di
introdurre i cosiddetti Coronabond per fare fronte all’emergenza economica
causata, in particolare in Spagna e Italia, dal contagio di Coronavirus. Una
posizione da falchi, contro le colombe dei Paesi del Sud Europa che non vogliono
invece sentir parlare di Mes come aiuto economico per risollevarsi dalla crisi.
L’autorevole quotidiano tedesco, nell’articolo riportato da Agenzia Nova, non
nega la necessità di aiuti agli Stati membri dell’Unione Europea, ma mette in
guardia su controlli e limiti. Gli italiani infatti “devono essere controllati”
dalla Commissione europea e “devono dimostrare” di spendere i soldi degli aiuti
esclusivamente per l’emergenza sanitaria. ‘Die Welt’ quindi sottolinea come la
solidarietà europea e tedesca debba essere generosi, ma con limiti e controlli
perché le obbligazioni europee, con responsabilità congiunta del debito degli
Stati membri dell’Ue, sarebbe “una gigantesca perdita di miliardi di euro per i
contribuenti tedeschi”. Da qui l’appello alla cancelliera Angela Merkel a non
cedere sulla proposta di Italia e Spagna, dato che le conseguenze di un
allentamento delle regole di bilancio sarebbero “incontrollabili”, mentre il
quotidiano tedesco spinge nell’altro senso a continuare ad applicare le misure
di rigore economico anche durante la crisi economica provocato dall’emergenza
Covid-19.
DI MAIO: “GOVERNO TEDESCO SI DISSOCI” – Non è mancata una presa
di posizione italiana alle parole del quotidiano tedesco. Intervenendo in
diretta a ‘Uno Mattina’ su Rai1, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha
chiesto al governo tedesco di di dissociarsi dalla “vergognosa” posizione
espressa da ‘Die Welt’. “Si tratta di una “affermazione vergognosa e
inaccettabile, mi auguro che Berlino prenda le distanze. L’Italia piange oggi le
vittime del Coronavirus, ma ha pianto e piange ancora le vittime di mafia. Non è
per fare polemica ma non accetto che in questo momento si facciano
considerazioni del genere”, ha detto Di Maio.
L’INTERVISTA DI CONTE ALLA BILD – “E’ nell’interesse reciproco
che l’Europa batta un colpo”, altrimenti “dobbiamo assolutamente abbandonare il
sogno europeo e dire che ognuno fa per sé“. Sono state queste le parole del
premier Giuseppe Conte in un’intervista al quotidiano tedesco Bild. “Vanno
allentate le regole di politica fiscale” è il messaggio che l’Italia ribadisce
da settimane senza però ottenere risposte concrete, sorpattutto da Germania e
Olanda. “Per non perdere competitività abbiamo bisogno di Eurobond – sottolinea
ancora una volta il presidente del Consiglio -. Noi competiamo con Cina e Stati
Uniti: vedete le manovre che hanno messo in campo. Negli Stati Uniti parliamo di
una manovra del 13% circa rispetto al Pil. Se l’Europa non agisce, le nostre
industrie perderanno competitività a livello globale”.
Der Spiegel
contro Angela Merkel: "No all'Italia sugli eurobond gretto e vigliacco".
Libero Quotidiano l'8 aprile 2020. C'è un tedesco che ragiona. E a sorprendere
ancor di più è il fatto che si tratta di Steffen Klusmann, direttore del Der
Spiegel che tante volte ha sfregiato e cosparso di fango l'Italia. Il punto è
che il direttore ha preso posizione in un editoriale pubblicato online, dal
titolo: "Il rifiuto tedesco degli eurobond è non solidale, gretto e vigliacco".
Piuttosto clamoroso. Il contesto ovviamente è quello degli aiuti negati per la
gestione dell'emergenza coronavirus. Un editoriale pubblicato anche nella
versione online in italiano. "Invece di dire onestamente ai tedeschi che non
esistono alternative agli eurobond in una crisi come questa - prosegue Klusmann
-, il governo Merkel insinua che ci sia qualcosa di marcio". Ossia "che in fin
dei conti sarebbero i laboriosi contribuenti tedeschi a dover pagare, in quanto
gli italiani non sarebbero mai stati capaci di gestire il denaro". Per una
volta, giù il cappello davanti a quelli di Der Spiegel.
Steffen Klusmann per “Der Spiegel” il 9 aprile
2020. Gli Eurobond- affermò la cancelliera Angela Merkel otto anni fa all’apice
della crisi dell’Euro- "non ci saranno finché sarò in vita". E così anche la
scorsa settimana al vertice dei capi di Stato e di governo dell'UE tenutosi in
videoconferenza, i paesi dell'Europa meridionale sono stati messi a tacere
bruscamente, quando hanno avanzato nuovamente la richiesta degli Eurobond per
proteggere le loro economie dall'impatto della pandemia. Il ministro
dell'Economia Peter Altmaier l'ha definita, in modo sprezzante, un "dibattito
fantasma". O il governo tedesco davvero non si rende conto di quello che sta
rifiutando con tanta noncuranza, oppure si ostina a non capire, spinta dalla
paura che il partito populista Alternative für Deutschland (AfD) possa
strumentalizzare gli aiuti ai vicini europei per la propria propaganda. Dopo
tutto è stato l’esasperante dibattito sul sostegno alla Grecia che ha portato
alla fondazione dell'AfD nel 2013. Invece di dire onestamente ai tedeschi che
non esistono alternative agli Eurobond in una crisi come questa, il governo
Merkel insinua che ci sia qualcosa di marcio in questi bond. Ovvero, che in fin
dei conti sarebbero i laboriosi contribuenti tedeschi a dover pagare, in quanto
gli italiani non sarebbero mai stati capaci di gestire il denaro. Questa
narrazione è stata usata talmente spesso dalla Cancelliera, che adesso ogni
concessione a spagnoli e italiani potrebbe soltanto sembrare una sconfitta. Non
avrebbe mai dovuto permettere che si arrivasse a questo, non fosse che per un
sentimento di vicinanza e solidarietà. L’enorme violenza della pandemia ha
comportato una vera e propria tragedia umana e medica in Italia e in Spagna-
anche perché ultimamente ambedue gli Stati avevano attuato una forte politica di
austerity, come voluto da Bruxelles- e sicuramente non perché vivessero al di là
delle loro possibilità. Non esistono alternative agli Eurobond in una crisi come
questa. L'Europa sta affrontando una crisi esistenziale. Apparire come il
guardiano della virtù finanziaria in una situazione del genere è gretto e
meschino. Forse conviene ricordare per un momento chi è stato a cofinanziare la
ricostruzione della Germania nel Dopoguerra. Gli eurobond sono obbligazioni
comuni emesse da tutti i paesi dell'Euro e non un’elargizione. Hanno il
vantaggio di essere considerati un investimento sicuro, in quanto gli stati con
una buona reputazione come la Germania risultano responsabili anche per i
debitori meno solidi, come l'Italia. Questo rende i prestiti un po' più costosi
per la Germania, ma notevolmente più economici per l'Italia. Berlino se lo può
permettere, mentre Roma, se fosse lasciata sola, presto non sarebbe più in grado
di prendere in prestito denaro sul mercato finanziario, dato che i tassi di
interesse sarebbero troppo alti. Se l'Italia, la Spagna e la Francia dovessero
applicare programmi di aiuto e garanzie cospicui come quelli tedeschi, per le
loro economie stagnanti e per evitare il fallimento di massa delle imprese, non
ci vorrebbero miliardi, bensì trilioni di Euro. E se gli europei non danno
immediatamente il segnale che stanno lavorando insieme per contrastare questa
crisi, sarà una vera festa per i populisti, i nemici dell'UE e gli hedge fund di
Londra o New York. Come già nel caso della Grecia, punteranno sul fallimento di
uno Stato europeo e questa volta vinceranno la scommessa. Gli stati come Italia
o Spagna sono troppo grandi da poter essere salvati con gli strumenti esistenti
come il Fondo europeo di salvataggio MES, i cui 410 miliardi di Euro non
basteranno a lungo neanche alla sola Italia. Inoltre, gli aiuti del MES sono
legati a condizioni, che non avrebbero senso nel caso di uno shock esogeno, come
quello del Corona. L’enorme violenza della pandemia ha comportato una vera e
propria tragedia umana e medica in Italia e in Spagna. I tedeschi vorrebbero
piuttosto ammorbidire queste condizioni e rivolgersi alla Banca centrale
europea, che potrebbe acquistare quello che nessun altro vuole. Già otto anni
fa, la banca centrale era già stata usata dai politici come ultimo baluardo,
perché i governi erano troppo vigliacchi per risolvere i problemi da soli. De
facto però, tutte queste proposte avrebbero lo stesso effetto: una gigantesca
collettivizzazione dei rischi - solo che non si chiamano Eurobond. Sarebbe
quindi più onesto ed efficace accogliere l’ultima proposta francese, che oramai
sembra trovare anche il consenso degli scettici degli Eurobond: i corona bond.
Si tratta di titoli di Stato europei limitati nel tempo e legati a uno scopo ben
preciso: far fronte alla pandemia. Darebbero un chiaro segnale ai mercati
finanziari, ma anche ai cittadini europei. Sarebbe la prova che non ci
abbandoniamo l'un l'altro in tempi di maggiore bisogno, e che l'Europa è più di
una mera alleanza di egocentrici, più di un mercato unico ben lubrificato ma dal
cuore freddo con una moneta (ancora) comune. E infine le corona bond sarebbero
anche un investimento a prova di bomba che finalmente tornerebbe a fruttare
interessi. Ma non per gli hedge fund.
Gianluca Mercuri per corriere.it l'1 maggio 2020. È uscito sei
giorni fa, ci era sfuggito, ma è importante e ve lo proponiamo ora: un altro
articolo dello Spiegel a favore dell’Italia. Dopo quello firmato dal direttore
Steffen Klusmann (ne avevamo parlato nella rassegna del 9 aprile), che arrivava
a definire «gretto e vigliacco» il rifiuto tedesco degli eurobond, ora è
l’editorialista Thomas Fricke a intervenire con un’analisi ancora più efficace,
perché addenta tutti gli stereotipi ed entra nel merito della grande questione
del debito pubblico italiano, spiegando perfettamente la nostra trentennale
virtuosità. Il titolo dice già molto — «La fatale distorsione tedesca
dell’Italia» — ma poi non c’è una virgola da perdere. «Forse è una conseguenza
di tanti film sulla mafia. Forse è semplicemente l’invidia per il fatto che
l’Italia abbia un tempo migliore, un cibo migliore, più sole e più mare.
Qualcosa comunque deve spiegare questo assillo nel puntare sul fatto che i
tedeschi sarebbero più oculati, più seri e più affidabili. E a questo proposito
mostrare l’inadeguatezza dell’Italia». Basterebbero queste poche righe per
disintegrare una montagna di pregiudizi, ma Fricke fa esplodere un’altra carica:
«Tutta questa spocchia tedesca non è di adesso, ma adesso è particolarmente
tragica. Perché? Perché questa giaculatoria tedesca ha così poco a che fare con
la realtà, più o meno come i crauti con le abitudini alimentari di Wanneeickel
(una cittadina della Ruhr, ndr 1), o come la lodata puntualità tedesca ha a che
fare con la velocità di costruzione del nostro delizioso aeroporto nella
capitale (un clamoroso caso di ritardi e costi gonfiati, ndr 2)». Ma il
giornalista è ancora più deciso quando affronta la questione sostanziale: «Il
vero dramma dell’euro risiede nel cliché erroneo dell’Italia spendacciona.
Questo non ha nulla a che fare con la realtà e sta per disintegrare l’Europa»,
scrive Fricke. Che citando l’economista Antonella Sturati dell’Università Roma
Tre, spiega che «se non si calcolano i pagamenti degli interessi, dal 1992 i
governi italiani hanno avuto eccedenze di bilancio anno dopo anno». Altro che
attitudine allo spreco, insomma, il cancro del debito ci ha fatto smettere di
spendere: «Dolce vita? Sciocchezze. Dal 2000 gli investimenti pubblici italiani
sono calati del 40%, un collasso regolato per legge. Nell’istruzione si è
investito quasi un decimo. Una follia. Le spese pubbliche ristagnano dal 2006.
In Germania sono aumentate quasi del 20%». E questa tendenza «è diventata poi
una catastrofe a partire dall’eurocrisi, quando Mario Monti sotto la pressione
internazionale e in particolare tedesca ha iniziato una riforma dopo l’altra.
Una volta sul mercato del lavoro. Un’altra volta sulla pensioni». E poi i tagli
alla sanità dal 2010, che tanta parte hanno nella tragedia della pandemia. Segue
l’affondo ben mirato su cosa può (deve?) fare la Germania: «Non è una colpa
diretta della politica tedesca. Chiaro. Ma è giunto il tempo di smetterla con
insegnamenti errati, e di contribuire alla riparazione del disastro, caro Herr
Schäuble». Il riferimento al ventennale custode delle finanze tedesche (e del
rigore europeo) serve a invocare un sano revisionismo: «Forse per salvare
l’Europa innanzitutto ci sarebbe bisogno in Germania di nuovi esperti». Perché
«non siamo al circo ma a una crisi che leva il fiato, per quanto è seria».
Quindi «è tempo di fermare questo dramma e gli eurobond sono il simbolo di un
destino comune. Destino che noi condividiamo comunque, avendo una valuta comune.
Altrimenti in un paio di anni l’Unione europea non sarà più tale. E Francia e
Italia avranno al potere persone come Trump e Johnson, che non hanno voglia di
giocare assieme: il gioco sul quale la Germania costruisce da decenni il suo
benessere». Parole di una nettezza che impressiona. A questo punto si può
affermare che il più grande settimanale tedesco sta conducendo una campagna pro
Italia. Ed è qualcosa di sensazionale perché è lo stesso giornale che nel tempo
si è distinto per iniziative di segno opposto. Lasciamo perdere la famosa
copertina del 1977 con la pistola nel piatto di spaghetti. Gli spaghetti
campeggiavano — a forma di cappio — su una copertina molto più recente, 2 giugno
2018, dal titolo in italiano «Ciao amore!» e dal sottotitolo «Come l’Italia si
autodistrugge e trascina l’Europa con sé». Gli articoli ci dipingevano come
schnorrer, scrocconi, e prendevano di mira il migliore di noi, Mario Draghi. Per
non parlare dei riferimenti a Schettino e al disastro del Giglio nel 2012: «Mano
sul cuore: qualcuno si è forse meravigliato del fatto che il capitano della
Costa Concordia fosse italiano?». Riflettiamoci su. Che un giornale così
importante in due anni abbia ribaltato la sua linea è bello e utile. Conferma
che la Germania non è un monolite ma un grande Paese che sa discutere di sé. Che
la grande leader che lo guida sa modulare i passi avanti con sapienza, e nelle
ultime settimane l’ha letteralmente spostato, il presunto monolite, accettando
l’idea di «una mobilitazione di risorse senza precedenti da parte dell’Europa»
per fronteggiare il virus, e pazienza se non si chiamerà «eurobond»: sarà
comunque — e finalmente — condivisione del rischio. Ma per venirci incontro
Angela Merkel ha bisogno di rassicurare i suoi elettori e i suoi contribuenti e
di tenere a bada la sua destra sovranista, che si muove con le stesse logiche
della nostra. Deve poter dire che non solo noi paghiamo eccome i debiti, ma
siamo decisi a rivedere il nostro sistema fiscale maxievasivo e disposti a usare
un po’ dei nostri oltre 4 mila miliardi di risparmi privati per la
ricostruzione. Sapremo farlo?
Roberto Brunelli per agi.it il 25 aprile 2020. La Germania ha
“un’immagine distorta e fatale dell’Italia”, un’immagine che finirà per “fare a
pezzi l’Unione europea”. Lo scrive oggi in un lungo editoriale lo Spiegel, che
lo pubblica addirittura in apertura del proprio sito. Un articolo molto duro nei
confronti della classe politica tedesca: Thomas Fricke, che firma il pezzo, non
esita a parlare di “tutta questa arroganza tedesca che - non solo adesso, ma
soprattutto adesso – è particolarmente tragica”. E non solo perché “la solita
lagna tedesca ha a che fare con la realtà della vita degli italiani quanto i
crauti hanno a che vedere con le abitudini alimentari dei tedeschi”. A detta
dello Spiegel, la lite sull’eventuale partecipazione dei tedeschi agli eurobond
“è imbarazzante”, perché si preferisce “fantasticare sul fatto che gli italiani
avrebbero dovuto risparmiare prima”, fantasie che “spiegano la mancanza di zelo
da parte della Germania nel far partire al vertice Ue di questa settimana una
storica azione di salvataggio”. Ed ecco l’affondo: “L’Europa rischia di
sprofondare nel dramma, non perché gli italiani sono fuori strada, ma a causa di
una parte predominante della percezione tedesca”. E ancora: “Forse è per colpa
dei tanti film sulla mafia”, scrive il settimanale tedesco ironizzando sui
rispettivi stereotipi tra i due Paesi, “forse è solo l’invidia per il fatto che
l’Italia ha il clima migliore, il cibo migliore, più sole e il mare”. Secondo
Fricke, “se lo Stato italiano in una crisi come questa finisce sotto pressione
dal punto di vista finanziario, dipende – se proprio deve dipendere dagli
italiani – dal fatto che il Paese ha una quota di vecchi debiti pubblici, ossia
dai tempi passati. Solo che questo ha poco a che vedere con la realtà della vita
di oggi, ma con una fase di deragliamento degli anni ’80, il che ha a sua volta
a che vedere con gli interessi improvvisamente schizzati in alto”. Lo Spiegel fa
anche un paragone storico sempre molto scottante per la Germania: “Se noi
tedeschi non avessimo avuto all’estero amici tanto cari che nel 1953 ci
abbuonarono una parte dei nostri debiti, staremmo ancora oggi con un pesante
fardello in mano. E come va a finire quando le persone devono continuare a
pagare debiti nati storicamente, la Germania lo ha dimostrato alla fine della
Prima guerra mondiale, quando alla fine il sistema si rovesciò, come da anni
rischia di succedere anche in Italia”. Inoltre, l'editoriale del settimanale
ricorda che “da 30 anni lo Stato italiano spende meno per i suoi cittadini di
quello che prende loro, con l’unica eccezione dell’anno della crisi finanziaria
mondiale 2009. Questo vuol dire risparmi record, non sperperare”. Il giornale
cita anche gli investimenti pubblici “tagliati di un terzo dal 2010 al 2015”,
così come “si sono rimpicciolite le spese per l’istruzione e la pubblica
amministrazione”. Insomma: “Dolce vita? Stupidaggini. Gli investimenti pubblici
dal 2010 in Italia sono calati del 40%. Un vero e proprio collasso”. Questo
mentre in Germania, la spesa pubblica “è cresciuta quasi del 20%”, ossia “lo
Stato spende a testa un quarto di più di quello che spende in Italia. Il che in
queste settimane si percepisce dolorosamente”. Una situazione che con l’attuale
crisi da pandemia del coronavirus si tramuta “in un dramma incredibile”: “In
Italia sono mancati i posti letto e sono morte tante persone che oggi forse
potrebbero essere ancora in vita. Non è direttamente colpa dei politici
tedeschi, ovvio. Ma sarebbe ben giunto il tempo di smettere con folli
lezioncine, e di contribuire a far piazza pulita delle cause del disastro, caro
signor Schaeuble (già ministro alle Finanze negli anni più caldi dell’eurocrisi,
ndr). O di dire “scusateci” almeno una volta”. E invece “con assoluta serietà”
si continua ancora a parlare della “dipendenza da credito” degli italiani,
continua lo Spiegel. “Ma anche qui, un piccolo suggerimento fattuale: i debiti
privati, commisurati al Pil, in quasi nessun Paese dell’Ue sono così bassi come
in Italia”. Infine: “È giunta finalmente l’ora di mettere fine a questo dramma,
e magari proprio con gli eurobond, quali simbolo della comunità del destino
della quale comunque facciamo parte sin da quando abbiamo una moneta comune”,
conclude Fricke. “Ancora i tedeschi hanno tempo di raddrizzare la curva dopo le
contorte settimane scorse: altrimenti l’Unione europea nel giro di qualche anno
non sarà più un’unione. In Italia come in Francia arriveranno al potere delle
persone che, come adesso già fanno Donald Trump o Boris Johnson, non hanno
nessuna voglia di stare al gioco: quel gioco sul quale la Germania da decenni
costruisce il proprio benessere”.
Paolo Valentino per corriere.it il 2 aprile 2020. Questa mattina
ci siamo svegliati con la sorpresa di una intera pagina della «Bild Zeitung»
dedicata all’Italia, il «Paese più colpito dal Coronavirus». Una pagina
affettuosa, sin dal titolo e dall’incipit: «Siamo con voi», «Piangiamo insieme a
voi i vostri morti». Una manifestazione di empatia forte e fraterna. «Vi siamo
vicini in questo momento di dolore perché siamo come fratelli». E poi
un’affermazione sorprendente: «Ci avete aiutato a far ripartire la nostra
economia». La parte centrale è un po’ più banale. Il solito elenco di luoghi
comuni: il tiramisù, Rimini, Capri, la Toscana, Umberto Tozzi e, per quelli più
raffinati, Paolo Conte. La voglia di emulazione, inseguendo la «vostra
rilassatezza, bellezza, passione». La bravura nel cucinare, la pasta, il
Campari, la dolce vita, manca solo il mandolino. «Per questo vi abbiamo sempre
invidiato». Come se in Italia nessuno lavorasse. Mai. «Ora vi vediamo lottare,
vi vediamo soffrire», prosegue la Bild ricordando che anche in Germania «la
situazione è difficile». Il finale è in crescendo: «Siete sempre nei nostri
pensieri. Ce la farete. Perché siete forti. La forza dell’Italia è donare
l’amore agli altri». L’arrivederci conclusivo è il trionfo dello stereotipo:
«Ciao Italia, ci rivedremo presto, a bere un caffè, o un bicchiere di vino
rosso. In vacanza oppure in pizzeria». L’ho riletta ancora una volta. C’è
qualcosa che non funziona: «Ce la farete. Perché siete forti». Cioè da soli.
Nessun accenno alla solidarietà che si deve ai fratelli, cui pure la «Bild»
riconosce di aver aiutato la Germania a far ripartire la sua economia. Nessun
accenno alla minaccia contro la nostra casa comune, l’Europa. Nessun accenno
alla necessità che siano i fratelli più ricchi a dover aiutare quelli più
poveri. Possiamo dirlo? Con tutto il rispetto, è una pagina ipocrita e pelosa,
una vergognosa manifestazione di egoismo, l’ennesima dimostrazione che la «Bild»
e l’europeismo stanno ai poli opposti. Non ci stupiamo. Era già successo nella
crisi economica, quando secondo la «Bild» i greci volevano pagarsi i loro vizi
con i risparmi dei pensionati tedeschi e invece i soldi di tutta l’Europa
servirono soprattutto rimborsare i crediti spericolati delle banche tedesche. Ed
era già successo durante la crisi degli immigrati, quando la «Bild» accusava i
Paesi del Sud di aprire le porte ai nuovi barbari. Di queste manifestazioni di
affetto facciamo volentieri a meno. Per fortuna, la «Bild Zeitung» non è (tutta)
la Germania, da cui in questi giorni riceviamo dimostrazioni concrete di
solidarietà e di aiuto. Ma da cui presto ci aspettiamo chiarezza sulla madre di
tutte le questioni: la garanzia finanziaria a tutela del mercato unico e
dell’economia Europa. Il resto sono chiacchiere banali. Come dice Juergen
Habermas, «se il Nord non aiutasse il Sud, perderebbe non solo sé stesso, ma
anche l’Europa». Ma di questo la «Bild Zeitung» non sembra avere alcuna
contezza.
Usa e
Germania hanno spiato gli alleati (Italia compresa) per 50 anni.
Pubblicato giovedì, 13 febbraio 2020 su Corriere.it da Paolo Valentino. Quando
nel 1986 Ronald Reagan ordinò di bombardare Tripoli, come rappresaglia per
l’attentato terroristico alla discoteca di Berlino La Belle dov’erano stati
uccisi due soldati americani, il presidente annunciando l’attacco disse che gli
Stati Uniti avevano prove «precise, dirette e irrefutabili» della responsabilità
dei servizi libici. La prova, così Reagan, dimostrava che l’ambasciata di
Gheddafi a Berlino Est aveva ricevuto l’ordine per l’attacco una settimana
prima. E che, il giorno dopo l’esplosione della bomba, la stessa ambasciata
«aveva informato Tripoli del successo della missione». Era chiaro, dalle parole
del capo della Casa Bianca, che gli Usa avevano intercettato e decrittato le
comunicazioni tra la Libia e la stazione berlinese. Era proprio così. Ma quella
di Reagan fu una gaffe madornale, che mise a rischio e in parte danneggiò la più
vasta e intrusiva operazione di spionaggio mai messa in campo dalla Cia, il
servizio segreto americano. Per oltre cinquant’anni, una sola compagnia svizzera
fornì a oltre cento Paesi di tutto il mondo gli strumenti per gestire le loro
comunicazioni riservate con spie, militari e missioni diplomatiche. La Crypto
AG, questo il suo nome, aveva iniziato a costruire «macchine cifranti» per gli
Usa già durante la Seconda Guerra Mondiale, diventando poi leader del mercato e
compiendo con successo negli anni la transizione dalla meccanica
all’elettronica, alle chip di silicio, ai programmi di software. Tra i suoi
clienti, nazioni democratiche e dittature, l’Iran prima e dopo la rivoluzione
khomeinista, Paesi del Terzo Mondo o Stati rivali fra di loro come India e
Pakistan, perfino il Vaticano. Quello che nessuno ha mai saputo fino ad oggi è
che la Crypto AG era segretamente di proprietà della Cia in società con la Bnd,
i servizi segreti tedesco-occidentali. I quali manipolavano sistematicamente le
apparecchiature, in modo da poter poi facilmente rompere i codici usati dai vari
Paesi per mandare i loro messaggi segreti e leggerli. Negli Anni ‘80, gli
strumenti di Crypto consentivano di decodificare il 40% di tutti i cablo
diplomatici e le altre comunicazioni intercettate dai servizi Usa. A rivelarlo è
uno straordinario pezzo di giornalismo investigativo, realizzato insieme dal
Washington Post e dalla ZDF, la seconda rete pubblica tedesca, basato su
documenti interni sia della Cia che del Bnd, che raccontano sin dalle origini
tutti i dettagli dell’operazione, all’inizio denominata Thesaurus e poi
ribattezzata Rubicon. «E’ stato il colpo d’intelligence del secolo – si legge
negli atti americani – i governi stranieri pagavano senza saperlo milioni di
dollari agli Stati Uniti e alla Germania Ovest per il privilegio di avere le
loro più segrete comunicazioni lette dai nostri servizi». Non tutti abboccavano
alle lusinghe di Crypto AG: nel clima di sospetto della Guerra Fredda, i Paesi
leader del campo rivale, l’URSS e la Cina, non furono mai clienti della premiata
compagnia, svizzera solo di nome. Ma la lista di chi usava le apparecchiature
truccate, pagandole milioni di dollari e facendo fare grassi profitti alle due
intelligence, comprendeva anche i più stretti alleati occidentali e membri della
Nato: Spagna, Grecia Turchia e ovviamente l’Italia. A partire dal 1970, racconta
il Washington Post, fu la National Security Agency, l’intelligence militare
americana, a prendere il controllo di tutte le operazioni di Crypto insieme ai
partner tedeschi, comprese le assunzioni, la scelta delle tecnologie, il
sabotaggio degli algoritmi, la promozione delle campagne di vendita a clienti
precisi. Tra il 1970 e il 1975, le vendite annuali di Crypto AG esplosero da 15
milioni a 51 milioni di franchi svizzeri. Ascoltarono e decrittarono di tutto: i
mullah iraniani durante al crisi degli ostaggi del 1979, le comunicazioni dei
militari argentini durante la guerra delle Falkland nel 1982 debitamente girate
agli inglesi, gli ordini per le campagne omicide delle dittature
latino-americane come l’assassinio del leader socialista cileno Orlando
Letelier, ucciso nel 1976 in piena Washington dagli agenti di Pinochet. Non
ultimo, le comunicazioni del presidente egiziano Anwar Sadat col Cairo durante i
negoziati di Camp David tra Egitto e Israele nel 1972. Per inciso la gaffe di
Reagan sulla Libia insospettì gli iraniani, a conoscenza del fatto che anche i
libici usavano la tecnologia svizzera per le comunicazioni segrete. E’ un fatto
che qualche anno dopo gli ayatollah arrestarono a Teheran uno dei rappresentanti
di Crypto AG, un cittadino tedesco, e lo rilasciarono solo nove mesi dopo,
dietro il pagamento di un riscatto di un milione di dollari, forniti in segreto
dal Bnd. La Cia si rifiutò di pagare, invocando la linea americana di non pagare
mai riscatti per ostaggi. Le due documentazioni, messe a confronto dai reporter
del Post e della ZDF, rivelano incomprensioni e polemiche tra tedeschi e
americani, i primi attenti soprattutto all’aspetto economico della joint
venture, che portava milioni di dollari in cassa, gli altri mai stanchi di
«ricordare che si trattava di un’operazione di spionaggio». Inoltre i tedeschi
erano basiti di fronte alla determinazione e all’entusiasmo dei colleghi Usa
nello «spiare su tutti gli alleati». «Gli americani si comportano con i Paesi
alleati esattamente come con quelli del Terzo Mondo», è la frase di Wolbert
Smidt, già direttore del Bnd, citata nei documenti tedeschi. In effetti la
collaborazione si concluse nel 1990, quindi con la fine della Guerra Fredda,
quando il governo tedesco ordinò al Bnd di uscire da Crypto Ag: la Cia
semplicemente acquistò le quote tedesche e continuò il vecchio andazzo. Crypto
AG non esiste più ma i suoi prodotti sono venduti ancora oggi a una dozzina di
Paesi. La vecchia compagnia è stata smembrata nel 2018, liquidata da azionisti
la cui identità rimane ben nascosta dalle leggi del Lichtenstein. Al suo posto
ci sono due società: CyOne Security e Crypto International. Entrambi affermano
di non avere alcuna connessione con il mondo dell’intelligence. Ma questa è
un’altra storia.
I sovranisti eleggono il leader: la Merkel vuole cancellare il
voto. Roberto Vivaldelli su Inside Over il 6 febbraio
2020. Nono sono affatto piaciuti, ad Angela Merkel, i contatti “segreti” fra la
Cdu della Turingia e Alternative für Deutschland che hanno portato all’elezione,
a sorpresa, di Thomas Kemmerich, presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp)
nel Land. Merkel ha sconfessato il suo partito in Turingia e ha sottolineato che
“l’elezione del governatore Thomas Kemmerich in Turingia deve essere annullata”.
Lo ha dichiarato la Cancelliera dal Sudafrica, dove è in visita di Stato, dopo
il voto che ha scatenato un vero e proprio terremoto politico in Germania.
Angela Merkel ha poi aggiunto che la Cdu non deve assolutamente partecipare a un
governo di un primo ministro eletto con i voti della formazione di destra. “È
stata una brutta giornata per la democrazia, che ha tradito i valori e gli
ideali della Cdu”.
Anche la leader della Cdu Annegret Kramp-Karrenbauer ha
scomunicato, nelle scorse ore, il nuovo governo della Turingia e descrive il
comportamento del suo partito a livello locale come “sbagliato”. La Cdu della
Turingia, ha sottolineato, “ha agito espressamente contro le raccomandazioni e
le richieste del Partito federale”. Il voto favorevole per Thomas Kemmerich,
infatti, è arrivato nonostante il veto di Annegret Kramp-Karrenbauer su
qualsiasi tipo di alleanza con l’Afd. Gli alleati di governo di Angela Merkel
erano stati molto duri nei confronti della Cdu in Turingia. Il segretario
generale della Spd, Lars Klingbeil, ha dichiarato che quello dell’altro giorno è
il “punto bassissimo della storia del dopoguerra tedesco, non solo della
Turingia” mentre Kevin Keuhnert, è convinto che “il 5 febbraio 2020 è una data
che sarà ricordata dagli storici”. Di fatto, con questo voto, si è rotto un vero
e proprio tabù nei confronti di Afd.
Kemmerich si dimette. L’avventura di Kemmerich, tuttavia, è
finita ancora prima di cominciare. Come riporta Der Taggespiegel, l’Fdp della
Turingia aveva presentato la richiesta dello scioglimento del parlamento
statale, al fine di chiedere nuove elezioni. Il nuovo primo ministro Thomas
Kemmerich aveva già fatto intendere di volere rinunciare alla sua posizione dopo
la “bufera” nella quale è finito: ipotesi che aveva scartato fino a poche ore
fa. E adesso è arrivata la certezza. Il neopresidente ha annunciato di
dimettersi definendo il passo “inevitabile”.
Cosa è successo in Turingia. Il primo ministro Thomas
Kemmerich, presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) nel Land, era stato
eletto grazie ai voti di Afd, battendo il governatore uscente, Bodo Ramelow
della Linke. Kemmerich ha vinto per un solo voto, 45 a 44. Come riporta il
settimanale Der Spiegel, Kemmerich avrebbe dovuto presiedere un governo di
minoranza formato da Fdp e Unione cristiano-democratica (Cdu). Ma la situazione
ora potrebbe cambiare dopo le parole di Angela Merkel, che ha scomunicato il suo
stesso partito. Come ricorda l’agenzia Nova, a seguito delle elezioni tenute nel
Land il 27 ottobre scorso, Ramelow aveva concluso un accordo tra Linke, Spd e i
Verdi per formare un esecutivo di minoranza. Il piano è fallito quando l’altro
giorno, al terzo scrutinio, quando l’Afd non ha più votato per il proprio
candidato a primo ministro della Turingia, bensì per Kemmerich, che già aveva
ottenuto l’appoggio della Cdu e naturalmente della Fdp. Ora l’ipotesi più
probabile è quella di nuove elezioni.
Vola il
surplus commerciale tedesco (alla faccia delle regole Ue).
Andrea Muratore su Inside Over il 5 febbraio 2020. the world. Il doppio
standard è figlio dei rapporti di forza. Rimane una costante storica nei
rapporti tra nazioni l’applicazione selettiva delle regole e dei trattati da
parte dei Paesi in posizione di vantaggio politico o economico. Per
la Germania nell’Unione europea vale proprio questo principio. Da oltre un
decennio Berlino si trova nella condizione di essere lo “sceriffo” che intende
far rispettare, selettivamente, le regole di Maastricht sul bilancio
riservandosi di violare i parametri europei sulle questioni commerciali. Stando
alle Macroeconomic imbalance procedure (Mip) introdotte nel 2011 dall’Unione un
Paese non dovrebbe avere un saldo positivo della bilancia commerciale superiore
al 6% del Pil nella media a tre anni. La Germania viola sistematicamente questo
dato e, anzi, nel 2019 ha visto il saldo delle partite correnti crescere dal
7,3% al 7,6% del Pil, un valore simile all’8% registrato tra il 2015 e il 2017.
Il 7,6% del Pil implica un saldo commerciale positivo delle partite correnti
(flusso di beni, servizi e investimenti) pari a 293 miliardi di dollari (circa
262 miliardi di euro). Nonostante un trimestre di recessione, la stagnazione
dell’economia e il ridimensionamento finale della produzione industriale la
Germania rimane la prima economia al mondo per rapporto tra surplus e Pil. Le
regole rimangono sullo sfondo. Orpello riservato a chi non ha la forza di
costruire un’influenza nel Vecchio Continente. In un contesto di crisi
dell’export europeo, la Germania non può, col senno di poi, lamentarsi del
risultato. Deve, piuttosto, preoccuparsi del mercato interno, stagnante e
bloccato dall’assenza di riforme e di politiche di investimento
anti-crisi. Annunciate e non applicate in maniera profonda. La Germania
di Angela Merkel,nel frattempo, prosegue in Europa con la sua ipocrisia. Con il
modello fondato sulla svalutazione interna del fattore lavoro Berlino riesce a
spiazzare il mercato europeo con l’export e a coagulare sul suo sistema
economico i dividendi di un surplus commerciale eccessivo. Il tutto mentre i
lavoratori si dibattono tra lavori precari e stagnazione salariale legati alla
mancanza di spesa interna. Un’ipocrisia denunciata sempre più fortemente, anche
da chi in Germania ne teme le conseguenze. Nel luglio 2018, parlando
alla Cnbc, Gabriel Felbermayr, direttore del Centro per l’ economia
internazionale presso l’Ifo, principale think tank economico tedesco ha
criticato il lassismo del governo: “Il surplus commerciale della Germania si sta
rivelando un problema crescente, non solo con gli Stati Uniti ma anche con altri
partner commerciali, e anche all’interno dell’ Unione europea. Il surplus sta
diventando tossico e anche in Germania molti ormai sostengono che dobbiamo fare
qualcosa al riguardo, allo scopo di abbassarlo. Risulta essere una passività
piuttosto che una risorsa”. Questo perché Berlino riesce a sfruttare con
la svalutazione interna e il declinante costo del lavoro la possibilità di
esportare beni ad alto valore aggiunto (auto, macchinari, farmaci, prodotti
chimici) senza equilibrare il tutto con un aumento dei consumi interni.
CARLO NICOLATO
per Libero Quotidiano il 25 gennaio 2020. «La Germania è intollerante, bigotta e
autoritaria» ha detto qualcuno che di certe cose se ne intende. Ricordate Ai
Weiwei, l' artista cinese, dissidente e attivista, finito in carcere e poi
rilasciato dalle autorità del suo Paese dopo 80 giorni? Lo avevamo lasciato là
in Cina e là è rimasto fino a quando nel 2015 non gli hanno restituito il
passaporto e quindi la possibilità di andarsene verso lidi più democratici. Ai
Weiwei scelse la Germania dove finalmente si stabilì con la famiglia da esule e
artista osannato. Cinque anni dopo però lo ritroviamo a Cambridge, nel cuore
dell' Inghilterra, senza barba, solo un accenno, e qualche disillusione in
tasca. Avrebbe potuto scegliere gli Usa, il Canada o l' Australia, ma lui scelse
l' Europa e dell' Europa il cuore pulsante economico e, forse, culturale. Scelse
Berlino, ma sono bastati quattro anni perché l' illusione si rivelasse pia. «L'
Europa era una società moderna e civile che avrebbe dovuto sostenere l'
umanesimo, la democrazia, la libertà e i diritti umani» disse lo scorso anno
sbattendo la porta di Brandeburgo, «l' Europa potrebbe non essere più Europa, se
non un' entità geografica». Si disse che ce l' aveva con i populisti, con «l'
ingiustizia sociale derivante dalla storia coloniale o dallo sfruttamento
ingiusto dovuto alla globalizzazione e al capitalismo dilagante» affermava
disgustato. Ma lasciando la Germania se ne è andato proprio nel Paese dalla
storia più coloniale, che ha fatto dello sfruttamento delle colonie la sua
ricchezza, l' Inghilterra. Il problema dunque non erano i populisti, ma proprio
i crucchi. «Sì è vero, la Gran Bretagna ha avuto le colonie» ha detto un paio di
giorni fa al Guardian, «ma almeno gli inglesi sono educati, mentre i tedeschi
non hanno un filo di gentilezza».
«Sono stati
molto scortesi nelle situazioni quotidiane» rincara la dose l' artista cinese,
«a loro non piacciono gli stranieri».
E la Brexit?
Non vedo il
problema, dice, «ma se avrò dei problemi vi farò sapere».
Per il momento
si gode il suo angolo felice nel gotha della cultura british lontano da spettri
nazicomunisti: «La Germania è una società molto precisa. La sua gente ama il
conforto di essere oppressa. In Cina è lo stesso. Una volta che ci sei abituato
può anche essere divertente. Vedere l' efficienza, lo spettacolo, il senso del
loro potere che si estende attraverso il condizionamento della mente».
Perché in
fondo in Germania «rispetto agli anni '30 hanno cambiato d' abito, ma si
identificano ancora nel culto di quella mentalità autoritaria». E se lo dice un
cinese...
Carlo Nicolato per “Libero quotidiano” il 21 gennaio 2020. Che la
Germania abbia sfiorato la recessione o meno, i numeri tedeschi tra Pil,
disoccupazione ai minimi (3,1%) e il famoso surplus da record del mondo di 250
miliardi di euro, sono sempre di gran lunga i migliori d'Europa. Eppure ci sono
altri numeri che Berlino preferisce non rendere troppo pubblici e che
rappresentano l' altra faccia della medaglia di un Paese ufficialmente gonfio di
benessere: tipo quel 240mila che rappresenta il numero record di pensionati
fuggiti all' estero registrato lo scorso anno. Qualcuno potrebbe pensare che
buona parte di loro sia costituita da benestanti che vanno a svernare in
paradisi tropicali dopo anni di duro lavoro e dopo aver ricevuto la meritata
compensa, ma non è esattamente così. Di quei 240mila meno di 50 vivono nelle
cosiddette "isole da sogno" come le Figi, Tonga e Samoa, altri 5mila in
Thailandia ma è ancora tutto da dimostrare che la Thailandia sia un paradiso.
Certo qualcuno dei fuggitivi non è che abbia fatto molta strada visto che si è
trasferito in Austria dove la vita costa un po' meno, ma la maggioranza dei
nuovi pensionati in fuga si è trasferito in Paesi europei del sud est dove la
vita costa molto meno che in Germania. E non è nemmeno una questione di tasse
come da noi, cioè non è il caso del pensionato da noi etichettato come
"furbetto" che se ne va ad esempio alle Canarie o in Portogallo dove la
tassazione è inferiore, percependo di conseguenza di più e spendendo anche meno.
No, è che molti di quei pensionati crucchi proprio non ce la farebbero se
restassero a vivere in Germania. Le mete preferite non sono paradisi, tutt'
altro, a meno che non si voglia pensare che lo siano Paesi come la Romania, l'
Ungheria, la Croazia o la Bulgaria. Il numero di pensionati tedeschi che si sono
trasferiti in questi Paesi è raddoppiato negli ultimi dieci anni arrivando a
quota diecimila. In particolare negli ultimi tempi va per la maggiore la
Bulgaria che è quello con il costo per vivere più basso d' Europa. Si parla di
circa la metà di quanto si spende mediamente in Germania e capite che per
qualcuno che magari non arriva nemmeno a mille euro al mese non è poco. Sembra
strano, ma per un pensionato tedesco che ha lavorato tutta la vita non è poi
così scontato prendere mille euro al mese di pensione. Anzi, secondo i dati
ufficiali del ministero del Lavoro federale tedesco quelli che percepiscono
mille o meno di mille euro al mese sono la maggioranza, il 62%, cioè 11 milioni
e mezzo di giubilati. Ma c' è ben poco da giubilare visto che sempre secondo le
stesse statistiche riferite al 2016, il 48% dei pensionati, cioè oltre otto
milioni di persone, prendeva meno di 800 euro al mese con una preoccupante
maggioranza (60%) di donne. Tanto per essere chiari in Germania quelli che
percepiscono meno di 892 euro al mese (meno del 50% del reddito medio) vengono
ufficialmente considerati poveri, mentre quelli che prendono 969 euro (il 60%
del reddito medio) vengono considerati a rischio povertà. Certo, qualcuno di
loro arrotonderà con i soldi investiti privatamente nel corso degli anni, altri
si faranno aiutare dai figli. Me le alternative sono poche. Secondo le
statistiche sciorinate dal Tafel, ovvero l' associazione di volontariato tedesca
che distribuisce ai bisognosi i generi alimentari ricevuti in dono dai
supermercati o dalle aziende, nel 2019 il numero di persone che è ricorso agli
spacci è aumentato del 10% rispetto l' anno precedente, toccando quota 1,650
milioni. Tra loro gli anziani sono saliti del 20%, mentre i rifugiati sono scesi
della stessa percentuale. Il numero uno dell' associazione Jochen Brühl durante
il recente bilancio annuale ha paragonato il fenomeno al cambiamento climatico:
«Ci travolgerà con forza» ha detto e si è augurato che il governo affronti la
situazione con riforme «drastiche» e «di vasta portata». E i numeri di Tafel
sarebbero anche maggiori se molti pensionati in difficoltà non avessero deciso
di lasciare il Paese per lidi più economici.
Da startmag.it
il 17 dicembre 2019. Gli aiuti approvati dal governo per salvare la Banca
Popolare di Bari non aiutano l’Italia a recuperare “la necessaria credibilità”.
Lo scrive l’Handelsblatt di oggi, in un commento dal titolo “non ha imparato
nulla in proposito”, riferito ovviamente al nostro Paese. “Le notizie dei
fallimenti bancari in Italia arrivano con la regolarità delle previsioni del
tempo – si legge sul quotidiano economico-finanziario tedesco -. Almeno una
volta all’anno la sorveglianza bancaria accerta che un istituto è finito in una
cattiva situazione. Il personale dirigenziale viene spodestato, commissari
vengono nominati dallo Stato a assumono il management della crisi, e la politica
si sforza di rassicurare risparmiatori ed elettori”. Le ragioni dei fallimenti,
procede l’analisi del giornale di economia e finanza, si assomigliano: “Cattiva
economia, clientelismo, e autoritari signorotti della finanza locale. A questo
si aggiungono problemi strutturali, come la soppressione dei crediti
deteriorati. Inoltre si trascina il consolidamento: ci sono troppe filiali,
troppi dipendenti, e troppa poca digitalizzazione. L’Italia arranca”. Questa
volta si tratta di una piccola banca del Sud come la Popolare di Bari, viene
sottolineato e non certo di un istituto del calibro di Monte Paschi di Siena,
vicenda che “fu ben più drammatica”. “I casi sono tutti però collegati dalla
permissiva conferma degli aiuti di Stato”, è il commento di Handelsblatt.
“Naturalmente Roma sa che la commissione europea vigila sugli aiuti di Stato e
che da tre anni vale il principio del partecipazione dei creditori nel
fallimento delle banche. Ma finora l’Italia ha sempre negoziato un accordo
speciale”, la conclusione del quotidiano economico-finanziario sul caso della
Popolare di Bari. Peccato che il giornale tedesco non faccia menzione del
salvataggio pubblico in Germania della banca pubblica NordLb che ha avuto
un controverso via libera da parte della Commissione europea, come peraltro ha
fatto notare negli scorsi giorni anche il Financial Times. Oggi via Twitter un
esperto di Germania, economia e banche come il saggista Vladimiro Giacché, che è
tra l’altro presidente dell’istituto Cer (Centro Europa Ricerche), ha rintuzzato
le critiche di Handelsblatt con questo tweet che evoca appunto il dibattuto caso
del salvataggio pubblico di NordLb: “Non puoi festeggiare ogni giorno: dopo il
grandioso salvataggio conforme al mercato della Norddeutsche Landesbank con
fondi pubblici, che magicamente NON costituiscono affatto aiuti di Stato,
arriviamo a una banca italiana e ora TUTTO è diverso”, ha scritto Giacché, noto
come esperto di Germania ed Europa con posizioni critiche sull’attuale struttura
dell’Unione monetaria.
Rodolfo Parietti per “la Stampa” il 31 gennaio 2020. Più che
appuntargli al bavero della giacca la Croce al merito, molti tedeschi avrebbero
preferito metterlo in croce. Vedere Mario Draghi insignito oggi della più alta
onorificenza tedesca, sarà per molti in Germania un boccone amaro da ingoiare.
Soprattutto perché la motivazione - per «meriti inestimabili in favore del bene
comune» - risulta perfino più urticante del riconoscimento stesso. Come
ammettere che l' ex capo della Bce, salvando l' euro, ha finito per strappare
dall' abisso anche la Germania. Se ne è accorto perfino, seppur con un tardivo
mea culpa, l' ad di Deutsche Bank, Christian Sewing, colui che assieme ad altri
era salito sulle barricate all' inizio dello scorso ottobre. Quando cioè serviva
una polifonia di voci per dar corpo alla rivolta capeggiata dal leader della
Bundesbank, Jens Weidmann, contro la decisione di Super Mario di riavviare le
macchine del quantitative leasing, attraverso acquisti mensili da 20 miliardi di
euro, e di sforbiciare un altro po' i tassi sui depositi presso l' Eurotower.
Sewing è alle prese con conti che continuano a non quadrare. Rivoltare come un
calzino una banca abituata ad anni di spericolate alchimie finanziarie e
canalizzare altrove obiettivi e strategie non è una passeggiata di salute. Anzi.
Il bilancio 2019 lampeggia infatti di rosso porpora: perdite per 5,7 miliardi
(-1,5 miliardi nel quarto trimestre), imputabili sostanzialmente proprio ai
costi di ristrutturazione sostenuti ma comunque superiori alle attese, hanno
allargato a 14 miliardi il buco dell' ultimo quinquennio. I ricavi sono inoltre
in calo dell' 8% a 23,1 miliardi. Insomma, i numeri sono da pianto greco, la
strada per rimettere in bolla DB è ancora lunga (la ristrutturazione dovrebbe
terminare nel 2022 con costi per 7,4 miliardi), eppure Sewing confessa ciò che
finora nessun banchiere ha avuto il coraggio di ammettere: «Bisogna dimenticare
ciò che i tassi negativi significano per le banche. Dobbiamo cambiare il nostro
modello di business. Noi lo abbiamo fatto». Onore all' onestà intellettuale, e
ulteriore nota di merito per avere anche aggiunto una verità banale, ma finora
sempre tenuta coperta da un velo spesso: «Il salvataggio dell' euro - riconosce
Sewing - rispecchia anche gli interessi della Germania, in quanto economia
basata sull' export». Non solo, visto che gli scantonamenti dall' ortodossia
monetaria dell' ex governatore di Bankitalia hanno consentito a Berlino di
risparmiare, grazie alla discesa dei rendimenti sui Bund, qualcosa come circa
440 miliardi. Peccato solo che questo tesoro sia per lo più andato a gonfiare il
già ipertrofico surplus, piuttosto che trovare impiego in misure per alimentare
l' asfittica crescita teutonica. Eppure, c' è ancora chi ha il dente avvelenato
con Draghi. Oltre alla grancassa nazionalista suonata da gente provvista di
pedigree da banchiere centrale come Alternative für Deutschland («Il più alto
riconoscimento della Repubblica federale andrà all' uomo che con i tassi a zero
ha espropriato i risparmiatori come nessun altro aveva fatto prima»), ringhiano
perfino esponenti della coalizione Cdu-Csu governata da Angela Merkel nel mentre
reiterano la solita storia: la politica di allentamento monetario è stato il
grimaldello per soccorrere i Paese mediterranei. Al primo passo sbagliato, sono
gli stessi che getteranno addosso anche a Christine Lagarde la croce dell'
infamia.
Fiorina Capozzi per “il Fatto quotidiano” il 31 gennaio 2020. La
Germania avrà anche i conti in ordine. Ma quanto a banche sta messa maluccio.
Per il quinto anno consecutivo Deutsche bank, chiude il bilancio in profondo
rosso. Il primo istituto di credito del Paese archivia il 2019 con 5,7 miliardi
di perdite, il secondo peggior risultato nella storia del gruppo. Il dato supera
le previsioni più nefaste (5 miliardi), ma include buona parte (il 70%) dei
costi di ristrutturazione previsti nel piano 2019-2022, presentato a giugno
scorso. "La nostra strategia funziona", ha spiegato l' amministratore delegato,
Christian Sewing, evidenziando come il risanamento non abbia richiesto sacrifici
agli azionisti. Tuttavia negli ultimi cinque anni Deutsche bank ha perso 15
miliardi, cassando oltre 9 miliardi di utili realizzati nel quinquennio
precedente. A pagare il conto degli errori di gestione sono soprattutto i
dipendenti: nel 2019 l' istituto tedesco, che dà lavoro a 87.600 persone, ha
tagliato altri 4.100 posti di lavoro e, a giugno, ha annunciato 18mila esuberi,
di cui buona parte in Germania. Il giro d' affari non è più quello di una volta
(-8% a 23,2 miliardi). E l' impressione è che la banca non riuscirà facilmente a
buttarsi alle spalle un decennio in cui il titolo in Borsa ha perso l' 82% del
suo valore. "Per noi resta un titolo sotto osservazione - ha spiegato in una
nota JP Morgan - abbiamo bisogno di risultati nei prossimi trimestri che diano
credito alla svolta sul giro d' affari". Anche perché intanto i rivali
americani, con cui Deutsche bank avrebbe voluto competere, hanno ormai
ampiamente recuperato dopo la crisi del 2008. Tutta colpa di derivati e crediti
inesigibili che il colosso tedesco sta smaltendo a fatica. Titoli tossici che
sono arrivati ad esporre la banca per l' incredibile cifra di 43 mila miliardi
di dollari. Ma Deutsche bank, forte di 1500 miliardi di attivi, non è un
istituto qualsiasi. È una di quelle banche che, secondo il Fondo Monetario
Internazionale, potrebbero far vacillare l' intero sistema finanziario. Di qui
la corsa a rimettere ogni cosa al suo posto ipotizzando le nozze, poi sfumate,
con la connazionale Commerzbank, e creando una bad bank con 74 miliardi di
crediti a rischio, tagliando pesantemente i costi e cedendo 50 miliardi di
crediti inesigibili alla statunitense Goldman Sachs. Nonostante la pulizia di
bilancio, l' istituto fatica a ritornare alla redditività. E la credibilità
resta ai minimi storici dopo una serie di imbarazzanti scandali. Nel 2015 Db è
coinvolta nelle indagini sulla manipolazione del tasso di riferimento sui mutui
(il Libor) con tanto di multe e risarcimenti per due miliardi e mezzo. Nel 2018,
la Federal reserve americana le contesta "ampie carenze" sui sistemi di
controllo nelle filiali d' Oltreoceano. E, infine, più recentemente l' istituto
deve affrontare anche i guai giudiziari con i Panama Papers da cui emergono gli
"aiutini" ai clienti per riciclare denaro attraverso società create nei paradisi
fiscali. Per non parlare dell' inchiesta sui rapporti "sospetti" (230 miliardo
di dollari di transazioni) con la Danske Bank, accusata di aver riciclato,
attraverso la filiale estone, miliardi di dollari provenienti da attività
illecite di operatori russi.
Le banche
tedesche sono in sofferenza?
Andrea Muratore su Inside Over il 10 gennaio 2020. L’Eba, l’autorità bancaria
dell’Unione Europea, ha recentemente pubblicato un rapporto sul tema della
stabilità degli istituti del Vecchio Continente, provvedendo ad analizzare la
stabilità degli asset, la redditività delle società e le prospettive future del
settore. L’analisi, compiuta su un campione decisamente significativo di 147
banche capaci di coprire l’80% della capitalizzazione europea del settore (tra
cui 11 italiane), ha prodotto risultati interessanti e, sotto certi punti di
vista, fatto scattare campanelli d’allarme. Le banche europee sono in
generale ritirata sul fronte degli utili e della redditività. “Il ritorno sul
capitale (roe) medio degli istituti europei è calato nel trimestre dal 7 al
6,6%”, sottolinea Milano Finanza. Quelli italiani sono sopra la media all’ 8,5%,
in calo dello 0,1% rispetto al mese precedente, ma al di sopra dei livelli
registrati in Spagna (7,3%) e Francia (6,5%). Le banche più redditizie sono
quelle ungheresi e dell’ Est Europa. Le peggiori sono invece le tedesche (0,3%
nel terzo trimestre, dal -0,1% del secondo e dal 2,3% del primo), che hanno dati
inferiori a quelle greche (3,2%).” Il rapporto fa seguito a un’analisi
di Moody’s pubblicata nello scorso dicembre, in cui le banche tedesche, assieme
a quelle britanniche in via di preparazione per la Brexit, erano indicate come i
principali fattori di indebolimento dell’outlook complessivo del sistema
europeo. Nonostante una sostanziale solidità patrimoniale complessiva a livello
dell’Eurozona (patrimonio pari al 14,4% degli asset), le banche tedesche fanno
peggio col 13,8%. A tirare verso il basso lo scenario germanico è il noto caso
di Deutsche Bank e Commerzbank, istituti che destano preoccupazione dopo che
nell’estate scorsa è fallito il tentativo di fonderli in un conglomerato unico.
In una Germania che ha perso il sentiero della crescita Deutsche Bank
rappresenta il fattore di maggiore instabilità sistemica; Berlino deve convivere
con un sistema finanziario che si è arricchito notevolmente con i crediti facili
al di fuori del Paese finalizzati a finanziare l’export tedesco e ora, complice
il rallentamento economico della Germania, è sbilanciato nel rapporto tra costi
e ricavi, pari all’84%, come rileva il rapporto Eba. Agli istituti tedeschi
resta dunque poco più del 15% di margine per ottenere margini sempre più incerti
di utile. Deutsche Bank ha recentemente reagito in maniera netta, puntando tutte
le sue fiches sulla transizione all’intelligenza artificiale e al fintech per
alleggerire i suoi organici, con le prevedibili consguenze per decine di
migliaia di dipendenti. Le banche tedesche, dunque, non sono affatto il fiore
all’occhiello della finanza Ue. Se uno dei loro problemi maggiori, la difficile
liquidabilità del Bund, potrà essere risolto nel contesto del safe asset
europeo, le debolezze sistemiche risulteranno più problematiche. In questo
contesto l’Italia si posiziona in maniera sostanzialmente stabile. L’Eba rivela
che il principale problema continuano ad essere i crediti deteriorati (7,2% di
Npl ratio rispetto al 2,9% europeo), anche se essi hanno tassi di copertura
superiori (53% contro 45%). Il rapporto costi/ricavi è al 64%, in linea con
quello medio Ue (63%), mentre la principale garanzia di stabilità è data dalla
presenza nel portafoglio di una quota di asset mediamente molto liquida (64%
contro una media Ue del 30%), certificazione di appetibilità per i prodotti
commerciati dal sistema italiano. Per Roma, come insegnano i casi Carige e
Popolare di Bari, il problema resta semmai la vigilanza prudenziale e il suo
rapporto con quella, eccessivamente severa, impartita in passato da Francoforte:
ma il rapporto Eba ci ricorda che, se dovessimo indicare un sistema finanziario
rischioso per l’Europa, guarderemmo con più attenzione a Berlino piuttosto che
al nostro Paese.
La Germania è in difficoltà. E in Europa Berlino ha abbassato
la cresta. Federico Giuliani su Inside Over il 2
gennaio 2020. Quando la Germania poteva ancora permettersi di fare la voce
grossa, Berlino era solita guardare gli altri Paesi europei dall’alto al basso.
Con una certa spocchia, inoltre, il governo tedesco distribuiva prediche non
richieste ai vari membri dell’Ue, convinto com’era di essere il miglior allievo
di Bruxelles, l’unico esempio da seguire, il più bravo a mantenere i conti in
ordine. Quei tempi adesso appartengono al passato, perché nell’ultimo anno la
Germania ha smesso di essere la locomotiva del continente. Le ragioni principali
sono due. Da una parte la crescita dell’economia tedesca si è fermata, e questo
è accaduto sia perché il modello tanto caro ad Angela Merkel, cioè
l’austerity, ha smesso di funzionare, sia a causa di turbolenze internazionali
(su tutte la guerra dei dazi); dall’altra il sistema politico teutonico basato
sulla Gross Koalition è arrivato al capolinea. In altre parole, le condizioni
che avevano fin qui consentito alla Germania di navigare in un mare dorato hanno
cessato o stanno gradualmente cessando di esistere. Il risultato è che Berlino
ha dovuto abbassare la cresta e ridimensionare le proprie aspettative.
Il momento magico è finito. Come fa notare il quotidiano Italia
Oggi, la rivista settimanale tedesca Der Spiegel ha dedicato la copertina del
primo numero dell’anno alle previsioni economiche, politiche e finanziarie del
2020. Il risultato è che il giornale si aspetta un futuro nerissimo per la
Germania, soprattutto dal punto di vista dell’economia. Già, perché il passaggio
al green e le crisi internazionali hanno colpito il made in Germany, e questo
potrebbe a sua volta ricadere sul resto dell’Europa proprio come nel più
classico degli effetti domino. Ma al di là della sfida che dovrà affrontare
Berlino e delle ipotetiche catastrofi in arrivo è interessante notare come sia
cambiato il modus operandi della Germania in campo internazionale. L’aria è
cambiata e, sapendo di non potersi più permettere di impartire lezioncine di
buona morale a destra e sinistra, il governo tedesco ha smesso di attaccare gli
altri Paesi. Il motivo è semplice: adesso Merkel guida (anche se non sappiamo
ancora per quanto) una nazione normale, alle prese con problemi simili a quelli
dell’Italia. E criticare gli altri quando sei uguale a loro ha poco senso.
Equilibrio politico in bilico. Prendiamo la politica interna
della Germania. La cancelliera Merkel era solita crogiolarsi tra le morbide
coperte della stabilità garantita dalla Grosse Koalition, cioè il governo di
larghe intese composto dalla Cdu-Csu e dai socialdemocratici dell’Spd.
Improvvisamente la magia si è interrotta. I partiti populisti hanno iniziato ad
avanzare con decisione e l’anima più a sinistra dell’intesa ha reagito voltando
pagina e rinnegando il credo politico degli alleati cristiano-democratici.
L’implosione potrebbe avvenire da un momento all’altro, tanto che oggi è
difficile dire con certezza se la coalizione in carica arriverà indenne a
primavera. Certo, un sondaggio pubblicato dalla Welt sottolinea come i tedeschi
confidino ancora nella Cancelliera. Ma Angela Merkel è sempre più sola. Mentre
il governo tedesco, anziché farsi beffe dell’Italia, ha altri problemi per la
testa.
Anche i mercati perdono la fiducia nella Germania.
Andrea Massardo su Inside Over il 2 gennaio 2020. Nonostante
l’anno passato abbia segnato un generalizzato aumento dei titoli azionari, i
migliori risultati sono stati segnati principalmente dai giganti della
tecnologia, col primo posto conquistato dalla adesso pubblica Saudi Aramco. I
risultati dei titoli azionari europei evidenziano invece una perdita di fiducia
degli investitori rispetto ai competitors internazionali, soprattutto per quanto
riguarda il settore manifatturiero, fiore all’occhiello delle produzioni
continentali. Come sottolineato da Hubert Barth, amministratore delegato della
società di consulenza EY allo Spiegel, dall’inizio della crisi finanziaria del
2007 la tendenza dei mercati a perdere fiducia nelle società europee è
aumentato, colpendo anche la più solida economia della Germania.
Solo due società tedesche nella top 100. Sono soltanto due le
società tedesche che sono rientrate nelle prime 100 posizioni per la valutazione
del proprio titolo azionario: SAP col suo solido 51° posto e Siemens, fanalino
di coda all’ultima posizione. Questo è quanto emerge dalla ricerca della società
EY, che ha potuto in questo modo tirare le somme delle evoluzioni del valore dei
titoli di borsa degli ultimi anni. L’unica società dell’Europa continentale
nella top 20 mondiale è la svizzera Nestlè, fuori però dall’Unione europea.
Prima della crisi del 2007, la Germania possedeva sette società rientranti nella
top100 mondiale, mentre ad oggi il loro numero è sceso a soltanto due. Ciò non è
dovuto solamente alla migrazione verso Paesi dalla pressione fiscale inferiore,
bensì anche alla perdita di competitività delle produzioni storiche della
Germania, che hanno pesato sulla fiducia degli investitori. Trend destinato però
ancora a durare nei prossimi anni: il settore manifatturiero, nonostante la
possibilità del ritiro di molti dazi doganali nel 2020, non sembra ancora far
sperare in una forte ripresa. Il grosso dei balzi in territorio positivo verrà
compiuto infatti dalle grandi aziende tecnologiche, principalmente registrate
negli Stati Uniti e nel continente asiatico, di cui l’Europa è priva. I soli
Usa, infatti, possiedono oltre la metà delle società della lista, nonostante il
primo posto assoluto sia detenuto dalla società petrolifera dell’Arabia Saudita
Aramco, soltanto recentemente quotata sul mercato pubblico.
L’Europa non riesce a ripartire. Nonostante l’incremento degli
indici azionari nel 2019, la crescita non è stata al passo con il resto del
mondo. Alla base del problema, scarsa fiducia degli investitori soprattutto nei
Paesi dall’alto debito pubblico e soprattutto carenza di società di innovazione,
principalmente registrate nei mercati americani e non limitate ai quattro
colossi Gafa. La mancanza di fiducia nel mercato europeo, nel quale la Germania
si erge a titolo di simbolo per quanto riguarda l’immobilità innovativa, è
dettata dalla perdita di interesse per i mercati tradizionali. Dopo l’inizio
della rivoluzione digitale, sempre più investitori si sono convinti che le
società tecnologiche saranno in grado di plasmare il futuro mondiale, mentre le
aziende che non riescono a stare al passo dei tempi lentamente scompariranno dal
mercato. Motivo, questo, che troverebbe riscontro nell’ex colosso di telefonia
svedese Nokia, che dall’introduzione dello smartphone ha perso sempre più
terreno, finendo con lo scomparire. E dopo gli ultimi dati relativi alla
produzione tedesca che hanno lasciato presagire una sostanziale staticità anche
per il biennio 2020-2021, la possibilità che in campo finanziario ciò si traduca
con una ulteriore perdita di terreno è una quasi certezza, che pone Berlino in
una scomoda posizione; con l’Europa che, priva della propria locomotiva, rischia
di essere destinata alla non rilevanza economica mondiale.
Alessandro Ricci per ilfattoquotidiano.it il 30 dicembre 2019.
Sembra l’Italia ma è la virtuosa Germania. Dove i commercianti sono in rivolta
contro il piano del governo di Große Koalition per contrastare un’evasione
fiscale monstre. Dall’1 gennaio 2020 scatterà l’obbligo di scontrino fiscale e
il controllo elettronico dei registratori di cassa e chi non si adegua rischia
una multa da 25mila euro. La misura punta a combattere le frodi legate alla
manomissione dei registratori di cassa, con cui vengono sottratte decine di
miliardi di euro al fisco. Ma gli esercenti non ci stanno e – proprio come in
Italia – lamentano che per adeguarsi dovranno sostenere costi eccessivi. Così –
come in Italia – a Berlino si sono rassegnati a rinviare le sanzioni: fino a
settembre 2020 liberi tutti. E liberi tutti, per ora, anche sull’installazione
dei pos nei negozi. Si parla di una legge che li renda obbligatori, ma per ora
in tutto il Paese sono un quarto di quelli presenti in Italia. Il quadro di
partenza, secondo Tax Justice Network, vede la Germania al secondo posto in Ue
dopo la Penisola per evasione fiscale e sommerso: in valori assoluti vengono
sottratti all’erario oltre 200 miliardi di euro l’anno. Questo nonostante per i
reati fiscali si finisca davvero in carcere: i detenuti per crimini di questo
tipo sono 55 volte di più che in Italia. Oggi in Germania non è insolito non
ricevere uno scontrino dal macellaio, parrucchiere o al bar sotto casa, che non
sono obbligati ad emetterlo. Secondo Lothar Binding di Spd, sostenitore della
nuova legge – che venne approvata inizialmente nel 2016 per poi essere
continuamente rinviata – “molti commercianti non registravano correttamente le
entrate o manomettevano i registratori di cassa, quindi si è reso necessario un
sistema di controllo a distanza, il TSE, per ristabilire concorrenza nel
mercato”. Tramite questo meccanismo ogni entrata arriverà in tempo reale al sito
del ministero tedesco – un meccanismo molto simile allo scontrino elettronico
italiano, che da luglio sarà obbligatorio per tutti – e rimarrà nei registri per
10 anni. Simili a quelle italiane anche le reazioni degli esercenti, che secondo
la Handelsverband Deutschland, l’associazione dei commercianti, dovranno
spendere tra i 300 e i 500 euro per aggiornare o comprare le attrezzature
previste dalla nuova legge. In alcuni settori, tuttavia, i costi potrebbero
salire alle stelle, ad esempio i macellai, perché ”i registratori di cassa e le
bilance sono collegati tra loro”, afferma Gero Jentzsch dell’Associazione
tedesca dei macellai. La conversione tecnologica, infatti, sarebbe più
complicata, fino ad un costo di circa 4.000 euro per negozio. A questo si
aggiunge il problema della certificazione del sistema, che al momento non
sembrerebbe univoco e di conseguenza avrebbe creato confusione tra gli
esercenti. Per ovviare al problema il Ministero delle finanze ha esteso il
periodo di non punibilità fino a settembre 2020. Un altro parallelo con
l’Italia. Finora, dei circa 1,85 milioni di registratori di cassa in uso in
Germania solo 400-500 sono stati riconvertiti. Gli altri dovranno essere
prodotti o sostituiti da zero e il governo non ha ancora introdotto sgravi
fiscali. Se da un lato la Große Koalition spinge per questa legge, dall’altra
parte Fdp e Verdi si dicono profondamente contrari. I primi con Christian Dürr
che sostiene questa misura sia una criminalizzazione a priori degli esercenti, i
secondi perché sostengono che l’obbligo di scontrino introdurrebbe una quantità
di carta termica che prima non c’era, da smaltire separatamente rispetto alla
carta comune. Ma nonostante la piccola rivolta dei commercianti, da gennaio i
clienti dovranno abituarsi a ricevere lo scontrino insieme al resto, che poi se
lo portino dietro o meno non è importante per il fisco tedesco. Chissà se il
Kassengesetz sarà anche un incentivo all’introduzione dei Pos negli esercizi
commerciali, che secondo una ricerca del Think Tank The European House –
Ambrosetti sono un quarto di quelli italiani. Ma anche su questo fronte sono in
arrivo novità: “Stiamo lavorando ad un legge anche in tal senso”, sostiene
Binding.
Scandalo Dieselgate, condannata Volkswagen: deve rimborsare
chi ha comprato un’auto con le emissioni truccate.
Redazione su Il Riformista il 25 Maggio 2020. La Corte di Giustizia federale
tedesca ha dato ragione a un cliente Volkswagen, esprimendosi contro la casa
automobilistica nel primo caso presentato al tribunale dal proprietario di una
vettura, in relazione allo scandalo delle emissioni truccate (Dieselgate). La
Corte ha stabilito che chi ha acquistato un’auto Volkswagen con il software che
ha manipolato i risultati dei test sulle emissioni avrà diritto a un
risarcimento. I proprietari delle vetture potranno restituire l’auto e ricevere
un risarcimento parziale dal gruppo tedesco: parziale, in quanto si deve
considerare l’usura del veicolo. L’importo del risarcimento dipenderà da quanto
segna il contachilometri, ma è necessario che i chilometri percorsi siano
accreditati sul prezzo di acquisto. “Il comportamento degli imputati deve essere
reputato non etico”, ha detto il giudice Stephan Seiters nell’annunciare il
verdetto della Corte. La sentenza apre la strada alla possibilità che migliaia
di proprietari tedeschi di automobili VW chiedano un risarcimento. Volkswagen ha
promesso “offerte appropriate” a chi si è ritrovato, suo malgrado, con il
software responsabile della manipolazione dei dati sulle emissioni inquinanti.
“La società ora ha intenzione di raggiungere un accordo in riferimento alle
cause collettive” ancora in corso. La decisione dell’Alta Corte di Karlsruhe ha
confermato una precedente sentenza della Corte di Appello di Coblenza sul caso
di un pensionato che aveva chiesto un risarcimento per la sua VW Sharan pagata
31.500 euro nel 2014, con i giudici che avevano disposto nei confronti della
casa automobilistica il pagamento di 25mila euro più tassi.
Dieselgate, Vw rimborserà i clienti con l'auto truccata.
Una causa vinta dà il via ai risarcimenti. Class
action: per Altroconsumo resa dei conti vicina. Pierluigi Bonora, Martedì
26/05/2020 su Il Giornale. L'incubo Dieselgate continua. Dopo quasi 5 anni,
Volkswagen è ancora alle prese con sentenze, cause e risarcimenti. L'ultima
tegola causata dalle emissioni truccate per far apparire meno inquinanti vari
modelli del gruppo, arriva dalla Corte di giustizia federale tedesca. Un
cliente, ha visto i giudici dargli ragione e otterrà così un congruo
risarcimento. A questo punto, secondo la Corte, chi ha acquistato un'auto con il
software taroccato potrà restituire il mezzo e farsi ridare i soldi spesi per
l'acquisto, considerando però l'usura del veicolo e i chilometri percorsi. Il
cliente che ha vinto la causa si chiama Herbert Gilbert. Per la sua auto, una
Sharan costata 31.500 euro nel 2014, riavrà da Volkswagen oltre 25mila euro. Il
verdetto spiana ora la strada alla possibilità che migliaia di proprietari di
modelli del gruppo tedesco chiedano un rimborso, mentre Wolfsburg reagisce
promettendo «offerte appropriate». La decisione potrebbe, infatti, coinvolgere
circa 60mila richieste individuali; altri 262mila casi sono già stati coperti da
un accordo di class-action per 830 milioni. «L'obiettivo è di chiudere l'onere
giudiziario il più rapidamente possibile», rispondono dal gruppo. Finora, il
Dieselgate è costato a Volkswagen oltre 30 miliardi in multe a livello mondiale,
la galera negli Usa per due dirigenti, procedimenti penali e indagini ancora in
corso, per non parlare delle teste illustri saltate. Euroconsumers, in una nota,
ricorda al gruppo automobilistico che il Dieselgate è uno scandalo
internazionale e che tutte le vittime, indipendentemente dalla nazionalità,
devono essere risarcite. Class action sono attive in Italia, Spagna, Portogallo
e Belgio. In Italia, intanto, la Procura di Verona ha chiesto l'archiviazione
del procedimento penale nei confronti dei legali rappresentanti del gruppo che
si sono succeduti dal 2009 al 2015. Resta invece aperta la class action, alla
quale hanno aderito circa 76mila proprietari di vetture coinvolte nello
scandalo, presentata da Altroconsumo al Tribunale di Venezia. «La richiesta del
pm di Verona - commenta Paolo Martinello, presidente di Altroconsumo - era
prevedibile in quanto non è stata trovata alcuna prova di frode in commercio.
L'indagine del pm, comunque, non ha solo riguardato l'ipotesi di dolo, ma anche
il fatto, attraverso un'approfondita consulenza tecnica che noi abbiamo già
prodotto al Tribunale di Venezia. Volkswagen Italia sta facendo le pulci ai
76mila aderenti, cercando di abbassare questa quota. Noi chiediamo che prima si
arrivi alla sentenza che stabilisca a chi spetta il risarcimento e a quanto
ammonta. Quindi, si vedrà chi tra i 76mila non ne ha diritto, al massimo qualche
migliaio, non 70mila come asserisce invece Volkswagen». La tegola italiana, per
Volkswagen, stando così le cose, ammonterebbe a circa 350 milioni.
Il settore
auto della Germania è a pezzi.
Federico Giuliani su Inside Over il 24 dicembre 2019. Quando parliamo di auto,
in ambito europeo è quasi scontato fare qualche riferimento alla Germania, un
Paese da tutti considerato campione per eccellenza per la produzione delle
quattro ruote. Mercedes, Bmw, Audi, Porsche: i brand tedeschi sono da sempre
sinonimo di qualità e, fatto salvo qualche recente scivolone, continuano a
scaldare i cuori di una nutrita clientela sparsa un po’ in tutto il mondo. Oltre
che per la qualità delle auto tradizionali, Berlino è stata elogiata per aver
puntato sui veicoli elettrici. Quest’anno la Germania ha infatti superato la
Norvegia per numero di Ev, cioè electric vehicles, immatricolati nell’ultimo
anno: dal gennaio al novembre scorsi il mercato tedesco ha registrato 57.533 Ev
mentre la Oslo, nello stesso lasso di tempo, si è fermata a 56.893 esemplari
venduti. Come se non bastasse, Berlino è pronta a giocare di sponda con Parigi
per piazzarsi in prima fila per la creazione di un consorzio europeo incaricato
di produrre batterie elettriche. Insomma, ci sono ingredienti in quantità per
ottenere un piatto delizioso. Ma è davvero tutto rose e fiori?
Situazione
critica. Assolutamente no. Iniziamo a sfatare i tanti miti sulla Germania
riguardo il settore auto. Intanto dobbiamo subito sottolineare che l’industria
automobilistica tedesca sta vivendo un momento complicatissimo, e il futuro non
si preannuncia certo migliore. La conferma arriva da Daimler e Volkswagen, due
gruppi tedeschi che per la loro storia non meritano presentazioni. I rispettivi
proprietari hanno annunciato che da qui a quando Berlino completerà la
transizione dai motori a combustione ai veicoli elettrici, il Paese dovrà fare i
conti con la perdita di oltre 20.000 posti di lavoro all’interno del settore
delle quattro ruote. Le previsioni tedesche preannunciano tempesta. C’è chi
parla di “sconvolgimento di vasta portata”, come il direttore generale della
citata Volkswagen, Herbert Diess – la cui azienda sta cercando in tutti i modi
di reinventarsi come leader mondiale delle auto a batteria – e chi, come varie
società di consulenza, tra cui Bain & Co, sostiene che nessun gruppo
“sopravviverà nella forma in cui esiste oggi”. In ogni caso Berlino ha già messo
le mani avanti: pochi mesi fa, la cancelliera Angela Merkel è volata in Cina per
elemosinare migliori condizioni di mercato oltre la muraglia per le auto
tedesche.
La trappola
dell’elettrico. L’analisi del Financial Times mette a nudo il settore auto,
ovvero il punto cardine attorno al quale si è sviluppato il miracolo economico
della Germania. Secondo alcune stime l’industria automobilistica tedesca, che
impiega 830 mila persone, sarà costretta a investire 40 miliardi di euro in
tecnologie alimentate a batteria nell’arco dei prossimi tre anni. Non è finita
qui, perché veri e propri giganti tedeschi delle quattro ruote, tra cui Daimler
e Audi, ma anche fornitori come Continental e Bosch, hanno annunciato che
quest’anno andranno in fumo la bellezza di 50 mila posti di lavoro (compresi
quelli a rischio). Le cause di una simile debacle sono molteplici: alcune sono
esterne (dalla guerra dei dazi Usa-Cina alla Brexit) altre interne (le misure di
austerity e una politica economica stantia). Il risultato è che il rallentamento
dell’economia, sia tedesca che globale, ha spinto i produttori a rivedere le
proiezioni di vendita al ribasso. Per uscire dall’impasse e per strizzare
l’occhio con la moda del momento, molte case automobilistiche tedesche si sono
tuffate sulla tecnologia elettrica, abbandonando, o meglio alienando, i tanti
clienti esistenti ancora “affezionati” al motore tradizionale. Incorrendo,
probabilmente, nell’ennesimo errore che contribuirà a sgonfiarle ulteriormente.
La crisi
delle auto tedesche. Dieselgate, calo delle esportazioni, , l'elettrico, tagli
dei posti di lavoro. L'auto tedesca, come la conoscevamo, non esiste più.
Daniel Mosseri il 19 dicembre 2019 su Panorama. In un numero di metà ottobre
della Welt am Sonntag, edizionale domenicale del quotidiano di area moderata Die
Welt, è apparso un editoriale controverso. Titolo: «L’industria automobilistica
tedesca ha ancora due anni di tempo». Nell’articolo Martín Varsavsky,
imprenditore seriale di origine argentina e guru del mondo delle
telecomunicazioni, dava l’ultimatum alle case automobilistiche tedesche che «se
non si muoveranno abbastanza in fretta, faranno la stessa fine di quei giornali
che non hanno digitalizzato i loro modelli di business per tempo». Estinti. Una
provocazione? Forse. Ma è vero che oggi sui cieli tedeschi si sono addensate
molte nuvole nere sopra la filiera dell’auto, architrave dell’intero comparto
manifatturiero in Germania. Alcuni guai i tedeschi se li sono creati in casa,
fra Stoccarda (sede del gruppo Daimler) e Wolfsburg (quartier generale di VW).
Per esempio il Dieselgate, lo scandalo delle emissioni taroccate esploso nel
2014, continua a produrre i suoi effetti: ancora lo scorso ottobre Daimler ha
richiamato oltre 250 mila veicoli commerciali equipaggiati con software
illegali. La macchia sulla credibilità dei produttori di autoveicoli appare
indelebile. Recuperare la fiducia della clientela nazionale e globale è
diventato oggi un imperativo assoluto del sistema-Germania. Perché, come si
legge nel lungo rapporto su Il futuro dell’industria automotive
tedesca pubblicato a fine 2018 dalla Fondazione Friedrich-Ebert (Fes), la
gestione del Dieselgate (un misto di falso ideologico e comportamenti omissivi)
«non ha danneggiato solo il comparto auto ma potrebbe contaminare anche il
marchio principale made in Germany». L’obiettivo non è più solo salvaguardare
gli alti livelli di occupazione, obiettivo caro all’economia sociale di mercato
di scuola renana, ma tutelare la reputazione di un intero sistema-Paese. Uno
studio dell’Istituto dell’economia tedesca (Iw) con sede a Colonia dimostra poi
che il 47 per cento delle richieste di brevetto depositate presso le autorità
federali in Germania fra il 2005 e il 2016 nei comparti elettronica e
digitalizzazione ha avuto origine proprio dal settore automotive. Nel periodo in
esame, le richieste di brevetti da parte delle case automobilistiche sono
aumentate del 70 per cento mentre nello stesso decennio l’attività brevettuale
delle altre aziende tedesche è calata del 16 per cento. L’industria dell’auto è
sempre il principale (se non unico) volano dell’innovazione in Germania. Altre
difficoltà arrivano da lontano. La Cina, per esempio, è stata per oltre dieci
anni il miglior alleato dei tedeschi, grazie alla sua corsa che sembrava non
finire mai. Le immatricolazioni di auto nel gigante asiatico sono passate dagli
11 milioni del 2000 ai 24,7 milioni nel 2018; e un veicolo su cinque era
tedesco. Da alcuni mesi, invece, il dragone cinese ha rallentato e non sembra
più garantire uno sbocco sicuro per le esportazioni made in Germany, ovvero
l’acquisto di auto tedesche prodotte sul suolo cinese. Forse il 2019 si chiuderà
ancora in attivo per le case automobilistiche in Germania, ma il trend è al
ribasso: a settembre 2019, quattordicesimo mese consecutivo in cui il mercato
cinese delle quattro ruote si è contratto, «la vendita di auto tedesche è calata
del 30 per cento rispetto a settembre 2018». Lo conferma a Panorama Thomas Puls,
economista senior dell’Iw di Colonia, esperto di infrastrutture e mobilità. Ai
problemi specifici dell’industria tedesca si aggiungono tendenze a carattere
globale: fra queste, la corsa ai veicoli a trazione elettrica da una parte e
quella alla guida assistita, l’auto che si guida da sola, dall’altra.
Cambiamenti di natura strutturale che nel medio periodo rivoluzioneranno la
mobilità come la concepiamo oggi. Così a metà novembre Daimler, il gruppo con il
marchio Mercedes-Benz, ha annunciato un taglio netto di circa 1.100 dipendenti
fra quadri e dirigenti per superare la crisi più difficile degli ultimi decenni.
Meno manager, minore produzione, più investimenti in ricerca e innovazione: il
futuro dell’auto passa da qui. La sfida non è solo per Daimler: Con 400 miliardi
di euro l’anno, oggi il fatturato dell’automotive tedesco è il più grande di
tutto il settore industriale e allo stesso tempo il più importante per ii
commercio con l’estero: nel 2016, si legge ancor nel rapporto della Fes, il
comparto ha generato vendite per 256 miliardi. Questo colosso non ha però
fondamenta solide: «A differenza di quello italiano o francese» riprende Puls
«negli ultimi dieci anni l’automotive tedesco ha avuto un successo strepitoso in
Asia, soprattutto in Cina, ma anche nel Regno Unito e negli Stati Uniti. Avere
successo grazie all’export significa però esporsi a grossi rischi. Nel Regno
Unito il mercato dell’auto è in rapido declino e con gli Stati Uniti è in atto
una guerra commerciale». Per adesso, osserva ancora l’economista, le difficoltà
in arrivo dall’Oriente non si stanno ripercuotendo direttamente sui produttori
tedeschi. «Porsche, Audi, Mercedes e Bmw stanno ancora andando bene in un
mercato in declino». L’indotto, invece, è messo male. «Quelli più in difficoltà
in Germania sono i fornitori del settore». Puls nomina a titolo di esempio
giganti come Bosch, Schaeffler e Continental «che forniscono componenti per
veicoli a propulsione convenzionale anche per le case non tedesche già in calo».
Se la componentistica per le auto a benzina è destinata al declino, quella
specializzata per motori diesel è ormai in crisi nera. Già a ottobre Bosch ha
annunciato un taglio di 2 mila posti, seguita a fine novembre da Continental che
manderà a casa 5.500 dipendenti: fra quelli a rischio ce ne sarebbero 750 nei
due stabilimenti in provincia di Pisa. Ad azzoppare il comparto auto a gasolio è
arrivato prima il Dieselgate, poi le multe milionarie comminate dai giudici
statunitensi ed europei ai produttori di auto taroccate, infine si sono
registrate le sentenze dei giudici amministrativi e le ordinanze dei sindaci
tedeschi uniti nel vietare la circolazione dei mezzi a gasolio nelle aree urbane
più densamente abitate e inquinate. Ironia della sorte, «oggi i modelli diesel
6B sono in teoria compatibili con le più stringenti norme europee in materia di
emissioni» osserva Puls. Questa volta però i mercati esteri non daranno una mano
alla Germania perché «in Cina, in India o negli Stati Uniti la macchina diesel
non la vuole nessuno». Non bisogna credere però che si tratti di una presa di
coscienza ecologista: «Per effetto del Dieselgate sono tornate a crescere le
vendite dei Suv a benzina che consumano di più, con il risultato che le
emissioni medie di CO2 delle nuove auto immatricolate in Europa stanno
risalendo. E questi Suv continueranno a inquinare l’aria per i prossimi 15
anni». Il futuro dovrà invece essere elettrico. Puls ricorda che dalla Cina
all’Europa nuove leggi «impongono il progressivo abbandono dei veicoli a
carburante fossile sul medio termine, e la transizione inizia adesso». Una serie
di comunicazioni da parte di alcune grandi case automobilistiche lo conferma. Il
12 novembre il patron della californiana Tesla, Elon Musk, ha annunciato
l’imminente sbarco in Europa con l’apertura di una linea di produzione di mezzi
elettrici nei pressi di Schönefeld, appena fuori Berlino. La Gigafactory 4, ha
promesso Musk, sarà attiva dal 2021. L’annuncio è stato accolto con favore dal
sindaco della capitale tedesca e dal primo ministro della regione Brandeburgo.
Meno entusiasti saranno stati i produttori tedeschi dell’auto, insidiati in casa
dal leader mondiale dell’auto elettrica. Il giorno dopo la sfida di Musk,
Daimler ha fatto cadere la sua scure sugli impiegati nel settore dell’auto a
carburante, mentre il 15 novembre è stato il turno di Volkswagen: il colosso di
Wolfsburg investirà 60 miliardi di euro mettendo l’accento sulla guida autonoma
e sull’elettrificazione. La cifra è di 16 miliardi più alta di quella dichiarata
nel 2018 sugli stessi obiettivi, un segnale di come anche i prudenti tedeschi
abbiano capito che il vento è girato e soffia forte. Ecco perché nel giro dei
prossimi dieci anni, VW metterà sul mercato 75 nuovi modelli elettrici e 60 a
trazione ibrida. Novembre si è chiuso con Audi (gruppo VW) che ha annunciato il
taglio di 7.500 posti di lavoro per diventare «più agile ed efficiente» e
risparmiare 6 miliardi di euro, seguita da Daimler che, oltre a 1.000 dirigenti,
ha confermato il licenziamento di altri 9 mila lavoratori ed economie per 1,4
miliardi. «L’industria automobilistica è nel mezzo della più grande
trasformazione nella sua storia» ha detto la casa di Stoccarda. Il solo annuncio
di Tesla vale però 10 mila nuovi posti di lavoro: possiamo dedurne che la crisi
dell’auto in Germania è risolta in partenza? «No» risponde Puls «perché la
produzione di un veicolo elettrico richiede molta meno manodopera di uno con il
motore a scoppio. Un po’ perché la componentistica è più semplice, un po’ perché
il suo assemblaggio è largamente automatizzato, il che, di nuovo, è una rovina
per i fornitori specializzati». Puls ritiene dunque che «soprattutto nel breve
periodo c’è da aspettarsi un calo occupazionale causato dalla trasformazione
tecnologica appena avviata, con meno addetti necessari in futuro». L’economista
osserva ancora che il mercato dell’auto in Europa è destinato alla stagnazione,
se non a un calo, nei prossimi due lustri: «Al tempo stesso, nel settore
automotive, ci aspettiamo un aumento della produttività del 2 per cento l’anno:
se combiniamo i due fattori otteniamo già meno posti di lavoro. Non
dimentichiamo poi le altre conseguenze sull’indotto: un’auto elettrica richiede
meno manutenzione di una vettura tradizionale». Gli analisti del Center
automotive research dell’Università di Duisburg-Essen hanno provato a
quantificare il calo immaginando il taglio di 234 mila posti di lavoro nello
sviluppo e produzione di motori a combustione solo parzialmente compensato
dall’assunzione di 109 mila nuovi addetti per sviluppo e produzione dei veicoli
elettrici. Con una perdita secca di 125 mila posti di lavoro: da quota 834 mila
oggi a quota 709 mila nel 2030. Anche Volkswagen ammette che la strada è in
salita. Due giorni dopo aver annunciato il mega-investimento sui veicoli
elettrici e a guida assistita, il direttore finanziario del gruppo, Frank
Witter, ha ammesso che «la festa è finita» notificando un taglio di 5 punti
percentuali all’utile previsto a causa delle «mutate condizioni del mercato»: a
causa cioè di Brexit, Cina e della guerra dei dazi. Qualche ragione di
ottimismo? Per Puls la Germania non è messa male nella corsa verso il domani. «I
tedeschi non sono i pionieri dell’elettrico, al primo posto c’è Tesla; però Bmw
è fra i primi cinque produttori mondiali di auto elettriche». La Cina, dal canto
suo, è invece il primo produttore di batterie elettriche per autoveicoli, «ma
anche là il mercato è in declino dopo che il governo ha tagliato i sussidi a
favore dell’auto elettrica, con il risultato che oggi il mercato globale di
questi veicoli è fermo». Il prezzo medio di un’auto elettrica oggi è ancora
alto, e l’economista dell’Iw non crede che la loro maggiore diffusione porterà
modifiche ai modelli di proprietà: cinesi, europei e americani continueranno a
comprare auto per il proprio uso esclusivo. Sarà piuttosto l’avvento, un domani,
dell’auto a guida assistita a cambiare le regole. «Se alla fine sarà un robot a
guidare al nostro posto, non sarà necessario essere proprietari del veicolo:
sarà come chiamare un taxi». Mentre produttori e analisti si scervellano
nell’immaginare l’auto tedesca del futuro, continuano a fare notizia gli
scandali a ripetizione di quella del presente. A fine novembre l’Antitrust
tedesco ha comminato una multa complessiva da 100 milioni di euro a VW, Bmw e
Daimler per aver fatto cartello beneficiando di prezzi dell’acciaio inferiori a
quelli di mercato. Il trio di costruttori tedeschi è lo stesso accusato la
scorsa primavera dalla Commissione Ue di accordi illegali per impedire
l’immissione sul mercato di nuove tecnologie anti-inquinamento. Se Bruxelles
proverà l’accusa, le tre case rischiano multe salatissime. Date le premesse e un
Dieselgate senza fine, il futuro dell’auto elettrica in Germania avrà certo
bisogno dell’apporto di molti capitali per la ricerca e l’innovazione, ma anche
di una robusta iniezione di trasparenza.
Fabio Dragoni per “la Verità” il 2 marzo 2020. «Un' Italia fuori
dall' euro, visto il nostro apparato industriale, poteva fare paura a molti,
incluse Francia e Germania che temevano le nostre esportazioni prezzate in lire.
Ma Berlino ha consapevolmente gestito la globalizzazione: le serviva un euro
deprezzato, così oggi è in surplus nei confronti di tutti i Paesi, tranne la
Russia da cui compra l' energia. Era un disegno razionale, serviva l' Italia
dentro la moneta unica proprio perché era debole. In cambio di questo vantaggio
sull' export la Germania avrebbe dovuto pensare al bene della zona euro nel suo
complesso». Ma non lo ha fatto. Queste ultime cinque parole sono nostre. Le
ottantotto che le precedono no. Ma dell' ex ministro Vincenzo Visco, in un'
intervista del 2012. Ancora più che attuali. Tutti oggi, Germania compresa, si
preoccupano delle conseguenze economiche dovute alla diffusione del coronavirus,
visto che in Italia le stime sulla decrescita del Pil sono già quantificate all'
interno di una forbice che va dal -1% al -3% a trimestre da oggi fino a giugno.
Ma alla base di tutto vi è un grosso punto interrogativo.
La Germania è un problema per l' intera eurozona. E quindi per il
mondo intero. E questo non tanto perché il suo sistema bancario non goda di
buona salute. Cento euro investiti nelle grosse banche quotate nel 1989 dopo 30
anni valgono grosso modo 80. O per la caduta degli ordinativi industriali, che a
febbraio 2020 sono arrivati a quasi un -9% annuo. Mai così male dal settembre
2009. O per le pesanti ricadute sull' export che Berlino sarà costretta a
sopportare con l' esplosione del Covid-19. Le principali corporation teutoniche
(da Bayer a Volkswagen; da Adidas a Bmw) esportano infatti in Cina fette
rilevanti del loro fatturato (dal 15% al 35%). Mentre Pechino registra un crollo
delle immatricolazioni superiori al 90% rispetto a un anno fa. No, non sono
queste nubi all' orizzonte a preoccupare la Germania quanto i suoi successi.
Tanto reali quanto insostenibili. Con i suoi quasi 270 miliardi di dollari di
avanzo nelle partite correnti stimati dal Fmi per il 2019, Berlino supererà di
quasi due volte quello della Cina previsto a poco meno di 150 miliardi. Con la
non trascurabile differenza che in Germania vi sono poco più di 80 milioni di
anime rispetto ai quasi 1,4 miliardi della Cina. Magia dell' euro. Un marco
sottovalutato condividendo la Germania la stessa moneta con Paesi
intrinsecamente più deboli (Grecia, Portogallo, Spagna ecc) che ne abbassano il
valore. Quello che l' economista Marcello Minenna definisce «un formidabile
sussidio implicito alla manifattura tedesca». Dal momento che «senza l' euro il
marco sarebbe più forte di un buon 10%-20% e il suo export meno conveniente». E
i numeri non riescono certo a dargli torto visto che dal 1991 al 1999 Berlino ha
totalizzato un avanzo commerciale di 66 miliardi (contro i nostri 235), mentre
dal 2000 al 2019 questa cifra cumulata è esplosa all' astronomico importo di
3.300 miliardi contro i nostri 420. E la Germania continua a essere un grosso
problema pure per Frau Angela Merkel, reduce da continue batoste elettorali
nelle varie elezioni regionali nei singoli Länder. La domanda che vale la pena
porsi è perché la cancelliera continui a essere punita dal proprio elettorato
nonostante gli indubbi vantaggi assicurati alla Germania dall' appartenenza all'
eurozona. Una sconfitta elettorale dietro l' altra, comunque tali da aver da
tempo costretto la Merkel ad annunciare il proprio addio alla guida del suo
partito, la Cdu. I numeri nella loro crudeltà una risposta la danno sempre. E
osservando le fredde statistiche della Commissione Ue si scopre che i consumi
delle famiglie nel 2001 ammontavano al 57% del Pil, contro l' attuale 53%. Uno
sviluppo economico, quello di Berlino, costruito su una patologica centralità
dell' export a dispetto della più importante componente dei consumi interni. Il
confronto con gli Stati Uniti è esemplare. Un Paese dove infatti i consumi delle
famiglie arrivano a sfiorare il 70% del Pil. Un Paese, gli Usa, che di fatto è
il cliente del mondo. Il disavanzo delle partite correnti arriva a quasi 540
miliardi. Una cifra che gli americani possono ma non vogliono più permettersi.
Pur essendo la bilancia dei pagamenti così abnormemente e stabilmente in rosso,
gli Usa hanno l' unico indubbio privilegio che nessun altro Stato al mondo ha.
Creano i dollari con cui onorare gli acquisti senza timore di morire per l'
incapacità di rimborsare il debito contratto con l' import, visto che è
denominato nella loro valuta. E comunque Donald Trump non vuol più permettersi
questo lusso perché il sistematico acquisto delle merci all' estero, che spesso
si nasconde dietro la delocalizzazione, alla fine sfocia in
deindustrializzazione. Anche qui il coronavirus non fa che dargli una mano.
Tutt' altra strada quella della Germania, fornitore del mondo anziché cliente.
La deflazione salariale ottenuta con le varie riforme Hartz ha reso le imprese
tedesche più competitive all' estero, scaricandone però il prezzo sul tenore di
vita delle famiglie, che quindi non stanno sicuramente meglio rispetto al 2001.
A condire il tutto, le solite bugie profuse dai media tedeschi che continuano a
dipingere l' Europa in generale - e l' Italia in particolare - come realtà
sussidiate e sostenute dal contribuente tedesco, quando invece l' Italia dalla
Germania non ha mai ricevuto un euro. Anzi, avendo noi versato un contributo
capestro di oltre 60 miliardi ai vari fondi salva Stati, serviti a finanziare
soprattutto la Grecia affinché rimborsasse le incaute banche francesi e tedesche
che le avevano fatto fin troppo credito. Alimentare il risentimento anti
italiano sembra comunque essere una strategia perdente, dal momento che a
guadagnare voti è sempre stata la destra di Afd, mentre la Merkel si trova di
fatto intrappolata e costretta a dire no di fronte a qualsiasi progetto di
riforma dell' eurozona, pur di non apparire troppo accondiscendente nei
confronti di un elettorato sempre più in fuga. Con ciò, condannando l' eurozona
alla sua inesorabile implosione, con sommo dispiacere della Confindustria
tedesca, che sul marco svalutato travestito da euro ha di fatto costruito il suo
successo, senza però condividerlo con i consumatori. Che sono un po' di più, e
prima e poi, votando, lo fanno sapere.
Vanni Zagnoli per “il Messaggero” l'1 marzo 2020.
Hoffenheim-Bayern Monaco diventa un caos. La partita, sul risultato di 0-6,
viene interrotta più volte per gli insulti che i tifosi ospiti rivolgono al
patron di casa, Dietmar Hopp. Gara poi ripresa, ma portata atermine dai
giocatori pro-forma, con passaggetti a metà campo: il Bayern rischia la
sconfitta tavolino. A Sinsheim, dove asi giocava il match, la gara è fermata per
due volte dall'arbitro per i cori e gli striscioni offensivi rivolti dagli
spalti a Hopp. Situazione di profondo disagio, che fa infuriare l'allenatore del
Bayern, Hansi Flick, e, tribuna, l'ex attaccante dell'Inter Rummenigge, che
abbraccia il presidente Hopp per scusarsi. Brutta immagine, per la Bundesliga,
espressione di appassionati in genere caldi ma rispettosi, tedeschi in tutto. Lo
striscione viene esposto dal gruppo Schickeria: Sei e resti un figlio di p.... I
giocatori provano a convincere gli ultrà a togliere la scritta, finché l'arbitro
Digert manda le squadre negli spogliatoi. Si cerca di spaventarli, l'odio non è
ammesso. Dieci minuti di stop e ripresa, addirittura con sostenitori
dell'Hoffenheim ad applaudire la protesta dei bavaresi. I giocatori, in campo,
riprendono a giocare, ma per protestare contro gli insulti, si mettono a
palleggiare tra loro (passandosi ripetutamente la palla) per portare pro-forma a
termine la partita. Da capire, ora, se il Bayern, che domina da anni la
Bundesliga, si vedrà punire con la perdita dell'incontro o meno. Intanto, l'ex
interista Rummenigge va giù duro con i tifosi bavaresi, per i quali chiede
punizioni esemplari. «Mi vergogno profondamente. In realtà, non ci sono scuse
per questo episodio da condannare. È necessario un provvedimento da parte dei
vertici federali visto che gli occhi sono stati chiusi da troppo tempo». La
stessa mano dura che userà il Bayern. «Il club agirà contro chi ha screditato la
nostra società. Questa è la brutta faccia del Bayern Monaco», ha concluso
Rummenigge. Non è la prima volta che il presidente dell'Hoffenheim Hopp viene
preso di mira dalle tifoserie avversarie, secondo cui le sue politiche di
investimento sarebbero l'emblema della crisi del calcio tedesco. È successo nel
dicembre 2019 con i tifosi del Borussia Dortmund, che per questo non potranno
più seguire la squadra a Hoffenheim per i prossimi tre anni. E soltanto una
settimana fa il sostenitori del Borussia Moenchengladbach hanno esposto uno
striscione con la faccia del proprietario di maggioranza dell' Hoffenheim
all'interno di un mirino.
Chi è il patron dell’Hoffenheim Dietmar Hopp e perché tutti i
tifosi tedeschi ce l’hanno con lui. Pubblicato lunedì,
02 marzo 2020 su Corriere.it da Salvatore Riggio. In Bundesliga continuano le
offese nei confronti di Dietmar Hopp, il proprietario dell’Hoffenheim, magnate
dell’informatica. Dopo il caos nella partita tra il suo Hoffenheim e il Bayern
di Monaco, è stato interrotto un altro match. Il nuovo caso è accaduto nella
sfida tra Union Berlin e Wolfsburg, con una parte dei tifosi berlinesi che hanno
esposto striscioni di insulti nei confronti dello stesso Hopp. Ancora una volta,
i giocatori hanno abbandonato il campo rientrando negli spogliatoi.
L’interruzione è durata sei minuti, poi le squadre sono tornate sul terreno di
gioco. Per la cronaca, la sfida si è poi chiusa sul 2-2, alimentando altre
polemiche. Ma perché Dietmar Hopp - l’uomo che ha portato una squadra
dall’ottava serie del calcio nazionale a giocare la Champions lo scorso anno - è
tanto odiato dai tifosi? Questo perché in Bundesliga esiste la regola che
stabilisce come il 51% di un club non possa appartenere a una persona o azienda.
Ci deve essere sempre l’azionariato popolare, ma Hopp, che non risponde a questa
regola dopo una deroga ricevuta, è diventato il simbolo di un calcio dove sono i
soldi a fare da padrone. Le proteste nascono da qui. Inoltre, secondo i dati di
Forbes, Hopp è al 96esimo posto al mondo tra i miliardari più ricchi del 2019 e
al 23esimo dei più ricchi nel mondo tech nel 2017. Il suo patrimonio stimato è
di 14,7 miliardi di dollari. Sposato con due figli, il 79enne è entrato nel
mondo del calcio nel 1989 rilevando l’Hoffenheim e guidandolo dall’ottava serie
alla Bundesliga nel 2008 con tanto di qualificazioni in Europa League e in
Champions. Non solo. Perché Hopp ha investito molto sulle infrastrutture come lo
stadio e il campo delle giovanili. Tutto questo, però, non lo mette a riparo di
offese e insulti.
Irene Soave
per il ''Corriere della Sera'' il 21 febbraio 2020. «Che la strage sia stata in
Assia, un Land dell'Ovest, è indice che la xenofobia cresce. Questo tipo di
crimini era concentrato all' Est, ma le ultime elezioni ci mostrano che sale
ovunque». Il suo personaggio più noto è la libraia Kati Hirschel, tedesca a
Istanbul protagonista di una serie di polizieschi editi da Sellerio, come Tango
a Istanbul (2012); tra Berlino e Istanbul la scrittrice Esmahan Aykol, nata in
Turchia e di cittadinanza tedesca, ha trascorso «14 anni, quasi tutta la vita
adulta, finché sei anni fa ho detto basta. Ero stufa di questo clima. Accendi la
tv e parlano di cosa fare dei migranti. Apri un giornale e parlano di cosa fare
dei migranti. In Assia ho vissuto: a Wiesbaden. Zona conservatrice, tutta Cdu.
Quando mi ci ero trasferita, era nei primi duemila, imperversava la campagna
Kinder statt Inder : bambini anziché indiani, contro un'azienda che reclutava
ingegneri dall'Asia».
Il clima le
pare peggiorato ancora?
«Non è mai
stato aperto. In quegli stessi anni, per i polizieschi avevo studiato i
cosiddetti Döner-Morde , i delitti del kebab: omicidi di turchi in Germania. Li
faceva un gruppo terroristico non organizzato, ma è probabile che avessero ganci
nei servizi segreti. E del resto in Germania lo Stato è una struttura così
capillare che anche oggi mi stupisce che questi terroristi possano comprare armi
e organizzarsi senza che nessuno li fermi».
Com'era la sua
vita da turca a Berlino?
«Trasparente.
Nel senso che non facevo parte della comunità turca, ma nemmeno avevo amici
tedeschi. Vivevo a Prenzlauer Berg, una delle prime zone gentrificate della
capitale, e ricordo concerti bellissimi, passeggiate, e anche una città
accogliente».
Percepiva
razzismo nei suoi confronti?
«Io sono
bionda, alta, non porto il velo e parlo bene tedesco, anche se preferirei di no
per non sentire tutto quel che sento. Con me l' approccio era normale. Ma quando
parlavo e si sentiva l' accento, o dicevo il mio nome, Esmahan, scattavano gli
eufemismi. "Bizzarro".... Verso gli altri turchi c' è molto fastidio».
Sono
integrati?
«Ci sono
politici, avvocati, professori turchi. Ma la gran parte vive in famiglie
conservatrici, non studia la lingua tedesca, si istruisce il minimo, non diventa
mai parte della società. Le istituzioni si sforzano, io non sono pessimista: in
quarant' anni la Germania non avrà più un problema turco. Ma non siamo ancora a
questo punto».
Germania,
strage ad Hanau: 11 morti e 4 feriti nei bar della comunità turca.
Lettera e video d'addio: "Sterminare gli stranieri". Morto anche lo sparatore:
"Alcuni popoli che non si riescono a espellere dalla Germania vanno sterminati".
Fra le vittime anche cittadini curdi. Nella casa dell'assassino trovato il
cadavere della madre. Merkel: "Razzismo veleno della società". Tonia Mastrobuoni
il 20 febbraio 2020 su la Repubblica. Notte di sangue alle porte di Francoforte.
Secondo la polizia, sarebbe di undici morti e quattro feriti gravi il bilancio
provvisorio di una strage avvenuta a Hanau, venti chilometri a est dalla
capitale finanziaria. E dopo il ritrovamento di un video e di una lettera a casa
del killer, alcuni media parlano del gesto di un estremista di destra. Anche la
Procura generale avrebbe aperto un'indagine, indizio di un gesto dal movente
"razzista". Stando alle prime ricostruzioni, l'attentatore sarebbe arrivato
intorno alle dieci di mercoledì sera in centro città su una macchina scura e
avrebbe sparato all'impazzata in due diversi shisha-bar (locali dove si fuma il
narghilè). Le vittime della sparatoria sono almeno nove, ma tra i morti ci sono
anche il cecchino e una persona trovati entrambi senza vita nel suo
appartamento, ha fatto sapere la polizia. L'altro cadavere sarebbe quello della
madre 72enne. È stato il ministro dell’Interno dell’Assia, Peter Beuth, a
confermare alcuni dettagli. Tra cui il movente “razzista”. E “un attentato alla
nostra società libera e pacifica”. In un video e una lettera Tobias Rathien, 43
anni, questo forse il nome dell'attentatore, avrebbe spiegato le ragioni della
sua furia omicida: alcuni popoli che non si riescono a espellere dalla Germania
vanno sterminati, sosterrebbe. L'uomo ha aperto il fuoco al "Midnight" in centro
città, poi si è spostato in auto all'"Arena Bar & Café", in un altro quartiere.
Nel primo locale avrebbe suonato il campanello, poi sarebbe entrato nell'area
fumatori e avrebbe ricominciato a sparare alla cieca. Tra le cinque vittime del
secondo attacco ci sarebbe una donna.
Klaus
Caminsky (SPD), sindaco della città di 96mila abitanti, ha detto di "non
riuscire a immaginare una serata peggiore di questa". Il portavoce di Angela
Merkel, Steffen Seibert, parla in un tweet di "orrendo crimine" ed esprime il
suo cordoglio alle famiglie delle vittime. "Al momento non ci sono indizi su
complici" fa sapere un tweet ufficiale. Secondo Bild il padre dell'attentatore
sarebbe stato portato via dalle forze speciali dallo stesso edificio. Tra le
vittime della mega sparatoria ci sarebbero dei cittadini di origine curda. Lo
stragista sarebbe tedesco, secondo Bild, e avrebbe una licenza da cacciatore. La
polizia sta perquisendo il suo appartamento e la sua auto, dove avrebbe trovato
armi e munizioni. Nella notte c'era stato anche un arresto, ma il sospettato è
stato rilasciato dopo poco.
Le reazioni
politiche. Il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, si è detto
"sconvolto" per la strage xenofoba. "Sto dalla parte di tutte le persone che
vengono minacciate dall'odio razzista. Non sono sole", ha dichiarato il capo
dello Stato tedesco. "La grande maggioranza delle persone in Germania condanna
questo atto e ogni forma di razzismo, di odio e di violenza" ha aggiunto
Steinmeier, "non smetteremo mai di impegnarci per una convivenza pacifica nel
nostro Paese". "Il razzismo è un veleno, l'odio è un veleno che esiste nella
nostra società" ha detto Angela Merkel. "È un giorno quanto mai triste per la
Germania", ha aggiunto la cancelliera che ha definito la strage di Hanau un
crimine "agghiacciante". "Questo crimine abominevole ci sconvolge e ci lascia
senza parole", hanno detto i due leader dell'ultradestra di Afd, Alexander
Gauland e Alice Weidel. "I nostri pensieri vanno alle vittime di questo crimine
spietato e ai loro parenti", ha aggiunto, augurando una veloce guarigione ai
feriti. "Il nostro dibattito politico non deve eludere la questione che, 75 anni
dopo la fine della dittatura nazionalsocialista in Germania ci sia di nuovo il
terrorismo di destra", ha dichiarato il vicecancelliere socialdemocratico Olaf
Scholz. Il portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalin, su Twitter ha
riferito di "connazionali morti nell'attacco razzista". "Ci aspettiamo che le
autorità tedesche facciano il massimo per chiarire l'incidente", ha aggiunto.
"Sono profondamente sconvolta per la tragedia di ieri sera ad Hanau. Questa
mattina, è con profonda tristezza che penso ai famigliari ed agli amici delle
vittime, ai quali trasmetto le mie più sentite condoglianze. Oggi, condividiamo
il vostro dolore", ha scritto su Twitter la presidente della Commissione
europea Ursula von der Leyen, parlando della strage in Germania. Tweet anche dal
presidente francese, Emmanuel Macron che ha espresso "immensa tristezza" e
"pieno sostegno" alla Germania: "I nostri pensieri alle vittime e alle famiglie
in lutto. Sono al fianco della cancelliera Merkel nella lotta per i nostri
valori e la protezione delle nostre democrazie".
C’è
un’«internazionale» del terrorismo neonazista? I sette punti rivelatori.
Pubblicato giovedì, 20 febbraio 2020 da Corriere.it. Oslo, Auckland, El Paso e
adesso la sparatoria di Hanau in Germania contro la comunità turca. Luoghi
geografici ai quattro angoli della Terra, punti dove il terrore xenofobo, in
epoche diverse, ha colpito rivaleggiando con lo Stato Islamico. Anzi possiamo
dire che in Occidente gli assassini neonazisti sono spesso più letali dei
jihadisti, con i quali condividono molti punti. Senza cadere nel gioco delle
categorie – complicate quando il protagonista è un singolo individuo – gli
attentatori hanno comunque degli indicatori che ritornano.
1) Si
considerano le ultime sentinelle e passano all’azione contro l’invasione in
quanto ritengono che non ci sia più tempo da perdere.
2) Sono bene
armati e non di rado preparati. Lo dicono i bilanci dei massacri. E sono pronti
a morire, sotto il fuoco della polizia oppure togliendosi la vita.
3) Il fenomeno
dell’estrema destra eversiva è stato trascurato per molto tempo e questo ha
permesso agli assassini di muoversi sotto traccia.
4) Anche
quando agiscono in modo solitario fanno comunque parte di una realtà più ampia,
grazie alla rete e ai contatti. Spesso non esiste un network operativo, però è
forte ed esteso quello ideologico in quanto sfrutta il tema dell’immigrazione.
5) Intensa
l’attività di propaganda: rapporti negli Usa e l’FBI hanno indicato la
pericolosità della minaccia.
6) Alcuni
militanti si sono recati in Ucraina per unirsi alle formazioni combattenti:
viaggio che ricorda quello dei mujaheddin in Siria e Iraq.
7) I target
variano: sinagoghe, moschee e anche chiese (negli Stati Uniti) sono prese di
mira in quanto simboli, tuttavia chi spara si è lanciato in assalti contro
negozi gestiti/frequentati da stranieri e ebrei. Bersagli indifesi e facili. In
Germania (ma anche in altri paesi) sono stati registrati molti episodi, a volte
minori, ma che hanno rappresentato un segnale d’allarme. Appena pochi giorni fa
la polizia tedesca ha arrestato una cellula che stava progettando attentati, la
conferma di un fenomeno pericoloso. E non a caso i servizi di sicurezza hanno
annunciato il reclutamento di agenti da impiegare contro i neonazisti.
Salvini e gli
attentati di serie A e serie B: per Hanau nessuna parola su razzismo e matrice
di estrema destra. Redazione de Il Riformista il 20 Febbraio 2020. Attentati di
Serie A e attentati di Serie B. La differenza per Matteo Salvini? La matrice
terroristica del killer. È la reazione social del leader del Carroccio dopo la
strage di Hanau, provocata dalla follia xenofoba di un estremista di destra, il
43enne Tobias Rathien, a scatenare le polemiche contro l’ex ministro
dell’Interno. La sua Bestia su Twitter pubblica infatti un messaggio di
cordoglio parlando genericamente di “strage ad Hanau” e di rivolgere un pensiero
ai feriti e alle famiglie delle vittime “della follia omicida”, esprimendo
solidarietà “al popolo tedesco”. Un messaggio in cui non vi sono riferimenti
all’origine neonazista dell’eccidio nella città tedesca, dell’obiettivo chiaro
dell’attentatore di colpire le minoranze curde e turche, di una strage
apertamente razzista. E sui social c’è chi fa notare i toni utilizzati dal
‘Capitano’ nel 2015 per la strage di Parigi del 13 novembre, quando gli
attentatori dell’Isis uccisero 130 persone, la maggior parte all’interno del
Bataclan, dove era in corso un concerto. In quel caso Salvini non esitò a
parlare di “tagliagole” e di “terroristi islamici” che andavano “eliminati con
la forza”, oltre a chiedere misure come “chiusura delle frontiere, controllo a
tappeto di tutte le realtà islamiche presenti in Italia, bloccare partenze e
sbarchi, attaccare in Siria e in Libia”.
Il delirio di
Lerner su Hanau: "Come il leghista di Macerata". Il giornalista paragona
Rathjen, killer della strage in Germania, a Traini: "Ammiratore di Hitler e
iscritto alla Lega". Alberto Giorgi, Giovedì 20/02/2020 su Il Giornale.
"Impressiona l'analogia fra la strage nei shisha bar di Hanau e il raid
di Macerata che due anni fa cambiò il corso della politica italiana (per come fu
dai più giustificato dalle condizioni ambientali in cui era maturato). Il killer
era un ammiratore di Hitler iscritto alla Lega", scrive Gad Lerner su Twitter.
Il giornalista, commentando la strage in Germania – in cui undici sono le
vittime –, vuole fare un paragone con l’attentato di Macerata del 3 febbraio
2018, quando Luca Traini sparò a sei immigrati: lì ferì tutti, senza ucciderne
nessuno. E nel farlo vuole trovare un fil rouge che leghi per forza di cose i
due avvenimenti, tirando in mezzo il Carroccio, dicendo che Traini era un
ammiratore di Adolf Hitler e, appunto, ex iscritto alla compagine leghista. Alle
elezioni del 2017, Traini era stato infatti candidato con la Lega Nord al
consiglio comunale di Corridonia, un comune di 15mila abitanti nel Maceratese,
prendendo zero preferenze. Insomma, parlando del killer Tobias Rathjen –
l’estremista di destra è trovato morto in casa dalle forze dell’ordine
teutoniche, in seguito al raid commesso – il saggista deve comunque affiancarci
la parola "Lega" e un riferimento (seppur indiretto) a Matteo Salvini. Come se
la Lega e il suo segretario – oltre che Traini e Macerata – oggi centrassero
qualcosa con il folle attentato nella città d Hanau. Rathjen ha lasciato una
lettera e un folle video-testamento xenofobo in cui sostiene la necessità
di "annientare i popoli che non si possono espellere". Impressiona l'analogia
fra la strage nei shisha bar di #Hanau e il raid di Macerata che due anni fa
cambiò il corso della politica italiana (per come fu dai più giustificato dalle
condizioni ambientali in cui era maturato). Il killer era un ammiratore di
Hitler iscritto alla Lega. Tornando a Traini, la Procura della Repubblica di
Macerata formulò nei suoi confronti l'accusa di strage aggravata dalla finalità
di razzismo, oltre a contestargli altri reati, tra cui il porto abusivo d'arma
da fuoco. Il 3 ottobre 2018 fu condannato a 12 anni di carcere con rito
abbreviato, confermata il 2 ottobre 2019 dalla corte d’assise di appello di
Ancona.
Chi è l’autore
della strage di Hanau. Giovanni Giacalone su Inside Over il 20 febbraio 2020.
L’attentatore di Hanau ha lasciato una lettera e una video-confessione con le
quali rivendica i due attacchi della scorsa notte agli “shisha bar” sostenendo,
tra le altre cose, “la necessità di annientare certi popoli la cui espulsione
dalla Germania non è più possibile”, come riferito dalla Bild che ha citato
fonti della sicurezza. L’attentatore è stato identificato come Tobias Rathjen,
cittadino tedesco, forse estremista di destra. Sui social network sta inoltre
circolando un filmato, caricato cinque giorni fà sul canale YouTube denominato
“Tobias Rathjen”, nel quale il soggetto in questione manda un messaggio agli
americani dove afferma che gli Usa sono controllati da società segrete, citando
non meglio precisate “basi militari segrete sotterranee dove si tortura, dove
viene venerato il diavolo e dove si abusano e si uccidono bambini” e invitando
gli americani a reagire. L’uomo critica poi i “mainstream media” e invita tutti
a cercare le informazioni per conto proprio e a “combattere”. Una miscela di
follia e xenofobia? Più che plausibile, ma è ancora presto per le certezze.
Il testo del
video-messaggio. L’inquietante video con cui Tobias si rivolge al suo pubblico
ha innanzitutto un particolarità: parla di “americani”. Un elemento che fa
propendere gli investigatori per un mix letale di follia e razzismo. “Questo è
il mio personale messaggio a tutti gli americani. Il vostro paese è sotto il
controllo di società segrete invisibili. Utilizzano metodi sconosciuti e
malevoli come il controllo delle menti e un moderno sistema di schiavitù. Se non
credete a ciò che vi dico, fareste bene a svegliarvi in fretta”. “Nel vostro
Paese – continua il killer – esistono delle cosiddette basi segrete militari. In
alcune celebrano il diavolo in persona. Abusano, torturano e uccidono i bambini.
Una quantità incredibile di queste cose accadono ormai da molti anni.
Svegliatevi. Questa è la realtà di quanto accade nel vostro Paese”. Il messaggio
continua rivolgendosi anche contro i media. “Spegnete i media mainstream, loro
non sanno nulla. Il primo passo è informarsi. Per credermi forse dovrete leggere
o ascoltare queste cose di nuovo anche da altre fonti. Ma ora lo sapete. Il
secondo passo è agire. Localizzate queste basi, raccogliete una massa di persone
e assaltatele. È il vostro dovere come cittadini americani mettere fine a questo
incubo. Combattete ora”. Così si conclude il messaggio delirante del killer.
La dinamica. I
fatti sono avvenuti ad Hanau, città a una ventina di chilometri da Francoforte
sul Meno. Intorno alle ore 22 di mercoledì sera, un uomo a bordo di un’auto
scura ha aperto il fuoco contro i clienti di due “sisha bar” frequentati in
prevalenza da curdi e situati nei distretti di Lamboy e Kesselstadt, uccidendo
nove persone e ferendone gravemente altre cinque. Intorno alle tre di notte,
dopo ore di caccia all’uomo, la polizia è riuscita a individuare la residenza
dell’assalitore (forse grazie ad alcuni testimoni), non lontano dal secondo bar
attaccato. Gli agenti hanno fatto allontanare il padre dell’attentatore e una
volta all’interno dell’appartamento, hanno trovato il suo corpo senza vita
assieme a quello di un altra persona (la madre). All’interno dell’auto
dell’assalitore, che aveva regolare porto d’armi da caccia, sono poi stati
trovati proiettili, caricatori, una fondina e diversi cataloghi di armi. Se
inizialmente tutte le ipotesi erano state date per plausibili, incluso un
regolamento di conti della criminalità organizzata, col passare delle ore la
pista xenofoba si rivelava la più plausibile, fino alle rivendicazioni trovate
dagli agenti all’interno dell’appartamento dell’attentatore. Gli “shisha bar”
colpiti erano frequentati in prevalenza da immigrati curdi e il fatto che i due
siti colpiti si trovassero rispettivamente in periferia est e ovest, faceva
pensare da subito a un attacco mirato, di stampo xenofobo, verso quel tipo di
target. Ci sono poi una serie di elementi che fanno capire come, nonostante la
premeditazione del gesto, l’assalitore non fosse certo un terrorista
“professionista”, a partire dal fatto che ha utilizzato la propria auto
lasciando anche prove al suo interno; auto probabilmente nota nel distretto. È
però altrettanto vero che probabilmente l’attentatore aveva già messo in conto
di venire ucciso e non a caso aveva già la rivendicazione pronta. Resta tra
l’altro ipotesi più che plausibile il suicidio post-strage. Per avere maggiori
dettagli bisognerà però attendere ulteriori sviluppi delle indagini, attualmente
in corso.
Hanau, la
confessione del killer: "Annientare gli immigrati". L'assassino, Tobias R., ha
pubblicato un video dove dice di "annientare" i "popoli che non si possono più
espellere". Renato Zuccheri, Giovedì 20/02/2020 su Il Giornale. Ci
sarebbe l'estremismo di destra dietro la strage di Hanau, in Germania. Secondo
le prime informazioni avute dalla testata tedesca Bild, l'uomo che ha ucciso
dieci persone nella città vicino a Francoforte - Tobias R. ha lasciato una
lettera in cui confessa la strage e il movente. Nel documento avuto dalla Bild,
il killer parla della "necessità di distruggere certe persone la cui espulsione
dalla Germania non è più possibile". La polizia non ha ancora rilasciato
dichiarazioni ufficiali su quanto avvenuto né sull'identità del sicario. Ma
inizia ormai a essere confermata la pista del terrorismo di matrice razziale:
uno dei problemi principali della sicurezza tedesca a detta dei servizi segreti
federali. Proprio per questo motivo, il ministro dell'Interno dell'Assia, Peter
Beuth, ha annunciato che la procura federale tedesca ha aperto un'indagine
per terrorismo. Da tempo i servizi segreti hanno lanciato l'allarme sulla
possibile esplosione del terrorismo di matrice neonazista o di stampo
elusivamente razzista. E il fatto che la strage sia avvenuta in un bar
frequentato tendenzialmente da turchi, arabi e curdi, lasciava pensare che anche
questa volta il movente dell'atto terroristico fosse quello politico. In questi
istanti, le forze speciali, che hanno fatto irruzione nella casa dell'assassino
e che hanno fermato il padre per un interrogatorio, stanno valutando la lettera.
Nella casa dell'assassino è stato trovato anche un secondo cadavere, quello
della madre. Intanto il bilancio dei morti della strage continua a crescere.
Attualmente sono almeno dieci le vittime delle due sparatorie nel cuore
di Hanau, ma c'è chi parla di 11 morti. Alcuni feriti versano in condizioni
critiche negli ospedali della città dell'Assia, portati in codice rosso dopo che
il killer ha colpito nei due bar in cui si fuma narghilè e frequentati proprio
dalle comunità curda, turca e araba che risiedono nella città. "Stamattina i
pensieri vanno agli abitanti di Hanau, nel cuore della quale è stato commesso
questo terribile crimine". Questo il messaggio rilasciato dal portavoce di
Angela Merkel su Twitter commentando la strage avvenuta nella città di Hanau, in
Assia, a venti chilometri da Francoforte.
Il messaggio
di Steinmeier Il presidente Frank-Walter Steinmeier, in una nota, ha descritto
tutto il suo sgomento per quanto avvenuto nella città dell'Assia. Il presidente
della Repubblica federale ha detto di essere "inorridito" dall'"atto
terroristico" esprimendo tutto il suo cordoglio per le famiglie delle vittime e
la vicinanza nei confronti di "tutte le persone minacciate dall'odio razzista".
Il capo di Stato ha poi concluso il messaggio rivolgendo un appello ai cittadini
tedeschi affinché non rinuncino "a difendere la coesistenza pacifica nel nostro
paese".
Paolo
Valentino per il ''Corriere della Sera'' il 21 febbraio 2020. (ha collaborato
Christina Ciszek). Un terrorista di estrema destra assalta due bar di Hanau
frequentati da immigrati e uccide nove persone. Un terrorista di estrema destra
attacca la Sinagoga di Halle, piena di ebrei in preghiera, fa alcuni feriti e
solo per miracolo manca la strage. Un terrorista di estrema destra uccide il
prefetto di Kassel, Walter Lübcke, paladino della politica dell' accoglienza,
con un colpo testa sul terrazzo di casa sua. Tre episodi nell' arco di nove
mesi. Diversi. Tutti legati a lupi solitari, o quasi (come sembra nel caso
Lübcke). Ma tutti generati dallo stesso delirio ideologico: l' odio per lo
straniero, il disprezzo per chi non è bianco, l' antisemitismo, il falso mito
della «morte di una nazione», la leggenda nefasta del Bevoelkerungsaustausch lo
scambio di popolazione, presunta minaccia esistenziale all' identità tedesca.
C'è del marcio in Germania, se la trama dell'eversione razzista esce dalle fogne
della narrazione nascosta, tracimando dal fiume carsico e mefitico del dark web
e delle teorie complottistiche, per diventare azione violenta e mortifera. C'è
del marcio anche perché i «cani sciolti» non sono più soli, ma agiscono in un
quadro sempre più inquietante. L'ombra del terrorismo di estrema destra si
stende sull' intero Paese. Appena pochi giorni prima del massacro di Hanau, la
polizia federale ha arrestato 12 uomini di età compresa tra i 20 e i 60 anni in
sei Laender tedeschi. Sono accusati di aver dato vita a una cellula del terrore,
il Gruppo S, che progettava attacchi a moschee e centri di accoglienza per
migranti, attentati a uomini politici e rifugiati. Disponevano di armi,
munizioni, granate, lingotti d' oro per finanziarsi. Il loro scopo: provocare
una guerra civile, mettere in discussione l' ordine costituzionale. «Abbiamo
sottovalutato il pericolo dell' estrema destra radicale», avverte l'ex
cancelliere federale Gerhard Schroeder. Parole piene di riscontri. Secondo il
Bundeskriminalamt, ci sono oggi in Germania 53 estremisti di destra considerati
un pericolo per la sicurezza statale e tenuti sotto osservazione (15 nel Nord
Reno-Vestfalia, 7 in Sassonia, 4 in Assia dove all' evidenza Tobias Rathjen, il
killer di Hanau, non era considerato tale). Ma qualcosa in queste cifre non
funziona. L'Ufficio Federale per la tutela della Costituzione, i servizi civili,
segnala infatti l' esistenza di 25 mila estremisti di destra sul territorio
federale, dei quali poco più della metà sono considerati «pronti alla violenza».
Ma qual è la differenza tra quelli che sono «un pericolo per la sicurezza dello
Stato» e quelli «pronti alla violenza»? Un problema c'è, se pochi mesi fa lo
stesso capo del Bundeskriminalamt, Holger Muench, aveva criticato i ministri
degli Interni dei Land, sollecitandoli a rendere più omogenei i loro sistemi di
valutazione della minaccia estremista. Uno dei nodi è che classificare uno come
minaccia per lo Stato comporta costi aggiuntivi per il bilancio di un Land, che
in quel caso ha l' obbligo di impegnare forze di polizia nell' osservazione del
sospettato. Eppure è stato proprio grazie alla sorveglianza che il Gruppo S è
stato sgominato prima che colpisse. Ma perché ora? Perché all' improvviso la
feccia nazista, lupi solitari o gruppi, si sente in grado di passare all'
azione? Forse la risposta ce la offre Sciascia: è cambiato il contesto. Forse
non si sentono più così isolati, marginali, devianti. C'è una nuova Stimmung ,
un nuovo umore perfino nel Parlamento federale, il presidio della democrazia,
dove i leader di AfD possono impunemente definire il nazismo una «cacca
d'uccello su mille anni di storia tedesca». C'è in Turingia l'astro nascente
dello stesso partito, Bjoern Hoecke, che per i suoi discorsi attinge senza
ritegno al vocabolario nazional-socialista: racconta un'ex dirigente di AfD, ora
andata via, che Hoecke e il suo stretto collaboratore Kubitschek analizzino
quelli di Joseph Goebbels, il capo della propaganda hitleriana, usando poi
versioni appena modificate delle sue parole chiave. Detto altrimenti, i lupi
solitari hanno la percezione di una legittimazione ad agire. La democrazia in
Germania non è in pericolo. Le reazioni del governo federale si muovono nella
giusta direzione. Ma se è vero che il sonno della ragione genera mostri, allora
è tempo di svegliarsi.
Germania, auto sulla folla alla parata di Carnevale: feriti
anche alcuni bambini. Pubblicato lunedì, 24 febbraio
2020 su Corriere.it da Paolo Valentino. Un’auto è finita sulla folla a un corteo
di Carnevale a Volkmarsen nell’Assia tedesca e ha provocato almeno 30 feriti,
una decina quelli gravi. Lo riporta la Dpa. Il conducente del mezzo è stato
fermato. Dopo la strage di Hanau, che si trova sempre in Assia, il ministero
dell’Interno aveva aumentato i dispositivi di sicurezza in tutto il Paese. A
quanto riferisce l'emittente Hessischer Rundfunk, alcuni testimoni affermano che
l'automobile piombata sulla folla avrebbe dato gas partendo da circa 30 metri di
distanza. Da parte loro gli inquirenti finora non sono stati in grado di dire se
l'autista abbia preso intenzionalmente di mira la folla che assisteva al corteo
oppure se si tratti di un incidente. «È ancora troppo presto» per fare questo
tipo di valutazioni, ha detto una portavoce della polizia. Le forze dell'ordine
hanno anche pregato la popolazione e i media «di non diffondere segnalazioni non
accertate». Tutte le sfilate di carnevale in Assia sono state interrotte e
annullate per precauzione.
Germania, auto su folla a parata di Carnevale: numerosi
feriti. Il grave episodio è avvenuto a Volkmarsen, nel
land dell'Assia, durante la festa di Carnevale. Il conducente dell’auto è stato
arrestato. Gabriele Laganà, Lunedì 24/02/2020 su Il Giornale. Terrore a
Volkmarsen, città situata nel land tedesco dell'Assia. Un'auto si è lanciata
contro la folla che partecipava a una parata di Carnevale. Secondo la Bild vi
sono oltre 30 feriti: almeno 10 sarebbero in gravi condizioni. L'autista del
veicolo è stato subito arrestato dalla polizia presente sul posto con numerosi
mezzi: al momento, però, non si conosce la sua identità. Le autorità finora non
hanno neanche fornito ulteriori precisazioni sulla dinamica dei fatti. Non è
stato chiarito se si sia trattato di un attacco terroristico o di un incidente.
Tra le persone travolte dalla vettura mentre partecipavano alla festa di
Carnevale ci sarebbero anche dei bambini. Numerose ambulanze e un elicottero
sono giunte sul luogo per soccorrere i feriti.Tantissime le persone presenti tra
Steinweg e Rewe-Markt per il corteo. Dal racconto di alcuni testimoni oculari,
riportato da hessenschau.de, l’auto Mercedes color argento ha superato le
barriere e si è lanciata sulla folla intorno alle 14:30. L’autista avrebbe
proseguito per circa 30 metri tra la folla prima di fermarsi. I testimoni hanno
avuto l’impressione che il conducente stesse prendendo di mira principalmente i
bambini. Ma questa notizia non è stata confermata dalle forze di sicurezza. Un
altro testimone, secondo la Bild, afferma che molte persone sono corse
inferocite verso il guidatore: a quel punto è dovuta intervenire la polizia per
evitare che la situazione precipitasse. L'uomo, Maurice P. Hij, è un cittadino
tedesco 29enne che fino ad oggi non si era fatto notare come ipotetico
estremista politico. Lo scrive lo Spiegel, secondo cui fonti di inquirenti
ritengono che l'uomo abbia fosse sotto l'effetto "un'elevata quantità di alcol".
L'uomo è stato trasferito dalle autorità in una clinica psichiatrica. "Quando
sono arrivato c’erano per terra almeno 15 persone, tra questi molti bambini
piccoli. Dappertutto volti in lacrime. Tra questi i padri i cui figli erano lì
per terra". È quanto riporta un testimone, citato dalla Bild, in merito alla
tragedia di Volkmarsen, Tutte le ipotesi sono al vaglio della polizia. "Non
possiamo dire se si tratti di un malore, un guasto tecnico o se il fatto sia
intenzionale", ha affermato un portavoce della polizia, secondo quanto riferito
dal quotidiano "Sueddeutsche Zeitung". Le forze dell'ordine hanno anche pregato
la popolazione e i media "di non diffondere segnalazioni non accertate". La
polizia ha confermato che "l’autista è stato arrestato e che molti feriti
vengono ancora soccorsi sul luogo. Non sappiamo ancora se l’autista abbia mirato
intenzionalmente sulla folla". Una seconda persona è stata arrestata per i fatti
di Volkmarsen. Lo ha riferito il capo della polizia di Francoforte, Gerhard
Bereswill. Tutte le parate di Carnevale organizzate nell'Assia sono state
cancellate. Lo ha comunicato la polizia del Land tedesco parlando di
una "misura precauzionale". Dopo la strage di Hanau, altra località dell’Assia,
il ministero dell'Interno aveva aumentato i dispositivi di sicurezza in tutto il
Paese. I due attacchi a mano armata erano avvenuti lo scorso mercoledì sera in
locali frequentati dalla comunità turca. Il killer, Tobias Rathjen, un tedesco
di 43 anni, ha fatto fuoco intorno alle 22 uccidendo 9 persone. A perdere la
vita anche una donna di 35 anni incinta. Sei i feriti di cui uno in gravi
condizioni. Il suo corpo senza vita, e quello della madre, sono stati poi
trovati nel suo appartamento. L’assassino ha lasciato una video-confessione in
cui rivendica la volontà di "annientare alcuni popoli".
Germania, auto tra la folla al Carnevale: oltre 30 i feriti,
anche bambini. Due arresti. È accaduto nella città di
Volkmarsen. L'autista, tedesco ventinovenne che fino ad oggi non si era fatto
notare come ipotetico estremista politico, ha sterzato sulla folla, accelerando
e oltrepassando la barriera che bloccava il traffico dalla parata mirando sui
bambini. Procura Francoforte indaga per tentato omicidio. La Repubblica il 24
febbraio 2020. Oltre 30 persone, tra queste anche bambini piccoli, sono rimaste
ferite da un'auto che verso le 14,30 ha fatto irruzione a tutta velocità nel
corteo della parata di Carnevale che si stava svolgendo nella città di
Volkmarsen, nello stato dell'Assia, a circa un'ora a sud della città di
Bielefeld, in Germania. Sette sono in gravi condizioni. Il conducente è stato
arrestato dalla polizia: un cittadino tedesco ventinovenne che fino ad oggi non
si era fatto notare come ipotetico estremista politico. Una seconda persona è
stata arrestata in serata. Lo ha riferito il capo della polizia di Francoforte,
Gerhard Bereswill. l video sui social mostrano una station wagon Mercedes
argentata con le luci di emergenza che lampeggiano sul marciapiede, mentre
passano le auto delle forze dell'ordine. La Procura generale di Francoforte ha
aperto un'inchiesta per tentato omicidio. Secondo quanto riferisce il portavoce
della Procura, Alexander Badle: "Stiamo indagando in tutte le direzioni". La
Procura ha confermato che il conducente dell'auto al momento non è in condizione
di essere interrogato: anche lui nello scontro ha riportato delle ferite.
Auto finita deliberatamente sulla folla. I media tedeschi citando
testimoni affermano che l'autista ha deliberatamente sterzato sulla folla,
accelerando e oltrepassando la barriera che bloccava il traffico dalla parata
mirando sui bambini. L'auto ha poi continuato a guidare tra la folla per circa
30 metri prima di fermarsi nell'incidente. Secondo la Frankfurter Rundschau,
alcuni presenti hanno affermato che "sembrava che in conducente mirasse sui
bambini". Un altro testimone, di nuovo secondo la Bild, afferma che molte
persone sono corse inferocite verso il guidatore: è dovuta intervenire la
polizia per evitare che la situazione precipitasse.
Ministero, non escludiamo attentato. Le autorità del Land tedesco
"non escludono un attentato. A quanto afferma il ministero dell'Interno
dell'Assia, citato dall'Afp, "data la situazione sul posto non possiamo
escludere un attentato". Un portavoce della polizia presente nella cittadina a
circa 30 chilometri da Kassel si è espresso diversamente: "Non pensiamo si sia
trattato di un attacco, ma riteniamo si sia trattato di un'azione intenzionale".
Cancellate le manifestazioni del Carnevale. Tutte le parate di
Carnevale organizzate nell'Assia sono state cancellate. Lo ha comunicato la
polizia del Land tedesco parlando di una "misura precauzionale".
Precedenti. L'incidente arriva meno di una settimana la strage di
Hanau dove un uomo armato ha ucciso 11 persone, incluso se stesso. Uno dei
peggiori attacchi razzisti in Germania. Il 19 dicembre 2016.
Il killer
di Hanau: «Sempre pedinato Non posso fidanzarmi».
Pubblicato giovedì, 20 febbraio 2020 su Corriere.it da Elisabetta Rosaspina.
Hanau Paranoico, razzista, suprematista, certo, ma non clandestino, né
trasparente: Tobias Rathjen gestiva dall’agosto scorso addirittura un sito,
oscurato poche ore dopo la strage, dove postava le sue farneticazioni e
assicurava che, se fosse esistito un pulsante per annientare «certi africani,
asiatici e mediorientali», lo avrebbe premuto volentieri, senza esitazioni. Nel
suo «manifesto» di 24 pagine non annunciava esplicitamente intenzioni omicide,
ma sciorinava tutta la sua insofferenza per la massiccia presenza di stranieri
che «mettevano in pericolo la Germania» e la cui espulsione non sarebbe stata
sufficiente. Occorrevano «una pulizia di massima» e «una pulizia finale». E gli
immigrati non erano i soli invasori che agitavano i suoi incubi. Avvertiva
attorno a sé spie e fantasmi che lo seguivano, lo controllavano e tentavano di
penetrare nel suo cervello e di impadronirsi dei suoi pensieri.
Aveva scritto
al procuratore di Hanau, la cittadina di novantamila abitanti a 20 chilometri da
Francoforte, dove abitava, e al procuratore federale di Karlsruhe, denunciando
di essere sorvegliato da misteriose organizzazioni segrete. Si era rivolto a
investigatori privati, tra i quali un austriaco di Neukirchen, con il quale ha
mantenuto i contatti fino al 6 gennaio scorso, per essere aiutato a smascherare
i suoi invisibili pedinatori. Non ha ovviamente seguito il consiglio del
detective di rivolgersi piuttosto a un buon psichiatra e ha continuato ad
alimentare le sue manie di persecuzione, il suo odio per le minoranze etniche,
la mitomania che lo spingeva ad accusare Donald Trump di avergli scientemente
scippato lo slogan «America first». Una settimana fa si era rivolto in inglese,
attraverso YouTube, proprio al popolo americano, esortandolo ad aprire gli
occhi, organizzarsi e lanciare l’assalto a basi militari segrete che, negli
Stati Uniti, «celebrano il diavolo in persona, abusano, torturano e uccidono i
bambini». La presenza di forze oscure in grado di leggere addirittura nella
mente sembra fosse una delle fissazioni che l’uomo diffondeva via web, assieme
all’allarme per l’esistenza di una vasta rete di complotti gestita dai servizi
di intelligence e alle sue idee xenofobe. Eppure Tobias Rathjen, iscritto a
un’associazione di cacciatori, possedeva legalmente tre pistole: la Glock 17
calibro 9 Luger che ha scaricato mercoledì sera contro i clienti dei due shisha
bar curdi, una Sig Sauer e una Walther, tutte acquistate via Internet. Era
membro di una società di tiro a segno a Bergen-Enkheim da otto anni, e il suo
porto d’armi è stato rinnovato appena l’anno scorso. L’amministrazione del
distretto Main-Kinzig di Gelnhausen aveva stabilito la sua idoneità, nonostante
i controlli, tra i più severi in Europa, che regolano in Germania il possesso di
armi da fuoco. E nonostante il monitoraggio da parte delle autorità sia
aumentato dopo il massacro di Winnenden nel 2009 (16 vittime compreso il
giovanissimo assassino) e l’assalto a un centro commerciale di Monaco del luglio
2016, quando un diciottenne tedesco di origini iraniane in preda a deliri sulla
purezza ariana, sparò e uccise 9 persone, ferendone altre 36. Tobias è arrivato
a 43 anni covando inosservato le sue ossessioni e le sue fobie. Abitava con i
genitori in una villetta a schiera di Helmholtzstrasse, in un quartiere
piuttosto anonimo e modesto alla periferia di Hanau. Tra decine di casette
identiche bianche o grigie, a un piano e con un pezzetto di giardino, una
tettoia di mattoni rossi identifica l’ingresso dell’abitazione dei Rathjen,
transennato dalla polizia per proteggere l’andirivieni degli agenti della
Scientifica. I vicini sapevano che era in casa quando vedevano parcheggiata la
sua Bmw nera, ma avevano rare occasioni di incrociarlo o di scambiare con lui
qualche parola. E mai nessuno lo ha visto in compagnia di una ragazza: «Non
posso avere una moglie né una fidanzata», si lamentava online, riferendosi
sempre alla sua certezza di essere circondato da ostili segugi. Ancora non è
chiaro il momento in cui la sua vita è deragliata dai binari della normalità.
Nato ad Hanau nel 1977, Tobias Rathjen aveva frequentato una scuola locale
lasciando sbiaditi ricordi nella maggioranza dei suoi compagni di classe. Il suo
destino sembrava quello di un tranquillo lavoro in banca, dopo aver conseguito
il suo titolo in business management all’università di Bayreuth nella primavera
del 2007. Come un bravo studente qualsiasi.
La strage
di Hanau, «Mercedes aspettava un bimbo, era lì solo per portare la cena».
Pubblicato venerdì, 21 febbraio 2020 su Corriere.it da Elisabetta Rosaspina. Se
mercoledì sera non si fosse assentato un paio d’ore dall’Arena Cafè per andare a
festeggiare il compleanno di un’amica, Jack ora non sarebbe qui a descrivere la
scena apocalittica che si è presentata ai suoi occhi quando è ritornato, ignaro
di tutto, al shisha bar del padre. Non credeva ai suoi occhi: «C’era un cadavere
nell’auto parcheggiata di fronte. E altri corpi insanguinati per terra, nel
locale. Li conoscevo tutti. È morto mio zio, Gökhan. Non è davvero mio zio, ma è
come se lo fosse. Lavorava con noi da tanto tempo. Mercedes era venuta soltanto
per portarci la cena. Non doveva essere qui». Lei non doveva esserci, lui sì. E
la madre di Jack, una colombiana divorziata da un turco e vissuta a Roma (dov’è
nato suo figlio) non può che ringraziare l’imperscrutabile volontà del fato: «Ma
capisco e soffro per i genitori di quelli che non hanno avuto la mia stessa
fortuna — si affretta ad aggiungere Abaned che, per altri complicati intrecci
famigliari, ha un nome di origini arabe e un fratello domiciliato ad Alghero —.
Gökhan faceva parte della famiglia, viveva qui da vent’anni». L’età di Jack, che
ha lasciato l’Italia a 8 anni e ormai si sente più tedesco che turco o
sudamericano. E comunque, fino a mercoledì sera, non pensava potesse diventare
una questione di vita o di morte. Kesselstadt è un quartiere così, un miscuglio
di etnie, nazionalità, idiomi che fino a tre giorni fa pareva pacifico. Ci si
conosce e capisce in quell’affollata torre di Babele. Una città nella città,
popolata da rom (ma qui si preferisce definirli «sinti»), polacchi, bosniaci,
curdi, afghani. L’Arena Cafè non era soltanto il ritrovo serale dei fumatori di
narghilè: «Di giorno entrava anche qualche tedesco a bersi una birra o a
comprare le sigarette» testimonia Iñaki che da Vitoria Gasteiz, nei Paesi
Baschi, si è trasferito anni fa ad Hanau per trovare lavoro alla Dunlop. Una
serie di etichette adesive in varie lingue e alfabeti segnala che da qui
partivano anche le rimesse verso i Paesi d’origine. Una mano ha tracciato sulla
vetrina un messaggio di pace in tedesco: «Il nostro amore è più forte del vostro
odio». L’aria è lacerata da un urlo spaventoso: è la madre di Mercedes Kierpacz,
la ragazza sinti-polacca falciata assieme al bimbo che portava in grembo. La
donna è venuta a vedere il luogo in cui ha perso la figlia e un nipotino mai
nato. La trascinano via quando sta per crollare sul piccolo altare di fiori e
lumini cui Johann, un pensionato tedesco, ha cercato invano di contribuire.
Niente da fare: il vento spegne immancabilmente la fiammella. «Io me lo ricordo
bene Tobias — rivela Abaned, prima di dileguarsi all’improvviso, come se la
disperazione dell’altra madre le rinfacciasse la tortura cui lei è
miracolosamente scampata —. Abito a qualche casa di distanza, in
Helmholtzstrasse, a cinque minuti da qui. Lo incontravo spesso al supermercato,
sempre solo. Non sorrideva mai, non salutava nessuno. Adesso ho capito che
odiava a morte questo quartiere». Simbolo della promiscuità che aborriva tra
«ariani» e «razze impure». Secondo il giornale Bild, che ha rintracciato uno dei
suoi rari amici d’un tempo, Tobias si era isolato dopo un infortunio al
ginocchio che aveva stroncato le sue ambizioni calcistiche e aveva lasciato il
posto in banca perché scontento dello stipendio. Viveva con i genitori, nella
cameretta in cui era cresciuto, rimuginando ossessioni e ansia di vendetta. Un
malato mentale, per gli investigatori. Ma a pochi chilometri di distanza, nella
sede del centro culturale turco-curdo, la storia del pazzo solitario non
convince. Quasi metà delle vittime appartenevano alla comunità, che da tempo si
sente in pericolo: «Esistono gruppi clandestini di estrema destra, già
responsabili di altri attacchi razzisti, la polizia lo sa», ricorda Nazim Turan.
Strage di
Hanau, a forza di agitare il terrore si generano solo nuovi terrorismi.
Giulio Cavalli de Il Riformista il 21 Febbraio 2020. È successo ancora. Questa
volta in Germania, ad Hanau, una città dell’Assia a circa 20 chilometri
da Francoforte. Alle 22 di mercoledì sera c’è stata la prima sparatoria nel
centro della città, la seconda a due chilometri di distanza, in una piazza nel
quartiere periferico di Kesselstadt, dove si trova anche l’abitazione di Thomas
Rathien, un estremista di destra di 43 anni, trovato in casa senza vita insieme
al cadavere della madre mentre il padre è stato portato via da casa dalle forze
speciali tedesche. Il bilancio parla di 11 persone morte tra cui una 35enne
incinta e già madre di due figli. I primi otto o nove colpi sono stati sparati
al Midnight, un bar scisma molto conosciuto nel centro della città. L’omicida
poi si sarebbe spostato nella periferia occidentale all’Arena Bar & Cafe, un
altro locale dove si fuma il narghilè. Le forze dell’ordine hanno mobilitato
centinaia di uomini e decine di ambulanze sono accorse sui luoghi delle
sparatorie. In un primo momento la polizia tedesca aveva ipotizzato che potesse
essere un regolamento di conti tra bande criminali. Già lo scorso venerdì, in
pieno centro a Berlino, durante uno spettacolo di un comico turco c’era stata
una sparatoria al Tempodrom con uno spettatore ucciso e almeno sette feriti. I
locali colpiti a Hanau sono bar amati dalla comunità turca e curda. Questa volta
sui moventi ci sono pochi dubbi: l’omicida ha lasciato una video-confessione in
cui rivendica la volontà di “annientare alcuni popoli”. Peter R. Neumann,
direttore dell’ICSR (Centro di ricerca sul terrorismo) ha scritto su Twitter che
nelle 24 pagine del manifesto “politico” lasciato dal killer si rivela tutto “il
suo odio per gli stranieri e i non bianchi. Sebbene enfatizzi l’Islam, chiede la
distruzione di vari Paesi del Nord Africa, del Medio Oriente e dell’Asia
centrale (che sono tutti a maggioranza musulmana). Sempre Neumann scrive che il
killer avrebbe giustificato la sua richiesta di cancellare intere popolazioni di
alcuni Paesi «in termini esplicitamente eugenetici» dicendo che «la scienza
dimostra che alcune razze sono superiori». Tra i suoi scritti c’è anche la
rivelazione che l’uomo non ha «mai avuto una relazione con una donna negli
ultimi 18 anni, per scelta» e che sarebbe «stato sorvegliato da un servizio di
intelligence per tutta la vita». Thomas Rathien aveva un regolare porto d’armi e
una licenza da cacciatore e secondo la polizia non aveva complici. Sulla matrice
razzista della strage sembra non avere dubbi anche Angela Merkel che ha parlato
di «giorno orribile per il Paese»: «Molto lascia pensare che il massacro sia
stato mosso dall’odio xenofobo, un odio verso chi ha origini, religioni o
aspetto diverso. Il razzismo è un veleno, l’odio è un veleno che esiste nella
nostra società». Ha poi continuato: «Il governo tedesco e le istituzioni statali
sostengono i diritti e la dignità di ogni persona in questo paese. Non facciamo
alcuna distinzione per la provenienza o il credo delle persone». Dopo Oslo, dopo
Auckland, dopo El Paso ora anche Hanau si aggiunge ai luoghi delle stragi
xenofobe dove il terrorismo bianco risulta essere addirittura più feroce di
quello che vorrebbe combattere. Non si tratta di episodi collegati, certo, e non
c’è nessun elemento per immaginare un’internazionale del razzismo ma è evidente
che il fenomeno della destra eversiva abbia raggiunto livelli di allarme che
pongono alcune rilevanti questioni: siamo sicuri che stiamo dando il giusto peso
al ritorno di talune intolleranze? Siamo certi che sia il caso di continuare a
derubricare alcuni importanti segnali come sciocchezze, ragazzate o singoli
episodi (tenendo conto che poi spesso sono singoli anche gli attentatori che
procurano ingenti danni)? Esiste un’intelligence europea, come per il terrorismo
islamico, in grado di monitorare e scambiarsi velocemente informazioni sui
gruppi di estrema destra? La scorsa settimana la politi federale tedesca ha
arrestato 12 persone (di età tra i 20 e i 60 anni) in sei diversi Länder
federali, sospettati di fare parte di un’organizzazione terroristica di estrema
destra che stava progettando attacchi a moschee, scuole di quartieri musulmani e
centri di accoglienza. Sono state ritrovate armi, munizioni, granate e
addirittura bombe artigianali. La cellula terroristica puntava anche a alcuni
politici particolarmente impegnati sui temi dell’accoglienza e l’idea era quella
di provocare, in Germania, un clima «da guerra civile», scrivono gli
investigatori. Sempre secondo l’intelligence tedesca oggi in Germania ci
sarebbero almeno una cinquantina di persone di destra pronti a compiere atti
terroristici. Cinquanta altri Thomas Rathien: sicuri che vada tutto bene? Poi
un giorno, magari, si rifletterà sul fatto che a forza di agitare il terrore non
si fa che partorire terrorismi e terroristi di ogni risma, terroristi che
combattono con il terrorismo il terrorismo degli altri. E nelle strade scorre il
sangue.
·
Quei razzisti come
gli Spagnoli.
Domenico Zurlo per leggo.it il 13 giugno 2020. Anche la Spagna ha
il suo George Floyd. In questi giorni di proteste in tutto il mondo dopo la
morte dell'uomo di colore a Minneapolis, soffocato dal ginocchio di un agente di
polizia - la scena ha fatto il giro del pianeta - sui media spagnoli si parla
negli ultimi giorni di un caso con forti analogie con Floyd. Quello di Iliass
Tahiri, un 18enne marocchino morto il 1° luglio dell'anno scorso in un centro di
detenzione minorile spagnolo. Iliass, nativo di Tetouan e che viveva ad
Algeciras, morì nel Centro Giovanile Tierras de Oria ad Almeria, in Andalusia.
Secondo il giudice, il ragazzo fece resistenza alle guardie: la sua fu giudicata
nel gennaio di quest'anno una «morte violenta accidentale». Ma la sua famiglia
si è appellata alla sentenza, dopo che sono emerse nuove prove che hanno
rivelato particolari terribili. Tahiri entrò in quel centro il 2 maggio 2019, e
ne uscì morto due mesi dopo. Il centro lo descriveva come «ragazzo problematico»
a cui era stato diagnosticato un «grave disturbo antisociale della personalità»,
scrive El Pais, che spiega come il 18enne era già stato in altri due centri
giovanili ed era in attesa di processo per aver minacciato uno psicologo con un
coltello. Inoltre faceva uso di droghe da quando aveva 10 anni e aveva subìto
atti di bullismo, scriveva El Pais che citava i rapporti degi psicologi e degli
psichiatri che lo avevano avuto in cura.
LA MORTE DI ILIASS. Lo scorso 9 giugno El Pais ha pubblicato
video inediti dalle telecamere di sicurezza, in cui si vede com'è morto il
giovane marocchino. Nessuna resistenza da parte sua, ma sei uomini, 4 guardie e
due uomini in borghese, che lo tengono ammanettato a faccia in giù su un letto:
un incubo lungo 13 minuti che finisce con la morte del ragazzo, con un medico
che arriva a verificare che non respira più. In quei 13 minuti, una guardia gli
controllava il polso e verificava il suo respiro, più di una volta.
A PANCIA IN GIU'. A gestire i centri di detenzione minorile è la
GINSO (Associazione spagnola per la gestione dell'integrazione sociale): secondo
i suoi protocolli, l'immobilizzazione non deve mai avvenure a faccia in giù, a
meno che non siano dei medici a raccomandarlo. Nel caso di Tahiri, nessun medico
lo aveva fatto. Secondo il rapporto ufficiale del centro alla Guardia Civil, le
guardie avrebbero tentato di immobilizzarlo a faccia in su, ma la sua resistenza
li aveva costretti a metterlo invece a faccia in giù. Inoltre le guardie
avrebbero parlato di «calci e violenza estrema» descrivendo la reazione del
giovane, particolari di cui non c'è traccia nei video. E in quest'ultimo si
vedrebbe anche una guardia mettergli un ginocchio vicino alla testa (particolare
molto simile alla morte di George Floyd e che potrebbe aver avuto un ruolo nella
sua morte). Il rapporto dell'autopsia escluse il soffocamento come causa della
morte, parlando invece di aritmia cardiaca. Ma lo stesso rapporto descriveva
chiari segni di soffocamento sul corpo del giovane marocchino: il giudice
giudicò perciò accidentale la sua morte, ritenendo necessaria la procedura
seguita dalle guardie per «prevenire atti di violenza o di autolesionismo da
parte del detenuto», scrive sempre El Pais, il cui video ha riaperto il
dibattito sul caso provocando furiose polemiche.
IL FRATELLO. Mounaim, fratello del 18enne morto, ha subito
paragonato la sua morte a quella di George Floyd, parlando con il giornale
spagnolo Publico. «Lo hanno ucciso», ha detto dopo aver visto il video.
«Controllano il suo polso, sembrano nervosi tra loro. La sua faccia è sul
cuscino, un ragazzo è sopra di lui, continuano a legarlo». Anche le Ong spagnole
per i diritti umani hanno condannato l'accaduto chiedendo chiarezza: «Cinque
adulti per immobilizzare un ragazzino», ha detto a Publico Jose Miguel Morales,
segretario generale della Ong Andalucia Acoge. «Questa situazione rivela che le
cose non vanno fatte come dovrebbero in ciò che riguarda i diritti umani».
Juan Carlos lascia la Spagna per l’inchiesta su una presunta
frode fiscale. Il figlio Felipe VI lo ringrazia. Il 4
agosto 2020 su Il Corriere della Sera. Juan Carlos lascia la Spagna. Il re
emerito ha comunicato la decisione in una lettera inviata al figlio. Juan Carlos
lascia la Spagna. A sorpresa il re emerito ha annunciato la sua decisione di
auto esiliarsi per le indagini su una frode fiscale in Spagna e in Svizzera. La
comunicazione, come scritto dal Corriere della Sera che cita El Pais, è arrivata
attraverso una missiva inviata al figlio Felipe VI che ha ringraziato il padre
per la decisione presa. Resta mistero sulla nuova destinazione che potrebbe
essere comunicata nelle prossime settimane. Juan Carlos lascia la Spagna. La
decisione del re emerito è stata comunicata con una lettera inviata al figlio re
Felipe IV. “Con lo stesso desiderio di servire la Spagna – si legge nella
missiva citata dal Corriere della Sera – che ha ispirato il mio regno, e in
vista delle ripercussioni pubbliche che certi eventi del passato nella mia vita
privata stanno degenerando, desidero esprimere la mia assoluta disponibilità a
contribuire a facilitare l’esercito delle vostre funzioni, dalla tranquillità e
dalla pace che la vostra alta responsabilità richiede“. Un auto-esilio che è
stato deciso per le inchieste su una presunta frode fiscale che vedono
coinvolto Juan Carlos in Spagna e in Svizzera. La missiva è stata ricevuta dal
figlio Felipe VI che ha ringraziato il padre per la decisione di lasciare la
Spagna. Resta top secret, al momento, la nuova destinazione del re emerito anche
se non è escluso nelle prossime settimane la comunicazione della città dove
risiederà Juan Carlos in questo periodo di esilio. Possibile un ritorno in
patria alla chiusura dei fascicoli anche se non si hanno delle certezze su
questa ipotesi. Una decisione storica visto che per la prima volta il re emerito
ha deciso di lasciare il proprio Paese.
Travolto dagli scandali, re Juan Carlos abbandona la Spagna.
La decisione comunicata dall'ex sovrano al figlio, re
Felipe VI, è conseguenza delle inchieste della magistratura svizzera e del
Tribunale supremo spagnolo sui presunti fondi trasferiti in paradisi fiscali.
Alessandro Oppes il 03 agosto 2020 su La Repubblica. Prima di essere cacciato
per indegnità dalla Zarzuela, il palazzo reale che occupò come sovrano di Spagna
per 39 anni, il re emerito Juan Carlos di Borbone ha deciso di abbandonare la
Spagna. Lo ha comunicato al figlio, re Felipe VI, che ha subito annunciato la
notizia al Paese attraverso un comunicato ufficiale della Casa Reale. Da
settimane il governo progressista guidato da Pedro Sánchez chiedeva all'attuale
monarca di prendere duri provvedimenti nei confronti del padre (si ipotizzava
appunto l'allontanamento dal palazzo alla periferia di Madrid sede della
monarchia borbonica) in seguito alle inchieste sempre più imbarazzanti della
magistratura elvetica e del Tribunale supremo spagnolo sui conti in Svizzera e
le società offshore nelle quali Juan Carlos avrebbe depositato presunte
tangenti: in particolare, la più clamorosa, quella da 100 milioni di dollari
ottenuta dall'ex re Abdallah dell'Arabia Saudita per la sua opera di mediazione
nella trattativa per l'assegnazione a un consorzio di 12 imprese spagnole
dell'appalto per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità tra
La Mecca e Medina. Già nel marzo scorso, dopo le rivelazioni della stampa
spagnola e internazionale sullo scandalo, re Felipe VI decise di rinunciare
all'eredità del padre e a privarlo dell'assegnazione annuale di circa 180mila
euro a carico dello Stato: una mossa con lo scopo di tenere la fragile
istituzione monarchica al riparo da possibili accuse di coinvolgimento negli
affari opachi di Juan Carlos. "Sono stato re di Spagna per quasi quarant'anni e
ho sempre voluto il meglio per la Spagna e per la Corona", scrive Juan Carlos
nella lettera al figlio Felipe VI. Il suo avvocato assicura in un comunicato
che, nonostante la decisione di lasciare il Paese, il suo assistito resterà a
disposizione della procura del Tribunale supremo spagnolo che sta indagando su
di lui.
"Ha lasciato la Spagna". Travolto dagli scandali la fuga di re
Juan Carlos. Potrebbe essere indagato sui presunti
fondi trasferiti in paradisi fiscali. "È già all'estero". Manila Alfano, Martedì
04/08/2020 su Il Giornale. Essere un imbarazzo anche dopo aver rinunciato al
Regno. Non si ricorda fine più ingloriosa di quella che è toccata a Juan Carlos,
82 anni, ex monarca di Spagna, parabola discendente di un re eroe della
democrazia a corrotto e odiato. Da mito a nemico del popolo, pesa tutto in
questi 39 anni di regno. E così ieri, prima di essere cacciato per indegnità
dalla Zarzuela, il palazzo reale, il re emerito Juan Carlos di Borbone ha deciso
di abbandonare la Spagna. A comunicarlo è stato il figlio, re Felipe VI, diverso
e opposto, così legato alla mamma Sofia e già ai ferri cortissimi che salito al
trono come primo atto, gli ha negato un ufficio a Palazzo. Sono cambiati i
tempi, è cambiata la Spagna, e troppe inchieste giudiziarie soffiano sul collo
di questo vecchio monarca che ha perso il suo tocco e soprattutto ha perso
l'amore incondizionato della sua gente. Eppure ci sapeva fare Juan Carlos, anche
se non si faceva problemi ad ammettere che non era mai riuscito a finire un
libro in vita sua, più intelligenza che cultura la sua. «Qui sono scarso»,
confessò una volta a un politico toccandosi la testa; «ma qui», e si toccò il
naso, «sono imbattibile». E lo aveva dimostrato fin dall'inizio della sua
carriera, quando alla fine della dittatura, barattò il potere con la discrezione
sulle proprie spese e sulla tolleranza sulla propria vita privata. A lui si
perdonava tutto perchè era orgoglio nazionale, l'esuberanza del suo sangue blu
piaceva, le corse notturne nel centro di Madrid su una delle sue 72 auto
sportive, i maschi lo invidiavano per le sue millecinquecento amanti a
certificare il macho latino. Fino all'ultima, l'austriaca, quella di troppo.
Corinna zu Sayn-Wittgenstein, amante nobildonna elevata quasi al rango di
seconda moglie. C'era anche lei nel 2012 in Botswana quando si fratturò l'anca
durante una caccia all'elefante. Un bel guaio per uno che è anche presidente
onorario del Wwf spagnolo. I giornali infransero lo storico patto del silenzio e
la notizia uscì. Erano i mesi più duri della crisi spagnola, migliaia di
famiglie avevano perso la casa. Juan Carlos capì e chiese scusa ma non bastò.
Era l'inizio della discesa. Un re travolto, nonostante il suo infallibile fiuto
di togliersi di mezzo al momento giusto. Nel 2014. Nel mirino della magistratura
era già finita sua figlia Cristina, e lui comprese che era il momento di
sparire. Credeva potesse bastare ma non ha funzionato. Da settimane il governo
progressista di Pedro Sánchez chiedeva all'attuale monarca di prendere duri
provvedimenti nei confronti del padre in seguito alle inchieste sempre più
imbarazzanti della magistratura elvetica e del Tribunale supremo spagnolo sui
conti in Svizzera e le società offshore nelle quali Juan Carlos avrebbe
depositato presunte tangenti: in particolare, la più clamorosa, quella da 100
milioni di dollari ottenuta dall'ex re Abdallah dell'Arabia Saudita per la sua
opera di mediazione nella trattativa per l'assegnazione a un consorzio di 12
imprese spagnole dell'appalto per la realizzazione della linea ferroviaria ad
alta velocità tra La Mecca e Medina. Il 15 marzo l'ultimo affronto, l'ultima
presa di distanza da quel padre diventato una vergogna da nascondere. Il re
Felipe dichiarava di rinunciare all'eredità di suo padre Juan Carlos e gli
tagliava l'assegno annuale di 200mila euro di fondi pubblici che percepiva. «Il
re è nudo», titolavano i giornali. Juan Carlos non è ancora ufficialmente
indagato, anche se fonti giudiziarie svizzere non escludono che lo sarà in
futuro. Fine ingloriosa di un monarca che oggi può solo sperare nell'oblio.
Elisabetta Rosaspina per “il Corriere della Sera” il 5 agosto
2020. Caccia al re. A Santo Domingo oppure in Europa, in Portogallo, in Francia,
in Italia, dove ha ancora parenti, in Grecia, il paese natale della regina
Sofia. Se la Casa reale ha sperato, con la partenza dalla Spagna di re Juan
Carlos I, di calmare le acque agitate dagli scandali finanziari e sentimentali
del vecchio sovrano, ha ottenuto almeno per ora l'effetto opposto. Caos tra i
due partiti di governo, il Psoe del premier Pedro Sánchez, che era al corrente
dei preparativi per l'allontanamento dell'ex capo di Stato, e Unidas Podemos, la
sinistra radicale dei coniugi Pablo Iglesias e Irene Montero, vice presidente e
ministra dell'Uguaglianza, che invece ne erano all'oscuro. E se l'ex monarca ha
cercato di rafforzare il figlio e successore, Felipe VI, togliendo il disturbo,
la Corona è invece sotto l'attacco dei repubblicani e degli indipendentisti
catalani indignati da quella che considerano un'ignominiosa fuga di Juan Carlos
dalle proprie responsabilità e dalla giustizia. La Corte suprema spagnola ha
infatti aperto un'inchiesta in giugno per stabilire se dal 2014, ha abdicato e
non è più protetto dall'immunità reale, l'anziano sovrano si sia macchiato di
frode fiscale, riciclaggio o altri delitti nei confronti dell'Agenzia delle
entrate. Sulla sua immunità per quanto commesso prima dell'abdicazione
(l'eventuale tangente saudita da cento milioni di dollari per la costruzione
della linea ferroviaria ad alta velocità tra la Medina e la Mecca da parte di un
consorzio di ditte spagnole) i giuristi discutono. In Svizzera la procura di
Ginevra che indaga da due anni sul conto intestato alla Fondazione Lucum (creata
ad hoc per ricevere il denaro e sciolta nel 2012, quando un bonifico da 65
milioni di euro è partito da una banca svizzera al conto alle Bahamas dell'ex
amante Corinna Larsen) potrebbe dunque approfondire anche le azioni «non
ufficiali» dell'anziano re. La stampa nazionale ha mobilitato tutti i propri
segugi e i propri confidenti a palazzo per scoprire dove sia il suo rifugio,
mentre il re in carica e la sua famiglia cercano di condurre una vita normale,
pur senza impegni ufficiali in agenda. Venerdì Felipe e Letizia partiranno con
le figlie, la principessa Leonor e l'infanta Sofia, per una decina di giorni a
Palma di Maiorca, dove li ha preceduti la regina Sofia con la figlia Elena a
Marivent, la residenza estiva. Saranno vacanze lavorative, ha informato la
Zarzuela: la coppia reale visiterà le Baleari per verificare la difficile
situazione sanitaria provocata dal coronavirus. Felipe VI si riunirà con il
premier e riceverà le autorità locali. La famiglia comparirà forse per le foto
ufficiali e si scruteranno i loro sorrisi tirati. Letizia è furente con il
suocero, le cui opache manovre finanziarie e quelle palesemente extraconiugali
hanno messo a repentaglio il futuro di Leonor, erede di un trono pericolante.
Quanto all'attuale sovrano, gli osservatori concordano che non avrebbe potuto
fare di più per salvare l'onore dei Borbone: ha tolto titolo di duchessa di
Palma di Maiorca alla sorella Cristina, processata con il marito per corruzione;
ha rinunciato al non limpido patrimonio del padre, gli ha revocato il vitalizio
e ha infine benedetto il suo esilio.
Da tgcom24.mediaset.it il 7 agosto 2020. La Casa Reale non ha
voluto confermare dove si trovi Juan Carlos, che ha abdicato nel 2014, ma per
Abc egli ha lasciato la Spagna da Vigo in Galizia su un jet privato,
accompagnato da quattro guardie del corpo e da un collaboratore. Giunto
all'aeroporto Al Bateen di Abu Dhabi, usato solo per i voli privati, il re e il
suo entourage sono stati trasferiti con un elicottero all'Emirates Palace Hotel,
"uno dei più costosi al mondo", di proprietà del governo degli Emirati. Da
allora, Juan Carlos non ha mai lasciato l'albergo a causa del caldo. Secondo
l'emittente Abc, Abu Dhabi non sarà l'ultima tappa del re che attende la fine
della stagione degli uragani per raggiungere la Repubblica Dominicana, ospite a
Casa de Campo, il complesso alberghiero del magnate dello zucchero Pepe Fanjul.
Juan Carlos va in esilio: ascesa e caduta dell’ultimo re
Borbone. L’ex monarca travolto dagli scandali lascia il Paese.
Daniele Zaccaria su Il Dubbio il 5 agosto 2020. Quando nel 1975
Juan Carlos prestò giuramento davanti l’Assemblea spagnola il leader comunista
Santiago Carrillo gli aveva affibiato un soprannome di rara perfidia: Juan el
breve, convinto che quel monarca senza personalità sarebbe durato molto poco,
spazzato via assieme agli altri cascami del franchismo. Sei anni dopo, nel
febbraio del 1981, lo stesso Carrillo non esita a esclamare: «Che Dio protegga
il re!». Pochi giorni prima il colonnello Antonio Tejero era entrato con un
manipolo di militari in Parlamento, esplodendo diversi colpi d’arma da fuoco;
una scena terribile, trasmessa in diretta tv e rimasta negli occhi di tutti gli
spagnoli. L’intervento di Juan Carlos è decisivo, in un discorso alla nazione il
re intima ai vertici delle forze armate di difendere la democrazia e di isolare
i golpisti. I partiti di sinistra e repubblicani salutano quel discorso come una
pietra miliare della storia moderna del Paese. Al punto da stringersi tutti
attorno alla monarchia, o meglio attorno al sovrano; secondo una definizione
all’epoca molto in voga gli spagnoli non si definiscono monarchici, ma
semplicemente “juancarlisti”. Non ci aveva visto lungo il buon Castillo; il
regno di Juan Carlos è durato infatti quasi quarant’anni, fino al 2014, quando
ha abdicato a favore del figlio Felipe VI. Altro che Juan el breve. È stato il
garante della transizione tra la dittatura del caudillo Francisco Franco e la
democrazia, lo ha fatto con lungimiranza e abilità politica, comprendendo che il
franchismo era ormai una vestigia del passato e riuscendo a includere nel
processo tutte le forze politiche fino alla Costituzione del 1978. Alla morte di
Franco si è autoproclamato re di Spagna e in moltivedevano in lui , se non
proprio una sovrano autoritario, un palese intralcio alla modernizzazione di una
Spagna rimasta isolata dall’Europa per oltre mezzo secolo. Una reggenza, quella
di Juan Carlos, accompagnata da molte luci e da alcune ombre che sul finire del
sua parabola si sono allungate sempre di più, specie i piccoli grandi scandali
che negli ultimi anni lo hanno costretto a farsi da parte. Da ieri è
ufficialmente in esilio, ha lasciato la Spagna con disonore verso una meta
sconosciuta, forse Santo Domingo come sussurrano i media. A rendere ancora più
malinconica la sua parabola, la moglie Sofia, che non lo ha seguito nel suo
mesto tramonto. «È un comportamento vergognoso e una frode dei confronti della
nostra giustizia», ha tuonato il leader di Podemos Pablo Iglesias, un pensiero
condiviso un po’da tutto il panorama politico iberico. Solamente il figlio
Felipe ha salutato la decisione «con profondo rispetto e gratitudine». Frasi di
circostanza però, visto che Felipe ha rinunciato alla cospicua eredità paterna
per non venire più associato alla sua gestione disinvolta della ricchezza. Da
alcuni mesi Juan Carlos era infatti oggetto di inchieste giudiziarie per
evasione fiscale e per corruzione, il Tribunale supremo spagnolo e la
magistratura svizzera indagano infatti su dei sospetti conti segreti del vecchio
re, sulle società off shore su cui avrebbe depositato presunte tangenti. Come
racconta la Tribune de Genève, in un articolo dello scorso marzo l’occhio degli
inquirente si è posato in particolare su una tangente “monstre”, oltre 100
milioni di dollari ottenuti dall’ex re saudita Abdallah per ricompensare lo zelo
con cui avrebbe favorito la costruzione di una linea ferroviaria ad alta
velocità tra La Mecca e Medina ad opera di un consorzio di imprese spagnole. Una
parte di questo faraonico compenso sarebbe andato addirittura nelle tasche della
sua vecchia amante, Corinna Larsen, una nobile tedesca di origine unghereseche
tra le altre cose è stata l’ex consigliera della principessa Charlene di Monaco.
È stata proprio la relazione con la Larsen uno degli elementi che
hanno contribuito a sgretolare la popolarità di Juan Carlos, ad assestargli il
colpo fatale, non tanto per moralismo, al limite per empatia verso la povera
consorte Sofia, senz’altro l lusso sfrenato del loro ménage vissuto dagli
spagnoli come un autentico insulto alle loro difficoltà quotidianer. Nel 2012,
quando il Paese affrontava una feroce recessione economica e subiva la pressione
costante dei mercati finanziari, il sovrano e la sua amante sono infatti volati
in Africa, nel Botswana, dove hanno partecipato a una battuta di caccia
all’elefante costata decine e decine di miglia di euro. Alcuni fotografi
passarono ai giornali le immagini di quel safari reale e in un batter d’occhio
si aprì il vaso di Pandora. Un’esperienza peraltro molto sfortunata considerando
che il sovrano rimediò una brutta frattura all’anca e fu rimpatriato d’urgenza a
Madrid per essere operato. L’opinione pubblica venne colpita a fondo da quel
monarca che aveva un’agenda privata ( e segreta) di stampo coloniale e che
finanziava i suoi divertimenti in modo opaco. In quell’occasione Juan Carlos
provò a respingere i colpi e fece una cosa che nessun re aveva mai fatto prima:
si scusò pubblicamente con gli spagnoli: «Ho commesso un grave errore, una
leggerezza sono davvero mortificato, ma prometto che questo non succederà più».
Un gesto storico che però non basta più a placare i malumori che ormai
serpeggiano anche tra i suoi più fedeli sostenitori. La parabola del re Borbone
sembra dunque terminata. Due anni dopo il viaggio in Botswana arriva
l’abdicazione al cospetto del premier popolare Mariano Rajoy in cui rinuncia
alla corona lasciando il trono al figlio Felipe. Nel 2019 in una lettera
indirizzata proprio a Felipe annuncia il suo ritiro definitivo dalla vita
pubblica: «Credo che si venuto il momento di aprire una nuova pagina della mia
vita», Peccato che si tratti della pagina più buia.
Alessia Grossi per "Il Fatto Quotidiano" – articolo del
10/03/2020. "Nella genealogia di Juan Carlos di Borbone ci sono re che furono
santi e altri che furono crudeli, magnanimi, cerimoniosi, sciocchi, terribili,
grandi, pazzi, belli, magnifici, giustizieri, malinconici e poco duraturi. I
piselli di Mendel hanno una grande varietà tra cui scegliere. Nella monarchia si
mischiano lo Stato e gli ormoni, le vicissitudini della storia e l 'avventura
ovarico-seminale, non meno convulsa ". Mai descrizione fu più azzeccata di
questa contenuta nel romanzo El azar de la mujer rubia di Manuel Vicente per
descrivere il monarca spagnolo emerito, ritiratosi nel 2014 e giù dal trono dal
2018, tante volte già assurto alle cronache per le sue disavventure non tanto
reali quanto amorose. Ultima, quella che in questi giorni lo vede accusato da un
' altra donna bionda, più famosa quasi della protagonista del libro di Vicente,
la sua ex amante, anche detta "amica intima", tal Corinna Larsen, imprenditrice
tedesca già divorziata da Casimir zu Sayn-Wittgenstein, della nota casata dei
Sayn-Wittgenstein-Sayn. La donna ha denunciato al tribunale di Londra il re
emerito per lo stalking da lei subito dal 2012 - anno della fine della storia
extraconiugale del monarca - perché non rivelasse " i segreti di Stato " di cui
è a conoscenza. "Dopo 8 anni di soprusi, che hanno coinvolto anche i miei figli
e visto che non se ne vede la fine, non mi resta altra opzione che intraprendere
le vie legali " , ha dichiarato al tabloid britannico Daily Mail la tedesca
additata nel 2012 come l 'organizzatrice dei " famosi " safari del re Juan
Carlos in Botswana a estinguere gli elefanti. Nella denuncia la bionda rivale
della regina Sofia tira in ballo anche i servizi segreti spagnoli, che a detta
sua, non appena svelata dalla stampa scandalistica la relazione particolare con
il monarca, avrebbero occupato il suo appartamento di Monaco con la scusa di
darle protezione. "Insistettero affinché non parlassi. Mi inviavano e-mail,
utilizzando uno pseudonimo nelle quali mi spiegavano che parlare con i media
sarebbe stato devastante per la mia immagine. Mi sembrò una minaccia: avrebbero
distrutto la mia immagine se non avessi collaborato. E infatti così è stato". Ma
non si tratta di screzi d'amore, né tutto è cronaca rosa. È di due giorni fa la
notizia ricostruita dal quotidiano iberico online eldiario.es che l
'Anticorruzione spagnola ha inviato formale richiesta al Tribunale di Ginevra
per conoscere le ragioni che hanno portato la Svizzera ad aprire un 'inchiesta
sui 100 milioni di dollari provenienti dall 'Arabia Saudita e arrivati a una
fondazione svizzera che il giudice identifica con l 'ex re Juan Carlos. Di
questi, 65 milioni di euro sarebbero stati trasferiti a loro volta su un conto
bancario di Corinna Larsen. Motivo? Stando all 'avvocato dell'imprenditrice si
tratterebbe di "un regalo non richiesto ricevuto dal re emerito" . Secondo il
procuratore Bertossa, invece, potrebbe trattarsi di parte della " commissione "
che l ' ex sovrano le doveva per aver seguito con lui l ' assegnazione
dell'appalto del treno Ave (alta velocità) alla città della Mecca a favore di
aziende spagnole, tra cui Ohl, impresa dell 'amico di Juan Carlos, Juan Miguel
Villar. Non si tratta di un tema nuovo: "i due intimi amici " erano stati già
messi sotto inchiesta dopo che erano trapelate le intercettazioni illegali con
il commissario Villarejo (ora in prigione) nelle quali Corinna parlava di
"commissioni milionarie " per l 'Ave della Mecca richieste dal ex re "non in
grado di distinguere ciò che legale, da ciò che non lo è". Tuttavia questa
inchiesta era stata archiviata " perché non suscettibile di condanna penale " e
perché il re all'epoca non aveva ancora abdicato e quindi era inviolabile.
Peccato che ora il monarca emerito non goda di immunità a Londra. Motivo per cui
la denuncia di Corinna potrebbe avere seguito oltreché per il fatto che il
legale della donna è James Lewis, uno degli avvocati che rappresenta gli Stati
Uniti nel processo di estradizione di Julian Assange. All' ex " regina " non
mancano neppure legami con personalità di spicco di tutta Europa. Nel palmares
delle amicizie, secondo Vanity Fair Spagna, compare anche la presidente del
Senato Maria Elisabetta Casellati, con la quale Corinna ha assistito al concerto
del figlio Alvise a New York e alla festa all 'ambasciata italiana a Mosca in
onore del direttore d ' orchestra russo, Valeri Guérguiev. Per non parlare del
legame con Alekséi Leonídovich Kudrin, ex ministro delle Finanze russo preposto
da Putin a titolare della Commissione anticorruzione in quanto suo uomo di
fiducia. O delle sue amicizie artistiche, tra cui spunta la top model Natalia
Vodianova, sua socia in una app di beneficenza nonché moglie di Antoine Arnault,
erede dell'impero del lusso Lvmh.
Elisabetta Rosaspina per il “Corriere della Sera” il 21 agosto
2020. In stile Lady D, Corinna Larsen ha scelto la Bbc di Londra, dove vive, e i
peggiori giorni della Casa reale spagnola, per vuotare il sacco. A poche ore
dalla conferma ufficiale del temporaneo trasferimento del re emerito Juan Carlos
I di Borbone ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi, l'«ex amante», o «ex amica» a
seconda delle definizioni più o meno indulgenti della stampa spagnola, parla ai
microfoni della tivù pubblica britannica, perché la magistratura (svizzera e/o
spagnola) intenda. Ne risulta il ben calibrato resoconto sentimental-finanziario
di una relazione poco segreta durata cinque anni e culminata con il disgraziato
safari all'elefante in Botswana, preludio dell'abdicazione due anni dopo in
favore del morigerato principe Felipe. Avveduta donna d'affari tedesca, di
origini danesi, Corinna Larsen, 55 anni, 27 meno dell'ex sovrano, si presenta
come una vulnerabile madre single, sedotta dalle attenzioni del re casanova che
prometteva improbabili nozze. E infine le ha elargito, a fiamma già spenta, un
presente per il figlio da 65 milioni di euro con un bonifico alle Bahamas da un
deposito svizzero di cento milioni di dollari provenienti dall'Arabia Saudita.
Che, di tutta la romantica vicenda, è il passaggio più interessante per la
Procura di Ginevra, la Corte suprema spagnola e l'Agenzia delle Entrate a
Madrid. Il feuilleton inizia a una battuta di caccia, nel febbraio 2004, quando
Juan Carlos resta affascinato dall'abilità balistica della neo divorziata
principessa zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, che gli aggiusta in un batter d'occhi il
fucile inceppato. Inizia così un flirt nutrito per mesi di lunghe telefonate
fino al primo fatale appuntamento estivo a Madrid: «Ridevamo sempre tanto
insieme - ricorda l'intesa immediata Corinna Larsen -. Avevamo tanti interessi
in comune: la politica, la storia, il cibo eccellente, i vini...». Lei sta a
Londra, lui a Madrid o in giro per rappresentanza e la chiama «fino a 10 volte
al giorno», precisa la nobildonna con tenerezza retrospettiva. Certo, lei si
preoccupava della consorte ufficiale, la regina Sofia, ma lui la
tranquillizzava: «Mi disse che avevano un accordo per rappresentare la corona,
ma che conducevano vite completamente diverse e separate. Il re era appena
uscito da una relazione quasi ventennale con un'altra donna che aveva occupato
un posto importante nel suo cuore e nella sua vita». Comunque sia, la nuova
coppia non era poi così clandestina: Juan Carlos incontrava i figli di Corinna,
che vedeva quelli del monarca e compariva in foto al suo seguito nei viaggi
ufficiali. Finché all'inizio del 2009 il re si è presentato a Finn Bönning
Larsen, per manifestargli la serietà delle sue intenzioni verso la figlia: «Gli
disse che era molto innamorato di me e che intendeva sposarmi» svela via Bbc ai
sudditi spagnoli l'ex fidanzata del re. Assicurando di averlo ricambiato con
uguale trasporto, e maggiore lucidità sull'ipotesi di un divorzio reale:
«Prevedevo, da stratega politica, che ciò sarebbe stato difficile. E che avrebbe
destabilizzato la monarchia». Preoccupazione che non ha più, adesso, quando
dettaglia di aver interrotto la love story perché al funerale del padre, pochi
mesi dopo aver richiesto al caro estinto la sua mano, il re le confessò
intempestivamente di avere da 3 anni anche un'altra amante. Molto più riservata
sugli aspetti patrimoniali del loro legame, che si è trasformato in amicizia e
poi in ostilità, Frau Larsen non chiarisce l'origine del monumentale dono
pecuniario offertole da Juan Carlos nel 2012. Una tangente saudita? «Questo lo
dirò al procuratore svizzero». E s' irrigidisce all'idea di doverlo restituire
se risultasse frutto di malversazioni: perché proprio quei soldi, pegno d'amore,
con tutti i fondi neri della famiglia reale forse sparsi nel mondo?
Parla l'ex amante di Juan Carlos: "Il re mi regalò 65 milioni
di euro". Corinna Larsen, ex amante di Juan Carlos di
Spagna, ha raccontato in esclusiva alla Bbc della sua relazione con l'ex sovrano
e di un "generoso" dono da 65 milioni di euro. Mariangela Garofano, Venerdì
21/08/2020 su Il Giornale. A pochi giorni dalla “fuga” di Juan Carlos ad Abu
Dhabi, ecco che l’ex amante del re emerito racconta particolari che potrebbero
inguaiare ulteriormente la situazione dell’ex sovrano spagnolo. La bionda
Corinne Larsen ha affidato le sue rivelazioni alla Bbc, a cui ha raccontato che
Juan Carlos voleva sposarla e che le fece un “generoso” regalo da 65 milioni di
euro provenienti da un misterioso conto corrente saudita, versati su un conto
delle Bahamas. L’intervista della Larsen contribuisce ad agitare le acque della
monarchia spagnola, che ultimamente sta vivendo un difficile momento, a causa
delle indagini che la procura svizzera e quella spagnola hanno avviato sugli
strani movimenti finanziari dell’ex sovrano. “Ridevamo così tanto insieme.
Avevamo tanti interessi in comune: la politica, la storia, il cibo eccellente, i
vini”, racconta l’elegante Larsen, parlando dei tempi felici della relazione con
il più anziano, ma affascinante sovrano di Spagna. La scintilla tra i due scoccò
ad una battuta di caccia nel 2004, quando il re, famoso per essere un don
Giovanni, rimase stregato dagli occhi blu della donna. Seppur sposato con la
regina Sofia, Juan Carlos disse alla Larsen di non preoccuparsi e che “avevano
un accordo matrimoniale per rappresentare la corona, ma conducevano due vite
separate”. “Juan Carlos era appena uscito da una relazione durata vent’anni”,
prosegue la Larsen. La coppia inizia una relazione sotto gli occhi di Sofia,
moglie devota di un uomo, che non le nascose mai le sue scappatelle. Corinna
diventa così intima a corte, che conosce anche i tre figli del re, il quale a
sua volta frequenta i figli della sua amante. Il rapporto prende una piega
sempre più seria, quando nel 2009, racconta Corinna, Juan Carlos si presenta dal
signor Finn Bönning Larsen, per chiedergli la mano della figlia. “Disse a mio
padre che era innamorato di me e che intendeva sposarmi”, rivela la donna alla
Bbc, aggiungendo però che “da stratega politica, sapevo che sarebbe stato
difficile e che ciò sarebbe stato uno scandalo per la monarchia”. La relazione
si interromperà poco dopo, quando al funerale del padre, il sovrano donnaiolo le
confesserà di avere un’altra amante da tre anni. Di quella relazione a Corinne
Larsen rimane quel “dono” da 65 milioni di euro, che oggi interessa alla Procura
di Ginevra a quella di Madrid e all’Agenzia della Entrate spagnola. “Di questo
ne parlerò alla procura”, taglia corto la Larsen, a proposito dell’ingente somma
ricevuta dall’ex sovrano, a cui potrebbe essere costretta a rinunciare.
DAGOREPORT il 21 agosto 2020. Sposato con la regina Sofia dal
1962, era l'archetipo di Casanova: bello, titolato, abbronzato e ricco. Cinque
anni fa uno scrittore spagnolo affermò che Juan Carlos aveva messo a letto 1.500
donne (tra le quali Gabriella di Savoia e Olghina di Robilant). All'inizio di
quest'anno un libro di Amadeo Martinez Ingles, un ufficiale dell'esercito
spagnolo in pensione, svela "la vera storia di un re amorale, senza scrupoli,
spudorato, ambizioso, autoritario" che "ha avuto migliaia di avventure
sessuali". Fino a 5.000, proprio come il suo omonimo, il seduttore Don Juan.
Ingles ha affermato che le storie d'amore di alto profilo dell'ex re
"rappresentano solo la punta di un monumentale iceberg sessuale" e che durante
il "periodo senile" tra i 67 e i 76 anni, dal 2005 al 2014, quando si credeva
che il testosterone avesse "rallentato" la corsa, Juan Carlos aveva ancora 191
amanti. Il libro lo etichetta "un autentico stallone reale", un "monarca che
potrebbe aver lasciato più di 20 figli". Juan Carlos, tanto per non farsi
mancare nulla, ci avrebbe provato anche con Lady Diana, ma senza successo. I due
si sono incontrati nel 1986, quando Carlo e l'allora consorte si recarono in
vacanza in Spagna. Date le avance di Juan Carlos, Lady D disse al suo bodyguard
che lui la desiderava. La Spencer, anni più tardi, confessò di trovare il re
iberico molto affascinante, ma troppo pressante. Nell'elenco delle 5mila amanti,
allora, non c'era posto per Diana. Il giovedì santo del 1956, durante le vacanze
di Pasqua a Estoril, Juan Carlos e il fratello Alfonso stavano giocando con una
pistola nella sala giochi della villa dei loro genitori. Quello che è successo
dopo non è chiaro, ma ha provocato la morte di Alfonso. Il giorno successivo
l'Ambasciata di Spagna a Lisbona, sotto la direzione di Franco, ha rilasciato
una dichiarazione ambigua: "Mentre Sua Altezza l'Infante Alfonso stava pulendo
una rivoltella con suo fratello, un colpo è stato sparato colpendolo sulla
fronte e uccidendolo in pochi minuti". I commenti successivi, tuttavia, dalla
madre dei ragazzi, Doña María, la sua sarta e un amico di famiglia, hanno
suggerito che Juan Carlos aveva in mano la pistola, che pensava non fosse
carica. Il Re non ha mai negato la sua responsabilità o offerto una spiegazione,
ma come un suo conoscente di lunga data, ha detto: "Lo ha segnato per tutta la
vita". Suo padre, il danese Finn Bonning Larsen, era il direttore europeo della
Varig, la compagnia aerea nazionale brasiliana; sua madre, Ingrid Sauer, era di
Francoforte, dove Corinna è nata il 28 gennaio 1964. Cresciuta tra Francoforte e
Rio de Janeiro e ha frequentato scuole femminili in Germania e Svizzera. Dopo la
laurea presso l'Università di Ginevra, nel 1987, è andata a lavorare per L'Oréal
a Parigi dove gestiva i rapporti istituzionali delle grandi aziende. Ha
incontrato il suo primo marito, Philip Adkins, laureato alla Columbia e ad
Harvard, a Parigi nel 1989; si sposarono l'anno successivo e si stabilirono a
Londra. Nel 1992, la coppia ebbe una figlia, Anastasia. I due divorziarono tre
anni più tardi, nel 1995, ma sono rimasti amici e soci in affari. Adkins era al
safari in Botswana con Juan Carlos, così come il figlio Kyril di 10 anni di
Corinna dal suo matrimonio con Sayn-Wittgenstein. La vispa Corinna ebbe quindi
una relazione con Gert-Rudolf Flick, milionario residente in Svizzera, nipote
del fondatore di uno dei più grandi conglomerati industriali della Repubblica
Federale Tedesca (che include ad esempio la Mercedes-Benz) e che già aveva
divorziato e si era risposato tre volte. Quando ha incontrato il re di Spagna
con il duca di Westminster nel 2004, aveva recentemente rotto con il suo secondo
marito, il principe Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, che aveva sposato quattro
anni prima. ("La sua famiglia era sbalordita", ha detto il jet-set.) Malgrado il
divorzio nel 2005, Corinna ha continuato a usare il suo blasonato nome da
sposata senza il consenso della famiglia, fatto che è stato motivo di scontri
legali. La relazione di Corinna con il re è iniziata apparentemente su base
professionale, quando lui la chiamò e le chiese di organizzare il viaggio di
nozze del principe Felipe e della principessa Letizia nel maggio 2004 in
Giordania, Thailandia e Fiji. "Abbiamo finito per parlare al telefono per alcuni
mesi", ha rivelato in un’intervista. "Il primo appuntamento era all'inizio
dell'estate. Abbiamo sempre riso molto. Avevamo molti interessi comuni:
politica, storia, cibo fantastico, vini..."All'epoca vivevo a Londra, avevo
appena avviato la mia attività di consulenza. Ed ero una madre single di due
figli. Quindi ci saremmo incontrati a Madrid in un piccolo cottage nella tenuta
più grande, e abbiamo viaggiato insieme. "Nel primo anno è stato più difficile
perché ero molto impegnato e lui aveva un fitto programma, ma mi telefonava fino
a 10 volte al giorno. Voglio dire, è stato subito un rapporto molto forte,
profondo e significativo". Ad un certo punto, la tedesca in calore chiede
‘’notizie’’ della moglie, che fine ha fatto la regina Sofia. "Mi ha detto che
avevano un accordo per rappresentare la corona, ma hanno condotto vite
totalmente diverse e separate. E il re era appena uscito da una relazione di
quasi 20 anni con un'altra donna che aveva anche un posto molto importante nel
suo cuore e in la sua vita". (La storia del re con Marta Gaya era un segreto di
Pulcinella a Madrid negli anni '90). Grazie al suo lavoro presso Boss & Co.,
produttori di armi ‘’su misura’’ per i ricchi di Londra, organizzò due safari in
Mozambico per il re, nel 2004 e nel 2005, "sempre al suo fianco". Da allora, ha
detto un insider reale, è stata un'ospite regolare nei fine settimana di caccia
alle pernici che Juan Carlos ospitava ogni primavera nella sua tenuta di
campagna, a sud di Madrid. Boris Izaguirre, un popolare giovane personaggio
televisivo di Madrid, ha ricordato che le voci sulla fidanzata del re sono
iniziate quattro o cinque anni fa: "A quanto pare, Corinna ha preso la manicure
che tutte le grandi signore di Madrid usano nei viaggi con il re, e la gente ha
iniziato a chiedere, "Chi è questa donna tedesca che viaggia con il re?" Poi
sono arrivate le storie sulla casa nel complesso del palazzo El Pardo. Il re
l'ha ristrutturata e la gente diceva che era la casa di Corinna e che lui era
sempre lì con lei ei suoi figli. Dispone di due piscine, una interna, e di un
parcheggio sotterraneo. El Mundo ha pubblicato tutte queste cose e in parlamento
sono state poste domande su chi ha pagato per la ristrutturazione. La famiglia
reale ha risposto che ‘’la casa è stata utilizzata per gli ospiti stranieri".
Più seriamente, la stampa ha iniziato a chiedere perché Sayn-Wittgenstein, che
ha lasciato Boss & Co. nel 2006 per avviare la sua società di consulenza,
Apollonia Associates, abbia accompagnato il re in viaggi all'estero, tra cui
Germania, Arabia Saudita, Kuwait e Emirati Arabi Uniti. Corinna racconta anche
come è finita la sua storia d'amore con il re: "Subito dopo il funerale di mio
padre, il re mi ha detto che aveva una relazione con un'altra donna da tre anni.
Ero letteralmente devastata, era l'ultima cosa che mi aspettavo, dopo che mi
aveva chiesto sposarlo". Quando il re avrebbe dovuto subire un'operazione nel
2010, zu Sayn-Wittgenstein dice di averle chiesto di essere in ospedale con lui.
"Ho dormito su un divano accanto al suo letto prima dell'intervento perché era
molto nervoso", dice. "Ma la biopsia ha mostrato che il tumore era benigno". Poi
arrivò la famiglia del re. "Mi è stato chiesto senza tante cerimonie di
andarmene da un membro non così gentile del suo staff", ricorda. "Quando la
regina Sofia e alcuni cortigiani si resero conto di quanto fosse serio il re nei
miei confronti, si era sviluppato un livello piuttosto elevato di ostilità."
Dopo questa traumatica rottura, però Corinna ha continuato la sua amicizia con
il monarca e nel 2012 dice che fu incaricata di organizzare il rimpatrio di Don
Juan Carlos dal Botswana dopo aver subito la famosa caduta a caccia di elefanti
che avrebbe significato l'inizio del caduta in disgrazia del re e la
pubblicazione della natura della loro relazione dal 2004. I sospetti sono stati
sollevati dopo che la storia del Botswana è scoppiata, quando El Mundo ha
riferito che Mohamed Eyad Kayali, il re e ospite del safari di Corinna, era il
"braccio destro" del principe Salman bin Abdulaziz Al Saud, il ministro della
difesa saudita, che aveva "risolto l'accordo da 9 miliardi di dollari per un
consorzio di aziende spagnole per la costruzione della ferrovia ad alta velocità
tra La Mecca e Medina’’. L'amante tedesca ha affermato che il versamento di 65
milioni di euro da parte del re Juan Carlos era "un regalo generoso e un
riconoscimento di quanto ho significato per lui". In una rara intervista,
Corinna Zu Sayn-Wittgenstein ha raccontato alla BBC come il monarca ha cercato
di riconquistarla due anni dopo averle dato i soldi ed è "impazzito" quando lei
lo ha respinto e ha chiesto indietro i suoi 65 milioni. Attualmente Corinna
Sayn-Wittgenstein è residente a Monaco. Nell'estate del 2013 è stata prescelta
dalla principessa Charlene di Monaco quale consigliera personale e consulente
per la sua immagine. Mentre il principe Alberto ha pensato bene di arruolarla
come ‘’consulente d’affari’ (ma anche qui le malignità si sprecano).
Juan Carlos, il Re pasticcione che salvò la Spagna.
Angela Nocioni su Il Riformista il 5 Agosto 2020. Maldestro è
sempre stato. Non riesce a chiunque di andare in luna di miele segreta
in Botswana, cadere in piena notte dal lettone della capannetta di lusso e
finire su tutti i giornali del mondo con l’anca rotta e la faccia da vecchio
europeo gnoccolone in Africa. Col fucile da guerra imbracciato accanto a una
signora bionda dalla pelle candida, posa ancién regime in piena caccia
all’elefante. Molto Alberto Sordi. Da tener riservata, quella volta, buio 2012 –
crisi economica a Madrid, spagnoli imbufaliti attaccati ai rotocalchi da salone
del parrucchiere a scolarsi i dettagli della figuraccia reale – non era tanto
l’amica tedesca, stranota, alla quale la Regina Sofia ha delegato volentieri per
anni il lavorone di accompagnare il marito in ogni dove, eventi compresi. Quanto
la compagnia di certi amici sauditi. Da lì, poi, i guai di queste ore. Valigie
varie con milioni di petrodollari inguattati dall’ex sovrano in Svizzera. Il
fatto è che Juan Carlos I dei Borboni – l’elemento più scandaloso della
scalcagnata corona spagnola – non voleva fare il re. Avrebbe di gran lunga
preferito nascere Julio Iglesias. Avere gli applausi, l’appeal e il codazzo di
fans d’una pop star anni Ottanta. E invece, ostaggio per lungo tempo dei tira e
molla tra suo padre e Francisco Franco, alla fine gli è toccato il trono. A
dedazo, dicono gli spagnoli, cioè su indicazione esplicita del dittatore,
nemmeno per successione diretta. Ed è stata la fortuna degli spagnoli perché
lui, fanfarone e gaffeur, ha garantito nel 1978 alla cattolicisisima Spagna,
piena zeppa di fascistoni ora, figuriamoci allora, la transizione alla
democrazia, con i comunisti tirati dentro. L’ha fatto da erede al trono
designato. Mica da anarchico izquierdista. E s’è inventato giorno per giorno,
all’impronta, un passaggio incruento di regime, smontando il franchismo
attraverso le leggi franchiste, quelle stesse leggi che garantivano la
legittimità del suo potere, senza regalare mezza chance ai militari scalpitanti,
quando la struttura e gli uomini della dittatura – il Bunker si chiama, il deep
state nero – erano pronti a prendersi il governo. Tanto convinti di farcela che
nel 1981 hanno tentato il golpe. Era il 23 febbraio, se sembrò un colpo di Stato
da operetta è perché non riuscì. Juan Carlos annusò l’aria, con la rivoluzione
dei garofani in Portogallo ormai andata e i colonnelli greci finiti, seppe
convincere i golpisti a lasciar perdere. Ma la democrazia non era inevitabile in
Spagna allora, era solo una delle possibilità. Poi, là come qua d’altra parte, i
fascisti son diventati in un battibaleno tutti riformisti, nello specifico là si
sono riciclati alla svelta nelle braccia spalancate del partito popolare di cui
hanno costituito e costituiscono ancora la non trascurabile nerissima
maggioranza. Quindi buoni un attimo prima di liquidare come avanzo della storia
l’ottantaduenne Juan Carlos. Il vecchio che con sguardo acquoso sorride
comprensivo ai figli che lo detestano. Se a Madrid dopo la morte di Franco non
ci sono stati spari casa per casa parecchio del merito è suo. Del patetico e un
po’ buzzurro re di Spagna. Vuoi mettere lui, un pasticcione capace di uscite
fulminanti (memorabile quel “perché non ti stai zitto?” urlato a Hugo Chavez in
piena logorrea durante un incontro di capi di stato spocchiosi ma muti) vuoi
mettere lui con quel lungaccione mesto mesto di suo figlio Felipe, Felipe VI?
Quello che come somma rivolta non è riuscito a far altro che sposare una
giornalista borghese, la reportera Leticia, la quale dopo sei anni da regina
ancora cammina sempre tre passi davanti al marito calpestando il protocollo?
Quel Felipe che, dopo aver accettato sempre a muso lungo la corona grazie
all’abdicazione paterna nel 2014, ha tolto al padre scavezzacollo anche i
194.232 euro l’anno che gli spetterebbero come ex sovrano cercando così di
ingraziarsi i repubblicani spagnoli che lo odiano lo stesso? Grosse miserie
umane alla corte di Spagna. Pedro Sanchez, il premier socialista, lo sa, e ieri
era tutto un inchinarsi del capo del governo più di sinistra (sulla carta) della
Spagna democratica al ruolo fondamentale avuto dalla monarchia nei passaggi
delicati della storia recente. Mentre il re Felipe VI, con quell’aria da
ragioniere affranto anche quand’è coperto di mostrine come un cavallo da parata,
ringraziava via etere il padre per essersene finalmente andato definitivamente
all’estero. Juan Carlos era già lontano. In un resort nella repubblica
dominicana pare. Scappato nottetempo per fare l’ennesimo regalo al figlio
ingrato. Per non complicare la vita al re senza talento con l’eco del suo ultimo
scandalo. Niente di nuovo nello scandalo. La faccenda saudita si conosce da
mesi. Sono solo stati rivelati quattro pompatissimi dettagli su una sostanziosa
fortuna arrivata a rate in valigia a Juan Carlos dal Medio Oriente, una fortuna
mai dichiarata. L’ex re è accusato da tempo di aver convinto l’impresa spagnola
che ha realizzato il treno veloce per la Mecca a fare un sostanzioso sconto ai
committenti sauditi. Che l’hanno ricompensato per il favore. Ha facilitato un
affare, lo fanno gli ex governanti di mezzo mondo. Solo che lui i soldi s’è,
diciamo, scordato di dichiararli . L’ha fatti sparire prima in Svizzera, in un
fondo che alla sua morte doveva andare al figlio. Poi in parte l’ha affidati
alla signora tedesca. Felipe VI, inorridito quando il dettaglio sul suo ruolo
passivo è stato svelato, ha rinunciato all’eredità. Sapendo benissimo che la
mossa non ha alcun effetto se non d’immagine perché il codice civile non
consente di rinunciare a un’eredità quando ancora non è morto nessuno.
Tristissimo il comunicato della Casa Reale: “Rifiuto fin d’ora di ricevere in
eredità qualsiasi cifra, investimento o struttura finanziaria le cui origini,
caratteristiche e finalità possano non essere consone alla legalità e ai criteri
di rettitudine e integrità che reggono e devono caratterizzare l’attività
istituzionale e privata della Corona”. A dare il via ai fuochi d’artificio
attorno al vecchio re emerito fuorilegge sono state, ormai quattro anni fa, le
voci sulla confessione a puntate data da Corinna Larsen, l’apparentemente
esausta ex amante tedesca dell’ex sovrano, al commissario Josè Manuel Villarejo,
poi arrestato per spionaggio. “Ogni volta che viaggia in Medio Oriente torna con
moltissimo denaro”, fu la prima frase della Larsen finita sui giornali. I realtà
a viaggiare era il suo avvocato. La seconda: “E al Palacio de la Zarzuela c’è
una macchina conta soldi”. Come a casa di un truffatore di serie B, gridarono
tutti, e quello è il Palazzo reale. Ritardando appena un po’ l’uscita di scena,
Juan Carlos alla fine s’è levato di torno. Sempre inseguito dal coro che dal 20
novembre 1975, morte di Franco, lo descrive come “intellettualmente non
all’altezza del ruolo”. Santiago Carrillo, segretario del partito comunista
spagnolo dal 1960 al 1982, uno di quelli che lo pensava non in grado e poi
ammise d’aver cambiato idea, tempo fa raccontò che Juan Carlos, già re, gli
confidò: “Per vent’anni ho dovuto far finta d’essere scemo, guarda amico mio che
non è mica facile”.
DAGONEWS il 5 agosto 2020. La fuga di quel mandrillone di Juan
Carlos dalla Spagna è solo l’ultimo atto di una vita sopra le righe, a tratti
epica, soprattutto sotto le lenzuola. Secondo lo storico Amadeo Martinez Ingles
il re emerito ha avuto nella sua “carriera” da scopone qualcosa come 5mila
partner sessuali, lasciando in giro per il mondo almeno 20 figli non
riconosciuti. Una storia che si perde nella leggenda: a partire dal suo breve
periodo in accademia militare, quando aveva 20 anni e avrebbe sedotto 332 donne
diverse. Durante un breve periodo all'accademia militare, poco più che ventenne,
Juan Carlos ha sedotto 332 donne diverse, secondo Ingles, la cui ricerca si è
basata su rapporti riservati compilati dalle spie dell'ex dittatore del paese,
il generale Franco. La sua media dei bei tempi farebbe impallidire Rocco
Siffredi: quattro a settimana. Un'altra biografa non autorizzata, la socialite
spagnola Pilar Eyre, in un libro del 2012 aveva ridimensionato la conta a 1500.
Una cifra che, secondo Ingles, sottostimerebbe (addirittura) l’attività pelvica
del toro di Spagna che sarebbe riuscito a giacere con 2.154 donne soltanto dal
1976 al 1994. Anche nel suo cosiddetto 'periodo invernale', dal 2005 al 2014,
cioè alla veneranda età di 67-76 anni, la libido del Re non ha accennato a
spegnersi: in quei 9 anni ha allettato altre 191 donne. Nel libro di Pilar Eyre
c’è anche un dettaglio piccante su Lady D: secondo la biografa del re, il
trombador Borbone ci avrebbe provato anche con la Principessa Diana. Era il 1986
e durante un viaggio in barca a vela avrebbe fatto delle avance “tattili”.
Insomma, ha allungato le mani, ma avrebbe anche in quel caso portato a casa il
risultato.
(Agenzia Nova il 5 agosto 2020) - Nelle indagini che vedono
coinvolto l'ex monarca spagnolo Juan Carlos, c'è un nome ricorrente e centrale
che ha giocato un ruolo fondamentale in tutta la vicenda: Corinna Larsen, 56
anni, ex amante del re emerito. Di lei si sa poco, ma secondo le cronache rosa
spagnole, i due si sarebbero conosciuti nel 2004, durante una caccia a La
Garganta, una tenuta a Ciudad Real di proprietà del Duca di Westminster, nel
2005, durante una gara di tiro a segno, o probabilmente nel 2006, in occasione
di una cena a Ditzingen, in Germania. Se, dunque, non è possibile stabilire una
data certa del loro primo incontro, la stampa specializzata concorda nel
ritenere che entrambi, nonostante i 26 anni di differenza, avrebbero avviato una
relazione amorosa clandestina. Entrambi, infatti, erano impegnati
sentimentalmente. Juan Carlos con la regina emerita Sofia, figlia del re Paolo
di Grecia e della regina Frederica, Corinna Larsen con il principe tedesco
Casimir zu Sayn-Wittgenstein, suo secondo marito. Corinna Larsen, figlia del
danese Finn Bönnig Larsen, che era stato il direttore europeo della compagnia
aerea brasiliana Varig, e della tedesca Ingrid Sauerland. Ingrid sarà proprio il
nome in codice che gli accompagnatori di La Zarzuela (la residenza della
famiglia reale) avrebbero dato a Corinna quando si stabilì a El Pardo, a soli 20
chilometri dal palazzo reale. A 25 anni aveva sposato l'uomo d'affari britannico
Philip Adkins, conosciuto quando lavorava per una multinazionale a Parigi e con
il quale ebbe una figlia, Anastassia. Secondo le cronache rosa spagnole,
Corinna, sin da giovanissima avrebbe cercato di frequentare i più importanti
circuiti dell'aristocrazia europea, riuscendo ad accedere a quel mondo
esclusivo. La storia d'amore tra Corinna e Juan Carlos, rimasta segreta per
diversi anni, venne alla luce in seguito alla pubblicazione ne 2012 di una foto
che li ritraeva insieme in Botswana durante una battuta di caccia immortalati
accanto ad un elefante appena abbattuto. Un'immagine che fece il giro del mondo
e che fece venire alla luce un relazione della quale si "mormorava" fino a qual
momento solamente negli ambienti più vicini alla nobiltà internazionale. Durante
quella cruciale giornata, Juan Carlos si ruppe un'anca in tre punti e, una volta
rientrato in Spagna per essere operato, fu costretto ad ammettere davanti alla
stampa di "aver commesso un errore" e che "non si sarebbe ripetuto". Quella
vicenda, tuttavia, segnò l'inizio della fine del regno di Juan Carlos che nel
2014 decise di abdicare, dopo 38 anni, in favore del figlio Felipe per tentare
di rilanciare l'immagine della Corona. Nel 2006 Corinna era stata era stata
ricevuta con gli onori militari all'aeroporto di Stoccarda, camminando dietro al
re e nello stesso anno, pochi mesi prima dell'apertura della gara d'appalto per
il contratto di costruzione del treno ad alta velocità per la Mecca, (poi vinto
da un consorzio di società spagnole), si era recata in Arabia Saudita in
compagnia del monarca e di Shahpari Zanganeh, commissario ed ex moglie del
trafficante d'armi saudita Adnan Khashoggi. Proprio i lavori di costruzione
della linea ad alta velocità sono al centro della principale inchiesta che vede
coinvolto il re emerito. Il 9 giugno scorso il quotidiano "El Pais" aveva
pubblicato un'esclusiva secondo la quale il giudice svizzero, Yves Bertossa,
aveva avviato un'indagine nei confronti di Juan Carlos in seguito al
ritrovamento studio dell'avvocato ginevrino Arturo Fisana di documenti che
proverebbero l'esistenza della fondazione panamense Lucum con un conto, il cui
primo beneficiario era Juan Carlos, aperto presso la banca svizzera Mirabaud,
sul quale era stato effettuato un versamento, l'8 agosto del 2008, di 64,8
milioni di euro frutto di una donazione della casa reale saudita. Prima della
chiusura del conto nel giugno 2012, tutto il denaro era stato trasferito ad un
altro deposito alle Bahamas a nome di Corinna Larsen, all'epoca amante del
sovrano. Il giudice starebbe indagando anche su altri due pagamenti milionari
sempre sul conto della banca Mirabaud. Il primo da 1,9 milioni di dollari che
Juan Carlos avrebbe portato in una valigia a casa dell'avvocato Fasana nel 2010,
al ritorno da un viaggio ad Abu Dhabi, il secondo da 4,6 milioni di euro versati
dallo Stato del Kuwait. Nel 2019, Corinna avrebbe inviato una lettera alla Casa
reale, rivelando che, due anni dopo la donazione da 64 milioni di euro, il re
Juan Carlos le avrebbe chiesto di restituire il denaro, sostenendo di aver
rifiutato per paura di essere accusata di reati finanziari. Un rifiuto che,
secondo l'ex amante, provocò una dura reazione da parte del re emerito che
l'avrebbe accusata di averlo derubato. Tuttavia, la lettera inviata alla Casa
reale non ottenne gli effetti sperati. Dal Palazzo reale, infatti, le avrebbero
risposto di essere pronti ad avviare un'azione legale se avesse coinvolto Felipe
VI nelle operazioni del padre e di "non essere a conoscenza" delle vicende a cui
alludeva.
Valeria Braghieri per “il Giornale” il 5 agosto 2020. «La
volontaria partenza di Juan Carlos non ha tanti precedenti. Forse
l'allontanamento più simile, nel passato, è stato quello di Carol di Romania,
negli anni Venti. Lasciò il trono al figlio Michele, che allora aveva pochi
anni, sotto la tutela della madre, la regina Elena, zia di Amedeo d'Aosta, per
fuggire con Magda Lupescu. Un giorno ci ripensò, tornò e si riprese il trono. Ma
su di lui non pendevano accuse». Distingue bene le grandi fughe dei reali di
oggi e di ieri, il professor Domenico Savini, storico delle famiglie Reali.
Perché hanno avute tutte ragioni o travagli differenti.
Per esempio? Che ragioni e che travagli?
«Penso alla fuga di Elisabetta d'Austria, Sissi. Un'eterna fuga
da se stessa. Fu quella che fece più scalpore, sia per l'epoca, sia per il
personaggio (erano gli anni '50 dell'800 ed era una donna che anticipava i
tempi). Dopo soli quattro anni di matrimonio, adducendo ad una salute «fragile»,
si imbarcò sullo yacht imperiale e salpò per Madeira, dove restò sei mesi. Da
allora, presenziò ai suoi doveri imperiali e matrimoniali il minimo
indispensabile. Comprò una casa a Corfù e da lì viaggiò, meglio, fuggì tutta la
vita».
In che senso fuggì da se stessa?
«Credo che fosse troppo giovane per il ruolo e avesse poca
attitudine per i doveri di corte. Cercò la libertà, e se stessa, tutta la vita.
E pagò un prezzo altissimo: fu uccisa da un anarchico in Svizzera».
Altre fughe simili?
«Beh, in un certo senso Lady D. Forse la sua stessa morte fu una
fuga dal ruolo che non reggeva, dalla famiglia reale, dalle restrizioni, da un
matrimonio fallito... e in un certo senso aprì la strada al figlio».
Al figlio?
«Anche quella dei duchi di Sussex, questa primavera, è stata una
fuga. Più per Harry che per Meghan. Lei in realtà è tornata alla sua vita, per
lui si è trattato di fuga».
Altri tipi?
«Quella clamorosa del Duca di Windsor, Edoardo VIII, per sposare
Wallis Simpson. Anche se forse, non c'erano solo ragioni sentimentali, la sua
malcelata simpatia per il nazismo fece il resto. Infatti come prima cosa, una
volta sposato, andò a salutare Hitler con la neo moglie».
E quella dei Savoia?
«Quella dei Savoia non fu una fuga, fu un obbligo. Ma io sono
indulgente, sia per l'amicizia che mi lega alla famiglia, sia per il profondo
rispetto nei confronti di Umberto. Sarebbe stato il miglior Re d'Italia e non si
sarebbe mai allontanato. Lo fece per obbedire al padre: i Savoia regnano uno
alla volta».
Lo scià di Persia?
«Quella fu una necessità, come ogni volta che si assiste a un
cambio di regime. Tra l'altro, quando iniziò la fuga, lui era malato terminale
di cancro e non c'era un Paese disposto ad accoglierlo perché era un personaggio
scomodo. Subito iniziavano proteste contro di lui, una volta, negli Usa, anche
sotto all'ospedale dov' era ricoverato. Ranieri di Monaco fu ospitale con lui. E
ovviamente l'Egitto, infatti morì al Cairo un anno e mezzo dopo».
I fuggitivi finiscono sempre in disgrazia?
«No. Penso a tanti membri delle famiglie imperiali russe che
riuscirono ad anticipare la Rivoluzione, e poi al principe Jusupov che partecipò
all'uccisione di Rasputin, lui riuscì ad andarsene portando via la sua
inestimabile collezione di quadri».
L'aneddoto più divertente?
«È legato alla fuga di Maharani di Baroda. Alla caduta del
marito, il Maraja di Baroda, fuggì dall'India sul suo jet privato con una cassa
piena di rubini e incredibili gioielli. A bordo c'erano lei, il pilota e l'aiuto
pilota che, la minacciarono con una pistola ordinandole di consegnare tutto:
diversamente l'avrebbero uccisa. In tutta risposta, lei estrasse dalla borsetta
un'altra pistola: Allora moriremo tutti e tre, fu la risposta. Visse tutta la
sua vita all'Hotel de Paris di Montecarlo».
La “fuga” di Juan Carlos I e l’indignazione della Spagna.
Iglesias: “Frode contro la giustizia”. Redazione su Il
Riformista il 4 Agosto 2020. L’ex re spagnolo Juan Carlos I ha annunciato che
lascerà la Spagna per vivere in un altro Paese, a seguito dello scandalo
finanziario che l’ha coinvolto. Il sito web della famiglia reale ha diffuso una
lettera in cui l’ex monarca si rivolge al figlio, re Felipe VI: “Guidato dal
convincimento di prestare il miglior servizio agli spagnoli, alle loro
istituzioni e a te come re, ti informo della mia meditata decisione di
trasferirmi, in questo periodo, fuori dalla Spagna. Una decisione che prendo con
molto dolore, ma con grande serenità”. Il re, aggiunge la nota, ha ringraziato
il padre per la decisione e gli ha espresso il proprio rispetto. L’ex re
emerito, in realtà, avrebbe però già lasciato il Paese. A renderlo noto è ‘El
Mundo’. Secondo le fonti consultate dal giornale di Madrid, la lettera in cui
l’ex monarca comunicava l’intenzione di farlo, sulla scia dello scandalo
finanziario che l’ha coinvolto, è stata inviata al figlio, re Felipe VI nelle
ultime ore. “La fuga all’estero” di Juan Carlos I di certo non è passata in
osservata. A commentare prontamente questa notizia ci ha pensato il
vicepresidente spagnolo e segretario generale di Podemos Pablo Iglesias, il
quale sul suo account ufficiale Twitter ha scritto: “E’ un atteggiamento indegno
di un ex Capo di Stato e lascia la monarchia in una posizione molto compromessa.
Per rispetto dei cittadini e della democrazia spagnola, Juan Carlos I dovrebbe
rispondere delle sue azioni in Spagna e davanti al suo popolo”. “È dovere di
quelli come noi in posizioni governative garantire istituzioni esemplari e
pulite”, aggiunge. E ancora: “Un governo democratico non può voltarsi dall’altra
parte, tanto meno giustificare comportamenti che minano la dignità di
un’istituzione chiave come il Capo dello Stato e che sono una frode contro la
giustizia”.
Roberto Pellegrino per “il Giornale” il 9 marzo 2020. L' occhio
vigile della Giustizia spagnola torna a radiografare la Casa reale dei Borboni,
a distanza di tre anni dall' assoluzione dell' Infanta Cristina, giudicata non
colpevole nello scandalo Noos. All' epoca la stampa s' interrogò su una
eventuale complicità del re emerito Juan Carlos I, nessun magistrato lo convocò
per fornire spiegazioni, dopo che, davanti al rischio di essere indagato, lui
tuonò: «Qui si sta superando il limite!». Non si pone un limite, invece, la
magistratura svizzera che lo indaga per un conto corrente di 100 milioni di
dollari, aperto a Ginevra e riconducibile all' ex sovrano. Dalle indagini si è
scoperto che la somma è una donazione versata nel 2007 alla Banca Mirabaud dal
ministero delle Finanze dell' Arabia Saudita su ordine della Casa reale di re
Abdullah, scomparso nel 2015. Beneficiario del conto corrente è la Lucum
Foundation di Panama, ma il titolare della fondazione sarebbe proprio Juan
Carlos, padre dell' attuale re di Spagna Felipe VI. La Giustizia elvetica,
esaminando i movimenti del conto, ha poi, scoperto un bonifico di 65 milioni di
dollari autorizzato dal conto e destinato alla nobildonna tedesca, Corinna
Larsen, coniugata Sayn-Wittgenstein, 55 anni, conosciuta dai media spagnoli come
l' ex amante di Juan Carlos. La donazione, secondo l' avvocato della Larsen,
incassata su un conto delle Bahamas, era un regalo del re emerito. Il
procuratore svizzero Yves Bertossa, però, sta indagando se questo denaro sia,
invece, una commissione pagata a Corinna per il suo ruolo di mediatrice nel
contratto, vinto da un consorzio spagnolo, per la costruzione del treno ad alta
velocità Mecca-Medina in Arabia Saudita. Secondo il quotidiano El País, la
considerevole transazione è stata rilevata durante un' indagine giudiziaria
negli uffici ginevrini degli avvocati Arturo Fasana, gestore di fondi, e Dante
Canonica, sospettati di avere agito come front per il monarca spagnolo in
pensione. Lo scorso dicembre, Corinna Larsen, i due avvocati Fasana e Canonica,
assieme a due rappresentanti della Banca Mirabaud, sono stati convocati e
ascoltati dal gip del Tribunale di Ginevra. L' avvocato della nobildonna tedesca
dichiarò che quel bonifico del 2012 non era altro che «un dono indesiderato» che
Juan Carlos destinò a Corinna e al di lei figlio, a cui l' ex sovrano si era
molto affezionato negli anni della lunga storia con la madre. Inoltre, il legale
dell' ex amante, negando ogni possibile relazione con il caso delle commissioni
dell' affare saudita, dichiarò al giudice che «la donazione era chiaramente
documentata come dono, e le società di servizi e le banche avevano eseguito le
formalità necessarie, applicando la dovuta diligenza sui fondi». Tuttavia, a
insospettire i magistrati svizzeri, sono state le dichiarazioni di Alvaro de
Orleans, cugino di Juan Carlos, che ha ammesso che la nobildonna tedesca e l'
allora re di Spagna, erano soliti recarsi in Arabia Saudita o altrove, su comuni
voli non di Stato al fine di evitare controlli ufficiali e commerciali. E per
non avere gli uomini dell' intelligence spagnola alle costole, mandando in tilt
il protocollo di sicurezza ufficiale. Nella Spagna che inizia a prestare
preoccupazione sull' aumento dei contagi del Covid-19, lo scandalo, esploso in
sordina, ora ha preso forza e sta distraendo gli spagnoli dal virus, e
riportando alla ribalta il conflitto tra monarchici e antimonarchici. Dal 1975
al 2013, al re, hanno perdonato innumerevoli amanti, ma sui soldi, Juan Carlos
potrebbe rovinarsi gli ultimi anni.
Elisabetta
Rosaspina per corriere.it l'11 marzo 2020. Juan Carlos di Borbone e il tesoro
nascosto: una nuova puntata della densa storia pubblica e personale dell’ex
sovrano, e ora re emerito di Spagna, agita le acque della politica e del
parlamento a Madrid e affila le armi degli indipendentisti repubblicani.
L’ultimo capitolo parte dai cento milioni di dollari che avrebbe depositato sul
conto di una banca privata svizzera, la Mirabaud, intestato alla Fondazione
Lucum, di cui risultava l’unico beneficiario. Secondo le rivelazioni della
stampa svizzera, La Tribune de Genève e Tages-Anzeiger, la somma proviene dal
Ministero delle Finanze dell’Arabia Saudita ed è stata giustificata come «un
dono senza contropartita». La Fundación Lucum, creata a Panama nel 2008, risulta
disciolta nel 2012, quando il generoso regalo di re Abdullah fu in buona parte
trasferito, sempre a titolo di donazione, su un altro conto, domiciliato alle
Bahamas e intestato a Corinna zu Sayn-Wittgenstein, 55 anni appena compiuti, una
non qualunque nobildonna tedesca, divorziata dal principe Johann Casimir e
chiacchierata per la sua «amicizia intima» con l’ottantaduenne Juan Carlos I. Di
più, considerata addirittura la causa della sua abdicazione nel 2014, in favore
del figlio, Felipe. E, ad aggiungere sorpresa alla sorpresa, un dettaglio non
irrilevante: il destinatario finale del denaro è Alexander, il figlio 18enne
della principessa. Come prevedibile, il mix di bonifici bancari esotici e
amicizie pericolose ha generato non pochi interrogativi tra gli spagnoli, dai
banchi del congresso ai giornali di gossip, fino ai meno indulgenti uffici
giudiziari. L’affaire sentimentale, ormai esaurito, era già stato arato
nell’ultimo decennio, in particolare dall’aprile del 2012 quando l’allora
sovrano in carica (e allora guida del Wwf spagnolo) si ruppe l’anca durante un
safari in Botswana. Il che fece emergere una foto di Juan Carlos in posa davanti
a un pachiderma fucilato e la presenza di Corinna nel seguito. Fin qui, erano
più che altro problemi di immagine e di armonia coniugale con la regina Sofia.
L’intreccio bancario, di interesse più generale, data però dello stesso anno.
Innanzitutto: perché l’8 agosto del 2008 le casse saudite hanno riversato nelle
tasche di Juan Carlos tutti quei petrodollari? Un’ipotesi (già esplorata e
archiviata a suo tempo dagli inquirenti) è che si sia trattato della
favoleggiata commissione illegale a margine di un contratto vinto da un
consorzio di imprese spagnole per la costruzione della linea ferroviaria ad alta
velocità tra la Medina e La Mecca. Ma il contratto è stato concluso nel 2011 e,
nel 2008, non era stata aperta nemmeno la gara d’appalto. E poi, nel caso, non
sarebbero state le imprese spagnole a essere favorite dal re per quell’accordo
da 6,7 miliardi di euro? L’immunità garantita al titolare del trono impedì
comunque di procedere, dopo che, segretamente intercettata, Corinna aveva alluso
a una tangente regale per l’alta velocità nel deserto. Così nel 2018 è stata
Corinna a finire sotto inchiesta per riciclaggio. Quindi, quali altri legami tra
le case reali saudita e borbonica potrebbero spiegare il ricco omaggio
personale? Uno scambio di cortesie dopo la concessione, nel 2007, della più alta
onorificenza spagnola, il titolo di cavaliere dell’Ordine del Toson d’oro, al re
saudita (scomparso nel 2015)? Il gesto dell’allora re di Spagna contribuì a
lustrare l’immagine del regime di Riyad, ma appare cronologicamente più logico
un nesso con la visita a Madrid di re Abdullah, nel 2008, sfociata in un accordo
di cooperazione economica e culturale tra i due Paesi. Una settimana dopo arrivò
il bonifico. Infine, perché 65 milioni sono stati intestati all’ultimogenito,
appena maggiorenne, di Corinna? È una dimostrazione «d’affetto per lei e per il
ragazzo» ha spiegato l’avvocato della principessa, Robin Rathmell alla stampa
elvetica. Il procuratore svizzero Yves Bertossa intende andare a fondo, mentre a
Madrid la sinistra di Unidas Podemos e il Psoe, insieme al governo, litigano
sull’apertura di una commissione investigativa sul tesoro nascosto del vecchio
re. Minacciato anche da Corinna che da Londra lo accusa di pressioni in
complicità con l’ex capo dell’intelligence, dopo la rottura, perché lei non
riveli segreti di Stato.
Elisabetta
Rosaspina per il “Corriere della Sera” il 16 marzo 2020. «In nome della
trasparenza e della dignità», il re di Spagna, Felipe VI, rompe i vincoli
finanziari con il padre, Juan Carlos di Borbone, divenuto re emerito dopo
l'abdicazione del 2014. E cerca di scongiurare, con un atto tragicamente simile
a un ripudio, il coinvolgimento della Casa reale nello scandalo
economico-sentimentale che sta travolgendo l' anziano monarca. Felipe ha deciso
di rinunciare all'intera eredità personale del padre ottantaduenne e di
tagliargli la pensione annua di 194 mila euro di denaro pubblico. La dura
risoluzione arriva con un comunicato della Zarzuela, dopo che la magistratura
svizzera ha aperto un' inchiesta su una eventuale tangente di cento milioni di
dollari, bonificati nel 2008 dal ministero delle Finanze dell' Arabia Saudita su
un conto elvetico intestato fino al 2012 alla Fondazione Lucum, di base a
Panama. E di cui risultava primo beneficiario Juan Carlos e, secondo, l'
inconsapevole Felipe. La causale parlava di «donazione», senza alcuna
contropartita, ma i giudici sospettano che possa esserci un nesso con la
costruzione della ferrovia ad alta velocità fra la Medina e La Mecca, un affare
da 6,7 miliardi concluso da un gruppo di imprese spagnole (però soltanto un anno
dopo), oppure con una onorificenza concessa da Juan Carlos a re Abdullah, allora
sul trono saudita, dopo la firma di un accordo di cooperazione economica e
culturale tra Madrid e Riad. Otto anni fa, sempre sotto forma di donazione, la
somma era passata alla principessa (divorziata) tedesca Corinna zu
Sayn-Wittgenstein, «amica intima» dell' allora sovrano in carica. La Casa reale
ha informato che re Felipe VI ha scoperto di essere il secondo intestatario
della fondazione dalla lettera di uno studio di avvocati britannici di Corinna,
Kobre&Kim, nel marzo 2019, e che ha risposto rigettando qualunque trattativa.
Nella nota si sottolinea pure che «Don Juan Carlos ha chiesto alla Casa reale di
rendere pubblico di non aver mai informato il re dell' esistenza delle due
fondazioni». Già, perché secondo il quotidiano El Pais il re emerito figura come
terzo beneficiario anche della Fondazione Zagatka, di proprietà di Álvaro de
Orleans-Borbón, creata in Liechtenstein addirittura prima, nel 2003. In questo
caso il re padre avrebbe beneficiato di voli privati. Sullo sfondo, ma non
tanto, ci sono le vicende sentimentali dell' inquieto Juan Carlos con la
cinquantenne nobildonna che lo accompagnava nell' aprile del 2012 nel
disgraziato safari in Botswana durante il quale si ruppe l' anca e si fece
fotografare accanto a un elefante ucciso. La storia finì (male) e ora Felipe VI
prende le distanze dal padre e dai suoi affari off-shore.
Spagna, re
Felipe rompe con il padre Juan Carlos e rinuncia all'eredità.
Con un
comunicato ufficiale la casa reale annuncia che il re emerito cessa di percepire
il fondo stanziato per lui nel bilancio della casa reale "che potrebbe non
essere conforme alla legalità o ai criteri di rettitudine e integrità che
regolano la sua attività istituzionale e privata". La Repubblica il 15 marzo
2020. Il re di Spagna Felipe VI ha deciso di rinunciare all'eredità di suo padre
Juan Carlos. Ne dà notizia El País online citando un comunicato della casa reale
in cui si annuncia che il re emerito cessa di percepire il fondo stanziato per
lui nel bilancio della casa reale. Felipe rinuncia a qualsiasi "attività,
investimento o struttura finanziaria la cui origine, caratteristiche o finalità
potrebbe non essere conforme alla legalità o ai criteri di rettitudine e
integrità che regolano la sua attività istituzionale e privata". Felipe VI
"vuole che sia noto pubblicamente che Sua Maestà il re Juan Carlos è consapevole
della sua decisione". La casa reale informa inoltre che il re emerito non
riceverà più la dotazione di bilancio che concede annualmente e che negli ultimi
anni ha raggiunto 194.232 euro all'anno. Questa decisione arriva dopo l'avvio da
parte della Procura dell'Anticorruzione di un'indagine su presunti 100 milioni
di euro che Juan Carlos I avrebbe ricevuto su un conto svizzero per conto di una
fondazione panamense dalla monarchia saudita. Ora Felipe VI prende le distanze.
Nel comunicato si puntualizza infatti che Juan Carlos è a conoscenza che "le
summenzionate Fondazioni non hanno mai fornito informazioni" a suo figlio.
·
Quei razzisti come gli Svizzeri.
Svolta in
Svizzera: «L’omofobia sanzionata come il razzismo».
Il Dubbio il 9 febbraio 2020. Exit poll: 62% a favore della norma contro le
discriminazioni per l’orientamento sessuale. L’omofobia sarà sanzionata come il
razzismo. Secondo la prima proiezione dell’istituto gfs.bern, gli elettori
svizzeri dovrebbero accogliere il divieto della discriminazione basata
sull’orientamento sessuale con una quota del 62%. I primi risultati confermano
il trend: Glarona e Nidvaldo hanno accettato il testo entrambi con il 51,3%,
così come Argovia (56,4%), Lucerna (59,6%) e il canton Grigioni (58,6%). Stando
ai primi risultati parziali, oltre tre ginevrini su quattro hanno votato a
favore, mentre a Zurigo e in Vallese la quota dovrebbe essere superiore al 60%.
Nel canton Vaud la percentuale – dopo lo spoglio di tre quarti delle schede – si
attesta oltre l’80%. Nel dicembre 2018 il Parlamento ha votato per estendere la
norma antirazzismo contenuta nel Codice penale (articolo 261) che mira a vietare
espressamente le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale per
proteggere la comunità omosessuale, bisessuale, transgender o intersessuale.
DANIELE
MASTROGIACOMO per repubblica.it il 5 marzo 2020. L'ha scoperto per caso. In
mezzo alle cartacce ammassate alla rinfusa in un sotterraneo di una vecchia
banca ormai in disuso. Rovistando si è soffermato su documento dal titolo
anomalo, almeno arcaico: "Congresso della Nazione Argentina". Si è incuriosito e
ha iniziato a sfogliarlo. Pedro Filippuzzi, investigatore privato, ha capito
subito che era qualcosa di grosso: si era imbattuto sulla rete di 12mila nazisti
che tra il 1941 e il 1943, prima della caduta del Terzo Reich, avevano preso il
largo e si erano rifugiati in Argentina. La lunga lista di nomi indicava anche
le somme che si erano portati dietro e che erano il bottino sottratto ai milioni
di ebrei saccheggiati dei loro averi. La lista era nota. Ma nel 1944 il governo
del dittatore filo tedesco Edelmiro Farrel aveva disciolto la Commissione
incaricata di analizzarla e ordinato la distruzione del documento. Tutti
pensavano che la questione si fosse chiusa e con il macero anche questa
importante prova fosse sparita dalla circolazione. Non sapevano che qualcuno ne
aveva fatto una copia rimasta poi per 80 anni seppellita nei sotterranei del
vecchio istituto. Filippuzzi ha contattato il Centro Simon Wiesenthal, famoso
per la sua caccia ai nazisti sopravvissuti al dissesto del regime di Hitler, che
a sua volta si è rivolto al Credit Suisse reclamando la restituzione dei beni
trafugati. Il Centro ha potuto anche ricostruire la rotta seguita da questo
tesoro che secondo diverse ipotesi è servito a finanziare le attività legali
messe in piedi in Argentina dai nazisti fuggiaschi. Parte di questi soldi
sarebbero poi rientrati in Europa tramite la banca svizzera Schweizerische
Kreditanstalt, oggi diventato appunto Credit Suisse. "Questi conti", osserva
Shimon Samuels, direttore delle Relazioni internazionali del Centro Simon
Wiesenthal, "includevano diverse imprese tedesche come la IG Farben, fornitore
del gas Zyklon-B, utilizzato nelle camere di sterminio, e organismi finanziari
come il Banco Tedesco Transatlantico e il Banco Tedesco dell'America del Sud.
Banche che, apparentemente, servirono per realizzare delle transazioni naziste
in Svizzera". La presenza di una folta comunità nazista a Buenos Aires era cosa
nota negli anni successivi alla fine della Seconda guerra mondiale. Si calcolava
che fosse formata da 1.400 persone, sostenute da 12mila simpatizzanti e da altri
8mila militanti di diverse organizzazioni locali. I governi dell'epoca facevano
finta di niente e lasciavano agire i nuovi arrivati come parte della massa di
immigrati già giunti, per sfuggire al conflitto e al terrore hitleriano, anni
prima. Ma una retata della polizia nella sede dell'Unione tedesca delle
corporazioni, una facciata per le migliaia di immigrati nazisti del Terzo Reich,
portò al sequestro della lista che fu consegnata al Parlamento argentino. "Non
tutti i 12mila indicati nel documento", precisa Ariel Gelblung, direttore per
l'America Latina del Wiesenthal, "erano persone che usarono la triangolazione
per portare via il denaro rubato dai nazisti. Ma all'interno della lista c'è
sicuramente chi la utilizzò". Far sparire quel denaro era vitale per Hitler. Non
c'era la possibilità di cambiare la moneta tedesca con i dollari. Trasferirla in
Argentina consentiva di farlo. Veniva scambiata con il foglio verde e da qui
rientrava in Europa. Secondo Gelblung è impossibile stabilire l'ammontare del
tesoro depositato nei conti sospetti. Ma è certo che quella ingente somma fu
usata come capitale iniziale dal Credit Suisse sorto sulle ceneri del
Schweizerische Kreditanstalt.
Il magnate
svizzero ultimo padrone dell’Eternit: «Provo odio per gli italiani, vivete in
uno Stato fallito».
Pubblicato
venerdì, 24 gennaio 2020 su Corriere.it da Floriana Rullo. Il processo a
Schmidheiny si aprirà il 27 novembre: dovrà rispondere di omicidio volontario
per la morte di 392 persone. È attesa per oggi, venerdì, la pronuncia sul
processo Eternit bis con cui il tribunale di Vercelli dovrà stabilire se Stephan
Schmidheiny debba o meno essere rinviato a giudizio. Va deciso anche il capo
d’accusa per l’imprenditore svizzero, ultimo proprietario dell’Eternit di Casale
Monferrato: omicidio colposo o doloso per la morte di 392 persone. Nel frattempo
fanno rumore le parole pronunciate dallo stesso Schmidheiny a dicembre al
giornale elvetico Nzz am Sonntag, riprese dal quindicinale «Area Unia» di
Lugano: «Quando oggi penso all’Italia provo solo compassione per tutte le
persone buone e oneste che sono costrette a vivere in questo Stato fallito. Non
ho intenzione di vedere una prigione italiana dall’interno. Alla fine il mio
comportamento sarà giudicato correttamente e un giorno verrò assolto». Ha poi
aggiunto: «Ho capito che mi sarei dovuto occupare della mia igiene mentale per
non lasciarmi abbattere da tutti questi incredibili attacchi. Mi sono reso conto
di provare dentro di me un odio per gli italiani e che io sono il solo a
soffrire per questo». Tornando al giudizio: il gup Fabrizio Filice dovrà dunque
decidere se mandare a processo Schmidheiny per omicidio doloso, così come
chiesto dai pm, cambiare il capo d’imputazione in colposo, oppure se
proscioglierlo, come invocato dai difensori Astolfo Di Amato e Guido Carlo
Alleva. Una decisione fondamentale per il futuro dell’inchiesta Eternit, e i
suoi 392 morti. Se il capo d’accusa contestato a Schmidheiny dovesse essere
quello per omicidio volontario, come richiesto dalla Procura, il processo si
svolgerà in Corte d’Assise, a Novara, e i familiari delle vittime di amianto
avranno ancora qualche speranza di vedere condannato l’imprenditore. Se invece
l’ex patron del gruppo industriale sarà accusato di omicidio colposo, il
processo si svolgerà davanti al giudice monocratico di Vercelli, e a quel punto
le possibilità che i reati vadano in prescrizione sono estremamente elevate.
Silvana
Mossano per “la Stampa” il 24 gennaio 2020. «Dentro di me provo odio per gli
italiani e io sono il solo a soffrire per questo. Non ho intenzione di vedere
una prigione italiana dall' interno». Sono dichiarazioni di Stephan Schmidheiny,
ultimo responsabile in vita della gestione degli stabilimenti Eternit,
rilasciate di recente alla testata «Nzz am Sonntag» in Svizzera, dove risiede.
Ampi virgolettati dell' intervista sono stati ripresi dal quindicinale «Area
Unia» di Lugano e rimbalzate sui social, alla vigilia della decisione del gup di
Vercelli, prevista per oggi, in merito alla richiesta di rinvio a giudizio dell'
imprenditore per l' omicidio volontario di 392 casalesi morti a causa dell'
amianto. Schmidheiny è l' unico imputato del cosiddetto «Eternit Bis». Non è il
primo procedimento penale a suo carico; era già stato incriminato dal pool della
procura torinese (Raffaele Guariniello, Gianfranco Colace e Sara Panelli) nel
maxiprocesso Eternit Uno: a Torino in primo e in secondo grado (con la condanna
a 18 anni per disastro doloso ambientale) e poi in Cassazione (con la
prescrizione del 2014). Successivamente, la stessa procura di Torino lo aveva
richiamato sul banco degli imputati, ma con una contestazione diversa: l'
omicidio doloso di oltre 400 persone. Il gup Federica Bompieri, però, aveva poi
riqualificato il reato da omicidio doloso a colposo; questo ha comportato uno
spacchettamento del fascicolo originario in quattro filoni, destinati a procure
diverse per competenza territoriale: a Torino è rimasto lo spezzone per due
morti di Cavagnolo (Schmidheiny è già stato condannato a 4 anni), a Napoli è
andato quello per otto morti di Bagnoli, a Reggio Emilia per alcuni morti di
Rubiera e a Vercelli per 392 vittime casalesi. Ha ricordato il pm Colace,
applicato a Vercelli e che affianca il collega Fabrizio Alvino: «Sessantadue
sono ex lavoratori dello stabilimento, ma trecento sono cittadini semplicemente
residenti». Con la fabbrica non hanno mai avuto a che fare, ma si sono ammalati
e sono morti. «A Casale ci dovrebbe essere una terza lapide - ha detto il pm
Alvino -: oltre a quelle della Prima e della Seconda Guerra mondiale, anche per
i morti di amianto». I circa 400 elencati nel capo d' accusa sono un campione in
difetto; dagli anni Cinquanta a oggi se ne contano non meno di 2500 e «la strage
non è finita - ha sottolineato Colace -: continua con una cinquantina di nuovi
casi di mesotelioma all' anno». Il mesotelioma è il cancro causato dall'
amianto: gli scienziati come Cesare Maltoni e Irvin Selikoff lo dicevano già
negli anni Sessanta. Oggi, dunque, è attesa la decisione del gup Fabrizio Filice
sull' Eternit Bis: rinvio a giudizio di Schmidheiny per omicidio doloso (come
chiesto dai pm) o riqualificato in colposo, oppure proscioglimento, come
invocato dai difensori Astolfo Di Amato e Guido Carlo Alleva che hanno definito
una «inammissibile tortura di Stato ripetere un processo nei confronti di una
persona per gli stessi fatti». I difensori parlano di tortura e Schmidheiny in
persona, nell' intervista alla testata svizzera, dichiara: «Ritengo che alla
fine il mio comportamento sarà giudicato correttamente e un giorno verrò
assolto». Ma, intanto, definisce il suo coinvolgimento processuale «pazzesco: 40
anni dopo si viene accusati di omicidi di massa e perseguitati per decenni». Un
carico emotivo che reputa insopportabile, tanto più che si definisce «una
persona piuttosto sensibile»; pertanto «ho dovuto occuparmi della mia igiene
mentale - spiega - per non lasciarmi abbattere da tutti questi incredibili
attacchi». Riferisce di essersi dedicato «a esercizi di meditazione quotidiani»
e di aver appunto «provato odio per gli italiani». E, ancora: «Quando oggi penso
all' Italia, provo solo compassione per tutte le persone buone e oneste che sono
costrette a vivere in questo Stato fallito». «La tortura - replica indignata
Assunta Prato, una delle molte casalesi vedove dell' amianto - è quella di
migliaia di persone che vivono nella paura di una tosse che non passa e della
diagnosi di una malattia che ancora non si può curare, oltre che nel dolore per
il lutto di tante persone care». Difficile alleggerire le angosce con
«quotidiani esercizi di meditazione». Potrebbe essere lenitivo e in parte
riparatore il sincero pentimento dell' imputato, il risarcimento per le
bonifiche, per i cittadini e per la ricerca di una cura. «Anche Schmidheiny è un
essere umano e può cambiare. Purché cambi. Per davvero», conclude Assunta Prato.
Mario Giordano per la Verità il 25 gennaio 2020. Dice che prova
per noi «compassione». Si definisce «perseguitato» e «torturato». E, con grande
rispetto per la nostra giustizia, annuncia, in caso di condanna, la propria
latitanza dicendo che lui comunque non ha «intenzione di vedere una prigione
italiana dall' interno». E di fronte a tutto ciò che cosa è successo? Nulla.
Ecco, per l' appunto: il problema è proprio quello. Di fronte a parole così
offensive per il nostro Paese non è successo nulla. Nulla di nulla. Dentro i
palazzi dell' italico potere non si è sollevato nient' altro che non sia un
lungo, incredibile, totale e assoluto silenzio. Lui si chiama Stephan
Schmidheiny. Il giornale cui ha rilasciato l' intervista è Nzz am Sonntag.
Cognome e testate che sembrano un codice fiscale, roba da scioglilingua e
attentato alle corde vocali. Ma per quanto possa sembrare strano la realtà è
ancor peggio dei nomi. Schmivattelapesca, infatti, è un manager importante,
ultimo responsabile in vita della gestione degli impianti Eternit, quelli che
con l' amianto hanno provocato una strage a Casale Monferrato, dolore, lutti,
2500 morti, e vittime anche nel resto d' Italia. Il magnate svizzero è accusato
della morte di 392 di loro. Ha già subito un processo (condannato in primo e
secondo grado a 18 anni, è stato salvato dalla prescrizione) ed è alla sbarra in
vari tribunali d' Italia, da Napoli a Vercelli, da Torino a Reggio Emilia per
rispondere di un massacro che, come ricordava La Stampa ieri, non è affatto
finito. Ogni anno, infatti, circa 50 persone vengono ancora colpite dal
mesotelioma, il cancro dell' amianto. Ora, scusate, ma a me pare evidente una
cosa: al di là delle responsabilità giuridiche che vanno accertate nei
tribunali, chi ha avuto ruoli di primo piano in un' azienda che ha provocato
tragedie simili, avrebbe il dovere di tacere. Semplicemente tacere. Dovrebbe
avere rispetto per le vittime. Per i familiari, che sono, loro sì davvero
perseguitati e torturati. Lo dovrebbe avere in ogni caso, ma tanto più se, come
in questa occasione, è uno straniero, ospite nel nostro Paese. Uno che è stato
accolto e beneficato con incarichi importanti e che ha ricambiato, secondo le
accuse, con un devasto. Ecco: uno così dovrebbe tacere. O, al massimo, parlare
per chiedere scusa. Invece Schmid eccetera non tace. Non chiede affatto perdono.
Fa di peggio: insulta. Deride. Denigra. Offende. E già tutto ciò è piuttosto
grave, non vi pare? Ma non è solo questo. Se fosse solo questo, come dicevamo,
lo spiacevole episodio avrebbe potuto essere liquidato rapidamente, archiviato
nella categoria «minchiate», sottocategoria: cafonata al sapor di emmenthal o
dichiarazione scema da miliardario senza cuore. E invece, come dicevamo, c' è di
più. C' è che tutte queste parole sono cadute nel vuoto. Sono state accolte da
un silenzio assoluto. Come mai? Possiamo avanzare due ipotesi: o gli interi
uffici stampa degli uomini di governo sono piombati in catalessi
contemporaneamente, mentre i collaboratori dei ministri giocavano a tresette
all' osteria e le segreterie organizzavano la prossima gita alle Seychelles;
oppure la notizia è regolarmente arrivata sui tavoli che contano ma nessuno (né
presidenza del Consiglio, né Farnesina, né alcuna altra autorità esistente e
vagamente competenze di difesa degli italiani) ha pensato che fosse il caso di
dare una risposta. E questo ci sembra, per assurdo, ancora più grave del fatto
in sé. Possibile, infatti, che tra una polemica sul citofono e una sulle
sardine, fra un dibattito sul futuro dei 5 stelle e sul nuovo nome del Pd, non
si sia trovato il tempo per chiedere un po' di rispetto per l' Italia? Possibile
che il nostro governo, nel tentativo di ridurre le tasse, in via elettorale e
sperimentale, abbia a tal punto perso la lucidità da non capire quanto è
offensiva l' arroganza di un signore (signore: si fa per dire) che sta
insultando i nostri morti? Possibile che nessuno abbia sollevato istintivamente
un sopracciglio? O, meglio ancora, un telefono? Possibile che nessuno abbia
sentito il dovere di difendere le vittime dell' Eternit? E i loro familiari? E
il nostro Paese? Possibile che nessuno sia sentito in dovere di dettare almeno
una replica alle agenzie? Possibile che nessuno abbia sentito l' urgenza di dire
al quel figlio della cioccolata al latte che noi italiani lo possiamo anche dire
che il nostro Stato è fallito, ma lui no? Che lui, svizzero accusato di strage
di italiani, non deve permettersi? Altrimenti, come minimo, dichiariamo guerra
ad Heidi? Negli altri Paesi non succede così. La Francia ha richiamato l'
ambasciatore italiano per un incontro fra due nostri leader politici e i gilet
gialli. La Tunisia ha protestato formalmente perché un ex ministro italiano ha
scampanellato a un suo concittadino (pregiudicato) in quel di Bologna. La
Turchia un giorno ha aperto un caso diplomatico perché un suo giocatore di
calcio, sbarcato in Irlanda, era stato intervistato per scherzo con uno
spazzolone al posto del microfono. Noi invece permettiamo che uno svizzero
insulti i giudici italiani, i morti italiani e i cittadini italiani, senza
levare, non dico una protesta formale tramite ambasciata, ma nemmeno un gemito
di disappunto. Niente di niente. Soltanto silenzio. Poi non ci stupiamo se, come
è successo a Berlino, nelle foto ufficiali finiamo in seconda fila, nell'
angolo. Tra un po' ci metteranno direttamente sotto i loro piedi. E noi zitti,
come ora, a farci calpestare.
·
Quei razzisti come i Francesi.
Charles De Gaulle, 50 anni dopo: le sue sfide per l’Europa
delle Patrie e il presidenzialismo. Mario Bozzi
Sentieri venerdì 6 Novembre 2020 su Il Secolo d'Italia. «Il gollismo era la
verticalità», ha dichiarato Alain de Benoist, intervistato in occasione degli
anniversari che invitano al ricordo di Charles de Gaulle (nato il 22 novembre
1890 e scomparso il 9 novembre 1970). La “verticalità” di de Gaulle sta
certamente nel suo carisma, nella sua “visione lunga”, nell’idea di una
“monarchia repubblicana” che ne ha caratterizzato l’azione politica: pragmatica
e innovativa, “sistema di pensiero, di volontà e di azione” – come egli
sintetizzò nel 1968, fino ad arrivare alla paradossale definizione di Michel
Onfray, intellettuale libertario e anticapitalista, che, nel suo recente libro
(Vies Parallèles), definisce de Gaulle come «un uomo di sinistra sostenuto dalla
destra».
De Gaulle e l’orgoglio nazionale. La verticalità e la
trasversalità gollista, il cui valore rimane incorrotto e potrebbe ispirare
quanti, oggi, volessero iniziare ad andare – da destra – oltre le sterili
contingenze, può essere sinteticamente fissato in tre idee-forza: l’orgoglio
nazionale, il presidenzialismo, l’idea partecipativa. «De Gaulle – scrisse André
Malraux (Les chênes qu’on abat, 1971) – è ossessionato dalla Francia come Lenin
lo è stato dal proletariato, come Mao lo è della Cina e come Nehru, forse, lo fu
dell’India. La Francia è sempre stata per lui come la Chiesa per quelli che la
difendono o la attaccano». Questa “ossessione” lo portò a seguire, nel lungo
dopoguerra europeo, un’idea integrale di indipendenza nazionale, realizzata con
il graduale sganciamento del suo Paese dalla Nato, pienamente realizzato nel
1966; con l’entrata nel “club atomico” (il primo test nucleare francese è del
febbraio 1960) e la creazione della cosiddetta “force de frappe” , forza d’urto
militare e nucleare; con la spregiudicata politica estera che portò la Francia
al riconoscimento della Cina di Mao (1964), al dialogo con l’Urss (1966) e alla
lotta al dollaro, con la richiesta di sostituirlo con l’oro, come base di
pagamento internazionale. Fino all’idea dell’Europa delle patrie, un’Europa
unita su base confederale, rispettosa della sovranità degli Stati aderenti,
coordinata da un Consiglio dei capi di governo, che – scriveva de Gaulle – dovrà
«unificare la politica estera, economica, culturale e di difesa» , elevando il
Vecchio Continente a terza forza tra Stati Uniti ed Unione Sovietica.
La riforma costituzionale in chiave presidenzialista. Sul piano
interno, con la riforma costituzionale, in chiave presidenzialista, del 1958
(approvata, attraverso referendum dal 79,50 per cento dei votanti) e l’
elezione di de Gaulle, nel gennaio 1959, a Presidente della Repubblica, si
inaugura per la Francia la Quinta Repubblica ed un lungo periodo di stabilità
politica e di crescita economica e sociale. Così lo stesso de Gaulle (in Memorie
della speranza, 1970) sintetizzerà la sua idea presidenzialista: «Da molto tempo
sono convinto che il presidente della Repubblica debba essere eletto mediante il
voto popolare. Designato – unico fra tutti – dalla massa dei francesi, potrebbe
essere davvero, in virtù di questa nomina, l’uomo del Paese, investito agli
occhi del popolo e ai propri dell’immensa responsabilità che i testi stessi gli
attribuiscono. Inoltre, è chiaro, dovrebbe avere la volontà e la capacità di
assumersi l’onere della carica. E questo evidentemente, la legge non lo può
garantire …».
De Gaulle e il nuovo modello sociale. E poi c’è l’idea
partecipativa , coltivata da tempo ed immaginata come risposta alla “malattia
morale”, che segna il capitalismo, relegando il lavoratore al ruolo di strumento
o di ingranaggio del sistema produttivo. Nel condannare gli eccessi del laissez
fare, laissez passer da una parte e della tirannia comunista dall’altra, de
Gaulle è spinto a guardare a un nuovo modello sociale, nel quale il lavoratore
partecipi direttamente ai risultati dell’impresa, con ciò fruendo «della dignità
di essere, per la parte che gli compete, responsabile del progresso dell’opera
collettiva da cui dipende il suo destino».
La compartecipazione dei lavoratori ai profitti. L’auspicio di de
Gaulle trova una prima concreta realizzazione nel gennaio 1959, con un’ordinanza
che apre la compartecipazione dei lavoratori ai profitti delle industrie,
incentivati dalle esenzioni fiscali assicurate dallo Stato, sia nel caso che i
contratti tra datori di lavoro e dipendenti comportino un prelievo sui profitti
generali, sia che sia stabilita una partecipazione al capitale e
all’autofinanziamento, sia che venga costituita una società in cui ogni
dipendente, a qualsiasi livello, sia azionista. In questa sua azione
riformatrice de Gaulle deve però fare i conti con l’opposizione del mondo
imprenditoriale e dei sindacati, che frenano l’attuazione del progetto.
L’auspicato progetto partecipativo, a cui egli dedica gli ultimi anni della sua
presidenza, tramonta con il suo ritiro definitivo a vita privata dopo il
referendum popolare del 27 aprile 1969, che lo vede sconfitto.
Le tre idee forza di De Gaulle. Europa delle patrie,
Presidenzialismo, Partecipazione sociale: tre idee forza che ci riconsegnano, a
cinquant’anni dalla scomparsa di de Gaulle, una visione di Politica ambiziosa e
sfidante, ancora oggi, in tempi di debolezza degli usuali sistemi di
rappresentanza, di “liquidità” sociale e di crisi delle vecchie appartenenze
ideologiche. A mancare sono gli uomini “alla de Gaulle”, in grado di dare forma
alle idee, trasformandole in azioni.
De Gaulle e
la grande destra che non c'è.
Nel suo nuovo
saggio Michel Onfray tesse le lodi del generale rispetto a Mitterand. Mauro
Zanon, Martedì 03/11/2020 su Il Giornale. Pochi giorni prima che morisse, Michel
Onfray promise al suo professore di filosofia greca e romana, Lucien Jerphagnon,
di scrivere un libro su Charles de Gaulle. Memore dei corsi e della
corrispondenza avuta negli anni Ottanta con l'amato insegnante, il filosofo
francese ha mantenuto quella promessa con Vies Parallèles (Robert Laffont), le
biografie incrociate delle due figure più importanti della Quinta Repubblica:
Charles de Gaulle, appunto, e François Mitterrand. Il centododicesimo libro di
questo philosophe enraciné, come lo definisce il Figaro Magazine, è una
controstoria del gollismo e del mitterrandismo e insieme un confronto tra il
Generale e il suo eterno rivale, da cui il primo esce sublimato e il secondo
estremamente rimpicciolito. «Dopo la morte del generale de Gaulle è finita la
grandeur. Il Generale aveva detto che il popolo aveva scelto di essere un
piccolo popolo, ed ebbe dunque dei piccoli governanti. Il più piccolo di questi
piccoli governanti si impegnò a distruggere tutto ciò che aveva fatto il
generale de Gaulle; fu la sua unica costante: rendere piccolo ciò che era stato
grande, piccolo come lui. Si chiamava François Mitterrand», scrive Onfray negli
estratti pubblicati sabato dal Figaro Magazine. E ancora: «L'opposizione tra
Charles de Gaulle e François Mitterrand mette schiena contro schiena un uomo che
lotta contro il crollo di una civiltà e un individuo a cui non importa che la
civiltà scompaia, gli basta poter vivere tra le rovine alla maniera di un
satrapo. Il primo sacrifica la propria vita per salvare la Francia; il secondo
sacrifica la Francia per salvare la propria vita. Uno vuole una Francia forte,
grande e potente, capace di ispirare l'Europa degli Stati; l'altro la vuole
debole, piccola e impotente, fagocitata dall'Europa del capitalismo. De Gaulle è
un senatore romano; Mitterrand un cittadino di Capua». Lo scorso 18 giugno, in
occasione degli ottant'anni del primo appello del Generale sulle onde radio
della BBC, Onfray ha pubblicato un video che ha fatto molto rumore negli
ambienti goscisti. Per questa affermazione: «De Gaulle era un uomo di sinistra
sostenuto dalla destra, Mitterrand era un uomo di destra sostenuto dalla
sinistra». Ma la gauche non aveva ancora letto le pagine del suo futuro libro.
«De Gaulle sa di essere e vuole essere al servizio della Francia fin dagli anni
della sua giovinezza, immaginandosi già in veste di generale che caccia gli
invasori tedeschi fuori dalla Francia; Mitterrand vuole una Francia al suo
servizio e, per raggiungere il potere supremo, farà intrighi politici con tutti,
con i comunisti, con l'estrema destra e poi con i socialisti, con i bigotti e in
seguito con i laicisti, con i sostenitori dell'Algeria francese e subito dopo
con i fautori della decolonizzazione, ma mai con i gollisti, che, ad ogni modo,
non lo avrebbero mai voluto al loro fianco», afferma Onfray. La grandezza di De
Gaulle, secondo il filosofo originario di Argentan, in Normandia, stava nel
fatto che sapeva di essere più piccolo della Francia, perché la Francia è al di
sopra di tutto: «Nasce nella notte dei tempi e la vuole eterna, non è senza
passato e nemmeno senza futuro, ma la vuole senza nascita e senza morte, è lì da
sempre e lo sarà per sempre». Mitterrand, invece, «si credeva più grande di ogni
cosa»: compresa la Francia. Il Generale era l'homme du destin, Mitterrand, tuona
Onfray, un piccolo uomo interessato alla «carriera». Il primo «ha fatto la
Francia», il secondo «ha ampiamente contribuito a distruggerla». Secondo una
certa narrazione, quella di Mitterrand fu la sola vera «présidence littéraire».
Ma Onfray, in Vies Parallèles, abbatte anche questa certezza della sinistra
francese. In poche righe: «De Gaulle leggeva Peguy, Bergson, Nietzsche;
Mitterrand leggeva Paul Guimard e Erik Orsenna. De Gaulle è nella Pléiade di
Gallimard; i libri di Mitterrand si acquistano in sconto dai bouqinistes per uno
o due euro». E soprattutto: «De Gaulle ha avuto Malraux; Mitterrand ha avuto
Jack Lang». È spietato Onfray contro l'idolo della gauche, perché se c'è uno che
ha condannato a morte il socialismo francese, sottolinea il filosofo, questo è
proprio Mitterrand. Nel 1983, con la «svolta del rigore», ha aperto la strada al
trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, considerata da Onfray la data di
morte della Francia: la fine della sua sovranità. «Cosa avrebbe fatto De
Gaulle?», è la domanda che oggi tormenta Onfray, pur nella certezza che l'Europa
gollista è un'Europa al servizio delle nazioni e non un gruppo di nazioni a
servizio dell'Europa. Mitterrand avrebbe potuto essere l'ultimo grande
presidente, secondo Onfray, ma è stato il primo dei piccoli. Come quando attaccò
Freud ne Le Crépuscule d'une idole. L'Affabulation freudienne, il filosofo
normanno si farà molti nuovi nemici nell'intellighenzia. A gauche dicono che è
troppo a destra, a droite che è troppo a sinistra. Lui, Michel Onfray, dice di
non essere né l'uno né l'altro, ma soltanto «fedele alla Francia».
Due virus letali scuotono la Francia: il Covid e il
terrorismo. Dopo la decapitazione nella scuola, la
strage di Nizza. Mentre la pandemia sembra fuori controllo. Ora il Paese dovrà
dimostrare di saper far fronte a una pericolosa sovrapposizione di emergenze.
Anna Bonalume su L'Espresso il 29 ottobre 2020. Di nuovo confinata, di nuovo
sotto attacco. Due settimane dopo lo shock della decapitazione di Samuel Paty,
un altro attentato è avvenuto a Nizza. All’interno della Cattedrale Notre Dame
de l’Assomption una donna è stata decapitata, un uomo pugnalato, mentre la terza
vittima sarebbe stata uccisa in un locale davanti alla basilica, dove si era
rifugiata. Il colpevole, che avrebbe ripetutamente gridato “Allah Akbar”, è
stato colpito e ferito. La Procura nazionale antiterrorismo (PNAT) ha
annunciato di aver aperto un’indagine per "omicidio e tentato omicidio in
relazione a un'impresa terroristica" e "associazione di malfattori terroristica
criminale". Nel 2016 Nizza è già stata colpita da un attacco terrorista
realizzato con un camion che provocò 86 vittime e 458 feriti. Il sindaco di
Nizza Christian Estrosi, membro del partito di destra I Repubblicani, ha scritto
su& Twitter: “#Nizza06 è ancora una volta toccata nel suo cuore
dall'islamofascismo, che non smetto mai di denunciare”. Il Consiglio del culto
francese musulmano ha invitato i musulmani di Francia “ad annullare i
festeggiamenti di Mawlid (commemorazione della nascita del profeta Maometto ndr)
in solidarietà con le vittime” dell'attentato. Due virus letali scuotono la
Francia in questo inizio d’autunno incerto : il terrorismo e il covid. Nuovi
stati d’allerta e dispositivi sono stati applicati a tutto il paese per far
fronte alle emergenze: prima “allerta massima” e poi “vulnerabilità elevata” per
i contagi da covid in quasi tutti i dipartimenti, mentre il piano “vigipirata”,
strumento di sicurezza e difesa contro il terrorismo, è stato portato al livello
“urgenza attentato”. Come l’Italia, anche i vicini d’oltralpe sono soggetti alle
imprevedibili evoluzioni della pandemia, ma devono confrontarsi con la difficile
sfida di attacchi islamisti perpetrati da alcuni individui su tutto il
territorio. Domenica 25 ottobre la Francia ha registrato un picco di contagi:
più di 52.000 in 24 ore, mentre il 28 ottobre si contano 244 decessi per
covid solo negli ospedali. Mercoledì sera il presidente Macron ha annunciato un
nuovo confinamento di un mese che consentirà però a lavoratori e studenti di
continuare le loro attività (università escluse), permettendo anche le visite
negli ospizi. A proposito dell’epidemia ha affermato che tutti in Europa “siamo
travolti da una seconda ondata che sarà senza dubbio più dura e mortale”. Il
ministro della salute Olivier Veran ha già parlato di una possibile “ terza
ondata ”. Mentre la gestione della crisi sanitaria e la comunicazione delle
decisioni strategiche del governo vengono criticate, crescono le tensioni
intorno a Macron e a Charlie Hebdo. Duri attacchi provengono dal Medio Oriente
dopo che il presidente francese ha difeso la libertà di caricatura del
Profeta nel corso dell’omaggio nazionale al professore decapitato vittima di
un attacco islamista. Dall’Università Sorbona di Parigi « il nostro luogo del
sapere universale », « il luogo dell’umanesimo », come lui stesso l’ha definito,
Macron ha evocato la difesa della libertà e dello spirito critico, affermando
che « non rinunceremo alle caricature, ai disegni, anche se altri
arretrano». Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha reagito prima mettendo
in discussione la "salute mentale" di Emmanuel Macron, poi invitando i cittadini
a boicottare i prodotti a marchio francese. La Turchia e la Francia sono
entrambe membri dell'alleanza militare della NATO, ma sono state in disaccordo
su questioni quali la Siria e la Libia, la giurisdizione marittima nel
Mediterraneo orientale e il conflitto nel Nagorno Karabakh. Il 12 ottobre, dopo
l’Olanda e la Germania, la Francia ha annunciato di “sospendere qualsiasi
progetto di esportazione in Turchia di materiale bellico che potrebbe essere
usato nell'offensiva in Siria”. Di fronte alla reazione di Erdogan, Macron ha
richiamato l’ambasciatore francese ad Ankara e diversi leader europei hanno
espresso il loro sostegno al presidente francese, come il primo ministro
olandese Mark Rutte e il portavoce della cancelliera Angela Merkel Steffan
Seibert, il quale ha definito “diffamatorie” le dichiarazioni del presidente
turco. Il presidente italiano Giuseppe Conte ha affermato su Twitter “le
dichiarazioni del presidente Erdogan sul presidente Macron sono inaccettabili.
Le invettive personali non aiutano l'agenda positiva che l'UE vuole perseguire
con la Turchia, ma al contrario allontanano le soluzioni. Piena solidarietà con
il Presidente @EmmanuelMacron”. I prodotti francesi sono stati tolti dagli
scaffali dei supermercati di Doha, la capitale del Qatar. Sui social network
sono stati diffusi video che mostravano gli scaffali dei supermercati in
Giordania svuotati dei prodotti francesi o sostituiti da quelli di altri paesi.
I video sono stati accompagnati dall’hashtag #FranceBoycott o
#OurProphetIsARedLine ("Il nostro profeta è una linea rossa"). Lunedì il
ministro iraniano degli affari esteri, Mohammad Javad Zarif, ha accusato la
Francia « di alimentare l’estremismo» e di “insultare 1,9 miliardi di musulmani
e i loro elementi sacri”. Il fuoco si è riacceso quando, martedì sera, la
rivista satirica francese Charlie Hebdo ha pubblicato online la nuova copertina
che raffigura Erdogan in mutande mentre solleva il velo di una donna. Su Twitter
Fahrettin Altun, il portavoce di Erdogan, ha accusato il giornale di " razzismo
culturale " affermando che "l'agenda anti-musulmana del presidente francese
Macron sta dando i suoi frutti". Dopo aver condannato l’attentato di Nizza il
portavoce ha scritto “il nostro Presidente ha sempre fatto appello alla
cooperazione contro il terrorismo e l'estremismo. Rinnoviamo ancora una volta
questo appello mentre rifiutiamo la retorica e le azioni dannose contro la
nostra religione e la nostra cultura senza badare alla sua fonte ideologica”. La
Francia dovrà dimostrare di saper far fronte a una pericolosa sovrapposizione di
emergenze, stretta nella doppia morsa del terrorismo e di un’epidemia che sembra
fuori controllo.
Ecco come è la Nizza del terrore. In
un capitolo nel nuovo volume di Gigi Riva si racconta perché la Costa Azzurra è
diventata una terra di jihadisti. L'Espresso il 29 ottobre 2020. C'è un ragazzo
congolese immigrato che si chiama Gino il cattolico perché quella è la sua
religione e si trova costretto a scappare dall' Ariane, la più disperata delle
banlieue di Nizza, edificata tra il fiume Paillon e la centrale nucleare. Non
c'è posto per lui nel quartiere dove sono comparsi imam fondamentalisti che
fomentano l'odio e dove molti suoi coetanei hanno abbracciato il Jihad. I pochi
francesi che ci abitano sono barricati in casa, spaventati dal rumore sordo di
una violenza in arrivo, dalle strade dove si odora la paura. La presenza del
genere femminile è rarefatta, le donne camminano tre passi indietro ai loro
uomini e sono velate. I rifiuti debordano dai cassonetti, i cani randagi vagano
alla ricerca di avanzi di cibo. La bella Nizza della Costa Azzurra, dei locali
alla moda, dei viali ordinati e orlati dalle case liberty, della Promenade des
Anglais, sta oltre il largo boulevard Pasteur che segna una cesura netta. Pochi
metri e si passa da un mondo all'altro, opposto. All'Ariane, in quel clima teso
e angosciante viene ucciso Salomon, senegalese d'origine, il proprietario del
bar-ristorante “Dakar”. E' un immigrato di prima generazione, ha assimilato gli
ideali della République, si oppone con forza agli estremisti arrivati come un
cancro a imporre la legge del terrore. E' il riassunto, molto succinto, di un
capitolo del mio ultimo libro “Non dire addio ai sogni” (Mondadori). Fiction. Ma
fiction basata sulla realtà. Sono stato a Nizza, all'Ariane, per essere più
esatto nell'ambientare questa parte della mia storia. Ho scoperto la fama
sinistra di una periferia che ha il triste primato del maggior numero di foreign
fighters reclutati per lo Stato islamico. A causa dell'incessante opera di Omar
Diaby, meglio conosciuto come Omar Omsen (il cognome è la crasi del nome e
dell'origine, Omar e Senegal). Omar era arrivato all'Ariane nel 1983 quando
aveva 7 anni. La sua carriera da piccolo delinquente aveva toccato il diapason
con le rapine nelle gioielleria di Montecarlo. In carcere si era radicalizzato
e, scontata la pena, era tornato a domicilio diventando un pioniere della
propaganda via Internet con alcuni video di incitamento alla Guerra Santa capaci
di stabilire record di visualizzazioni. La sua base era un chiosco halal
trasformato in un covo di aspiranti terroristi. Nel 2013 aveva trascinato in
Medioriente armati di fucile decine di adepti. A fine agosto scorso è stato
arrestato ad Harim (in Siria) in circostanze poco chiare, ma sembra da parte di
un gruppo jihadista concorrente che spadroneggia nella regione. I semi hanno
generato odio in abbondanza, all'Ariane e non solo. Non mi sono stupito
nell'ascoltare confessioni per le quali anche diversi agenti dei servizi
italiani monitorano l'area: il nostro confine è molto vicino. Così come non mi
sono stupito, purtroppo, nell'apprendere la notizia di questa nuova carneficina
nella cattedrale di Notre Dame a Nizza. Il mio libro si snoda tra il 2014 e il
2016. E' la storia di ragazzo africano, Amadou che viene portato in Europa da
falsi procuratori del calcio che gli promettono un futuro da campione. Ma poi lo
abbandonano per la strada. Tra Italia e Francia deve cercare di sopravvivere e
resistere. Avrà un piccolo riscatto finale. Ma prima conosce il degrado della
stazione Termini, è costretto a entrare in una gang di spacciatori a Marsiglia,
all'Ariane perde il suo compagno di avventura, Gino appunto. Assiste
all'incrudelirsi dei rapporti in banlieue. Vive seppur da lontano gli attentati
di Charlie-Hebdo, Bataclan, fugge poco prima del massacro di Nizza. Il Covid 19
fagocitante ci aveva fatto dimenticare altri mali della nostra contemporaneità.
Non essendo stati mai sradicati, ecco che tornano.
AGI il 12/10/2020. Una quarantina di persone ha attaccato e
assediato un commissariato di polizia fuori Parigi nella notte di ieri. Hanno
utilizzato spranghe di ferro e fuochi d'artificio, lanciati come mortai contro
l'edificio. Un'azione grave che spinto a nuove richieste per un'azione piu' dura
del governo dopo una serie di attacchi alle forze di sicurezza francesi. Due
agenti poco prima di mezzanotte erano in pausa sigaretta all'esterno del
commissariato di Champigny sur Marne, a circa 12 chilometri a est della
capitale, quando gli aggressori si sono improvvisamente riuniti e sono entrati
in azione. Gli agenti sono riusciti a malapena a barricarsi all'interno quando
la folla ha iniziato ad attaccare l'ingresso e diversi mezzi della polizia,
mentre altri hanno lanciato una raffica di potenti fuochi d'artificio contro lo
stabile. Nessuno è rimasto ferito. Nelle ore successive nel centro della città
era stata fermata una persona, ritenuta tra i responsabili, ma poi scagionata
dalla procura che sta esaminando i filmati della sorveglianza. Il sindaco della
città, Laurent Jeanne, ha spiegato che la polizia potrebbe essere stata presa di
mira per rappresaglia dopo un recente incidente con uno scooter, presumibilmente
causato dalla polizia che però "non è stato dimostrato". Il ministro
dell'Interno, Gerald Darmanin, ha twittato che "questi piccoli spacciatori non
spaventano nessuno e non scoraggeranno il nostro lavoro contro la droga",
sebbene i funzionari di polizia non abbiano ancora identificato gli aggressori.
Anche se il sindaco ha riconosciuto il problema del traffico di droga nel
quartiere di Bois L'Abbe, dove si trova il commissariato. L'ufficio di Darmanin
ha annunciato che martedì incontrerà i sindacati di polizia, che da mesi premono
per misure concrete per migliorare le condizioni di lavoro. Proprio loro hanno
raccontato che l'attacco vicino a Parigi ha evidenziato una crescente minaccia
contro le forze dell'ordine nei sobborghi depressi della capitale e in altre
grandi città. Le tensioni sono alte da molto tempo in queste aree densamente
popolate e spesso povere, dove grandi comunità di immigrati si sono lamentate a
lungo della brutalita' della polizia e del razzismo. Mercoledì scorso due agenti
di polizia erano stati aggrediti e colpiti con le loro armi in un sobborgo di
Parigi. Nella notte tra venerdi' e sabato si era verificato un attacco molto
simile in un commissariato a Le Mans. "Non c'è più rispetto per le forze
dell'ordine, e purtroppo il governo non e' riuscito a cambiare questa tendenza",
ha denunciato Frederic Lagache, del sindacato di polizia dell'Alleanza. "Sono
letteralmente scene di guerra", ha detto alla televisione Bfm, Valerie Pecresse,
leader di destra della regione dell'Ile de France che comprende Parigi, mentre
visitava la stazione di Champigny. "Il ministro dell'Interno deve aumentare il
numero di agenti nei quartieri più duramente colpiti dalla criminalità
organizzata", ha aggiunto. Diverse altre stazioni di polizia in tutta la Francia
sono state prese di mira in simili attacchi di fuochi d'artificio quest'anno e
la stazione di Champigny sur Marne era già stata colpita, lo scorso aprile, da
giovani che brandivano fuochi d'artificio. "Ma erano solo ragazzi che
protestavano durante il lockdown" imposto per frenare il coronavirus, ha
spiegato il sindaco Jeanne. "Oggi siamo di fronte a qualcosa di completamente
diverso, questi volevano ferire due agenti", ha aggiunto.
Estratto dall'articolo di Anais Ginori per “la Repubblica” il
12/10/2020. «Ci sono due clan, la polizia e loro. Inconciliabili». «Loro» sono
quelli che nel suo libro Valentin Gendrot chiama i «bastardi ». Giovani arabi,
migranti, ragazzi di colore. «Quando eravamo in pattugliamento e passavamo
davanti a un gruppo di giovani, il commento dei poliziotti era: Ecco i
bastardi». Gendrot è un giornalista di 32 anni ma parla ancora come se fosse un
poliziotto. Per sei mesi ha lavorato come assistente alla sicurezza in un
commissariato del diciannovesimo arrondissement , uno dei quartieri più popolari
della capitale. «All'inizio sono stato io a infiltrarmi nella polizia» racconta
bevendo un caffé nel quartiere multietnico della Goutte d'Or. «Dopo tre o
quattro mesi, è stata la polizia a infiltrare me. Ho adottato le parole, i
codici e gli atteggiamenti dei miei colleghi». Il libro di Gendrot, Flic ,
sbirro, ha provocato un nuovo shock in Francia dove non passa giorno senza che
ci sia una polemica sulle forze dell'ordine. Uomini in divisa accusati di
violenze e abusi, come nel caso di Adama Traoré o Cédric Chouviat, morti durante
dei controlli di polizia. Ma anche agenti che si fanno massacrare o attaccare da
bande di giovani com' è successo questa settimana nella regione di Parigi. «La
polizia francese ha due problemi - spiega Gendrot - la mancanza di
riconoscimento nella popolazione e l'assenza di risposte dallo Stato al suo
profondo malessere ». Il suo esordio in divisa è cominciato con l'assistere al
pestaggio di un ragazzo in custodia e l'arrivo di una donna venuta per
raccontare del marito violento. «Torni se lo farà di nuovo» hanno risposto gli
agenti rifiutandosi di prendere la denuncia. Gendrot narra una perquisizione per
un banale problema di musica ad alto volume che finisce con un giovane caricato
sul furgone, riempito di botte e scaricato qualche chilometro dopo. Quando
l'adolescente presenta denuncia, il giornalista fornisce una falsa testimonianza
per coprire i suoi colleghi aggressori. Gendrot ammette un «caso di coscienza».
La bugia, sostiene, è stata «un danno collaterale » per poter continuare la sua
inchiesta. Ora che l'Igpn, l'organo di vigilanza interna della polizia, ha
riaperto l'inchiesta sarà di nuovo convocato. «Non vedo l'ora di poter dire la
verità. A volte mi domando: cosa penserà quel ragazzo della polizia?». (…) Il
suo viaggio nella polizia, già in corso di traduzione in vari Paesi europei,
cambierà qualcosa? Il giornalista francese è pessimista. «Dubito che il governo
avrà davvero la forza di eliminare le mele marce».
Nicola Sarkozy in tv: "Scimmie e negri, si può dire ancora?".
Sconcerto in diretta: "Questo è razzismo". Mauro
Zanon su Libero Quotidiano il 12 settembre 2020. Per pubblicizzare il suo ultimo
libro, Le temps des tempêtes, l'ex presidente francese Nicolas Sarkozy ha
accettato giovedì sera anche l'invito di Quotidien, trasmissione molto seguita
dalla Parigi radical-chic, in onda sul canale Tmc. Alle domande
dell'intervistatore, il giornalista Yann Barthès, Sarkozy ha risposto
inizialmente con il suo solito atteggiamento da piacione, suscitando anche
alcuni sorrisi tra gli opinionisti progressisti presenti in studio. Ma ad un
tratto, la situazione è precipitata: Sarkò, tra una battuta l'altra, ha
associato infatti il termine «singes», scimmie, e «nègres», negri, come se
niente fosse. Prima ha criticato «le élite, che si turano il naso, che sono come
le scimmie e non ascoltano nessuno», poi si è interrotto e, convinto di
risultare simpatico, ha pronunciato queste parole: «Non lo so più: abbiamo
ancora il diritto di dire "scimmie"? Perché non abbiamo più il diritto di
dire... Come si dice? 'I dieci piccoli soldati' ora? Si dice così. Già la
società progredisce!». A nessuno è sfuggito il riferimento al celebre romanzo
di Agatha Christie Dix petits nègres, che è appena stato ripubblicato e
ribattezzato in francese "Ils étaient dix", con la parola "nègre" sostituita nel
libro dalla parola "soldat" per volere del nipote della giallista
britannica, James Prichard. E a nessuno è andata giù l'associazione maldestra
avanzata dall'ex inquilino dell'Eliseo. «E così un ex presidente della
Repubblica francese associa spontaneamente le scimmie ai "negri"il razzismo
senza mascherina», ha denunciato il segretario nazionale del Partito
socialista, Olivier Faure. Anche Ségolène Royal, ex candidata alle presidenziali
del 2007, che perse proprio contro Sarkozy, ha manifestato la sua indignazione:
«Ahimè, è sulla falsariga del suo deplorevole discorso di Dakar del 2007,
durante il quale aveva affermato che "l'uomo africano non è entrato abbastanza
nella Storia"». Audrey Pulvar, assessora di origini martinichesi del comune di
Parigi, ha twittato: «Oggi non si può più dire niente ma si può mettere il segno
uguale tra "negro" e scimmia, in un abissale silenzio, senza essere
contraddetti. È un razzismo puro e profondo, disinvolto, naturale. In
tranquillità». Accuse pesanti sono arrivate anche dal leader degli
ecologisti Yannick Jadot, che ha parlato di "naufragio razzista" dell'ex capo
dello Stato francese. L'unica persona che ha provato a difenderlo è
stata Rachida Dati, la sua fedelissima ministra della Giustizia. Ma è stata
l'unica, appunto.
Michela Marzano per la Stampa il 17 settembre 2020. In Francia,
esistono ancora dei certificati di verginità. In che senso? si chiederà senz'
altro qualcuno. Tanto più che anch' io me lo sono chiesta. Scioccata di fronte
alla querelle che si è scatenata oltralpe, dopo che il governo ha annunciato una
legge per vietare questo tipo di certificati. Ieri, su Libération, un gruppo di
medici e ginecologi ha infatti pubblicato un appello chiedendo all' esecutivo di
ripensarci. E la Francia si è spaccata. I firmatari del testo - va precisato -
non sono affatto favorevoli alla pratica, che giudicano anzi barbara, retrograda
e sessista: il certificato viene in genere richiesto dai genitori o dai futuri
sposi di giovani donne cui viene allora controllata l'integrità dell'imene. Ma
questi medici e ginecologi sostengono anche che, quando sono loro a fornire i
certificati, salvano la vita a ragazze fragili, sole, impaurite e oppresse. E
che una legge che impedisca loro di continuare a farlo implicherebbe solo un
peggioramento della situazione per tutte coloro che, non potendo proteggersi da
sole, sarebbero probabilmente costrette a recarsi all' estero o a sottomettersi
a visite clandestine. E quindi? Continueranno senz' altro a chiedersi in tanti.
Quindi la proposta dei firmatari della petizione contro la proposta di legge è
quella di non vietare, ma educare, al fine di dare strumenti a tutti e tutte per
modificare stereotipi e comportamenti. Una sorte di male minore. Come se sul
piatto della bilancia ci fosse, da un lato, il diritto all' intimità e alla
privacy e, dall' altro, il diritto alla salute. Io, però, ho qualche dubbio che
le cose stiano esattamente così. Nonostante sia sempre in prima linea per
difendere la necessità di superare attraverso l' educazione i problemi legati al
sessismo, al non rispetto dell' uguaglianza e ai fondamentalismi piuttosto che
obbligare per legge a modificare certi comportamenti, questa volta non ce la
faccio proprio a essere contraria a questa proposta di legge sui certificati di
verginità. Sono estremamente sensibile al rischio che possono correre tante
giovani donne, e penso che si debba escogitare tutti insieme il modo migliore
per proteggerle. Ma sono anche convinta che la legge abbia sempre un valore
simbolico, e che vietare qualcosa significa quindi dare un messaggio, indicare
una strada e, nel caso specifico, significare che nel 2020 questa pratica è un'
inaccettabile barbarie. Non intervenire e sperare che un giorno, forse, le cose
cambieranno, significherebbe avallare l' idea che una giovane donna debba
sottomettersi al volere dei genitori o del futuro marito, e quindi legittimare
la dominazione e la violenza e l' intrusione nella sfera intima e il non
rispetto non solo del corpo ma anche della persona. Come insegno ai miei
studenti universitari, non c' è un modo giusto o sbagliato di essere o di amare,
anche semplicemente perché ognuno di noi è diverso e la diversità è indice di
ricchezza. Ma questo non significa che non ci sia un modo giusto o sbagliato di
agire o fare o comportarsi. Nulla legittima l' oppressione e la dominazione né
tantomeno il non rispetto della dignità e della libertà della donna. E anche se
esiste una differenza fondamentale tra norme giuridiche e norme morali, è bene
che la legge vieti queste pratiche immorali, incarnando i valori della libertà,
dell' uguaglianza e della fraternità che sono alla base della République.
La Francia si spacca sui certificati di verginità per le
ragazze. I medici: "Sbagliato vietarli". Pubblicato
mercoledì, 16 settembre 2020 da Anais Ginori su La Repubblica.it Gli attestati
sono richiesti da genitori o futuri mariti: il governo vorrebbe abolirli
nell'ambito di un progetto contro il "separatismo", in particolare islamico. Ma
secondo molti operatori la legge rischia di mettere in pericolo le giovani più
fragili. "No alla legge che vieta i certificati di verginità". Il sorprendente
appello viene da un gruppo di ginecologi e medici francesi schierati contro la
decisione del governo di approvare una legge per vietare questa pratica
sessista, umiliante, rendendo penalmente responsabili i dottori che si prestano
a rilasciare i certificati. Secondo i firmatari del testo pubblicato
su Libération la proposta dell'esecutivo, che fa parte del progetto più ampio
contro il "separatismo" in particolare islamico, rischia di mettere in pericolo
le ragazze che vivono in famiglie integraliste. I certificati di verginità
vengono rilasciati dopo un controllo dell'integrità dell'imene e vengono di
solito richiesti da giovani, o piuttosto da genitori e futuri mariti. I medici
firmatari sottolineano che si tratta di un fenomeno minoritario. "Siamo
decisamente contrari ai test di verginità" precisano. "È una pratica barbara,
retrograda e totalmente sessista. In un mondo ideale, tali certificati
dovrebbero naturalmente essere rifiutati". Poi però aggiungono: "Ci capita di
dover fornire questo certificato a una giovane donna per salvarle la vita, per
proteggerla perché è indebolita, vulnerabile o minacciata". Secondo i firmatari
approvare un bando con reato penale significa abbandonare le ragazze a pratiche
clandestine, o a viaggi all'estero per ottenere comunque gli attestati, mentre
oggi la consultazione è l'occasione di aiutare le ragazze "a prendere coscienza
e a liberarsi dal dominio maschile o familiare". L'appello è sottoscritto tra
gli altri dal direttore del reparto ostetricia-ginecologia dell'ospedale
parigino Bicêtre, dalla presidente del collettivo femminista Cfcv Emmanuelle
Piet e dal presidente di Gynécologie Sans Frontières (Gsf) Claude Rosenthal. Il
ministro dell'Interno Gérard Darmanin, accompagnato dalla sottosegretaria alla
cittadinanza Marlène Schiappa, aveva annunciato la settimana scorsa la misura
appoggiandosi su una decisione dell'Ordine dei Medici. "Tale esame - ha scritto
il consiglio nazionale dell'Ordine nel 2017 - non ha alcuna giustificazione
medica e costituisce una violazione del rispetto della privacy di una giovane
donna, in particolare quando minorenne". L'idea che nella Francia del 2020 ci
siano ancora donne (e medici) che si occupano certificati di verginità, con
nessun valore legale, sembra incredibile. Ma la soluzione, dicono i medici
promotori dell'appello al governo, non è una legge. "Significa attaccare gli
effetti trascurando la causa che affonda le sue radici nell'ignoranza e nella
paura. Solo l'educazione - concludono i firmatari - permetterà l'emancipazione
di queste giovani donne".
Il caso del certificato di verginità.
Intervista a Marcelle Padovani: “Povera Francia, come sei caduta
in basso”. Umberto De Giovannangeli su Il Riformista il 19 Settembre 2020.
«Povera Francia mia, come siamo caduti in basso! Fare di una vicenda che
coinvolge un numero ridottissimo di ragazze un caso nazionale che investe il
Parlamento, è il segno di una regressione culturale davvero preoccupante». A
sostenerlo a Il Riformista è una delle più autorevoli giornaliste e saggiste
francesi: Marcelle Padovani, storica corrispondente in Italia del Nouvel
Observateur. La Francia si spacca sui certificati di verginità. Un gruppo di
ginecologi e medici francesi hanno sostenuto, in una lettera pubblicata da
Libération, che è «sbagliato vietarli», schierandosi contro la decisione del
governo di approvare una legge per vietare questa pratica sessista, umiliante,
rendendo penalmente responsabili i dottori che si prestano a rilasciare i
certificati.
Cosa c’è dietro questa storia?
«Prima di tutto devi raccontarla la
storia. Perché il numero dei casi è assolutamente ridicolo. C’era una infermiera
su Le Monde ieri (giovedì per chi legge, ndr) che raccontava che nell’ospedale
in cui lavora, uno dei più grandi di Parigi, lei ha avuto due casi nel corso di
un anno. Per dire che si tratta di fenomeni totalmente marginali. Il fatto
interessante è che la politica se ne occupi, questo sì, che il Parlamento voglia
vietare i cosiddetti certificati di verginità che sono richiesti in certi
settori del mondo musulmano, quelli più arretrati: in Francia ci sono cinque
milioni di musulmani e non sono tutti per il certificato di verginità. Questo
certificato servirebbe a garantire che la donna che tu devi sposare non ha avuto
relazioni sessuali. Ma, in concreto, come si fa questo esame di verginità? C’è
una infermiera che ti mette un apparecchietto nella vagina e poi nell’utero, che
vede se il tuo imene è intatto o meno. Però può essere intatto pure se tu hai
già fatto parecchi esercizi erotici e può essere rotto anche se tu non hai fatto
niente. Dunque non è da nessun punto di vista, né scientifico, né morale, una
cosa decisiva. E allora c’è da chiedersi perché il Parlamento francese ha messo
in programma una discussione sulla soppressione di questo certificato…»
Giusta annotazione. Perché lo ha fatto?
«Perché dietro c’è una grande
regressione delle nostre civiltà, una regressione che si traduce anche in altri
fenomeni…»
A cosa si riferisce?
«Ad esempio, parecchi aspetti del Me
Too, un movimento che in Francia è molto forte. Come fai a denunciare uno che ti
ha molestato tanti anni fa: perché non lo hai fatto prima? Oggi cerchi una
rivincita, cerchi di affermarti. Il tuo “femminismo” ha trovato un’unica via di
uscita: questa regressione, perché tale è, un ritorno indietro. In tutto questo
si parla di certificati di verginità. I giorni scorsi in Parlamento è arrivata
una ragazza diciottenne fra il pubblico che portava il chador. Si è scatenato un
dibattito se quella ragazza avesse il diritto o meno di indossare il velo.
Normalmente ha il diritto, perché è una persona del pubblico, ci sono altri però
che dicono che in una istituzione pubblica, che deve essere rappresentativa, non
ci devono essere simboli religiosi. Tutto è occasione per creare polemica. C’è
una regressione generale, una società incattivita, e questo si coglie
soprattutto nell’atteggiamento verso colui che dovrebbe rappresentare la Francia
e i francesi: il Presidente».
Come si manifesta e perché questo incattivimento?
«Oggi la stragrande maggioranza dei
francesi vorrebbe “ghigliottinare” Macron. Non vogliono sconfiggerlo, cosa del
tutto lecita, ma lo vogliono appendere per i piedi, lo vogliono eliminare. E
questo perché lui ha deluso, perché lui non è catalogabile. Non va dimenticato
che al primo turno delle presidenziali che lo hanno visto poi vincitore al
ballottaggio, Macron ha avuto il 24% dei suffragi. Al secondo turno, poiché
aveva come avversaria la Le Pen, tutti i democratici, anche di destra, come di
centro e di sinistra, hanno votato per lui e questo gli ha permesso di
raggiungere il 60%. Ma è sempre stato vissuto come un minoritario. Poi ha fatto
delle politiche che dal punto di vista tecnico e della competenza erano
assolutamente intelligenti, difendibili, ma dal punto di vista politico, lui ha
accumulato errori su errori per ignoranza, perché non è un politico. E adesso
sono gli antipolitici che vogliono vendicarsi su di lui».
Per tornare al tema di questa nostra conversazione. I medici e
ginecologici, che hanno firmato il testo pubblicato da Libération, sostengono
che abolire i certificati di verginità significa mettere in pericolo le ragazze
che vivono in famiglie integraliste. Ma che idea di Islam c’è dietro questo
assunto?
«C’è una generalizzazione
assolutamente infondata, perché stiamo parlando di pochissimi casi. Il problema
è assolutamente marginale e trasformarlo in un problema generale è una forzatura
che non regge. Lasciami aggiungere una cosa su Libération: il nuovo direttore,
che è stato nominato nei giorni scorsi, viene da Haaretz (uno dei più importanti
giornali israeliani, ndr), e non credo che sia un illuminato del mondo islamico».
Lei ha parlato del degrado del dibattito politico-culturale in
Francia. In tutto questo, gli intellettuali che ruolo hanno (se ne hanno ancora
uno)?
«Non c’è più un mondo intellettuale
unico, unitario, uniforme, che pure ha fatto la fortuna della Francia o comunque
ne ha fortemente segnato per decenni il mondo culturale. Oggi hai gli
intellettuali di sinistra, gli intellettuali di destra e pure gli intellettuali
di estrema destra, una cosa che prima non esisteva. Adesso questi parlano,
straparlano, hanno un seguito. Assistiamo a un problema più vasto che investe la
mentalità francese, dove alcune forme di ignoranza e di incompetenza si
traducono e alimentano gli estremismi, con la ghigliottina e con l’estrema
destra. E oggi con il certificato di verginità».
Quanto interessa questo mondo intellettuale al movimento
femminista francese?
«Direi poco o niente. Rivendicano
invece una presenza, un riconoscimento oserei dire “mediatico”. Quello che conta
davvero per loro è la rivincita mediatica. E questa rivincita ce l’hai di più
nella musica, nella canzone, nel cinema, nella produzione, nei social. Il resto
è marginale. È archeologia».
Stefano Montefiori per corriere.it il 16 settembre 2020. «Basta
vestirsi normalmente e andrà tutto bene», dice il ministro dell’Istruzione
Jean-Michel Blanquer, sperando così di spegnere la polemica. Ma una frase che
voleva essere distensiva ha rilanciato la protesta delle ragazze francesi, che
lunedì hanno cominciato ad andare a scuola in crop-top (con l’ombelico in
vista), minigonna, o braccia scoperte. Che cosa significa «vestirsi
normalmente?», in un Paese dove il senso del pudore sembra stia cambiando e il
canone finora abituale viene messo in discussione? Per decenni le donne francesi
hanno potuto — se volevano — prendere il sole in spiaggia a seno scoperto, ma il
26 agosto due di loro sono state invitate a rivestirsi dai poliziotti a
Sainte-Marie-la-Mer, poco lontano dalla Spagna, in seguito alle proteste di una
famiglia preoccupata per il «turbamento» dei bambini. Venerdì scorso una 22enne
è stata respinta all’ingresso del Museo d’Orsay a Parigi perché gli inservienti
hanno giudicato il suo abito troppo scollato, e qualche settimana prima era
toccato a un’altra ragazza essere bloccata all’entrata di un supermercato
«Casino» di Six-Fours-les-Plages, nel Sud, perché l’agente di sicurezza la
riteneva poco vestita. Accanto a questi casi straordinari, finiti sui giornali,
c’è l’infinita serie di piccoli soprusi che le donne francesi denunciano con
forza ormai da mesi, sull’onda del movimento #MeToo: ogni giorno, soprattutto in
certe periferie ma anche nel centro della capitale e delle altre metropoli, una
gonna corta viene interpretata come un invito a manifestare avances, un vestito
leggero scambiato per un’allusione sessuale, una maglietta sbracciata
considerata un ammiccamento che rende lecito qualsiasi commento. Che cosa sta
succedendo alla Francia, il Paese che il topless lo ha inventato e che un
immaginario forse un po’ sorpassato associava a una libertà femminile serena, al
riparo da oscurantismi, nervosismi e frustrazioni machiste? Le liceali
protestano contro regole che in un contesto normale e pacificato sarebbero di
«buon senso», come dice il ministro Blanquer: non si va a scuola vestiti come in
spiaggia, questo dovrebbe essere banale e valere per maschi e femmine. Il
problema è che poi il richiamo alla «tenuta corretta», in tanti istituti, viene
applicato solo alle ragazze, ritenute colpevoli altrimenti di distrarre i
compagni, e di indurli in tentazione per colpa di abiti non sufficientemente
castigati. Siamo all’eterna questione dell’uomo che molesta, o magari violenta,
ma è la donna che deve dimostrare di non averlo incoraggiato. Così i social
media francesi da lunedì sono pieni di foto di studentesse più o meno scollate,
con cartelli che dicono «invece di coprire le ragazze educate i vostri figli», e
messaggi che spiegano: «I ragazzi possono vestirsi come vogliono, mentre noi
veniamo costantemente riportate alla questione della sessualità. In questi
giorni ci sono 30 gradi, andiamo in giro scoperte solo perché fa molto caldo. O
dovremmo metterci un maglione per fare stare tutti tranquilli?». La protesta
delle studentesse delle scuole medie e dei licei francesi imbarazza anche il
governo, perché se il ministro Blanquer alza gli occhi al cielo provando a
minimizzare, la collega alla Cittadinanza ed ex ministra alla Parità
donne-uomini, Marlène Schiappa, si schiera con la protesta: «In tutta la Francia
ci sono ragazze che hanno deciso di mettersi in gonna, décolleté, crop-top o di
truccarsi, per affermare la loro libertà rispetto a giudizi o atti sessisti. Da
madre, le sostengo con vicinanza e ammirazione».
Stefano Montefiori per corriere.it il 10 settembre 2020. «O si
copre, o lei non entra», hanno intimato i funzionari del Museo d’Orsay a una
giovane donna con abito scollato. Dopo un breve litigio all’ingresso la
visitatrice ha ottemperato mettendosi la giacca, e con l’amica che
l’accompagnava ha contemplato, umiliata e intabarrata, nudi celebri come
«L’origine del mondo» di Courbet o la «Colazione sull’erba» di Manet. Poi, il
giorno dopo, Jeanne ha scritto una feroce lettera aperta, raccontando nei
dettagli l’accaduto su Twitter, con lo pseudonimo Tô’. «È martedì 8 settembre,
il caldo aumenta nel pomeriggio e le braccia si scoprono. Ho voglia di andare al
museo d’Orsay, e non sospetto che il mio décolleté sarà un oggetto di discordia.
Arrivata all’ingresso non ho il tempo di mostrare il biglietto che la vista dei
miei seni turba la funzionaria incaricata del controllo delle prenotazioni, che
parte salmodiando: ”Ah no, non è possibile, non si può lasciare passare una cosa
simile”, mentre la collega cerca di convincerla a lasciare perdere. Chiedo che
cosa stia succedendo, nessuno mi risponde ma fissano i miei seni, mi sento a
disagio, l’amica che mi accompagna è sconvolta. Un altro agente, di sicurezza
stavolta — i seni, quest’arma di distruzione di massa — si avvicina e mi intima
ad alta voce: ”Signora le chiedo di calmarsi”. Sono calmissima, vorrei solo
capire perché non posso entrare nel museo. ”Le regole sono le regole”. Arriva un
altro responsabile, nessuno ha il coraggio di dire che il problema è il
décolleté, ma tutti fissano apertamente i miei seni, designati alla fine con un
”questo”». «Le regole sono le regole», ripetono i funzionari. Non lo dicono, ma
la famosa regola potrebbe essere l’articolo 7 del regolamento interno: «Gli
utenti devono conservare una tenuta decente e un comportamento conforme
all’ordine pubblico e devono rispettare la tranquillità degli altri utenti».
Giudicare della decenza di un abito può essere operazione delicata, affidata
alla sensibilità di chi è chiamato a farlo. La donna diffonde quindi una sua
foto con lo stesso vestito, scattata qualche ora prima al ristorante dell’Hotel
Meurice. Davvero quella è una tenuta indecente? Ci si aspetterebbe questa
obiezione all’ingresso del Museo della rivoluzione islamica di Teheran, non
all’Orsay di Parigi, città che anzi un tempo aveva fama di essere gioiosa e
liberale. Ma se nella spiaggia di Pérpignan vengono multate (senza alcuna base
giuridica) due bagnanti in topless, può capitare che pochi giorni dopo una donna
in vestito scollato sia bloccata all’ingresso di uno dei musei più visitati al
mondo. Dopo la sua denuncia, anche un’altra ragazza su Twitter ha raccontato di
essere stata respinta di recente per motivi analoghi, colpevole di avere
lasciato braccia e ombelico scoperti «per il caldo, non certo per
esibizionismo». Jeanne protesta soprattutto contro il sessismo. «Io non sono
solo i miei seni, non sono solo il mio corpo. Mi domando se gli agenti che
volevano proibirmi di entrare sanno a che punto hanno obbedito a dinamiche
sessiste. Non può essere il giudizio arbitrario su che cosa è decente e cosa non
lo è a determinare l’accesso o meno alla cultura». Ma la questione è anche se la
nozione di decenza in Francia stia cambiando, e se quei funzionari abbiano
ubbidito a un nuovo canone — più severo, più castigato — ispirato al
neo-puritanesimo americano o magari al concetto di «modestia» propagandato nelle
periferie (e non solo) dagli islamisti radicali. In serata la direzione del
museo ha preso posizione — «Siamo profondamente dispiaciuti per questo incidente
e presentiamo tutte le nostre scuse alla persona coinvolta» — imputando
l’accaduto a un «eccesso di zelo» dei funzionari, dipendenti di una società
esterna.
Benedetta Perrilli per "d.repubblica.it" il 14 settembre 2020.
Indossava un abito troppo scollato per poter visitare le sale del museo d'Orsay,
a Parigi, e così una visitatrice è stata costretta a indossare una giacca per
poter ammirare l'esposizione. Un gesto che ha fatto molto discutere e che non
poteva non essere vendicato dalle attiviste di Femen. Le femministe, note per le
loro azioni di protesta a seno nudo, si sono introdotte nel museo e hanno posato
in topless, con le mascherine e mantenendo le distanze di sicurezza, mostrando
sul corpo le scritte "Non è osceno" e "L'oscenità è nei vostri occhi". In un
comunicato hanno spiegato la ragione della dimostrazione citando
anche l'episodio delle due donne in topless a Sainte-Marie-la-Mer alle quali gli
agenti di polizia hanno chiesto di indossare il costume: "Il museo d'Orsay
ospita numerose opere, molte delle quali nudi femminili e maschili, così come il
celebre dipinto L'origine du monde di Gustave Courbet. Per quegli agenti un
abito scollato è un problema, ma non crea loro alcun problema fissare i seni di
una donna e giudicare com'è vestita". Le attiviste hanno spiegato di voler
combattere il pregiudizio sul corpo della donna che "ogni volta è come se
venisse etichettato osceno o sconveniente" e che "solamente ricordando che il
corpo non è osceno e sostenendo Jeanne (la turista allontanata dal museo) e
tutte le donne vittime di discriminazioni sessiste si ferma la sessualizzazione
del corpo delle donne". Jeanne, la studentessa protagonista dell'incidente
avvenuto l'8 settembre al museo francese, aveva raccontato su Twitter di essere
stata discriminata all'ingresso a causa del suo abbigliamento. La lettera
aperta, nella quale raccontava come due agenti le avessero imposto di indossare
una giacca per poter entrare nel museo, era diventata subito virale e costretto
il museo a pubblicare delle scuse. Intanto la rentrée scolastica è stata segnata
in Francia, oltre che dall'emergenza Covid, anche da una polemica sul dress code
sessista imposto dalle scuole. Vari gruppi femministi e molti studenti hanno
indetto per il 14 settembre una protesta contro la decisione di alcuni istituti
scolastici (in particolare il liceo Pierres Vives di Carrières-sur-Seine) di
vietare indumenti giudicati "indecenti" come shorts, minigonne e crop top. Gli
stessi indumenti che chi partecipa alla protesta #Lundi14septembre ha deciso di
indossare in forma ancora più audace. La protesta, nata spontaneamente sui
social, ha ottenuto il sostegno della ministra Marlène Schiappa, delegata
responsabile della cittadinanza, che in un tweet ha commentato: "Come madre le
sostengo con sorellanza e ammirazione". A favore del movimento anche le
attiviste de Les Glorieuse che spiegano: "Osate top, gonne e trucco per reagire
alle loro proposte sessiste. Vi invito a farlo tutti, senza preoccuparvi del
vostro genere, uomini, donne, non binari. L'abbigliamento non ha un genere e
possiamo indossare quello che vogliamo. Dimostriamoglielo".
Le entrate di seno e le uscite di senno.
Roberto Marino il 13 settembre 2020 su Il Quotidiano del Sud. CHI
HA visto le foto è rimasto sconcertato: tutto ha la scollatura di Jeanne, una
studentessa di 22 anni, la prima persona al mondo a essere respinta all’ingresso
di un museo, tranne un aspetto conturbante, malizioso, ammiccante. Il seno è
abbondante, ma casto, composto, ordinato, somiglia a quello delle balie da latte
ciociare, per secoli supplenti di tette per i rampolli dell’aristocrazia romana.
Un seno da ciaciona, non da bonazza, senza pensieri tinti, neanche paragonabile
a quelli che si vedono su certi tappeti rossi del cinema, con capezzoli al vento
in cerca dello scattino portafortuna. La povera Jeanne è stata bloccata da una
donna davanti al Museo d’Orsay di Parigi, la vecchia stazione adattata che
ospita opere d’arte e capolavori dell’Impressionismo. Non è stato un uomo a
fermarla, ma un’altra donna. Una mortificazione incredibile, un imbarazzo da
trauma psicologico. Una follia. L’episodio ha fatto il giro del mondo e qualche
altro museo si è subito affrettato a rilanciare, offrendo pacchetti di visite a
occhi chiusi, senza stare con il centimetro in mano a contare la larghezza del
décolleté. Cosa sia passato per la testa dell’addetta al controllo resta un
mistero. Il Museo d’Orsay ospita un’infinità di quadri con nudi, a partire dal
celebre “L’origine del mondo”, di Gustave Courbet. Secoli e secoli di arte hanno
esaltato la bellezza femminile. Corpi e forme lontane dalla mercificazione della
donna di oggi, risalgono a prima di Cristo: hanno attraversato i tempi portando
sensualità, turbamenti, attrazione senza che mai venissero considerati sconci,
volgari. L’incredibile episodio di Parigi ci riporta in epoche buie. E il fatto
che sia stata proprio una donna a spalancare la porta della fobia per la nudità
femminile crea molte perplessità. Persino l’Italietta appena uscita dal boom
economico, con i vigili urbani a misurare sulle spiagge i bikini e i pretori
bacchettoni e ipocriti, con le forbici pronti a sequestrare film e riviste
scollacciate, non ha mai avuto esitazioni nell’esibire la bellezza nuda arrivata
dalla genialità degli artisti. E nessuna nei musei è mai entrata dopo il
famigerato invito: «Rosalia, componiti».
Luca Beatrice per mowmag.com il 10 settembre 2020. E pensare che
proprio in quelle sale dalla metà degli anni ’80 è esposto L’origine du monde,
il piccolo capolavoro di Gustave Courbet e mai prima di allora (il quadro era
stato dipinto nel 1885) un pittore aveva osato rappresentare in maniera così
realistica il sesso femminile, ai tempi tutt’altro che glabro, nonostante la
storia dell’arte sia ricca di nudi, alcuni dei quali erotici, ammiccanti,
provocatori. Quando L’origine arrivò finalmente al Musée d’Orsay, lascito degli
eredi dello psicanalista Jacques Lacan, sembrarono davvero piegate le ultime
resistenze della censura. D’altra parte, Parigi è sempre stata la capitale della
sessualità più libera già dagli anni ‘60, il cinema faceva passare modelli di
donne emancipate e dominatrici come Brigitte Bardot e Jane Birkin, il laicismo e
la libertà d’espressione, i bigotti erano invitati a trasferirsi altrove. Negli
anni ’70 si impose la Body Art e tante artiste donne lavoravano con il proprio
corpo nudo, un corpo contro, politico, aggressivo nei confronti del modello
femminile proposto dai media e adottato dai maschi. Un secolo dopo il quadro di
Courbet, le pornostar andavano in tv, in parlamento, alla Biennale di Venezia.
Per non parlare della moda che scopriva centimetri di pelle, lavorava con le
trasparenze fino al nude look e nelle spiagge era assolutamente normale il
topless. Oggi, anno di (s)grazia 2020, viviamo in un’epoca bacchettona,
moralista, pretesca, talebana e sessuofobica che, in nome del più stucchevole
politicamente corretto, censura, impone le mani sugli occhi, tarpa le ali,
tranne poi massacrarsi di seghe sui siti porno, gratuiti e di libero accesso
anche per i minori (provate a digitare sul motore di ricerca “giochi per
bambine”, compariranno sex toys mica le Barbie).
Tinder mi ha bloccato per sempre per colpa di una segnalazione
falsa. Un paio di giorni fa una giovane donna orientale di bell’aspetto, in
visita al Musée d’Orsay, è stata fermata all’ingresso da solerti guardiane
(donne pure loro): non aveva la mascherina? Aveva la febbre? Non si voleva
detergere le mani? Niente di tutto ciò, semplicemente la ragazza si era
presentata con un abito scollato, come se ne usano tanti nella calda estate, che
lasciava intravedere un seno piuttosto generoso. Al museo ci si veste più
decorosamente, le hanno detto, o ti copri o non entri. La giovane ha obbedito,
ma dopo aver concluso la visita ha pubblicato un post sui social raccontando
l’accaduto, di cui non risultano precedenti almeno in Occidente. Notizia ripresa
dalle maggiori testate, il dibattito divide le opinioni tra chi evidentemente
equipara il museo a una chiesa (nonostante le numerose opere a soggetto sacro il
museo non è un luogo di culto) e chi sostiene che di questo passo arriveremo
presto ai diktat della Santa Inquisizione. Mi prendo la responsabilità di ciò
che sto per scrivere e se da qua in poi qualcuno mi odierà, pazienza. Evviva chi
mostra il proprio bel corpo, soprattutto il seno che è un inno alla vita, alla
maternità, alla sessualità. Lo avevano capito i pittori, Botticelli e Velazquez,
Tiziano e Goya: oggi lasciamo decidere al personale di sorveglianza? Altre
sarebbero le cose da vietare per decenza:
le canotte su braccia mollicce con relativo alone di sudore.
I bermuda e i pinocchietti su gambe pelose, prevalentemente
maschili.
Sandali tipo Birkenstock su piedi nudi, prevalentemente maschili,
con unghie mal curate. Agli uomini andrebbe fatto obbligo, tranne che in
spiaggia, l’uso della scarpa chiusa.
Tshirt con marchi troppo vistosi, a meno che uno non sia pagato
dall’azienda a scopo pubblicitario.
Fantasmino o calzino corto che fuoriesce dal mocassino.
Un’aberrazione.
Mutandone bianco o nero reso troppo visibile da stoffe
trasparenti.
Capelli sporchi, mal curati, con evidente ricrescita o tintura
dozzinale.
La regola da osservare è che da una certa età in poi è meglio
coprirsi. In quanto alla giovane e bella orientale, obbligarla a chiudere il
decolleté è un sopruso politico indecente, specchio di una società malata che
sta tornando al Medioevo.
Le guerre oscure del Sahel. Davide
Bartoccini il 28 agosto 2020 su Inside Over. Si sta combattendo una
brutta guerra in Sahel. Una guerra complessa, asimmetrica, nella quale si
mischiano e si scontrano reclute di eserciti locali, poco preparate e mal
armate, terroristi sanguinosi e risoluti, e soldati europei, che nonostante
l’impiego delle armi e dei mezzi più sofisticati, non riescono ad arginare in
nessun modo la minaccia. Uno scenario che ha tutte le carte per diventare il
vero nuovo fronte caldo della “guerra santa”, combattuta ciecamente dalle ultime
bandiere nere dell’integralismo islamico. Sono state definite come ” due guerre
parallele”, quelle che si stanno consumando in Niger, Mali e Burkina Faso: i
fronti più caldi della fascia Sahel, dove soldati con armi sorpassate, uniformi
spaiate, e un addestramento basilare, talvolta lacunoso, vengono coadiuvati da
specialisti delle truppe d’élite francesi – ora anche italiane – e si scontrano
in una guerriglia sanguinosa che, dalle operazioni per l’eliminazione di
bersagli “hunting-killer” condotte con i droni, finiscono per sfociare in
“massacri e esecuzioni sommarie”. Mettendo sotto accusa il governo di Parigi,
che tace su quelle che parrebbero essere delle ritorsioni mosse dalla
frustrazione. Una frustrazione condivisa con i vertici militari francesi, che
non riescono a venir fuori da quella che più volte abbiamo definito
“l’Afghanistan francese“. Due guerre perché mentre le forze speciali francesi
conducono raid chirurgici – emulando i Navy Seal in Medio Oriente, ed eliminando
“bersagli di alto valore” come il leader di Al Qaeda nel Maghreb islamico,
Abdelmalek Droukdel -, gli eserciti che fanno capo ai governi africani che
Parigi supporta fornendogli armi e addestramento si stanno macchiando di veri e
propri massacri inter-etnici nel corso di quelle che dovrebbero essere delle
“operazioni anti-terrorismo“. A denunciarlo è stata per prima Amnesty
International. Sarebbero almeno 200- secondo l’organizzazione non governativa –
le vittime civili poi seppellite in fosse comuni localizzate in zone desertiche
e isolate. Morti che andrebbero a sommarsi – sempre secondo le medesime fonti –
alle “vittime collaterali” dei raid e delle operazioni condotte dai droni e dai
commando francesi – che reclamano l’eliminazione di oltre mille terroristi
affiliati alle cellule dei gruppi jihadisti attivi negli Stati che formano il
noto G5. Eliminazioni che non risultano essere sufficienti ad arginare la
minaccia, anzi, al contrario starebbero “gonfiando” le fila dei gruppi
islamisti, riproducendo lo stesso circolo vizioso cui si è assistito per
trent’anni in Afghanistan. Violazioni dei diritti umani, arresti, esecuzioni
sommarie e vittime collaterali porterebbero molti giovani ad unirsi ai militanti
del jihad che terrorizzano le reclute degli eserciti regolari – già vittime di
numerosi devastanti attentati – e spesso le inducono a gettare le armi per
unirsi a loro. Ibrahim Traoré, ricercatore dell’Institut d’études de sécurité di
Bamako citato nel reportage di Pietro Del Re su Repubblica, spiega come “la
strategia anti-jihadista dell’ex potenza coloniale” si sia rivelata
“controproducente”, dato l’incremento di violenza cui si è assistito negli
ultimi otto anni. “Dall’inizio dell’intervento di Parigi, nel 2013, i gruppi
armati si sono moltiplicati e l’anno scorso nel Sahel gli attentati sono
aumentati del 70%”, spiega il ricercatore. Gruppi che nell’ultimo decennio si
sono ben organizzati ed espansi fino a mettere i generali di Parigi di fronte a
una scelta estremamente delicata: abbandonare il campo e concedere la vittoria
ai terroristi; oppure inviare rinforzi, uomini e mezzi, alzando la posta in
gioco. Rinforzi che il ministro della Difesa francese ha chiesto apertamente
anche all’Europa. Nell’intenzione di formare un nuovo comando interforze analogo
a quello che venne allestito contro l’Isis nel Siraq. Secondo quanto sostenuto
dalle fonti locali, le esecuzioni sommarie commesse dalle milizie locali che
cooperano con l’esercito francese, hanno trovato una sorta di assoluzione da
parte di Parigi, che estranea ai fatti sembra non essere al corrente di tali
accadimenti. Anche se è difficile credere che l’intelligence francese fosse
completamente all’oscuro di ciò che viene denunciato da Amnesty International.
Dato che si sarebbe consumato in zone dove si muovono e operano continuamene
soldati francesi e dove l’occhio vigile dei servizi segreti è sempre allerta.
Ciò lascia quasi pensare, con il beneficio del dubbio, che di fronte a
questi metodi barbari, ci si sia limitato a chiudere gli occhi per non
aggiungere un’ulteriore problematica di difficile risoluzione, all’interno di un
conflitto che sembrerebbe essere già lungi dall’essere vinto. Ma sono solo
supposizioni fino a quando non ci saranno prove più schiaccianti sulla guerra
sporca del Sahel.
Lite
Algeri-Parigi sui resti dell'era coloniale. "La Francia ci deve ancora chiedere
scusa".
Pubblicato lunedì, 06 luglio 2020 su La Repubblica.it da Ettore
Livini. L'Algeria ha seppellito ieri, nel giorno della festa dell'indipendenza,
i resti di 24 combattenti caduti all'inizio dell'occupazione transalpina nel XIX
secolo e ha ribadito di attendersi ancora le scuse della Francia per quel
periodo storico. I teschi sono stati conservati per anni da un museo parigino e
dopo la restituzione ad Algeri sono stati inumati nel cimitero dei martiri della
rivoluzione algerina di El Alia, accanto ai resti dei capi di Stato. Alla
cerimonia ha partecipato il presidente della Repubblica Abdelmadjid Tebboune.
Algeri ha chiesto per la prima volta ufficialmente nel 2018 i resti dello
sceicco Bouziane, capo della rivoluzione dei Buzian, e dei suoi compagni d'armi,
catturati e passati per le armi all'inizio del periodo colonale durato dal 1830
al 1962, conservati al Museo nazionale di storia di Parigi. E lo stesso Macron
si era impegnato a onorare l'impegno. "E' un segno d'amicizia per riparare le
ferite della storia", ha spiegato. Nello stesso periodo, prima della sua
elezione, aveva etichettato il periodo coloniale come "un crimine contro
l'umanità" attirandosi molte critiche da destra. Al presidente algerino però non
basta. Intervistato sabato dalla tv France 24, ha detto che è necessario
"affrontare il problema della memoria che ipoteca molte cose nelle relazioni tra
i due Paesi". E sulle possibili scuse di Parigi, è stato chiarissimo: "Abbiamo
già ricevuto mezze scuse. Occorre fare un altro passo. Lo vogliamo. Contribuirà
a calmare il clima e renderlo più sereno per le relazioni economiche, le
relazioni culturali, le relazioni di vicinato".
Stefano Montefiori per il “Corriere della Sera” il 30 giugno
2020. Nascosti per ore dietro le mascherine anti-virus pur non obbligatorie,
seduti nel nuovo tribunale di Parigi, quello pieno di luce disegnato da Renzo
Piano, l'ex premier francese François Fillon e sua moglie Penelope ascoltano
cupi la giudice Nathalie Gavarino pronunciare la sentenza di condanna - cinque
anni di carcere per lui, tre per lei - assortita di frasi tremende: «Il
contributo della signora Fillon si limitava alla presenza a qualche
manifestazione locale, al racconto di qualche aneddoto»; l'ex premier «ha
mancato al suo dovere di probità» e al suo «dovere di esemplarità»; ha fatto
prevalere «il suo interesse a fini di arricchimento personale», ha contribuito a
«erodere la fiducia dei cittadini», ha «rovinato la vita della democrazia». La
ramanzina della giudice Gavarino è così dura e le accuse talmente vaste - pure
la crisi planetaria della rappresentanza politica sembra colpa di Fillon - che a
un certo punto è difficile reprimere un moto di simpatia per l'uomo che fino al
25 gennaio 2017 - giorno di uscita dell'articolo sul Canard enchaîné - era
pressoché certo di diventare a maggio il nuovo presidente della Repubblica
francese. Ma al di là dei toni moraleggianti della giudice, il tribunale ha
stabilito che François Fillon si è impossessato illegalmente di oltre un milione
di euro. Insomma sembra vero quel che era apparso subito anche ai meno inclini
al giustizialismo, ovvero che i Fillon l'hanno combinata grossa. Penelope
Fillon, nata Clarke nel Galles 64 anni fa, non è mai stata l'assistente
parlamentare dell'ex potente uomo politico francese, come lei stessa spiegava in
una candida intervista televisiva del 2007. Però il suo impiego fittizio a spese
dei contribuenti ha fruttato ai Fillon centinaia di migliaia di euro. Poi ci
sono i 46 mila euro per i finti lavori parlamentari dei figli Marie e Charles
Fillon, e 78 mila euro per il ruolo di Penelope - fasullo anche quello - come
consulente editoriale alla «Revue des deux mondes» edita dall'uomo d'affari
amico di famiglia Marc Ladreit de Lacharrière. Un totale di 1 milione 155 mila
701 euro «totalmente ingiustificabili» ma comunque entrati nelle casse di un
uomo di Stato sempre in bilico tra proclami sulla virtù borghese
dell'oculatezza, e le foto della coppia con i cinque figli davanti al castello
di proprietà nella Sarthe, sotto titoli di grande umorismo postumo come «per
governare bene bisogna essere equilibrati». Fino a quel giorno di gennaio 2017,
tutto o quasi era andato liscio nella vita non solo politica di Fillon. Una
famiglia numerosa e unita, una carriera parlamentare nella destra gollista
iniziata presto, a 27 anni (nel 1981 era il più giovane deputato francese), fino
all'incarico di premier dal 2007 al 2012, sotto la presidenza Sarkozy. Dopo
avere battuto Alain Juppé e lo stesso Sarkozy nelle primarie della destra, nel
gennaio 2017 i sondaggi davano Fillon sicuro vincitore nella corsa all'Eliseo.
Lo scoop del Canard enchaîné lo ha frenato, ai comizi la gente gli urlava «ridai
indietro i soldi», cosa che da ieri pretende anche il tribunale. Fillon ha
presentato immediatamente appello e resta un uomo libero fino al nuovo processo.
Gli avvocati denunciano l'accanimento nei suoi confronti, e l'appello -
dall'esito non scontato - si giocherà sulle frasi della ex procuratrice
nazionale finanziaria Éliane Houlette, che ha denunciato «pressioni» della
gerarchia sul caso Fillon. Il presidente Macron ha chiesto l'intervento del
Consiglio superiore della magistratura.
L’islamismo politico si infiltra alle amministrative francesi.
Giovanni Giacalone il 29 giugno 2020 su Inside Over.
Domenica 28 giugno la Francia è chiamata al voto per le amministrative con 4820
seggi aperti, tra cui in grandi città come Lione, Marsiglia, Montpellier, Le
Havre e Tolosa ed è proprio in quest’ultima, quarta città francese, che la
coalizione di sinistra “Archipel Citoyen”, guidata dall’ecologista Antoine
Maurice, si è alleata con un partito islamista, l’Union des démocrates musulmans
français–Udmf, indicato come legato ai Fratelli Musulmani, con l’obiettivo di
sconfiggere il sindaco uscente repubblicano Jean-Luc Moudenc, in carica dal
2014, cattolico praticante e noto per aver votato contro i matrimoni
omosessuali. Cosa può portare un partito islamista a schierarsi assieme alla
laica sinistra? Plausibilmente il tentativo di raccogliere più voti possibile,
visto che a destra non ne racimolerebbero molti. Esaminando idee e
proposte dell’Udmf, la prospettiva sembra chiara e ben poco laica: divulgazione
dell’Islam, insegnamento della lingua araba, sviluppo della finanza islamica e
dell’alimentazione halal, lotta alla cosiddetta “islamofobia” (che rischia però
di diventare lotta contro chiunque osi criticare l’Islam) con tanto di richiesta
di formazione di un direttivo europeo con l’obiettivo di monitorare ed
eventualmente far chiudere di tutti i gruppi e media “islamofobi”. L’Udmf è
ovviamente contraria alla legge anti-velo del 2004 e a favore dell’uscita della
Francia dalla Nato. Oltre ad aver proposto di conferire il diritto di voto anche
agli stranieri, l’Udmf porta avanti pure un discorso che la giornalista Judith
Waintraub ha definito “vittimistico, con l’intento di sedurre l’elettorato
musulmano”; una retorica anti-imperialista che enfatizza il vittimismo
ricollegato alla colonizzazione francese. Un aspetto che sinistra e Udmf possono
chiaramente condividere è l’anti-sionismo e non a caso il collettivo “Palestine
Vaincra” (legata alla Bds- Boycott, disinvestment and sanctions) si
era mobilitata già ad inizio anno a Tolosa per accusare il candidato
repubblicano Moudenc di essere “fedelissimo di Israele” e contestando il
gemellaggio tra la città francese e Tel Aviv.
Il “cavallo di Troia” islamista verso la politica francese. Il
partito Udmf veniva fondato nel novembre del 2012 dal franco-marocchino Nagib
Azergui, con l’obiettivo di “permettere ai musulmani di creare alternative
all’interno della società francese”, un’affermazione che dice tutto. Eloquente
anche la dichiarazione del rappresentante dell’Udmf a Tolosa, Mhamdi Taoufik,
che ha invitato i musulmani “che hanno a cuore la Repubblica e la religione” di
recarsi a votare (per Antoine Maurice) in modo da sbarrare la strada a Moudenc.
Un chiaro utilizzo della religione per fini politici. La pagina Facebook di
Taoufik non lascia dubbi sul suo sostegno all’islamismo politico, ai Fratelli
Musulmani e al sentimento anti-israeliano, sentimento che sembra condiviso anche
dal candidato di sinistra Antoine Maurice, visto che l’immagine del profilo di
Taoufik mostra la sua foto con tanto di scritta “no all’annessione della
Cisgiordania! Palestina libera! Antoine Maurice, Archipel Citoyen”. Nel giugno
del 2019 Taoufik pubblicava invece la foto dell’ex presidente islamista
egiziano Mohamed Morsy, legato ai Fratelli Musulmani, definendolo “coraggioso e
determinato” ed invitando gli altri utenti a condividerne la foto. Vale la pena
ricordare che la Arabic Network for Human Rights Information denunciò il triste
record dell’”epoca Morsi” per quanto riguardava i provvedimenti legali nei
confronti di giornalisti e personaggi legati ai media. Secondo tale rapporto il
numero di denunce sarebbe di quattro volte maggiore rispetto all’era Mubarak e
ventiquattro volte più grande rispetto a quella di Sadat (Mubarak rimase al
potere per trent’anni, Sadat per undici anni e Morsi soltanto per un anno). Nel
febbraio del 2018 Taoufik prendeva invece le difese di Tariq Ramadan,
intellettuale islamista nipote del fondatore dei Fratelli
Musulmani, arrestato con l’accusa di aver stuprato diverse donne tra cui una
disabile e con nuove accuse nei suoi confronti emerse a inizio 2020. Nel
novembre del 2015 invece Taoufik pubblicava un post dal titolo “urgente urgente
urgente” dove lamentava una “visita” a casa sua di una cinquantina di uomini
del Raid, le forze d’intervento speciale della polizia francese e chiedeva
consigli per un buon avvocato. Interessante anche la bandiera nera con
la shahada (testimonianza di fede islamica), frequentemente utilizzata anche dai
jihadisti. L’imprenditore franco-tunisino Jean-Pierre Marongiu conosce molto
bene l’islamismo ed anche uno dei suoi Paesi sponsor, il Qatar ed
ha definito l’Udmf come “cavallo di Troia per la propagazione dell’islamismo in
territorio francese”; una strategia messa in atto anche in altri Paesi come Gran
Bretagna, Stati Uniti ed anche in Italia. L’islamismo radicale punta così ad
infiltrarsi nel sistema politico-istituzionale sfruttando i meccanismi
democratici dei Paesi occidentali per poi apportare cambiamenti che vanno contro
i principi di libertà e democrazia, come ad esempio la censura mediatica con la
scusa dell’islamofobia. Del resto due esempi chiari di islamismo politico (in
salsa Fratelli Musulmani) sono l’anno di governo Morsy in Egitto e la Turchia
di Erdogan, che non ha certo bisogno di presentazioni. Entrambi sono andati al
potere con meccanismi vagamente democratici ed entrambi hanno mostrato ben poco
di democratico. E’ bene tener presente i punti di riferimento di questi
esponenti islamisti che si insediano all’interno dei meccanismi europei, perchè
una volta all’opera, seguiranno le stesse orme.
ANAIS GINORI per la Repubblica il 24 giugno 2020. «Sto
soffocando», urla Cedric Chouviat, il fattorino di 42 anni morto dopo un
controllo stradale avvenuto nel gennaio scorso a Parigi. Le ultime disperate
parole di Cedric emergono adesso in un filmato al vaglio degli investigatori.
Che ricorda quello che è successo a Minneapolis qualche settimana fa. Chouviat
come George Floyd? È quello che denuncia la famiglia che da mesi chiede verità
su quello che è successo la mattina del 3 gennaio vicino alla Tour Eiffel. Nelle
immagini Chouviat appare bloccato terra, con tre agenti poggiati sopra di lui.
«Sto soffocando », ripete ben sette volte il fattorino. Quando arriva in
ospedale è troppo tardi: i referti parlano di una frattura della laringe e danni
cerebrali per inizio di asfissia. Sposato, cinque figli, morirà due giorni dopo.
Alle 9.54 quattro agenti, tra cui una donna, fermano lo scooter di Cedric perché
- scrive il rapporto di polizia - l'uomo sta guidando con il cellulare in mano e
ha la targa della moto parzialmente illeggibile. Le cose si mettono subito male.
Cédric mostra insofferenza per il controllo e la multa che stanno verbalizzando
gli agenti. Comincia a filmarli con il cellulare. Loro si ribellano, vogliono
fermarlo. «È un mio diritto», dice il fattorino. «Vuole fare spettacolo?»,
chiede un poliziotto. «Senza la divisa non siete nulla», risponde Cedric. È
un'escalation. «Non penserai mica che mi debba mettere a quattro zampe e te lo
succhio?», dice un poliziotto quando l'uomo gli chiede di essere più corretto
nei modi. Sono passati già dieci minuti da quando Cedric è stato fermato. E per
tre volte gli agenti fanno per andarsene, poi ci ripensano. Uno dei poliziotti
già risalito in macchina, esce convinto di aver sentito un insulto. Cedric
tratta gli agenti da "pagliacci", "pupazzi". Alle 10.07 scatta la procedura di
arresto con la cosiddetta "tecnica di soffocamento" e "placcaggio". L'uomo viene
immobilizzato a terra, tenuto per il collo, con il peso di tre agenti sulla
schiena. «Sto soffocando». È l'ultimo grido di aiuto che si sente nella
registrazione. Alle 10.13 Cedric ha perso i sensi, gli agenti tentano un
massaggio cardiaco, lanciano l'allerta. «Aspettiamo delle risposte da Emmanuel
Macron», dice ora Sofia Chouviat, figlia dell'uomo. Dopo le rivelazioni, la
famiglia chiede giustizia. I quattro agenti coinvolti nell'arresto non sono
finora stati sospesi. La settimana scorsa sono stati fermati e interrogati
nell'inchiesta che al momento procede per omicidio colposo. Impossibile non
vedere un'accelerazione delle indagini alla luce con il caso Floyd e della
mobilitazione che cresce anche in Francia. Un altro simbolo della protesta
Oltralpe è il caso di Adama Traoré, morto anche lui per asfissia nel 2016, dopo
un arresto di gendarmi nella periferia di Parigi. Nel caso di Traoré non
esistono però video né testimonianze di prima mano. La morte di Chouviat avviene
in diretta. Il fattorino ha filmato la scena fino a un certo punto e il
microfono nel suo casco ha registrato fino alla fine. Altri passanti hanno
ripreso alcuni spezzoni dell'arresto in centro i n pieno giorno. Qualche
settimana fa, il governo aveva accolto le proteste degli attivisti, annunciando
di voler bandire la "tecnica di soffocamento". La rivolta delle forze
dell'ordine, che hanno manifestato contro il ministro dell'Interno perché
sostengono di averne bisogno davanti a sospetti violenti, ha convinto
l'esecutivo a rimandare questo bando.
Da "lastampa.it" il 18 giugno 2020. E' polemica in Francia per il
violento arresto di un'infermiera in camice bianco durante la manifestazione dei
sanitari ieri a Parigi. Un video, visto già oltre due milioni di volte sui
social, mostra poliziotti in assetto antisommossa che tengono la donna bloccata
a terra e poi la trascinano con violenza. Una scena che fa discutere, dopo che,
sull'onda del caso George Floyd negli Stati Uniti, la polizia francese è
recentemente tornata sotto accusa per comportamenti violenti. "Questa donna è
mia madre - ha poi twittato la figlia - ha 50 anni, è infermiera, per tre mesi
ha lavorato fra le 12 e le 14 ore al giorno. Ha avuto il covid. Manifestava
perché rivalutino il suo salario, perché riconoscano il suo lavoro. E' asmatica.
Aveva il camice. E' alta 1,55 metri". Ieri sera c'è stato un assembramento
davanti al commissariato dove era rinchiusa per chiedere la liberazione
"dell'infermiera Farida", poi chiesta su Twitter dal leader della sinistra
radicale Jean Luc Melenchon.
Da eroi a “criminali”: polemiche in Francia per il violento
arresto dell’infermiera. su Il Dubbio il 17 giugno
2020. I poliziotti in assetto antisommossa hanno bloccato la donna a terra per
poi trascinarla per i capelli durante le proteste dei sanitari. Si potrebbe
definire un nuovo caso Floyd, se non fosse che la vittima è ancora in vita. Ma
la violenza non è da meno. Vittima, questa volta, è un’infermiera in camice
bianco, arrestata ieri a Parigi durante la manifestazione dei sanitari. Il
momento, anche in questo caso, è immortalato da un video, già visto oltre due
milioni di volte sui social, nel quale si vedono i poliziotti in assetto
antisommossa che tengono la donna bloccata a terra e poi la trascinano per i
capelli, con le mani trattenute dietro la schiena. Una scena che fa discutere,
dopo che, sull’onda del caso George Floyd negli Stati Uniti, la polizia francese
è recentemente tornata sotto accusa per comportamenti violenti. «Questa donna è
mia madre – ha poi twittato la figlia – ha 50 anni, è infermiera, per tre mesi
ha lavorato fra le 12 e le 14 ore al giorno. Ha avuto il covid. Manifestava
perché rivalutino il suo salario, perché riconoscano il suo lavoro. È asmatica.
Aveva il camice. È alta 1,55 metri». Nel video si vedono decine di poliziotti
tenere bloccata la donna a terra, senza che la stessa possa opporre resistenza.
Davanti al commissariato dove è rinchiusa, ieri sera un gruppo di persone si è
riunito per chiedere la liberazione «dell’infermiera Farida», poi invocata su
Twitter dal leader della sinistra radicale Jean Luc Melenchon. Fonti della
polizia hanno intanto detto a Le Figaro che l’infermiera è stata arrestata per
«lancio di proiettili contro le forze dell’ordine», come dimostrerebbero altri
video, alcuni dei quali vengono ora condivisi sui social. Salutati come eroi
della lotta al coronavirus, gli operatori sanitari hanno manifestato per
ottenere aumenti di salario. Circa 1800 persone hanno manifestato sulla spianata
degli Invalides. Ma la protesta, nella quale si erano infiltrati dei
“blackblock”, è poi degenerata in scontri con la polizia, terminati con 32
arresti.
ANAIS GINORI per repubblica.it il 12 giugno 2020. Clamoroso
scontro tra Marine Le Pen e la nipote Marion Maréchal a proposito del
movimento Black Lives Matter, seguito anche in Francia con vari raduni. La
giovane delfina di casa Le Pen, in teoria ritirata dalla politica, ma sempre in
rampa di lancio per prendersi la leadership, ha pubblicato un video per
dissociarsi dalle manifestazioni contro il razzismo. L'ex deputata commenta:
"Non devo scusarmi come bianca e come francese per la morte di un afroamericano
negli Stati Uniti". Poi accusa "gruppi militanti, di sinistra, cosiddetti
antirazzisti, che pretendono non solo di metterci in ginocchio, ma anche di
macchiare la memoria dei nostri antenati, di sputare sulla nostra storia, di
purgare il nostro patrimonio, di demolire le nostre statue". Maréchal cita anche
il paragone tra Floyd e Adama Traoré, l'uomo francese morto nel 2016 durante un
fermo di polizia diventato un simbolo della mobilitazione di questi giorni in
Francia. Un "incidente", sostiene Maréchal, "avvenuto durante un fermo che non
era legato al colore della sua pelle, ma ai crimini che avrebbe commesso". È la
presidente del Rassemblement National a rispondere poche ore dopo la diffusione
del video, smarcandosi nettamente dalla nipote accusata di "cadere in una doppia
trappola". "Significa entrare in uno scontro razziale mentre dobbiamo rimanere a
livello repubblicano" dice Le Pen. "L'altra trappola - prosegue - è quella
dell'americanizzazione. Io preferisco prendere posizione in difesa della nostra
Costituzione, che rifiuta qualsiasi comunitarismo". La leader dell'estrema
destra ha ricordato che la nipote "non fa più politica". "Ma ha il diritto di
esprimere un'opinione" ha aggiunto facendo calare il gelo con quella che fino a
qualche anno fa era l'astro nascente della dinastia Le Pen. Maréchal, 30 anni,
ha deciso tre anni fa di aprire una scuola di studi politici a Lione che
dovrebbe aprire una succursale in Spagna grazie all'aiuto di alcuni dirigenti di
Vox. Maréchal ha anche allacciato relazioni negli Stati Uniti con l'alt right,
nel 2018 era stata invitata al Conservative Political Action Conference (Cpac),
ed è compagna dell'eurodeputato della Lega, Vincenzo Sofo. Intanto sale la
tensione tra governo e polizia dopo che il ministro dell'Interno ha annunciato
di voler sospendere l'uso della "tecnica per soffocamento" nel fermo di
sospetti. La decisione è stata presa sull'onda delle proteste importate dagli
Stati Uniti e che fanno temere alle autorità francesi una situazione esplosiva
in particolare nelle banlieue. Il governo ha anche promesso tolleranza zero
verso atti razzisti e la possibilità di sospendere agenti in caso di fatti
sospetti di discriminazione, senza aspettare le indagini interne. I sindacati di
polizia hanno reagito accusando il governo di non tenere conto delle difficoltà
del loro lavoro e hanno messo in scena un'inedita protesta: piccoli raduni di
agenti hanno manifestato davanti a Prefetture e commissariati buttando a terra
le manette. "Non viviamo nel mondo dei sogni" hanno detto alcuni rappresentanti
sindacali. Il divieto della "tecnica per soffocamento" nelle procedure di
arresto equivale, secondo i sindacati, a lasciarli senza mezzi per fermare le
persone più violente. La rabbia nelle forze dell'ordine è tale che il Direttore
Generale della Polizia Nazionale, Frédéric Veaux, e il Prefetto di Polizia di
Parigi, Didier Lallement, hanno scritto agli agenti per assicurare loro il loro
sostegno e la loro fiducia.
LA POLIZIA UCCIDE I NERI PURE NELLA FRANCIA SOCIALISTA.
Giovanni Longoni per “Libero quotidiano” il 4 giugno 2020. In
Francia c' è un caso che assomiglia a quello di George Floyd, l' afroamericano
di 46 anni soffocato dall' agente della polizia di Minneapolis Derek Chauvin, 44
anni, lo scorso 25 maggio. Si tratta della morte - avvenuta il 19 luglio 2016 -
di Adama Traorè, nero di 24 anni, mentre era in stato di arresto in una caserma
della Gendarmeria. Martedì scorso migliaia di persone hanno manifestato in
numerose città transalpine (Parigi, Lille, Lione e Marsiglia) contro la violenza
delle forze dell' ordine. Nella capitale la sfilata è degenerata in scontri con
la polizia e circa 18 persone sono finite in arresto. Fin qui, le somiglianze
fra le due vicende. La differenza macroscopica è che di Floyd e dei disordini
scoppiati un po' ovunque negli Stati Uniti leggiamo sulle prime pagine dei
quotidiani di tutto il mondo, mentre sulla morte e sugli scontri per Traorè c' è
poca attenzione, soprattutto in Italia. Non basta dire che è una questione di
proporzioni: cioè che i "riots" che stanno facendo vacillare la stabilità del
gigante americano (già provato dall' emergenza Covid-19) sono un evento più
importante dei 20mila "casseurs", di cui molti adolescenti, che hanno dato l'
assalto al palazzo di giustizia parigino. In realtà, la morte di Adama è ancora
più inquietante di quella di George: perché sotto accusa non sono "sceriffi"
assoldati da amministrazioni locali Usa che non vanno tanto per il sottile nel
reprimere i crimini e che fanno del pregiudizio contro neri e latini (racial
profiling) la base del loro mestiere. Sul banco degli imputati qui c' è la
Gendarmerie francese, forza di polizia di uno Stato europeo, ben addestrata e i
cui vertici hanno chiaro che il loro compito è anche politico. Altro fattore che
rende le violenze transalpine importanti è la facilità con cui le banlieue
esplodono in rivolte a sfondo razziale. Come negli Usa, se non peggio. Quindi ci
si può chiedere se la disparità di trattamento mediatico non dipenda dal fatto
che le violenze americane si possono usare per screditare il presidente Trump,
mentre quelle francesi no (si rammenti che il caso Traorè inizia quattro anni
fa, cioè quando all' Eliseo non c' era Macron bensì il socialista Hollande).
Adama Traorè venne arrestato dai gendarmi dopo un inseguimento e la fuga al
primo tentativo di arresto. Passarono due ore e venne trovato morto nella
caserma di Persan (Val d' Oise, hinterland parigino). A oggi è ancora in corso
l' inchiesta su cause e responsabilità: al centro delle polemiche, l' esito
delle varie perizie fatte eseguire a medici ed esperti sia dalle autorità che
dalla famiglia. L'ultimo rapporto commissionato dai Traorè, pubblicato questa
settimana, ha capovolto le conclusioni della perizia ufficiale che respingeva la
responsabilità di tre gendarmi. Gli agenti hanno al momento lo statuto di
testimoni per omesso soccorso a persona in pericolo. La nuova perizia
attribuisce invece il decesso di Traorè a una «sindrome da asfissia a seguito di
un edema cardiogenico provocato da una asfissia da posizionamento indotta dal
placcaggio ventrale». Per il legale della famiglia, Yassine Bouzrou, «questa
nuova perizia smonta punto dopo punto quella ufficiale della scorsa settimana,
comprovando che sia stato il placcaggio ventrale a causare la morte del
giovane». Le parti civili hanno 10 giorni a disposizione per chiedere ai giudici
di far procedere ad una nuova controperizia. Ma gli scontri di piazza repressi
dalla polizia con lancio di gas lacrimogeni hanno ridato vigore alle polemiche.
In Parlamento il ministro degli Interni Christophe Castaner ha difeso l' operato
delle forze dell' ordine nella recente vicenda di Gabriel Jovanovioc, un
adolescente di 14 anni gravemente ferito a un occhio durante il suo fermo per
tentato furto di motorino a Bondy (Senna-Saint-Denis). «C'è una polizia
repubblicana che, in questo Paese», ha dichiarato il ministro, «protegge uomini
e donne da tutto, anche dal razzismo. Anche il governo combatte con forza il
razzismo su ogni fronte e ogni qualvolta necessario». In bocca al lupo.
Francesco De Remigis per “il Giornale” il 4 giugno 2020. C' è un
filo di rabbia che lega New York a Parigi: il caso di Adama Traoré, deceduto il
19 luglio 2016 nel giorno del 24esimo compleanno dopo un fermo di polizia nella
banlieue. Le autorità hanno sempre escluso responsabilità. Martedì sera è
arrivata la versione della sorella: asfissiato per «placcaggio ventrale» dal
gendarme che lo immobilizzava. A dirlo, la controperizia della famiglia in un
timing perfetto per innescare una miccia già imbevuta Oltralpe. Quella delle
rivolte sociali. Basta un pretesto per ripartire. L' ennesima autopsia, la
terza, ha infatti scatenato una nuova protesta dei «neri di Francia». Chiedono
giustizia al grido di «Traoré come Floyd»: slogan in inglese, rabbia connessa
agli eventi sull' altra sponda dell' Atlantico e 20mila persone disperse a colpi
di gas lacrimogeni martedì. Un milione di euro di danni e 18 arresti in una
manifestazione davanti al tribunale parigino. Dopo la pubblicazione del nuovo
rapporto che coinvolge i gendarmi nella morte del ragazzo, la sorella soffia sul
fuoco: «Non è più la battaglia della famiglia Traoré, ma di tutti voi». Detto,
fatto. Ville Lumière illuminata dai fumogeni e dose rincarata sui media, ieri:
«La morte di Floyd ricorda quella del mio fratellino», dice Assa in tv. Non
chiede solo «giustizia» per il 24enne, accende gli animi (e la banlieue). Sulla
carta, i «neri di Francia» hanno risposto alla chiamata del comitato di supporto
alla famiglia del 24enne. Un «omaggio al Floyd di Parigi» contro ogni violenza
della polizia però trasformato in un campo di battaglia, facendo piombare Parigi
in un' atmosfera simile a quella newyorkese. Arredo urbano distrutto, negozi
alle fiamme. Scontri a Porte de Clichy. È tornato l' incubo della banlieue?
L'avvocato di due dei tre gendarmi che arrestarono Traoré, Rodolphe Bosselut, ha
l' impressione «che ci sia uno sfruttamento delle notizie americane, stanno
cercando di importarle in Francia, nulla a che fare con Traoré». La portavoce
del governo chiede «pacificazione», rifiutando il parallelismo: prudenza, dice
Sibeth Ndiaye, «situazione non comparabile né sul piano storico, né sociale».
Inevitabile, però, riportare l' orologio al 2005, alla rivolta della banlieue
che colpì duramente Parigi. «Smettete di chiamarli giovani - disse l' allora
ministro dell' Interno Sarkozy in tv - sono feccia, canaglie, ribadisco e
firmo». Allora si infuriò il campione del mondo Lilian Thuram. Oggi c' è Kylian
Mbappé in prima fila a stigmatizzare certe derive. «La violenza di Stato non è
insita nel nostro Paese», insiste l' esecutivo. Ma tutto si svolge in un clima
che vede da tempo le forze dell' ordine accusate di sproporzionato uso della
forza: nel 2014, nel 2016 e contro i gilet gialli. A inizio anno Macron parlò di
«migliorare la deontologia» dei gendarmi. Il precedente di Sarkozy che definì
«feccia» i casseur, termine usato anche da Trump, è vivo. Pronto a infuocare le
piazze e non più solo le periferie. Insiste la sorella di Traoré. «L'unico
responsabile degli scontri è il prefetto Lallement». Che ribatte: «Polizia né
violenta, né razzista». In serata è dovuto intervenire in Parlamento il ministro
dell' Interno Castaner: «Ogni responsabilità, comprese espressioni razziste,
sarà oggetto d' indagine e punita». Memore, forse, dell'assoluzione del 2015 per
gli agenti che scatenarono la rivolta di dieci anni prima.
L’odio anti italiano ha passaporto francese.
Andrea Indini il 3 marzo 2020 su Il Giornale. Non fa affatto ridere la
caricatura del pizzaiolo italiano malato di coronavirus che starnutisce e sputa
sulla quattro stagioni che ha appena finito di cucinare. Come non erano per
nulla divertenti le vignette di Charlie Hebdo sul terremoto, che nel 2016 aveva
fatto 300 morti in Centro Italia, e sulla tragedia dell’Hotel Rigopiano di
Farindoli travolto l’anno dopo da una valanga di neve. A questo giro, a fare
della volgare ironia sul nostro Paese, non è stato il giornale parigino ma
l’emittente Canal+ con un video irrispettoso. Ora, in attesa di trovare qualcuno
che con pazienza spieghi ai francesi che non si fa satira in questo modo e tanto
meno su temi così delicati, noi italiani continueremo a combattere a denti
stretti l’emergenza sanitaria come abbiamo fatto in passato. Che i rapporti di
vicinato siano tutt’altro che distesi, è assodato da tempo. Lo cantava pure
Paolo Conte nel 1979 musicando le gesta di Gino Bartali, il campione in maglia
gialla che lascia indietro qualunque avversario. “E i francesi che
s’incazzano…”. Zazzarazaz, zazzarazaz. Oggi a incazzarci siamo, giustamente, noi
italiani dopo che la trasmissione Groland Le Zapoi ci ha pubblicamente derisi
con uno sketch sulla “pizza corona”. Ironia disgustosa non solo per la resa
televisiva ma anche perché arriva in un momento in cui la diffusione del
contagio non solo sta mettendo a dura prova il nostro sistema sanitario ma sta
anche colpendo violentemente la nostra economia. A sollevare la polemica è stata
prontamente Giorgia Meloni che, oltre a prendersela con i cugini d’Oltralpe, ha
sferzato il governo e la maggioranza giallorossa invitandoli a “far sentire il
proprio sdegno”. Dopo diverse ore è, quindi, anche arrivata la presa di
posizione di Luigi Di Maio che, in quanto ministro degli Esteri, ha attivato la
nostra ambasciata a Parigi. La maleducazione dei francesi è ancora stampata nei
sorrisini tra Nicolas Sarkozy e Angela Merkel alle spalle di Silvio Berlusconi e
col tempo ha proliferato anche grazie al mancato sdegno di una certa sinistra
nostrana che godeva nel vedere l’Eliseo attaccare il Cavaliere. Tanto che
qualche anno più tardi, con Matteo Salvini al Viminale, il portavoce di Emmanuel
Macron si era permesso di dire che le politiche portate avanti dal governo
italiano sono “vomitevoli”, salvo poi riversarci (nottetempo) i clandestini nei
boschi di Bardonecchia o accanirsi su una donna incinta pizzicata su un treno a
Mentone. Con i francesi i confini si alzano e si abbassano a seconda della
convenienza: quando devono fare la lezioncina agli italiani si scoprono tutti
democratici, mentre quando devono difendere i propri interessi nazionali
diventano tutti più sovranisti di Marine Le Pen. Ne hanno dato prova anche in
piena emergenza per coronavirus chiedendo l’attuazione di un cordone sanitario
alla barriera con Ventimiglia. Le schermaglie politiche, lo capiamo anche noi,
fanno parte del gioco (sporco) e rientrano in un estenuante braccio di ferro che
l’Unione europea permette da tempo a suo stesso danno. Però, come non
sopportiamo certe ingerenze indebite da parte dell’Eliseo, ancor meno
tolleriamo la becera ironia di Canal+. A questo punto le scuse dell’emittente,
che ha definito la “breve sequenza di pessimo gusto”, giovano a poco. Perché
quel video disgustoso va ad alimentare lo stereotipo dell'”italiano untore”, già
cavalcato da Le Figaro che nei giorni scorsi ha pubblicato un sondaggio secondo
cui il 56% dei francesi scanserebbe les italiens per evitare il contagio. Il
risultato di questa bieca campagna? La fuga dei turisti stranieri dal Belpaese,
il taglio netto delle rotte sui nostri aeroporti e la messa in quarantena di
tutto il made in Italy. Un attacco al nostro sistema economico che pagheremo
caro nei prossimi mesi e che, forse, non è dettato soltanto dalla paura del
contagio.
Fabio Franchini per ilgiornale.it il 3 marzo 2020. Mentre in
Italia il coronavirus ha contagiato 2036 persone, provocando 52 decessi, in
Francia pensano bene di prenderci in giro. Spieghiamo. Canal+, noto canale
televisivo transalpino di proprietà di Vivendi, ha mandato in onda uno spot che
pensando di fare satira e ironia dice: "Questo spettacolo è offerto dalla pizza
Corona. La nuova pizza italiana che farà il giro nel mondo". Ma le parole sono
forse niente rispetto alle immagini. Nel video fa capolino un attore travestito
da pizzaiolo che sforna pizze e tossisce. Ne tira fuori una con la pala e dopo
un colpo di tosse ci sputa (finto) catarro verde, inquadrato in primo piano:
stomachevole. Dunque, compare in sovraimpressione la scritta "Corona pizza" con
la parola "Corona" (in riferimento ovviamente al coronavirus) scritta con i
colori del nostro tricolore. A denunciare la trovata Giorgia Meloni, che sui
propri canali social ha condiviso la clip incriminata, condannandola duramente.
Queste le parole del leader di Fratelli d'Italia: "Video 'satirico' disgustoso
mandato in onda dalla famosa tv francese Canal+ per insinuare che i prodotti
Made in Italy sono contaminati da coronavirus". Dunque, il capo politico di FdI
affonda il colpo, tirando anche le orecchie alla maggioranza giallorossa, alla
quale chiede di provvedimenti: "Disprezzo per gli autori di questa immondizia
anti-italiana. Il Governo Partito Democratico-Movimento 5 Stelle avrà la decenza
di far sentire il proprio sdegno?". Non è la prima volta che di fronte a certe
situazioni delicate italiane, i cugini francesi facciano cattiva satira. Come
dimenticare, a tal proposito, le scioccanti copertine di Charlie Hebdo dopo il
crollo del ponte Morandi – il viadotto distrutto, un'automobile schiantata al
suolo e un migrante in primo piano con una scopa in mano e il titolo "costruito
dagli italiani…pulito dai migranti" – e la tragedia di Rigopiano: nel disegno la
rappresentazione della "Morte" intenta a sciare in montana con due falci al
posto delle racchette e la scritta "è arrivata la neve".
(ANSA il 3 marzo 2020) - "Il video francese che irride l'Italia è
irricevibile. Pretendiamo scuse ministro Di Maio". Lo scrive su Facebook il
responsabile Esteri del Pd, Emanuele Fiano, riferendosi al video di Canal+.
Canal Plus ritira il video anti italiano. «Di cattivo gusto,
chiediamo scusa». Pubblicato martedì, 03 marzo 2020
su Corriere.it da Stefano Montefiori. Canal Plus ritira da tutte le sue
piattaforme e sopprime il video sulla Pizza Coronavirus, e invia una lettera di
scuse all’Ambasciatrice italiana a Parigi Teresa Castaldo. «E’ una breve
sequenza all’interno di una trasmissione umoristica ma in un periodo come questo
si tratta di immagini di cattivo gusto, inopportune, che non avrebbero mai
dovuto andare in onda. Presentiamo le nostre scuse», dice la direttrice della
comunicazione Emilie Pietrini. Il video è andato in onda lo scorso sabato sera
all’interno della trasmissione «Groland Le Zapoï», l’ultima versione di una
fortunata serie parodistica inaugurata nel 1992 che assieme ai «Guignols de
l’info» ha fatto la fortuna di Canal Plus, la prima pay tv francese. «Groland» è
un Principato immaginario che confina con 19 Stati e due città francesi e ha per
motto «Gioia, ospitalità e viltà». Nelle sue varie declinazioni in quasi
trent’anni di vita «Groland» ha di solito preso la forma di parodie – le più
irriverenti e demenziali possibile - dell’attualità francese e internazionale,
prendendosi gioco soprattutto dei protagonisti della politica della Francia,
compreso ovviamente il capo dello Stato Emmanuel Macron. Il presidente di
Groland, interpretato da Christophe Salengro scomparso a Parigi due anni fa, era
una parodia del generale Charles De Gaulle. In Francia capita di vedere su
qualche auto l’adesivo ovale del «GRD – présipauté de Groland» al posto della
«F», accanto alla targa. Due settimane fa la parodia ispirata al coronavirus
riguardava misure di sicurezza e controlli a distanza con droni e termometri.
Coronavirus, bufera sul deputato leghista: risponde ai francesi con una “pizza
bruciata Notre Dame”.
Redazione su
Il Riformista il 5 Marzo 2020. “Pizza Notre Dame. Tiè!”, come didascalia di una
pizza completamente bruciata. È la foto postata su Facebook da Leonardo
Tarantino, deputato leghista ed ex sindaco di Samarate (Varese) come forma di
‘risposta’ al video satirico mandato in onda dalla tv privata francese Canal+
sulla “pizza coronavirus”, un caso che ha provocato un polverone politico fino
alle scuse dell’emittente e al ritiro dello spot. Un gesto che rischia di far
ritornare tesi i rapporti con i cugini d’oltralpe, con i quali il ministro degli
Esteri Luigi Di Maio aveva ricucito simbolicamente mangiando proprio una pizza
nel centro di Roma con l’ambasciatore francese in Italia Christian Masset. Nei
commenti alla foto il popolo di Facebook si è spaccato. C’è chi ha commentato
con amarezza e delusione la foto del deputato leghista: “Non ci credo che questo
è un deputato,cioè siamo messi così male?”, scrive un utente, mentre uno dei
coordinatori delle Sardine varesine, Silvano Monticelli, scrive “non mi sento
rappresentato da un parlamentare che si presta a una bassezza di questo genere”.
Ma c’è anche chi apprezza l’uscita di Tarantino: “Il massimo sarebbe stato farlo
con la baguette.. Ma comunque ben fatto”, mentre un secondo utente rivendica e
accusa i francesi: “Chi la fa l’aspetti”.
Coronavirus, Pietro Senaldi contro i francesi: "Spuntano sulla pizza? Loro
mangiano formaggi puzzolenti e lumache".
Libero
Quotidiano Pietro Senaldi 06 marzo 2020. E se i francesi non ci rispettano, non
facciamoci girare le balle. Parafrasando Paolo Conte. Ha fatto scalpore lo
sfottò trasmesso da un' emittente televisiva transalpina, con un pizzaiolo
febbricitante che sfornava una gustosa Margherita, salvo poi starnutirci sopra e
trasformarla in una pizza al coronavirus. Non è il primo colpo basso che ci
arriva da Oltralpe e non sarà l' ultimo. Il video per una volta ha messo d'
accordo tutti i nostri politici, che si sono scandalizzati in blocco, e ci è
valso le scuse dell' ambasciatore francese e di Canal Plus, la televisione che
lo aveva trasmesso. Non ci vuole un genio per ravvisare nel filmato un attacco
al cibo made in Italy, da sempre ossessione dei galletti, che non riescono più a
tenere il passo contro l' agroalimentare italiano. Anche noi di Libero non lo
abbiamo gradito, ma riteniamo che la strategia migliore di questi tempi non sia
la polemica. Meglio tirar su il bavero del cappotto, alzare la spalla,
continuare per la propria strada e fottersene, come direbbero proprio i
francesi. Non sono stati i nostri cugini a dare al mondo l' immagine che il
nostro Paese è un lazzaretto, tanto che adesso perfino dalla Cina ci esprimono
solidarietà e ci chiedono se abbiamo bisogno di aiuto. È stato il comportamento
prima ambiguo, poi allarmistico, contraddittorio e disorganizzato del governo
Conte a dare agli altri argomenti per ridere di noi. Comunque sia, ora i nostri
problemi sono altri. L' emergenza è contrastare il virus, non rifarci il look
all' estero; anche perché è molto probabile che chi ci tratta da appestati
presto finirà infetto. Per un politico è facile partire lancia in resta alla
difesa dell' orgoglio nazionale. Buttarla sulla retorica e sulle parole è un
buon modo per celare di non essere in grado di affrontare i problemi che la
realtà pone. I francesi sono spesso odiosi con noi, ma i nostri politici non
dovrebbero inseguirli adesso. Meglio annotarsi tutto per presentare il conto
quando la buriana sarà passata e nel frattempo darsi da fare sul campo contro l'
influenza cinese.
È TUTTA
INVIDIA. Badare alla forma e non alla sostanza è il difetto del nostro sistema
politico e mediatico. I governatori Fontana e Zaia stanno facendo un grande
lavoro per arginare l' epidemia e limitarne i danni economici, ma la sinistra li
sta crocifiggendo perché uno si è messo la mascherina anti-contagio e l' altro,
seppure con una battuta infelice, ha rimproverato ai cinesi di avere abitudini
igieniche e alimentari che agevolano la diffusione di virus. I medesimi avevano
proposto saggiamente di mettere in quarantena chi tornava dalla Cina, ma siccome
alle orecchie degli stolti suonava razzista anziché saggio, Conte e i
progressisti si opposero e favorirono il dilagare dell' epidemia. Non è il
momento dei parolai, e se i francesi hanno voglia di scherzare è perché sono
meno furbi di quanto si credono. Ma ancora meno furbi sono gli italiani che si
aspettano benevolenza da un popolo che dai tempi dell' Unità del Regno ci fa
concorrenza in ogni modo e si stupiscono quando ricevono da esso l' immancabile
pedata in faccia. I francesi hanno ospitato come vittime della giustizia
italiana chi sparava nelle nostre strade alla borghesia che mandava avanti il
Paese, ci portano clandestini varcando il confine e rifiutano di farsi carico
delle loro quote di profughi, approfittano del loro potere in Europa per fare
concorrenza sleale ai nostri prodotti agroalimentari, con l' aiuto della
sinistra si sono divorati una buona parte di banche e imprese nostrane. Adesso
sputano pure sulla pizza. Il mondo li chiama «mangia rane», si nutrono di
formaggi puzzolenti e lumache e ormai i loro bistrot servono più cous-cous e
kebap che ostriche e champagne. Lasciamoli al loro invidia-virus e pensiamo a
curarci.
Così il giornale dei radical chic sfrutta
il lavoro degli immigrati.
Le Monde, il giornale dei radical chic parigini, dovrebbe trasferirsi a breve in
una nuova sede di zecca. Peccato che al lavoro ci siano operai africani
sfruttati. Roberto Vivaldelli, Martedì 03/03/2020 su Il Giornale. Le Monde è il
punto di riferimento della gauche parigina, il quotidiano dell'intellighenzia
francese e di tutta la sinistra al caviale. Nelle prossime settimane il
gruppo Le Monde si trasferirà nell'edificio futuristico progettato dallo studio
norvegese di architettura Snohetta nei pressi della stazione d'Austerlitz, nel
13°arrondissement. La forma dell'immobile che ospiterà il gruppo editoriale
progettato da Snohetta "riflette la relazione tra la presenza numerica e la
presenza analogica dei media", ha spiegato a Le Monde, Kjetil Thorsen
cofondatore dello studio di architettura, e "avrà una forma curva sposando
quella delle sfere virtuali, invitando alla riflessione e alla discussione fra
la trasparenza e l'opacità sull'appartenenza e l'esclusione". Questo imponente
edificio.ponte, ricorda Italia Oggi, sarà il segnale d'ingresso nel quartiere
Parigi Rive Gauche, che sta subendo il più grande intervento di ristrutturazione
della capitale francese mai effettuato da dieci anni a questa parte, con la
costruzione anche della biblioteca François Mitterrand e l'istallazione della
stazione F nella hall Freyssinet. Uno spettacolare e maestoso edificio
all'avanguardia, dunque, che sarà sicuramente realizzato da operai altamente
specializzati e ben pagati. O forse no. Come rivela Libero, infatti, le
condizioni di lavoro della cinquantina di lavoratori africani che sta ultimando
la costruzione della nuova sede di Le Monde sono ai limiti dello schiavismo. Gli
operati, quasi tutti provenienti da Mali, Senegal, Guinea e Costa d'Avorio,
vengono pagati solamente 40 euro al giorno, spesso lavorando ben oltre le sette
ore di lavoro previste. La cosa più grave è che anche la sicurezza lascia
parecchio a desiderare. "Non abbiamo mascherine, non abbiamo guanti e non
abbiamo gilet di sicurezza. A volte lavoriamo di notte per 40 euro e gli
straordinari ci vengono pagati 5 euro all' ora. Tutto questo 7 giorni su 7 senza
riposo domenica e lunedì. E se un giorno non veniamo, il capo minaccia di
cacciarci. Siamo nel Ventunesimo secolo, lo schiavismo è finito", racconta
a Libero Lamine Mohamed Touré, 26enne nato in Guinea e arrivano in Francia
quattro anni fa. Per i sindacati non c'è storia: la responsabilità è di Le
Monde, che si vanta tanto del nuovo edificio progettato da uno dei migliori
studi di architettura del mondo ma se ne infischia altamente dei diritti dei
lavoratori. "La responsabilità sociale è del Monde", ha sottolineato in una nota
il sindacato Cnt-So. "Quest'impresa, Eiffage, non fornisce né la busta paga né
l'equipaggiamento per lavorare in sicurezza. Si permette di fare questo perché
sono dei sans-papiers. Sembra di vivere come tre, quattro secoli fa!". Giovedì
scorso i lavoratori inferociti per le loro condizioni precarie e irregolari
hanno deciso di occupare la futura sede del giornale radical chic parigino. Ne è
nato un incontro con Louis Dreyfus, presidente del direttorio di Le Monde, e i
rappresentanti di Eiffage, Golden Clean, Cicad, dell'Ispettorato del lavoro e
dei lavoratori, che hanno siglato un "protocollo di uscita dalla crisi". I
lavoratori ora attendono risposte. Rimane però l'ipocrisia di fondo di un
quotidiano che accusava i tempi non sospetti l'Italia di aver stipulato accordi
con i trafficanti libici sulla pelle dei migranti; lo stesso giornale che
raffigurava in una vignetta l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini in costume
da carnevale e "trafitto" da una barca di immigrati.
Mauro Zanon per “Libero quotidiano” il 3 marzo 2020. «Sono stufo,
lavoriamo come animali. Essere pagati così poco, in contanti, è una roba da
pazzi». Sono le parole di Siku, originario del Mali, sans-papiers, che assieme a
una cinquantina di lavoratori africani sta ultimando la costruzione della nuova
sede di Le Monde, il grande quotidiano della gauche parigina, che entro poco
traslocherà tutti i suoi giornalisti in un edificio futurista vicino alla
stazione ferroviaria Gare d' Austerlitz, nel sud-est di Parigi. Il problema,
appunto, è che le condizioni di lavoro di Siku e degli altri lavoratori,
principalmente originari del Mali, del Senegal, della Guinea e della Costa d'
Avorio, sono ai limiti dello schiavismo, dato che vengono pagati 40 euro al
giorno (o a notte), spesso lavorano oltre le sette ore previste dalla legge, e
le condizioni in cui sono stati "assunti" sono tutt' altro che regolari. «Non
abbiamo mascherine, non abbiamo guanti e non abbiamo gilet di sicurezza. A volte
lavoriamo di notte per 40 euro e gli straordinari ci vengono pagati 5 euro all'
ora. Tutto questo 7 giorni su 7 senza riposo domenica e lunedì. E se un giorno
non veniamo, il capo minaccia di cacciarci. Siamo nel Ventunesimo secolo, lo
schiavismo è finito», ha attaccato Lamine Mohamed Touré, 26enne, nato in Guinea,
sbarcato in Francia quattro anni fa e sballottato da un cantiere all' altro
senza un contratto regolare. Lui e gli altri ragazzi sans-papiers sono
"dipendenti" di Golden Clean (che si occupa delle pulizie) e di Cicad (che
gestisce il cantiere), a cui Eiffage, colosso delle costruzioni francese, ha
subappaltato i lavori per conto di Le Monde. «La responsabilità sociale è del
Monde», ha attaccato il sindacato Cnt-So. «Questa impresa, Eiffage, non fornisce
né la busta paga né l' equipaggiamento per lavorare in sicurezza. Si permette di
fare questo perché sono dei sans-papiers. Sembra di vivere come tre, quattro
secoli fa!», ha tuonato Étienne Deschamps, giurista presso la Cnt-so. «Vogliamo
la regolarizzazione e un aumento dei loro salari. Pagare 40 euro la giornata o
la notte di lavoro, andando spesso oltre le sette ore effettuate, non è
normale», ha aggiunto. La scintilla che ha fatto perdere la pazienza alla
cinquantina di lavoratori africani letteralmente sfruttati da Eiffage è scattata
dieci giorni fa, quando la società ha chiesto loro di fare altri straordinari e
loro si sono rifiutati. «Il patron ha minacciato di cacciarci. Ci siamo detti
che dovevamo rivendicare i nostri diritti», hanno raccontato. Così, giovedì,
all' alba, hanno deciso di occupare la futura sede del giornale della sinistra
benpensante francese, gridando il loro malcontento per il trattamento subito.
«Il fatto di inaugurare questa sede con dei lavoratori senza documenti regolari,
è qualcosa di altamente simbolico», ha commentato Deschamps della Cnt-So. Dopo
un incontro di più di cinque ore tra Louis Dreyfus, presidente del direttorio di
Le Monde, e i rappresentanti di Eiffage, Golden Clean, Cicad, dell' Ispettorato
del lavoro e dei lavoratori coinvolti nella vicenda, è stato firmato un
«protocollo di uscita dalla crisi», con l' impegno a regolarizzare la loro
situazione e a fornire le buste paga. «Ma restiamo vigilanti», hanno commentato
i lavoratori.
Fabrizio
Cannone per “la Verità” il 20 febbraio 2020. Le Figaro, il classico giornale
della destra moderata e liberale, ha aperto la sua edizione di martedì 18
febbraio con un titolo abbastanza sorprendente: «Macron cerca la risposta al
separatismo islamico». Il sottotitolo, spiega che il presidente ha lanciato una
vigorosa «riconquista repubblicana» e perfino un «piano di lotta contro le
ideologie che appestano una parte del territorio». Il termine di ideologia,
specie se usato al plurale, tende a coprire ciò che nel titolo stesso è
affermato senza ambagi: esiste oggi una ideologia, l' islamismo radicale, che si
sta sviluppando in Francia e in tutta Europa, Turchia inclusa. Le denunce che da
decenni i sovranisti alla Marine Le Pen hanno prodotto, circa la possibile
islamizzazione del paese, non erano una paura isterica e irrazionale. Ma una
verità fattuale. L' editorialista Laurence de Charette, in un pezzo intitolato
«Osare la riconquista», scrive che «finalmente, un concetto è nato: e si chiama
separatismo». Il termine scelto da Macron stavolta non è affatto equivoco,
poiché si parla di separatismo, almeno in Europa, quando una minoranza etnica o
regionale pretende di separarsi dal resto della nazione. Ma qui, la minoranza
che vuole arrivare ad una sorta di indipendenza rispetto allo Stato nazionale,
non è un gruppo tradizionale e linguistico. Ma una popolazione recente la quale,
a causa dell' immigrazione di massa (con oltre 300.000 ingressi regolari in
Francia) e di una radicalizzazione forte nelle nuove generazioni di magrebini,
pretende ora di essere una sorta di stato nello stato. Secondo Laurence de
Charette, l' espressione forte di «separatismo» è apparsa per la prima volta in
un comunicato presidenziale di domenica, a proposito della visita di Macron a
Mulhouse. Macron del resto, già nel novembre scorso, parlando davanti ai sindaci
di Francia, aveva detto che «In certi comuni, in certi quartieri, si sviluppa da
alcuni anni un progetto di separazione dalla Repubblica». Separazione a base di
continue rivendicazioni sociali, di marce contro l' islamofobia, di rispetto
delle proprie tradizioni, e parallelo rifiuto della cultura, dell' identità e
della storia francese. Uno dei migliori specialisti dell' Islam, del
fondamentalismo islamico e dei pericoli dell' islamizzazione è il politologo
francese, ma di origini italiane, Alexandre Del Valle. L' islamologo ha appena
pubblicato un testo scottante: Il progetto. La strategia di conquista e di
infiltrazione dei Fratelli musulmani in Francia e nel mondo (Artilleur). Secondo
Del Valle, l' ideologia che oggi presiede alla conquista islamica dell'
Occidente è una sorta di «islamo-gauchisme», ovvero una alleanza ibrida tra
islamismo militante e sinistra, più o meno estrema. Il collante ideologico sta
nel cambio di paradigma vissuto dalla sinistra dopo il Sessantotto e nei recenti
approdi liberal. Tradizionalmente, la politica di accoglienza sostenuta dalle
sinistre e dai progressisti, implicava l' assimilazione, ovvero l' accettazione
da parte dello straniero della cultura dominante del paese destinato ad
ospitarlo. Ma in anni più recenti questa logica è completamente saltata. E
secondo Del Valle si deve parlare ora di «de-assimilazionismo» per indicare la
volontà sia delle sinistre, sia di buona parte del mondo arabo-mussulmano di non
cercare affatto l' integrazione con il corpo sociale. Anzi di rigettarla. A
sinistra in nome dell' antirazzismo, negli islamici più radicali per separare l'
Islam dall' Occidente e mantenerlo puro e a parte. Ora Macron ha capito il
problema, e non è mai troppo tardi per fare bene. Così, in questa nuova logica
più restrittiva, il presidente Macron, in un discorso lungo e molto critico sul
separatismo islamico, ha dichiarato a Mulhouse che saranno riviste le regole di
ingaggio dei docenti stranieri che insegnano nelle scuole francesi. A partire
dai docenti di lingue, tra cui l' arabo, nominati spesso da paesi extraeuropei
senza alcun controllo. Molti di questi insegnanti infatti, secondo il
presidente, «non parlano francese» e hanno dei programmi su cui il ministero
della Pubblica istruzione non ha alcuna contezza. Con insolita fermezza ha
aggiunto che dal prossimo settembre, per l' anno scolastico 2020-21 ci sarà una
stretta, perché «Non si possono insegnare cose che siano incompatibili con leggi
della Repubblica o con la Storia, così come noi la vediamo». La frecciatina ai
fondamentalisti è visibile. Il presidente, inoltre, ha annunciato (anche senza
specificare quando entrerà in vigore) una stretta agli imam «distaccati», ovvero
quelli che solitamente (da Turchia, Algeria e Marocco) arrivano in Francia in
base a degli accordi bilaterali con gli Stati d' origine per sostenere la
domanda interna di guide religiose in crescita (visto il boom immigratorio).
Salteranno anche i 300 salmodianti strabieri accolti ogni anno durante il
ramadan. Forse i sondaggi che danno Marine Le Pen quasi alla pari con Macron e
le amministrative alle porte (dopo il sexy-scandalo che ha fatto ritirare il
candidato sindaco di En Marche a Parigi) hanno avuto un ruolo in queste
dichiarazioni di sapore sovranista. Resta il fatto che l' immigrazione
araba-africana è uno dei fatti epocali di questi decenni su cui riflettere
maggiormente per evitare degli errori fatali, come quelli riconosciuti da
Macron.
Da ansa.it il
14 febbraio 2020. Il candidato della République En Marche alla poltrona di
sindaco di Parigi nonché fedelissimo del presidente Emmanuel Macron si ritira
dalla corsa alle elezioni municipali del prossimo marzo dopo la diffusione di
immagini intime di carattere sessuale. In una breve dichiarazione, l'ex
portavoce del governo ha denunciato "attacchi ignobili". "Ho deciso di ritirare
la mia candidatura all'elezione municipale parigina", ha dichiarato Griveaux, in
un video diffuso questa mattina da BFM-Paris, in cui denuncia "attacchi
ignobili". La decisione segue la diffusione sul web e sui social network di un
video intimo, di carattere sessuale, a lui attribuito. "Non intendo esporre
ulteriormente, me e la mia famiglia, quando tutti i colpi sono ormai permessi,
qui ci si spinge oltre. E' una decisione che mi costa, ma le mie priorità sono
chiare, prima la mia famiglia". Nella breve dichiarazione, Griveaux spiega che
da oltre "un anno, con la mia famiglia, abbiamo subito parole diffamanti, bugie,
pettegolezzi, attacchi anonimi, rivelazioni di conversazioni anonime e minacce
di morte. Questo torrente di fango - ha proseguito - mi danneggia ma soprattutto
fa male a chi amo. Come se non bastasse, ieri, si è superato un ulteriore
livello. Un sito web e dei social network hanno rilanciato degli attacchi
ignobili in cui viene messa in discussione la mia vita privata". L'ex socialista
di 42 anni, tra i primi sostenitori del movimento che nel 2017 portò Macron
all'Eliseo, Griveaux ha visto le sue chance di farcela a Parigi fortemente
ridimensionate dopo la mossa di Cédric Villani, l'altro candidato 'dissidente'
della République en Marche che ha spaccato in due l'elettorato macronista. in
Francia, le elezioni municipali si terranno in due turni, il 15 e il 22 marzo.
Secondo un ultimo sondaggio Odoxa-Cgi per Le Figaro, Griveaux si sarebbe
piazzato in terza posizione, con il 16% delle preferenze, dietro alla sindaca
uscente socialista Anne Hidalgo (23%) e la candidata dei Républicains, Rachida
Dati (20%). La sua uscita dalla corsa elettorale è anche un colpo per Macron,
che sostenne fortemente la sua candidatura.
Video hot
sui social: Griveaux, fedelissimo di Macron, si ritira dalla corsa a sindaco di
Parigi.
Pubblicato venerdì, 14 febbraio 2020 da Corriere.it. Il candidato sindaco di
Parigi nonché fedelissimo del presidente Emmanuel Macron si ritira dalla corsa
alle elezioni municipali del prossimo marzo dopo la diffusione di immagini
intime di carattere sessuale: è circolato un video che riprende Benjamin
Griveaux, de La République en Marche (Lrm), il partito del presidente, mentre si
masturba. In una breve dichiarazione, l’ex portavoce del governo ha denunciato
«attacchi ignobili».
Fermato a
Parigi l’artista russo che ha diffuso il video hot su Griveaux. Pubblicato
sabato, 15 febbraio 2020 da Corriere.it. L’artista russo Piotr Pavlenski, che ha
rivendicato la pubblicazione del video intimo attribuiti a Benjamin Griveaux, è
stato fermato dalla polizia a Parigi. Lo ha reso noto la tv francese BfmTv
citando una propria fonte. Il filmato del 42enne ex portavoce del governo ha
iniziato a circolare sui social mercoledì sera. Lui si è ritirato dalla corsa
alle elezioni municipali di marzo dichiarando: «Un sito e i social network hanno
lanciato vili attacchi riguardanti la mia vita privata. La mia famiglia non lo
merita. Nessuno dovrebbe mai essere sottoposto a tali abusi».
Griveaux e i
video hot per Alexandra: chi è la francese esperta di Russia che ha «tradito»
l’uomo di Pavlenski. Pubblicato martedì, 18 febbraio 2020 su Corriere.it da
Stefano Montefiore. Secondo i suoi genitori, «Alexandra non è certo
un’anarchica», «si trova in una vicenda più grande di lei», «è come
paralizzata», «è stata manipolata da quell’uomo, di cui è molto innamorata». Ma
dopo l’arresto e la custodia cautelare ieri Alexandra de Taddeo è stata deferita
al procuratore assieme al compagno Piotr Pavlenski. La 29enne studentessa
francese poliglotta e l’artista anarchico russo rifugiato a Parigi sono indagati
per avere violato la vita privata di Benjamin Griveaux, amico di Emmanuel
Macron, co-fondatore con lui del movimento En Marche, ex portavoce del governo e
ormai ex candidato a sindaco di Parigi nelle elezioni del prossimo 15 marzo. È a
Alexandra de Taddeo che nel maggio 2018 Griveaux inviava i due video intimi e le
frasi poi diffuse su Internet, venerdì scorso, da Pavlenski nel sito
«Pornopolitique.com» creato per l’occasione. «Denuncio l’ipocrisia di un
candidato che fa campagna elettorale difendendo i valori della famiglia ma in
realtà manda video di masturbazione a un’altra donna». La mattina successiva la
diffusione dei video Griveaux si è ritirato dalla campagna elettorale,
nonostante Macron gli avesse chiesto di resistere offrendogli solidarietà e
protezione. Pavlenski ha altro materiale a disposizione e Griveaux, sposato con
tre figli di 7 anni, 5 anni, e otto mesi, ha preferito non sottoporsi a una
lunga agonia. Capire il ruolo di Alexandra de Taddeo sarà importante per
comprendere se si è trattata di un’azione «politico-artistica» autonoma
congegnata da Piotr Pavlenski, suo compagno dal gennaio 2019, con l’aiuto del
suo avvocato Juan Branco consigliere di Julian Assange e dei gilet gialli,
oppure se si è trattato di un complotto più ampio al quale potrebbero avere
partecipato forze vicine al presidente russo Putin. Nata in una famiglia agiata
di Metz, Alexandra de Taddeo parla cinque lingue tra le quali il russo
(perfettamente) e si è laureata in diritto internazionale a Parigi con una tesi
sulla «politica estera della Federazione russa nell’Artico». Secondo il padre
«Alexandra vive da 10 anni a Parigi ed è in buoni rapporti con noi». Ha studiato
poi a Oxford ed è stata stagista all’Unesco e più di recente all’Alleanza degli
avvocati per i diritti umani. Dal 2018 fa parte del «Consiglio parigino della
gioventù», un organismo del comune di Parigi, cosa che ha fatto ipotizzare un
possibile coinvolgimento della sindaca Anne Hidalgo. In realtà il Consiglio, che
si occupa di democrazia partecipativa, non è legato ad alcun partito o esponente
politico, e se ne fa parte se tirati a sorte dopo avere presentato domanda.
Durante la custodia cautelare Alexandra de Taddeo avrebbe spiegato di avere
fornito i video a Pavlenski per motivi personali, «una vendetta» per il
comportamento di Griveaux nei suoi confronti. Nella prima metà del 2018 è stata
lei a contattare Griveaux, all’epoca portavoce del governo, su Facebook e
Instagram. I due hanno cominciato a parlare di politica, poi la relazione è
diventata personale e da virtuale sarebbe diventata reale, prima di
interrompersi. I famigliari della de Taddeo la descrivono come una studentessa
brillante, interessata alla Russia, molto innamorata di un uomo «che non è certo
il nostro tipo» e che l’avrebbe trascinata in un ambiente estremista servendosi
di lei. Alexandra ha partecipato all’operazione non solo registrando i messaggi
di Griveaux (che avrebbero dovuto cancellarsi un minuto dopo la ricezione) e
consegnandoli a Pavlenski, ma anche co-firmando con lui un’intervista a
un’attrice pornografica, apparsa nello stesso sito «Pornopolitique. com», dal
titolo «Il puritanismo in politica è il sintomo di un’ideologia da politici
frustrati».
Caso Griveaux,
«complotto anti-Macron?». L’amante, l’artista e l’avvocato. Pubblicato domenica,
16 febbraio 2020 su Corriere.it da Stefano Montefiori. Violazione dell’intimità
della vita privata» e «diffusione senza accordo di immagini a carattere
sessuale» sono le motivazioni dell’arresto dell’artista russo Piotr Pavlenski,
35 anni, e della sua compagna l’avvocata Alexandra de Taddeo, 29, bloccati dalla
polizia sabato pomeriggio all’uscita di un albergo dell’elegante XVI
arrondissement di Parigi. Pavlenski è l’autore del sito «Pornopolitique», dove
venerdì ha diffuso due video intimi e alcune frasi di Benjamin Griveaux, 42enne
ex portavoce del governo e ormai ex candidato al municipio di Parigi nelle
elezioni del 15 marzo. De Taddeo è la donna alla quale Griveaux, sposato con tre
figli, nel maggio 2018 ha inviato i filmati di masturbazioni e le frasi sulla
famiglia e figli «come una prigione». L’«azione militante» di Pavlenski, che
annunciava la diffusione di altri video, ha indotto Griveaux a ritirarsi dalla
corsa a sindaco e suscitato un’ondata di indignazione unanime nella politica
francese. Al di là delle considerazioni morali sul tradimento, che riguardano
solo Griveaux e sua moglie, molti sottolineano l’imperdonabile imprudenza
dell’ex candidato macronista. Ma Griveaux Comunque non ha commesso alcun reato,
a differenza di Pavlenski e forse di Alexandra de Taddeo, che a quanto pare
quando intratteneva la relazione con Griveaux non era ancora la compagna
dell’artista russo (lo sarebbe diventata solo nel gennaio 2020). L’inchiesta
cerca di chiarire il ruolo della donna: se sia stata complice di una trappola,
se ha fornito lei video e chat a Pavlenski o se quest’ultimo gliele ha
sottratte. La scorsa settimana Griveaux si trovava in grave difficoltà politica,
benché avesse l’appoggio incondizionato del presidente Emmanuel Macron. A
Parigi, dove il movimento di Macron ha ottenuto il 90% dei voti al secondo turno
della presidenziale e un ottimo 32% alle europee, Griveaux restava solo terzo
nei sondaggi dietro la sindaca uscente Anne Hidalgo (sinistra) e l’ex ministra
sarkozysta Rachida Dati (destra), e tallonato dal macronista dissidente Cédric
Villani che gli toglieva molte intenzioni di voto. Proprio mentre Griveaux era
impegnato in un ultimo tentativo di rilancio della sua campagna, è arrivato
l’attacco su Internet e sui social media di Piotr Pavlenski, controverso
personaggio autore di clamorose performance politico-artistiche (si è cucito le
labbra in sostegno alle Pussy Riot, si è avvolto nel filo spinato davanti
all’assemblea legislativa di San Pietroburgo, si è inchiodato lo scroto davanti
al mausoleo di Lenin sulla Piazza Rossa a Mosca, ha appiccato il fuoco al
portone dei servizi segreti russi e poi a Parigi all’entrata della Banca di
Francia). Pavlenski si fa anche fotografare a braccio teso davanti alla bandiera
nazista, ma dal 4 maggio 2017 gode dell’asilo politico a Parigi in qualità di
oppositore perseguitato da Putin. Un altro aspetto molto interessante è la parte
giocata in tutta la vicenda da Juan Branco, trentenne avvocato consulente di
Julian Assange e di alcune figure dei gilet gialli come Maxime Nicolle. Branco,
estremista di sinistra con ottimi studi alla Sorbona e a Sciences Po, ha
pubblicato nel 2019 «Crépuscule», un violento pamphlet contro Macron. Il 31
dicembre 2019 Branco ha organizzato in un grande appartamento di
Saint-Germain-des-Près una festa alla quale ha invitato anche De Taddeo e
Pavlenski, il quale intorno alle 3 del mattino ha accoltellato due persone ed
era da allora ricercato (senza grande convinzione evidentemente) dalla polizia.
«Ho dato consigli a Pavlenski prima della pubblicazione dei video», ha
dichiarato nei giorni scorsi Branco, al quale l’artista russo voleva affidare la
sua difesa. La procura di Parigi però ieri si è opposta, un gesto straordinario
motivato dal sospetto che Branco abbia avuto un ruolo di primo piano
nell’organizzazione dell’attacco a Griveaux. Accanto all’inchiesta, c’è
l’aspetto politico: ieri il partito di Macron ha designato la sua nuova
candidata al posto di Griveaux. Si tratta di Agnès Buzyn, ministra della Sanità,
che lascia la lotta al Coronavirus per tentare di porre rimedio al disastro di
Parigi.
Filippo Facci
per ''Libero Quotidiano'' il 15 febbraio 2020. Silvio Berlusconi, almeno, si è
portato a letto tremila ragazzette prima che il guardonismo giudiziario gli
squadernasse l' esistenza per undici anni e lo costringesse a divorziare.
Dominique Strauss-Khan, almeno, si portò a letto qualche sottoposta, molestò
innocuamente qualche cameriera e partecipò a dei festini con ragazze pagate da
altri. I due - Berlusconi e Strauss-Khan - hanno comunque fatto delle notevoli
carriere benché l' uso degli scandali sessuali avesse già preso cittadinanza
nello scemenzaio globale. Ma che cosa dire di Benjamin Griveaux, candidato
sindaco per Parigi? Si è fatto una sega: e allora carriera distrutta e
candidatura ritirata. Tecnicamente è andata così. La cronaca è ancor più penosa,
termine appropriato. Un artista russo che si chiama Pjotr Pavlenskij, uno che
che aveva ottenuto asilo politico in Francia nel 2017, ha pubblicato dei filmati
ovviamente privati (nelle intenzioni) con Benjamin Griveaux che si masturba col
suo grosso affare in primo piano. L' artista ha raccontato di aver ricevuto le
immagini da una ragazza che ebbe una relazione con Griveaux, e la pietra dello
scandalo consisterebbe nella morale adultera di un candidato, sposato e con
figli, che peraltro della politica in favore delle famiglie aveva fatto una
priorità di campagna elettorale. Quindi l' ex portavoce del governo, e ormai ex
candidato di En Marche (partito di Emmanuel Macron) ha deciso di rinunciare in
quanto sbertucciato sui giornali e sul web, questo per colpa di un artistoide
con la propensione al fanatismo provocatorio. In passato Pavlenskij si era
cucito la bocca in solidarietà con le Pussy Riot, si era tagliato un pezzo di
orecchio per denunciare le violenze psichiatriche in Russia, aveva dato fuoco
alla facciata della Banque de France beccandosi peraltro un anno di carcere: ma
è niente, in confronto all' aver mostrato il pene di un politico intento a
tornirselo. Poi naturalmente, ora che si è ritirato, fioccano le solidarietà.
Persino l' attuale sindaca di Parigi, la socialista sessantenne Anne Hidalgo, ha
invocato «rispetto per la vita privata». E il nemico politico Cedric Villani
(candidato rimasto in lizza che era stato fatto fuori da Le Marche proprio per
essere sostituito con Griveaux) ha rivolto all' avversario e alla sua famiglia
il suo «pieno e sincero sostegno in questo calvario». Ma perché, in sostanza,
Griveaux si è ritirato? Se il vero problema fosse un' incoerenza «politica»,
probabilmente avrebbe sollevato eguale scandalo la carriera di un politico che
cominciò con lo Sfio (sezione francese dell' Internazionale dei lavoratori) per
poi passare col partito socialista, e poi, ancora, con doppio carpiato, si unì
al neoliberista Macron giusto in tempo per diventare Segretario di Stato e
successivamente portavoce del governo. Ma si sa, nella politica moderna non è
questo genere di ipocrisia a menare scandalo. Allora potrebbe esser colpa, come
detto, e come si legge in Francia, dell' incompatibilità tra una presunta
scappatella e l' esibita fiducia di Griveaux nei valori della famiglia: e qui
sono fioccate vecchie e recenti interviste in cui il politico esaltava mielosi
quadretti familiari laddove «sono stati i miei figli a dare un nuovo significato
al mio impegno politico», al punto da definirsi il possibile «sindaco dei
bambini e della vita quotidiana dei genitori». L' incoerenza, dunque, sarebbe
che in un messaggio privato con una ragazza, poi, ha invece scritto che
«famiglia e figli sono una prigione». O, ancora, l' incoerenza sarebbe che delle
due l' una: o Griveaux mentiva ai suoi elettori, oppure mentiva alla ragazza.
Pare tutto un po' troppo semplicistico, tuttavia. Siamo in Francia, nazione
della «laicité» dove ogni dimensione religiosa, pur presente, resta lontana anni
luce da certo puritanesimo anglosassone: dunque il sapere o il presumere che un
bell' uomo di 42 anni possa concedersi delle distrazioni - anche continuando a
santificare la centralità della famiglia - no, non dovrebbe essere motivo di
grande turbamento: non in Francia, nazione dove l' amatissimo ex presidente
Francois Mitterrand convisse per 32 anni con l' amante Anne Pingeot anche se non
divorziò mai dalla moglie, che intanto aveva una relazione con un professore di
ginnastica. La Francia sapeva. E, mediamente, se ne fregava. Quindi, forse, il
problema di Benjamin Griveaux è un po' più crudo e modernizzato. Il problema,
ossia, non è il messaggio, ma il medium: internet, i social, il solito. C' è
mezza Francia che associa l' immagine Benjamin Griveaux a quella del suo cazzo,
fine. È così, e lo resterà chissà per chissà quanto. La servitù parla delle
persone e la nobiltà parla dei fatti: ma è la servitù a votare. Griveaux lo sa,
e confida nell' oblio. Ma sarà duro, pardon dura.
Rosalba
Castelletti per ''la Repubblica'' il 15 febbraio 2020. L' autore del sito che ha
affossato l' esponente di "En Marche!" di Rosalba Castelletti Definisce la sua
arte "politica". Per denunciare il regime russo, aveva incendiato la sede
moscovita dell' ex Kgb, si era cucito le labbra e si era inchiodato lo scroto
sul pavé della Piazza Rossa. Nella sorpresa generale, è stato il provocatorio
artista russo Pjotr Pavlenskij, rifugiato politico in Francia dal 2017, a
rivendicare la diffusione di video e messaggi a sfondo sessuale che hanno
portato Benjamin Griveaux a rinunciare alla candidatura di sindaco di Parigi.
«Griveaux si affida costantemente ai valori familiari, afferma di voler essere
il sindaco delle famiglie e cita sempre sua moglie e i suoi figli come esempio.
Ma fa esattamente il contrario», si è giustificato con Libération . «Che cosa
accadrebbe se una persona che odia e disprezza i suoi elettori diventasse il
capo della città? Avrebbe un grande potere e potrebbe essere molto pericoloso»,
ha ribadito a Afp . «È una questione di principio», ha ribattuto alle critiche
quasi unanimi, senza mai rivelare la sua fonte. «Ora vivo in Francia, sono
parigino, è importante per me», ha insistito. A difenderlo c' è Juan Branco, già
legale di Julian Assange, il fondatore di WikiLeaks. Figlio di un padre morto
per alcolismo e di una madre ex infermiera psichiatrica, testa rasata, guance
infossate, questo trentacinquenne russo sa come far parlare di sé. In passato
non ha esitato a usare il suo corpo per denunciare lo Stato di polizia in
Russia. Come quando si è mostrato nudo riverso come un cadavere in un bozzolo di
filo spinato o si è tagliato il lobo dell' orecchio destro seduto sul muro di un
ospedale psichiatrico. «Il mio è un genere d' arte che opera all' interno della
meccanica del potere e costringe gli strumenti del potere a smascherarsi», aveva
detto a Repubblica dopo l' uscita del libro Nudo con filo spinato. Le sue azioni
avevano raccolto consensi in Occidente tanto che nel 2016, mentre era in
detenzione preventiva, gli era stato assegnato il premio Vaclav-Havel di 42mila
dollari: subito ritirato quando Pjotr aveva detto di volerli devolvere alla
difesa di sei giovani russi accusati dell' omicidio di poliziotti. Aveva
lasciato Mosca nel dicembre 2016 dopo essere stato accusato, insieme alla
compagna Oksana Shalygina, di aggressione sessuale da un' attrice 23enne. Un
caso montato ad arte per ragioni politiche, ha sempre affermato. Ottenuto l'
asilo politico in Francia nel maggio 2017, Pavlenskij ha reindirizzato le sue
proteste «contro il ludibrio del potere». Solo pochi mesi dopo il suo arrivo, ha
incendiato una filiale della Banca di Francia. Dopo 11 mesi in detenzione
preventiva, processato nel 2019, è stato condannato a tre anni di carcere, due
dei quali sospesi. Secondo Mediapart , sarebbe tuttora ricercato per aver
accoltellato due persone alla vigilia di Capodanno. Oggi il suo obiettivo, dice
Pavlenskij, è «denunciare l' ipocrisia diventata norma». E promette: «Griveaux è
solo il primo. Ho appena iniziato».
Anais Ginori
per ''la Repubblica'' il 16 febbraio 2020. Da qualche ora, il sito che ha
postato i contenuti osé di Benjamin Griveaux non è più visibile. È stato lo
stesso artista russo Pjotr Pavlenskij - arrestato ieri dalla polizia per fatti
di violenza che risalgono al capodanno scorso - ad annunciare che
Pornopolitique.com è stato chiuso dalle autorità francesi, promettendo però di
tornare presto con nuove rivelazioni. E già questo fa capire che lo scandalo che
ha travolto Griveaux, candidato sindaco di Parigi per il movimento di Emmanuel
Macron, non è finito. Se Pavlenskij ha spiegato di voler denunciare «l'
ipocrisia» di Griveaux, molti cominciano a pensare che sia stato aiutato. La
stessa Marine Le Pen parla di un possibile «complotto». A destare sospetti sono
personaggi come il giovane avvocato Juan Branco, già legale di Julian Assange,
che l' anno scorso ha firmato un violento pamphlet contro Macron. Branco conosce
bene Pavlenskij con il quale ha trascorso l' ultimo capodanno finito con una
denuncia contro l' artista per avere ferito all' arma bianca due ospiti che ieri
ha portato al suo arresto. Branco ha ammesso di essere stato consultato da
Pavlenskij prima di pubblicare i contenuti hard. Il sito Pornopolitique.com è
stato creato nel novembre scorso e Pavlenskij ha messo in linea i contenuti già
mercoledì, insieme a un' intervista a Cicciolina, passando per qualche ora
inosservato. Sono stati alcuni profili legati ai gilet gialli a rilanciare i
contenuti giovedì. Anche il deputato Joachim Son-Forget, eletto con En Marche
prima di entrare in dissidenza, ha rilanciato i contenuti di Pavlenskij. Oggi il
deputato - che ha cercato di assumere come assistente parlamentare l' ex
responsabile sicurezza dell' Eliseo Alexandre Benalla - si difende sostenendo
che era un modo di allertare Griveaux. Resta anche il mistero sulla fonte di
Pavlenskij. Il filmato in cui Griveaux si masturba è stato inviato attraverso
Facebook Messenger nel maggio 2018 (quando era portavoce del governo), con la
funzione che cancella i contenuti dopo un minuto. Ma la persona che li ha
ricevuti ha registrato il video con il cellulare. Le Figaro parla di
«agghiacciante incoscienza politica» di Griveaux. Nel suo editoriale dal titolo
"L' abbassamento della democrazia", Le Monde auspica un «sussulto» dell'
opinione pubblica contro la «barbarie» della delazione online. Il direttore di
Libération , Laurent Joffrin, condanna la «la ghigliottina digitale» e «una
regressione della civiltà».
Stefano
Montefiori per il “Corriere della Sera” il 17 febbraio 2020. «Violazione dell'
intimità della vita privata» e «diffusione senza accordo di immagini a carattere
sessuale» sono le motivazioni dell' arresto dell' artista russo Piotr Pavlenski,
35 anni, e della sua compagna l' avvocata Alexandra de Taddeo, 29, bloccati
dalla polizia sabato pomeriggio all' uscita di un albergo dell' elegante XVI
arrondissement di Parigi. Pavlenski è l' autore del sito «Pornopolitique», dove
venerdì ha diffuso due video intimi e alcune frasi di Benjamin Griveaux, 42enne
ex portavoce del governo e ormai ex candidato al municipio di Parigi nelle
elezioni del 15 marzo. De Taddeo è la donna alla quale Griveaux, sposato con tre
figli, nel maggio 2018 ha inviato i filmati di masturbazioni e le frasi sulla
famiglia e figli «come una prigione». L'«azione militante» di Pavlenski, che
annunciava la diffusione di altri video, ha indotto Griveaux a ritirarsi dalla
corsa a sindaco e suscitato un' ondata di indignazione unanime nella politica
francese. Al di là delle considerazioni morali sul tradimento, che riguardano
solo Griveaux e sua moglie, molti sottolineano l' imperdonabile imprudenza dell'
ex candidato macronista. Ma Griveaux Comunque non ha commesso alcun reato, a
differenza di Pavlenski e forse di Alexandra de Taddeo, che a quanto pare quando
intratteneva la relazione con Griveaux non era ancora la compagna dell' artista
russo (lo sarebbe diventata solo nel gennaio 2020). L' inchiesta cerca di
chiarire il ruolo della donna: se sia stata complice di una trappola, se ha
fornito lei video e chat a Pavlenski o se quest' ultimo gliele ha sottratte. La
scorsa settimana Griveaux si trovava in grave difficoltà politica, benché avesse
l' appoggio incondizionato del presidente Emmanuel Macron. A Parigi, dove il
movimento di Macron ha ottenuto il 90% dei voti al secondo turno della
presidenziale e un ottimo 32% alle europee, Griveaux restava solo terzo nei
sondaggi dietro la sindaca uscente Anne Hidalgo (sinistra) e l' ex ministra
sarkozysta Rachida Dati (destra), e tallonato dal macronista dissidente Cédric
Villani che gli toglieva molte intenzioni di voto. Proprio mentre Griveaux era
impegnato in un ultimo tentativo di rilancio della sua campagna, è arrivato l'
attacco su Internet e sui social media di Piotr Pavlenski, controverso
personaggio autore di clamorose performance politico-artistiche (si è cucito le
labbra in sostegno alle Pussy Riot, si è avvolto nel filo spinato davanti all'
assemblea legislativa di San Pietroburgo, si è inchiodato lo scroto davanti al
mausoleo di Lenin sulla Piazza Rossa a Mosca, ha appiccato il fuoco al portone
dei servizi segreti russi e poi a Parigi all' entrata della Banca di Francia).
Pavlenski si fa anche fotografare a braccio teso davanti alla bandiera nazista,
ma dal 4 maggio 2017 gode dell' asilo politico a Parigi in qualità di oppositore
perseguitato da Putin. Un altro aspetto molto interessante è la parte giocata in
tutta la vicenda da Juan Branco, trentenne avvocato consulente di Julian Assange
e di alcune figure dei gilet gialli come Maxime Nicolle. Branco, estremista di
sinistra con ottimi studi alla Sorbona e a Sciences Po, ha pubblicato nel 2019
«Crépuscule», un violento pamphlet contro Macron. Il 31 dicembre 2019 Branco ha
organizzato in un grande appartamento di Saint-Germain-des-Près una festa alla
quale ha invitato anche De Taddeo e Pavlenski, il quale intorno alle 3 del
mattino ha accoltellato due persone ed era da allora ricercato (senza grande
convinzione evidentemente) dalla polizia. «Ho dato consigli a Pavlenski prima
della pubblicazione dei video», ha dichiarato nei giorni scorsi Branco, al quale
l' artista russo voleva affidare la sua difesa. La procura di Parigi però ieri
si è opposta, un gesto straordinario motivato dal sospetto che Branco abbia
avuto un ruolo di primo piano nell' organizzazione dell' attacco a Griveaux.
Accanto all' inchiesta, c' è l' aspetto politico: ieri il partito di Macron ha
designato la sua nuova candidata al posto di Griveaux. Si tratta di Agnès Buzyn,
ministra della Sanità, che lascia la lotta al Coronavirus per tentare di porre
rimedio al disastro di Parigi.
Gaia Cesare
per “il Giornale” il 19 febbraio 2020. Parigi? Più che la capitale di Francia
sembra ormai la capitale dei tradimenti, sentimentali e politici. L' Eliseo? Più
che il palazzo del presidente sembra il palazzo dei veleni. In attesa di capire
se e quale regia ci sia dietro lo scandalo sessuale che ha portato il candidato
de La République en Marche, Benjamin Griveaux, a ritirarsi dalla corsa a sindaco
della capitale, dopo la diffusione di un video compromettente divenuto di
dominio pubblico, la Francia scopre in questi giorni nuovi e inquietanti
dettagli su un altro circolo passionale-amoroso. Lo scandalo pareva dimenticato
ma riemerge proprio in questi giorni turbolenti, dopo le dichiarazioni di due
giornalisti del quotidiano Le Monde. Il caso è il celebre triangolo
Hollande-Gayet-Trierweiler, cioè il tradimento sentimentale dell' ex presidente
socialista Hollande nei confronti dell' allora compagna, la giornalista Valérie
Trierweiler, che fece il giro del mondo e contribuì alla fine politica di
Hollande nel 2017. La storia clandestina del leader francese con l' attrice
Julie Gayet, vent' anni più giovane di lui, diventò di dominio pubblico nel
gennaio 2014 con uno scoop del settimanale Closer, che pubblicò le foto del
presidente in scooter mentre si recava a casa dell' amante, per passarci la
notte, con tanto di croissant freschi consegnati dal capo scorta il mattino
dopo. Ma ecco la novità. Tre mesi prima che la notizia diventasse di dominio
pubblico, i giornalisti del Monde, Fabrice Lhomme e Gérard Davet, erano stati
avvisati dall' ex presidente Nicolas Sarkozy, sul quale stavano svolgendo un'
inchiesta, delle fughe d' amore di Hollande. «Incontriamo Sarkozy nei suoi
uffici - ha raccontato Davet alla radio francese Europe 1 - Ci urla contro per
mezz' ora, è sempre molto violento. Poi ci dice: Dovreste interessarvi a
Hollande. Pare che esca dall' Eliseo per incontrare la sua amichetta in
scooter...molto spesso». I due giornalisti in quel momento sono sulle tracce di
Sarko per le presunte irregolarità nei finanziamenti della campagna
presidenziale del 2012, vicenda per la quale l' ex presidente è stato rinviato a
giudizio. Non si curano più di tanto delle parole di Sarko. Salvo poi scoprire,
tre mesi dopo, dello scandalo Hollande-Gayet. Da qui le domande: come avrebbe
saputo della liaison, in anticipo di tre mesi, l' ex presidente Sarko? Si
trattava di un gossip che circolava già negli ambienti politici? Oppure la
rivelazione è frutto di una soffiata, magari di qualche membro dei servizi
segreti? Ed è forse Sarko la fonte che ha fatto arrivare la notizia ai giornali?
Tutto da appurare, come in queste ore serve capire il ruolo dell' artista russo
Piotr Pavlenski e della compagna Alexandra de Taddeo, ieri sentiti dalla
procura, nello scandalo Griveaux, che ha sepolto la carriera del candidato di
Emmanuel Macron. Quel che non stupisce sono le recenti rivelazioni di Paris
Match, secondo cui, all' Eliseo, la guerra tra première dame tiene banco. Julie
Gayet, ormai compagna fissa di Hollande, pare sia andata su tutte le furie per
il mancato invito di Brigitte Macron a un pranzo a palazzo tra ex first lady, un
anno fa, e lo abbia fatto sapere con un sms velenoso a Lady Macron. Anche
perché, oltre a Carla Bruni, verso la quale Brigitte ha dichiarato la sua stima,
all' appuntamento è stata invitata l' ex di Hollande, Trierweiler. Un affronto
per la Gayet, che dopo lo scandalo andò a vivere all' Eliseo e sogna di tornarci
con Hollande. In privato, l' attrice pare definisca Macron come «il traditore»
per aver pugnalato Hollande, candidandosi nel 2017 dopo essere stato consulente
del leader socialista e suo ministro dell' Economia.
Stefano
Montefiori per il “Corriere della Sera” il 18 febbraio 2020. Secondo i suoi
genitori, «Alexandra non è certo un' anarchica», «si trova in una vicenda più
grande di lei», «è come paralizzata», «è stata manipolata da quell' uomo, di cui
è molto innamorata». Ma dopo l' arresto e la custodia cautelare ieri Alexandra
de Taddeo è stata deferita al procuratore assieme al compagno Piotr Pavlenski.
La 29enne studentessa francese poliglotta e l' artista anarchico russo rifugiato
a Parigi sono indagati per avere violato la vita privata di Benjamin Griveaux,
amico di Emmanuel Macron, co-fondatore con lui del movimento En Marche , ex
portavoce del governo e ormai ex candidato a sindaco di Parigi nelle elezioni
del prossimo 15 marzo. È a Alexandra de Taddeo che nel maggio 2018 Griveaux
inviava i due video intimi e le frasi poi diffuse su Internet, venerdì scorso,
da Pavlenski nel sito «Pornopolitique.com» creato per l' occasione. «Denuncio l'
ipocrisia di un candidato che fa campagna elettorale difendendo i valori della
famiglia ma in realtà manda video di masturbazione a un' altra donna». La
mattina successiva la diffusione dei video Griveaux si è ritirato dalla campagna
elettorale, nonostante Macron gli avesse chiesto di resistere offrendogli
solidarietà e protezione. Pavlenski ha altro materiale a disposizione e
Griveaux, sposato con tre figli di 7 anni, 5 anni, e otto mesi, ha preferito non
sottoporsi a una lunga agonia. Capire il ruolo di Alexandra de Taddeo sarà
importante per comprendere se si è trattata di un' azione «politico-artistica»
autonoma congegnata da Piotr Pavlenski, suo compagno dal gennaio 2019, con l'
aiuto del suo avvocato Juan Branco consigliere di Julian Assange e dei gilet
gialli, oppure se si è trattato di un complotto più ampio al quale potrebbero
avere partecipato forze vicine al presidente russo Putin. Nata in una famiglia
agiata di Metz, Alexandra de Taddeo parla cinque lingue tra le quali il russo
(perfettamente) e si è laureata in diritto internazionale a Parigi con una tesi
sulla «politica estera della Federazione russa nell' Artico». Secondo il padre
«Alexandra vive da 10 anni a Parigi ed è in buoni rapporti con noi». Ha studiato
poi a Oxford ed è stata stagista all' Unesco e più di recente all' Alleanza
degli avvocati per i diritti umani. Dal 2018 fa parte del «Consiglio parigino
della gioventù», un organismo del comune di Parigi, cosa che ha fatto ipotizzare
un possibile coinvolgimento della sindaca Anne Hidalgo. In realtà il Consiglio,
che si occupa di democrazia partecipativa, non è legato ad alcun partito o
esponente politico, e se ne fa parte se tirati a sorte dopo avere presentato
domanda. Durante la custodia cautelare Alexandra de Taddeo avrebbe spiegato di
avere fornito i video a Pavlenski per motivi personali, «una vendetta» per il
comportamento di Griveaux nei suoi confronti. Nella prima metà del 2018 è stata
lei a contattare Griveaux, all' epoca portavoce del governo, su Facebook e
Instagram. I due hanno cominciato a parlare di politica, poi la relazione è
diventata personale e da virtuale sarebbe diventata reale, prima di
interrompersi. I famigliari della de Taddeo la descrivono come una studentessa
brillante, interessata alla Russia, molto innamorata di un uomo «che non è certo
il nostro tipo» e che l' avrebbe trascinata in un ambiente estremista servendosi
di lei. Alexandra ha partecipato all' operazione non solo registrando i messaggi
di Griveaux (che avrebbero dovuto cancellarsi un minuto dopo la ricezione) e
consegnandoli a Pavlenski, ma anche co-firmando con lui un' intervista a un'
attrice pornografica, apparsa nello stesso sito «Pornopolitique. com», dal
titolo «Il puritanismo in politica è il sintomo di un' ideologia da politici
frustrati».
Scandalo
Griveaux, la Francia si riscopre più bacchettona dell’Italia.
Fulvio Abbate de Il Riformista il 20 Febbraio 2020. L’Affaire Griveaux getta una
pessima luce moralistica sull’Esagono. Da Parigi alla Francia tutta, forse.
Sulle macerie del Parti socialiste un tempo egemone nella sua rue de Solfèrino,
abbiamo visto sorgere la piccola sagoma di Emmanuel Macron, ircocervo politico
post-post-gollista. Ora l’affare si ingrossa con lo spettro di un video privato,
assai privato, intimo, impudico, girato online, “dono” d’amore che il candidato
sindaco, creatura proprio del vivaio macroniano, aspirante alla guida della
capitale, sfidante della socialista Anne Hidalgo, Benjamin Griveaux, sposato con
tre figli di 7 anni, 5 anni, e otto mesi, ha nottetempo inviato da certo
spasimante, “missive”, come dire, post-pneumatiche, sì, che François
Truffaut avrebbe ben saputo rendere anche questo racconto epistolare virtuale
sullo schermo, come già aveva fatto in “Baisiers volés”, “Baci rubati”. In
presenza dello “scandalo” dei video divenuti pubblici, Griveaux si è visto
condannato da se stesso a biffare ogni possibile aspirazione elettorale, il
filmato d’annuncio del suo stop mostra altro genere di contrizione. Nelle
immagini inviate alla sua corrispondente erotica su WhatsApp, il candidato
di République En Marche, sia detto con parole semplici, era invece lì a
masturbarsi con estatico vigore sentimentale. «Ho deciso di ritirare la mia
candidatura all’elezione municipale parigina», annuncia l’uomo, sconfitto dalla
sua imprudenza, in un incontro pubblico convocato dopo che il video è stato
diffuso dalla BFM-Paris. «Ho ricevuto attacchi ignobili. Non intendo esporre
ulteriormente, me e la mia famiglia, quando tutti i colpi sono ormai permessi,
qui ci si spinge oltre. È una decisione che mi costa, ma le mie priorità sono
chiare, prima la mia famiglia». Anche per Macron, sia detto, assodato che il
Presidente aveva puntato molto su Griveaux, indicato al terzo posto nei sondaggi
(su di lui pesavano già infatti gli attacchi recenti ricevuti dai “gilets
jaunes” contro un candidato ex socialista ed ex collaboratore di Strauss-Khan,
maestro di altrettanta rapace nonchalance sessuale; Dominique “rattuso” globale,
direbbero prosaicamente a Napoli) ora con il suo ritiro la conquista di Parigi
si mostra ripida. Compreso l’approdo all’Hotel De Ville, imperiale sede del
Municipio di Parigi, dinanzi al quale Robert Doisneau ebbe modo di scattare il
più celebre bacio della storia fotografica, in un dopoguerra eroticamente infine
felice esistenzialisticamente di se stesso, quasi un manifesto di liberazione,
ciò che i surrealisti chiamano “istinti desideranti”, compreso, estremizzando,
la scelta di inviare in dono tutto di se stessi, i fiotti del proprio piacere.
Riaffiora in mente una vignetta di Wolinski dedicata a trascorse disfide
elettorali, dove il candidato, piazzandosi davanti a una fanciulla in fiore
nuda, così da coprirne il “delta di Venere”, come direbbe Anaïs Nin, promette di
scansarsi qualora dovesse essere eletto; così per chiarire che la Francia mai ha
mostrato ossequio al moralismo sessuofobico, ne ha sempre riso, non ha mai
criminalizzato il sesso. Si chiama Alexandra de Taddeo, studentessa ventinovenne
francese, la destinataria della nostra storia erotico-epistolare, è a lei che,
nel maggio 2018, Griveaux invia i video personali poi diffusi su internet
da Piotr Pavlenskij, l’artista anarchico russo rifugiato a Parigi, sempre da
questi riversati nel sito “pornopolitique.com” con scarne parole
d’accompagnamento: «Denuncio l’ipocrisia di un candidato che fa campagna
elettorale difendendo i valori della famiglia ma in realtà manda video di
masturbazione a un’altra donna». Si tratterà ora di comprendere, assodato il
crucifige toccato all’ingenuo Griveaux, quanto si tratti di azione
politico-artistica di segno situazionista concepita dal singolo Pavlenskij,
compagno dal gennaio 2019 di Alexandra, all’insaputa di quest’ultima o semmai di
un “affaire” calibrato dai servizi del presidente russo Putin. Di Pavlenskij va
ricordato, fra poco altro, la volta in cui inchiodò il proprio pene sulle basole
della Piazza Rossa. Pupilla alto-borghese di Metz, Alexandra de Taddeo conosce
cinque lingue, compreso il russo, si è laureata in diritto internazionale a
Parigi, ha frequentato Oxford, è stata stagista all’Unesco. In stato di fermo,
racconta di avere offerto i video a Pavlenskij per ragioni “vendetta personale”
nei confronti di Griveaux. Per la cronaca, all’inizio del 2018 sarebbe stata lei
a contattare l’uomo, allora portavoce del governo, sui social. La relazione è
presto divenuta personale, da virtuale a reale, prima di interrompersi. I
familiari affermano intanto che l’artista russo l’avrebbe trascinata in un
ambiente estremista servendosi di lei per i suoi scopi diciamo spettacolari,
«Alexandra non è anarchica!». Ora, chiunque abbia esperienza del mondo così
com’è adesso nel tempo digitale, può immaginare che nottetempo lungo le strade
celesti della rete immagini simili a zampilli si rincorrono da un capo all’altro
dei borghi, delle città, delle metropoli; se improvvisamente, come nel romanzo
La vita istruzioni per l’uso di Georges Perec, potessimo scostare le facciate
per mettere lo sguardo dentro i vani segreti degli appartamenti subito ne
avremmo contezza. In tutt’altro contesto letterario, così recita un greve canto
goliardico narra “l’agile mano” che “snuda il banano”. Ci viene in mente il caso
di Dominique Strauss-Khan, pensiamo al Paese dove Toulouse-Lautrec faceva mostra
fotografica di sé mentre, interamente nudo, defecava sulla spiaggia, il paese
che con il can-can ha mostrato per primo l’intimo femminile; insomma, può
lasciarsi andare a un simile moralismo la grande nazione che, insieme
all’Illuminismo, ha avuto tra i suoi presidenti della Repubblica, ben altro che
Mitterrand o Hollande o Pompidou la cui “Madame” era oggetto di implacabile
satira sessuale, ovvero un Félix Faure deceduto nel 1899 a causa di un ictus
nella Sala Blu dell’Eliseo, mentre si intratteneva con l’amante che gli stava
praticando “une pipe”? Insomma, pietà, se non indulgenza laica, per l’incauto
Griveaux.
Scandalo
Griveaux, il rampante Benjamin nella morsa tra la bella Alexandra e la spia
Piotr.
Angela Nocioni de Il Riformista il 27 Febbraio 2020. Brume parigine, tecnica
sovietica. È l’avvocato del performer russo, molto più del performer russo, il
personaggio interessante dello scandalo francese che ha mandato all’aria la
candidatura del macronianissimo Benjamin Griveaux a sindaco di Parigi. Si chiama
Juan Branco. Ha 30 anni. È stato avvocato di Julian Assange. Ha lavorato in vari
gabinetti ministeriali. È stato candidato senza successo di Francia
Insumisa, sinistra populista. Ora sta con i Jilet jeaunes. Viene dalle stesse
ottime scuole, vivaio dell’aristocrazia repubblicana francese, da cui viene il
presidente francese Emmanuel Macron ed odia profondamente Emmanuel Macron. È
autore di un pamphlet di successo (150 mila copie vendute) sulle malefatte del
macronismo. Un capitolo del libro è dedicato a Griveaux. La storia dello
scandaletto che ha cambiato a trenta giorni dal voto la campagna per governare
Parigi è nota. Il sito Porno Politique ha pubblicato un video privato di
Benjamin Griveaux, stretto collaboratore di Macron e candidato sindaco, da lui
inviato due anni fa a Alexandra de Taddeo, studentessa ventinovenne che con
Griveaux ebbe una relazione lampo nel maggio del 2018 quando Griveaux – sposato,
tre figli, con tutto il packaging perfettino del trentenne conservatore e di
potere a Parigi – era portavoce del governo Macron. L’immediata rinuncia di
Griveaux ha tolto ogni dubbio sulla autenticità del video. La questione della
non escludibile manomissione delle immagini è più complicata, ma interessa meno
perché intanto la candidatura è saltata. Alexandra de Taddeo è attualmente la
fidanzata di Piotr Pavlensky, autore dell’invio del video a Porno Politique.
Pavlensky sembra essere personaggio più spostato che controverso. Ha 35 anni, si
muove a scatti. Sgrana sempre gli occhi quando parla, in ogni dichiarazione
pubblica fa la parte del nichilista allucinato votato a scandalizzare con
performance ad effetto. S’è crocifisso lo scroto a Mosca sulla Piazza Rossa, s’è
mutilato un orecchio, s’è avvolto nudo nel filo spinato, ha incendiato la porta
della Banca di Francia in piazza della Bastiglia (ed è stato condannato a 11
mesi di prigione per questo). In Francia risiede da rifugiato. Ha ottenuto
rapidamente l’asilo politico nel 2017 dopo esser fuggito dalla Russia con accuse
di violenza. Il 15 febbraio, subito dopo la pubblicazione del video, è stato in
arresto due giorni insieme alla fidanzata. Rilasciati entrambi il 17 in libertà
condizionata con divieto di comunicare tra loro e imputati per attentato alla
vita privata e diffusione di immagini a carattere sessuale senza il consenso
delle persone coinvolte. Pavlensky si dice «sorpreso» di essere in libertà
vigilata. Dice di non aver nessuna intenzione di andarsene, di sentirsi parigino
e di voler partecipare alla politica francese. Incontra i giornalisti nello
studio privato di Juan Branco, il suo avvocato fino al giorno del suo arresto,
che l’altro giorno gli ha messo a disposizione gli eleganti saloni della “Branco
& Associati”, il suo appoggio e anche i suoi due bellissimi gatti per fare
coreografia. È stato Branco, secondo quanto racconta Branco e Pavlensky
conferma, a consigliarlo prima della pubblicazione del video. E, secondo il
racconto di entrambi, è stato sempre lui a introdurlo a Parigi. Dice di averlo
fatto perché il performer russo gli sembrava in difficoltà con la
socializzazione. Di averlo incontrato insieme alla fidanzata nel novembre scorso
a Lisbona durante i preparativi di una conferenza internazionale sulle
tecnologie. E di esserlo andato ad ascoltare a dicembre alla Sorbona dove teneva
un discorso. «L’ho invitato a una festa di Capodanno perché mi sembrava un po’
isolato» dice Branco. Festa finita male. Pavlensky avrebbe accoltellato vari
invitati. È stato denunciato per aggressione. Il suo ospite non l’ha presa male.
Informato da Pavlensky e Taddeo su «una grande azione quasi pronta» i primi di
febbraio ha incontrato i due per vedere il video. Dice di aver spiegato loro le
possibili ricadute e anche di averli avvisati che in Francia in genere la vita
privata dei politici in genere non appassiona molto. Poi i racconti si
confondono. Pavlensky assicura che la sua fidanzata non c’entra nulla, che anzi
il video gliel’ha rubato lui dal computer di nascosto. Poi però dice anche di
aver preparato la «grand’azione» insieme a lei. Che il video se l’è tenuto in
memoria per due anni. Insieme forse a qualcos’altro, vista la fuga fulminea di
Griveaux dalla vita pubblica.
Anais Ginori per repubblica.it il 2 marzo 2020. “Rimpianti? No,
non ne ho”. Parla Alexandra de Taddeo, la donna dello scandalo che ha portato al
ritiro del candidato a sindaco di Parigi, Benjamin Griveaux. Studentessa in
legge, nata a Metz 29 anni fa, con interessi legati alla Russia, Taddeo ha
rilasciato la sua prima intervista all'emittente M6. Spiega di aver conservato i
video osé che Griveaux le aveva mandato nel 2018 per proteggersi in caso si
fosse scoperta la loro relazione con l'allora ministro, sposato con figli.
“Volevo poter dimostrare che era lui che mi aveva sollecitato”. Con l'ex
ministro, fedelissimo di Macron, è cominciato nell’aprile 2018 un rapporto
virtuale, via Instagram e Facebook Messenger, poi concretizzato in un incontro
fisico, nella casa parigina della giovane. Taddeo precisa che c'è stato un unico
rapporto sessuale con Griveaux. “Un po' deludente, come spesso capita quando ci
si conosce prima virtualmente” aggiunge. Gli scambi di messaggi e video tra i
due però sono continuati per qualche mese, con la giovane che ha ricambiato con
immagini “meno pornografiche e più erotiche”, precisa. Alla fine Taddeo sostiene
di aver chiuso le comunicazioni con Griveaux all’inizio del 2019, annunciandogli
di essersi fidanzata con l'artista russo Piotr Pavlenskij. “L'uomo della mia
vita” dice a un certo punto dell'intervista, commuovendosi quando
l'intervistatore le chiede se è difficile non avere più contatti con lui, come
hanno stabilito i magistrati per i due indagati nell'affaire. “E' molto dura
perché lo amo. Ma sono convinta che questa vicenda ci unirà ancora di più”.
Taddeo è indagata insieme a Pavlenskij per "violazione della privacy" e
"diffusione senza il consenso della persona di immagini di natura sessuale",
reati puniti in Francia con due anni di carcere e 60mila euro di sanzione.
Eppure non sembra preoccupata, anche se ripete di essere stata all'oscuro del
progetto del suo fidanzato. I video, prosegue, sono stati messi in linea da
Pavlenskij a sua insaputa sul sito PornoPolitique. “L'ho scoperto solo dopo”
racconta. “Sul momento, a caldo, mi sono arrabbiata con Piotr. Poi ho capito il
suo gesto che è nel solco delle mie convinzioni politiche”. La giovane, che
alcuni hanno immaginato addirittura come una Mata Hari al servizio della Russia,
si mostra sorridente e tranquilla. “Non ho rimpianti perché amo Piotr”. Dice di
essere rimasta stupita dal clamore suscitato dalla pubblicazione del video. “In
fondo siamo circondati da immagini pornografiche” commenta. Pensa che Griveaux
sia stato costretto a farsi da parte “prendendo atto della sua ipocrisia”,
ovvero della contraddizione tra il suo flirt e il programma di sostegno alle
famiglie che portava avanti in campagna elettorale. “Forse questa storia
costringerà i politici ad essere un po’ onesti tra quello dicono in pubblico e
fanno in privato”. Pavlenskij ha promesso di diffondere altri video. Taddeo
sorride. “Non lo so ma - conclude - non è un affabulatore, e quindi penso sia
vero”.
Macron come Chirac: si infuria contro gli agenti a Gerusalemme.
Pubblicato mercoledì, 22 gennaio 2020 su Corriere.it da Stefano Montefiori,
corrispondente da Parigi. La rabbia contro le forze di sicurezza locali che
volevano scortarlo nella basilica di Saint-Anne. Come fece «ChiChi» nel 1996. In
visita in Israele per i 75 anni della liberazione di Auschwitz, il presidente
francese Emmanuel Macron ha perso per qualche istante l’aplomb diplomatico
mentre faceva una passeggiata nella città vecchia di Gerusalemme. Intorno alle
15, al momento di entrare nella basilica di Saint-Anne, che è francese e gode di
una sorta di extra-territorialità simile a quella di un’ambasciata, gli agenti
di sicurezza francesi hanno avuto un diverbio con quelli israeliani, che
volevano a loro volta entrare nella chiesa per proteggere Macron e il suo
seguito. Il presidente francese si è irritato e ha alzato la voce gesticolando
con le guardie israeliane. «Tutti conoscono le regole - ha detto Macron in
inglese -. Non mi piace quello che avete fatto di fronte a me. Andate fuori. Mi
spiace. Conoscete le regole. Nessuno deve provocare nessuno». Anche l’inglese di
Macron, di solito perfetto o quasi, è andato un po’ fuori controllo e ha preso
un forte e inusuale accento francese. L’Eliseo. Questa la spiegazione di quanto
accaduto secondo le fonti della presidenza francese: «Sainte Anne è un dominio
nazionale francese a Gerusalemme. Spetta alla Francia proteggere questi luoghi.
Le forze di sicurezza israeliane sono volute entrare nonostante la sicurezza
fosse assicurata dagli agenti francesi. Il presidente ha reagito a una lite tra
le forze di sicurezza israeliane e francesi al momento di entrare nella chiesa,
con lo scopo di mettervi fine e di ricordare le regole che si applicano in
questa situazione. Ha sottolineato che tutto era andato per il meglio fino a
quel momento nella visita e che non era necessario creare un incidente. Tutto è
rientrato in ordine, niente di grave». L’uscita di Macron sembra una citazione
dell’altro presidente francese, Jacques Chirac, che in una circostanza identica
nel 1996 si lasciò andare a uno sfogo rimasto celebre in Francia e rivisto molte
volte nelle commemorazioni televisive seguite alla sua morte, il 26 settembre
2019. «Vuole che torni suo mio aereo?», disse Chirac a un agente israeliano
davanti alla basilica di Sainte-Anne. «Questa non è sicurezza, questa è una
provocazione». La visita in Israele e nei territori dell’Autorità palestinese fu
complicata, per altri motivi, anche per l’allora premier Lionel Jospin nel 2000,
quando venne preso a sassate all’uscita dell’università Bir Zeit in Cisgiordania
da decine di militanti islamisti furiosi perché aveva qualificato di
«terrorista» il movimento Hezbollah. Il presidente francese ha già incontrato il
premier israeliano Benjamin Netanyahu e nel pomeriggio era atteso a Ramallah, in
Cisgiordania, per incontrare Mahmoud Abbas, il capo dell’Autorità palestinese.
Ma il programma della visita è scombussolato, Macron in serata non era ancora
andato a Ramallah dove è tuttora atteso nonostante a cena debba vedere il
presidente israeliano Reuven Rivlin. In una conferenza stampa Macron ha preso
posizione contro chi nega il diritto all’esistenza di Israele. «L’antisionismo,
quando è la negazione dell’esistenza di Israele come Stato, è una forma di
antisemitismo. Questo non significa che non sia lecito avere disaccordi, o
criticare questa o quell’azione del governo di Israele, ma la negazione della
sua esistenza è oggi una forma contemporanea di antisemitismo».
Anais Ginori
per “la Repubblica” il 9 gennaio 2020. Il 2020 sarà un anno ad alta tensione
giudiziaria per Nicolas Sarkozy. L' ex presidente francese verrà infatti
processato in autunno (dal 5 al 22 ottobre). Sarà la prima volta, nella storia
della Quinta repubblica, che un ex capo di Stato andrà sul banco degli imputati
con l' accusa di corruzione. Jacques Chirac, ormai vecchio e malato, era stato
chiamato nel 2011 alla sbarra per accuse di impieghi fittizi risalenti al suo
mandato come sindaco di Parigi, poi condannato a due anni con la condizionale
per appropriazione indebita di fondi pubblici. Questa volta l'accusa per l'ex
inquilino dell'Eliseo è ancora più grave visto che il rinvio a giudizio è
motivato dalla corruzione di un alto magistrato. I fatti risalgono al 2014,
quando Sarkozy era indagato per presunte somme ricevute in campagna elettorale
da Liliane Bettencourt, esponente della famiglia che ha fondato L'Oréal. Sarkozy
è stato prosciolto dall' accusa ma è stato rinviato a giudizio per il tentativo
di corruzione del magistrato Gilbert Azibert, documentato da intercettazioni
telefoniche in cui l' ex presidente aveva preso un'utenza con un nome falso.
Dalle conversazioni emerge che Sarkozy e il suo avvocato, Thierry Herzog,
avrebbero offerto a Azibert un incarico nel principato di Monaco in cambio di
notizie riservate nel procedimento. Presidente francese fra il 2007 e il 2012,
Sarkozy ha sempre negato le accuse, ma è stato sconfitto nei suoi diversi
ricorsi per tentare di archiviare la faccenda. Non è il solo processo che dovrà
affrontare Sarkozy, rinviato a giudizio anche nell' inchiesta sul finanziamento
illegale della sua campagna presidenziale nel 2012. In questo caso è coinvolta
la società Bygmalion che avrebbe gonfiato i costi della campagna attraverso
false fatture. La data del processo sarà fissata nei prossimi mesi. L'ultimo
fronte aperto è quello dell'inchiesta della magistratura su presunte somme
ricevute da Sarkozy da parte del regime libico di Gheddafi per la campagna
presidenziale del 2007. La denuncia del faccendiere Ziad Takkiedine, che sarebbe
stato testimone e intermediatore dei versamenti da Tripoli a Parigi, ha portato
nel 2018 all' iscrizione nel registro degli indagati. Sarkozy è indagato per
"corruzione passiva, finanziamento illegale della campagna elettorale e
occultamento di fondi pubblici libici". La Corte d' appello di Parigi esaminerà
a marzo un ricorso degli avvocati dell' ex presidente contro questo
procedimento.
Migranti,
il rapporto che inchioda la polizia francese «brutale e razzista».
Alessandro Fioroni il 6 Settembre 2019 su Il Dubbio. Human Rights watch accusa
Parigi di violare I diritti dei minori immigrati. Tra gli abusi riscontrati la
falsificazione dell’età, la detenzione, senza cibo e coperte, l’assenza di
tutori legali. La ong: «queste violazioni sono un’abitudine». Respingimenti
illegali, mancanza di alloggi adeguati, procedure illegali per il riconoscimento
della minore età, scarsa possibilità di accedere a istruzione e strutture
sanitarie. L’ultimo rapporto dell’organizzazione umanitaria Human Right Watch si
è concentrato sulla situazione dei migranti minori non accompagnati al confine
tra Italia e Francia. Le violazioni dei diritti dei giovani immigrati, che
spesso tentano il passaggio del confine su sentieri ghiacciati e senza
equipaggiamento adeguato, sono numerose. Non a caso il rapporto prende in esame
ciò che succede nelle regione delle Alte Alpi e si basa su diverse testimonianze
( almeno una sessantina) di ragazzi tra i 15 e i 18 anni. Sotto accusa le
autorità francesi, colpevoli di compiere procedure contrarie al diritto
internazionale sulla protezione dell’infanzia. Bènèdicte Jeannerod di HRW spiega
come «durante il colloquio di valutazione i ragazzi vengono spesso accusati di
mentire e ogni loro racconto viene strumentalizzato per non riconoscere
arbitrariamente la loro minore età». Un’ «abitudine» già denunciata da ong come
Oxfam. In un altro rapporto infatti si raccontava della polizia che «ferma i
bambini stranieri soli e li obbliga a salire su treni diretti in Italia dopo
averne alterato i documenti per farli apparire più grandi o facendo sembrare che
vogliano tornare». Oxfam parlava chiaramente della registrazione dei minori come
maggiorenni, di detenzione senza cibo o coperte e senza un tutore legale. Fecero
scalpore anche le testimonianze sui furti delle Sim telefoniche e il taglio
delle scarpe per impedire la prosecuzione del viaggio verso la Francia. Ma le
accuse riguardano anche il comportamento degli agenti nei confronti dei
volontari che aiutano i migranti a passare il confine o che soccorrono chi è in
difficoltà. Nonostante il riconoscimento del “principio di fratellanza” da parte
della Corte costituzionale francese dopo il caso di Cedric Herrou ( il contadino
della Val Roya più volte sanzionato penalmente per la sua opera di solidarietà),
nulla sembra essere cambiato. Il rapporto di Human Rights Watch attribuisce alla
polizia francese atti «intimidatori» per «impedire le attività umanitarie». La
ong ha spiegato cosa succede: «i loro veicoli vengono perquisiti, subiscono
controlli di identità non giustificati oppure finiscono in tribunale». Le
conseguenze per i “solidali” possono essere pesanti. Chi aiuta i migranti a
entrare in Francia rischia fino a 5 anni di prigione e 30mila euro di multa.
La rivolta cattolica che fa tremare Macron.
Andrea Massardo su Inside Over the world il 20 gennaio 2020.
Nell’ultimo mese e mezzo, la Francia ha vissuto la mobilitazione di massa dei
movimenti contro la riforma delle pensioni che ha letteralmente bloccato il
trasporto pubblico del Paese. Il 2018 invece era stato l’anno dei gilet gialli,
che avevano iniziato le proteste contro l’Eliseo a causa degli aumenti previsti
che avrebbero colpito principalmente la fascia medio-bassa del Paese. Adesso, un
nuovo fronte di protesta a guida cattolica sta scendendo in strada, con una
manifestazione che, ai dati della prefettura e come riportato da Le Monde,
avrebbe raccolto oltre 41 mila partecipanti. Le proteste, che nascono a seguito
della proposta di modifica della legislazione francese riguardante la fecondità
assistita che si aprirebbe anche in parte alle coppie omosessuali, gettano nuove
ombre sull’esecutivo guidato da Edouard Philippe, sempre più nell’occhio del
ciclone per un piano di riforme troppo invasivo nella società della Francia.
Le opposizioni dei cattolici. Come ribadito dai portavoce della
protesta, la gravità della riforma risiede nella distruzione della famiglia
tradizionale, in quanto rendendo superflua la presenza della figura del padre
all’interno del nucleo familiare. Infatti, aprendo la legge alla possibilità per
le donne single e omosessuali di aver accesso all’inseminazione artificiale, la
presenza o meno della figura maschile appare irrilevante ai fini riproduttivi e
di costruzione della struttura familiare: particolare che i fedeli francesi
aderenti alla manifestazione di protesta non possono tollerare. La possibilità
di aprire alla fecondazione assistita nelle situazioni in cui la struttura della
famiglia tradizionale è snaturata apre inoltre a due importanti problemi, che il
fronte cattolico ritiene di primaria importanza. Innanzitutto, i bambini
diverrebbero di fatto oggetto di scambio, divenendo merce, entrando prima ancora
di nascere all’interno delle logiche di mercato. In secondo luogo, una volta
cresciuti i bambini sarebbero privati dei giusti punti di riferimento in assenza
della figura paterna, particolare che si ripercuoterebbe sul regolare
svolgimento della loro vita e creerebbe lacune difficilmente colmabili.
Il fronte delle proteste. All’interno dei partecipanti alla
manifestazione indetta per la giornata di domenica non erano presenti però
soltanto i fedeli cattolici. Il gruppo sceso in piazza era assai variegato, con
i partecipanti provenienti da differenti culture e da diversi ambienti;
particolare che sottolinea quanto sia compatto il fronte di opposizione alla
riforma voluta da Emmanuel Macron. Durante la manifestazione di domenica, i
partecipanti hanno invitato la popolazione a presentarsi nella giornata di
martedì davanti alle porte del Senato, all’interno del quale verrà effettuata la
seconda lettura della proposta di legge. Nonostante gli stessi manifestanti
riconoscono come facilmente la legge verrà convalidata, la volontà degli
organizzatori risiede nel portare nelle piazze il disagio della popolazione
verso una riforma che può compromettere le generazione future, che rischiano di
essere private della presenza della figura paterna. Inoltre, la mossa del
governo di Philippe rischia di aprire ad un vero e proprio mercato attorno alla
fecondazione assistita, con le grandi case mediche e farmaceutiche che
trasformerebbero ovuli e feti in merci: situazione questa che la comunità
cattolica del Paese non può assolutamente tollerare.
Macron è sotto attacco su più fronti. L’ondata di manifestazioni
che ha caratterizzato il governo di En Marche! ha messo a dura prova la tenuta
dell’esecutivo, che per mantenere la stabilità ha già dovuto ruotare oltre 10
ministri dal suo insediamento. I punti di attrito sulla popolazione sono sempre
arrivati nei momenti in cui il piano di riforme voluto da Macron ha toccato i
temi chiave del Paese: imposte indirette, sistema previdenziale e questioni
legate alla famiglia tradizionale ed ai nuovi nuclei familiari. Una parte del
contrasto è dovuto alla forse eccessiva immobilità che ha avuto il sistema
sociale francese negli anni scorsi e che non ha seguito le aperture che hanno
caratterizzato invece gli altri Paesi dell’Unione europea. Dall’altra, è dovuto
ad un’eccessiva fretta e dirompenza con la quale il governo ha voluto sviluppare
il piano di riforme, mentre una implementazione più graduale avrebbe molto
spesso limitato i contrasti. Tuttavia, la volontà dell’esecutivo di raggiungere
il risultato nel più breve tempo possibile è stato sin da subito il tratto
caratterizzante di En Marche!, in accordo anche con le promesse della campagna
elettorale. Tuttavia, il governo francese si ritrova ancora una volta sotto
assedio, barricato all’interno delle mura dell’Eliseo ad osservare la folla che
manifesta la propria opposizione alle volontà dell’esecutivo. La scena, che si
ripete quasi senza sosta da oltre un anno a questa parte, evidenzia il
forte distacco tra governo e popolo della Francia, in una situazione che sempre
peggiorare sempre di più col passare delle settimane. Nonostante questa
condizione, il governo francese continua il suo piano di riforme, sfidando la
pazienza del popolo francese. La possibilità però che un giorno la popolazione
della Francia giunga allo stremo sono elevate: e quel punto, per Macron
diventerà difficile persino portare avanti l’ordinaria amministrazione.
Parigi
perde 10.000 abitanti l’anno: troppo cara per giovani e famiglie.
Pubblicato giovedì, 02 gennaio 2020 da Corriere.it. Parigi è il sogno dei
turisti di tutto il mondo; la meta di tanti francesi di provincia che ambiscono
a vivere finalmente nella capitale del Paese più centralista d’Europa; e la casa
di molti cittadini agiati che vivono benissimo in una metropoli straordinaria.
Ma la ville lumière continua a perdere abitanti. Secondo le ultime cifre diffuse
dell’Insee (Istituto nazionale di statistica) tra il 2012 e il 2017 la capitale
francese è stata abbandonata da 53.095 residenti. Ogni anno se ne vanno 11 mila
persone in più di quante ne arrivano, mentre fino al 2012 accadeva il contrario.
Oggi Parigi ha due milioni 187 mila 526 abitanti (nel 2012 erano due milioni 240
mila 621). «Parigi ha il più forte deficit migratorio di tutti i dipartimenti
francesi», si legge nello studio dell’Insee. Non è una questione legata al
dinamismo economico, anzi: la capitale è sempre di più una calamita per i
lavoratori qualificati, i servizi e le start-up legate alle nuove tecnologie
sono riusciti a compensare il declino degli stabilimenti industriali del secolo
scorso. Ma chi trova lavoro a Parigi spesso va ad abitare nei comuni vicini, e
infatti la popolazione aumenta in tutti gli altri dipartimenti della regione,
grazie anche alla natalità. La capitale soffre del suo successo, molti non
possono più permettersela. Soprattutto i giovani e le famiglie non riescono ad
affrontare un mercato immobiliare dove il prezzo medio l’estate scorsa ha
superato i 10 mila euro a metro quadro. I candidati alle municipali del marzo
2020 — dalla sindaca uscente Anne Hidalgo agli sfidanti Benjamin Griveaux e
Cédric Villani — promettono una Parigi di nuovo accessibile alle persone comuni,
e incolpano il turismo e il fenomeno Airbnb. «A Parigi solo l’82% degli
appartamenti sono case di chi ci abita — dice l’assessore socialista Emmanuel
Grégoire —. Una quota diminuita del 3% negli ultimi anni perché aumentano le
seconde case e gli appartamenti affittati per pochi giorni». Il sindaco
ecologista del secondo arrondissement Jacques Boutault stima che il rendimento
di una casa destinata ai turisti superi di due volte e mezzo quello di un
appartamento affittato tutto l’anno. Quindi le case da abitare scarseggiano e i
prezzi continuano ad aumentare. «La sfida del prossimo mandato sarà ridare ai
quartieri centrali la loro vocazione residenziale», ha detto Boutault al
Parisien. Nel centro di Parigi chiudono alcune scuole, le classi vengono
raggruppate per mancanza di bambini, diminuiscono i negozi di alimentari —
nell’île Saint-Louis sono praticamente scomparsi — a vantaggio di caffè e
ristoranti di lusso. Una tendenza all’opera anche a New York, dove nel 2018 gli
abitanti sono diminuiti di 39 mila 500 persone. Londra invece cresce, sostenuta
dalla forte demografia dei nuovi arrivati. A Parigi molti abbandonano perché la
città è diventata troppo cara, ma aumentano anche quelli che pur potendo
rimanere sono attratti da una vita più tranquilla in provincia. Il sito «Paris,
je te quitte» (Parigi, ti lascio) ha fatto fortuna organizzando a parigini
stanchi una seconda vita a Montpellier, Limoges, Strasburgo o Rennes.
Leonardo Martinelli per “la Stampa” il 23 dicembre 2019. Nata nel
1945, come moneta comune delle colonie francesi in Africa, il franco Cfa era
rimasto in funzione anche dopo l' indipendenza raggiunta dai Paesi dell' area,
una sessantina d' anni fa. Sempre più criticato come il retaggio del
colonialismo di Parigi, a sorpresa Emmanuel Macron, in visita ad Abidjan, ha
annunciato al fianco del presidente della Costa d' Avorio, Alassane Ouattara, il
tramonto della valuta. La nuova valuta, che entrerà in circolazione nel 2020
(forse a luglio, ma non è stata fissata una scadenza precisa), sarà ribattezzata
Eco. Resterà ancorata all' euro, ma gli otto Paesi che l' adotteranno non
avranno più l' obbligo di depositare il 50% delle proprie riserve presso il
Tesoro francese. E nessun rappresentante di Parigi siederà più nel consiglio d'
amministrazione della Bceao, la banca centrale dei Paesi dell' Africa dell'
Ovest interessati dal cambiamento. Come sottolineato da Ouattara «la fine del
franco Cfa porrà fine a tutte le illazioni su questa moneta». Della questione,
nel gennaio scorso, era impicciato addirittura il vicepremier Luigi Di Maio.
Aveva dichiarato che, «se la Francia non avesse le colonie francesi che sta
impoverendo, sarebbe la 15ª forza economica internazionale e invece è fra le
prime per quello che sta combinando in Africa». Giovedì sera, Macron,
rivolgendosi a Ouattara, ha affermato: «Il franco Cfa cristallizza troppe
critiche: i giovani africani ci rimproverano di continuare una relazione che
giudicano postcoloniale». Da lì il via libera all' addio al Cfa. Il presidente
ha aggiunto che «troppo spesso si percepisce la Francia come se avesse ancora
sull' Africa uno sguardo egemonico e con gli orpelli di un colonialismo che è
stato un errore profondo della nostra Repubblica». I limiti di questa svolta? Si
applica agli 8 Paesi francofoni dell' Africa occidentale (Uemoa), tra cui Costa
d' Avorio e Senegal, economicamente quelli trainanti del gruppo, ma non alle ex
colonie di Parigi nell' Africa centrale (Cemac), sei Stati in tutto, tra cui
Camerun e Gabon, che continueranno a utilizzare il Cfa. Poi, almeno per il
momento, la Banca centrale francese resta garante finanziaria per gli otto Paesi
dell' Uemoa. E soprattutto l' Eco rimarrà ancorato alla moneta europea, come il
Cfa (l' attuale parità è di un euro per 655,96 franchi Cfa). Questa
caratteristica ha permesso ai Paesi che utilizzano la valuta di conservare una
certa stabilità monetaria e un' inflazione sotto controllo. Ma il legame con l'
euro ha rappresentato pure una zavorra per l' export rispetto al resto dell'
Africa ed è un problema che si manterrà intatto con l' Eco. Non solo: Ouattara
ha parlato in qualità di presidente in carica dell' Uemoa, ma non esiste un
mandato specifico da parte dei capi di Stato degli altri Paesi, né si è svolto
un dibattito parlamentare in Costa d' Avorio al riguardo. Eco, poi, è lo stesso
nome della moneta comune che tutta la Cedeao, la Comunità economica dell' Africa
dell' Ovest (quindici Paesi compresi gli otto dell' Uemoa, più altri, come la
potentissima Nigeria, ex colonia britannica), voleva da tempo adottare. Nella
speranza di Macron e Ouattara anche il resto della Cedeao potrebbe accodarsi. Ma
non sarebbe stato meglio aspettare una decisione di tutta quella Comunità? E
quei Paesi accetteranno il ruolo della Francia di garante finanziario dell' Eco?
Lucie
Delaporte e Marine Turchi per “Mediapart”, pubblicato da “il Fatto Quotidiano”,
traduzione Luana De Micco il 16 dicembre 2019. Stanno sollevando polemiche le
foto di Emmanuel Macron e di sua moglie Brigitte insieme a Elie Hatem,
monarchico, amico del "patriarca" del Front National Jean-Marie Le Pen e
fervente ammiratore di Charles Maurras, uomo politico antisemita. Gli scatti
sono stati realizzati l' 8 novembre scorso, all' Eliseo, durante una cerimonia
per la consegna della Legione d' onore agli attori Jean- Paul Belmondo e Robert
Hossein e allo stilista Ralph Lauren. L'Eliseo ha parlato di "incidente" e di
"manipolazione". Ma intanto le foto, pubblicate sul profilo Facebook di Hatem e
poi ritirate, in cui si vedono Emmanuel e Brigitte Macron posare insieme al
controverso avvocato franco-libanese, hanno fatto il giro dei social network
giovedì scorso. Molte personalità hanno gridato la loro indignizione, tra cui l'
intellettuale socialista Raphaël Glucksmann e Alexis Corbière della France
Insoumise, partito della sinistra radicale, ma anche l' Unione degli studenti
ebrei di Francia (Uejf). "Come è possibile che Elie Hatem, ex membro di Action
Française e cospirazionista di estrema destra, sia stato ricevuto in pompa magna
all' Eliseo?" ha scritto l' Uejf su Twitter. Mediapart ha ricostruito la storia
di questi scatti. L' 8 novembre, dunque, all' Eliseo, Jean-Paul Belmondo, Robert
Hossein e Ralph Lauren hanno ricevuto la prestigiosa medaglia da Emmanuel
Macron. Elie Hatem era tra gli ospiti della cerimonia. Sentito da Mediapart,
Hatem ha spiegato di essere stato invitato "dai suoi amici Belmondo e Robert
Hossein, a titolo personale e per amicizia". Ci ha spiegato: "Una volta alla
cerimonia, come fanno tutti, ho scambiato qualche parola con il capo dello Stato
e ho fatto delle foto insieme a lui. Mi sono anche congratulato con lui per la
sua politica estera fedele alla tradizione diplomatica della Francia". Cosa le
ha risposto il presidente? "Che è amico del Libano e dei libanesi. Sono stato
molto impressionato dalla sua visione delle relazioni internazionali! Emmanuel
Macron - ha aggiunto Hatem - conosce il mio percorso: sa che sono stato stretto
consigliere di Boutros Boutros-Ghali, dell' ex presidente del Libano Amine
Gemayel e dell' attuale Michel Aoun. Sa anche quali sono i miei legami con il
Medio Oriente e con la Siria". Ieri - ha continuato Hatem - si è tenuta a Parigi
una riunione, voluta da Emmanuel Macron, per tentare di risolvere la crisi in
Libano. Ho colto l' occasione per ringraziarlo per i suoi sforzi ed ho
pubblicato quelle foto. Non pensavo che avrebbero sollevato polemiche", ha
aggiunto, divertito da tanto "scalpore". Contattato da Mediapart, l'Eliseo ha
dovuto ammettere: "È stato un incidente". E ha riconosciuto che, in tutta questa
vicenda, è stato vittima di "manipolazione". L'entourage del presidente ha
confermato la presenza di Elie Hatem alla cerimonia di consegna delle medaglie,
ma ha anche precisato: "Non è stato invitato da noi. Quel giorno c'erano più di
duecento persone nella Salle des fêtes". L'Eliseo nega che si sia tenuta tra
Hetem e Macron una conversazione su temi di geopolitica. "Ovviamente, il
presidente non ha mai parlato di Libano con Elie Hatem. In questo genere di
ricevimenti, capita spesso che le persone avvicinino il presidente per
consegnargli dei fascicoli o per illustrare la loro situazione personale", è
stato spiegato. Come è possibile che un personaggio così dubbio sia riuscito a
trovarsi al fianco del presidente e di sua moglie senza alcuna allerta da parte
degli uffici dell' Eliseo? "Verifichiamo eventuali precedenti di polizia degli
ospiti che figurano sulla lista, per ovvi motivi di sicurezza, ma è impossibile
ricostruire la carriera politica di ognuno di loro", hanno risposto. Di fronte
alle reazioni scatenate dagli scatti, la stessa fonte ha spiegato che "sarà
portata avanti una riflessione sulla questione delle liste degli invitati nelle
cerimonie di quel tipo all' Eliseo", in modo tale che la situazione non si
ripeta. La presidente della Uejf, Noémie Madar, intervenuta sul quotidiano Le
Parisien, ritiene che "bisogna essere prudenti: stiamo parlando di un fedele
seguace di Maurras che mostra di avere una certa vicinanza con il presidente
della Repubblica". Per Macron, in effetti, la presenza di Elie Hatem all' Eliseo
è più che imbarazzante. Il franco-libanese, 54 anni, avvocato di professione (ha
in particolare difeso in passato il mercenario francese Bob Denard), è stato per
molti anni membro del comitato direttivo di Action française, un movimento
politico filomonarchico e nazionalista. È sempre stato un fermo difensore delle
idee di Charles Maurras (1868-1952), il maître à penser di Action française,
teorico dell'"antisemitismo di Stato". Lo scorso aprile, ha tenuto una riunione
ad Avignone in omaggio a Maurras. Ha partecipato a alcuni raduni organizzati dal
movimento cattolico fondamentalista Civitas. Il 19 gennaio 2019, Hatem è stato
anche invitato a un convegno in presenza di diverse figure vicine a Alain Soral,
il saggista più volte condannato per antisemitismo e istigazione all' odio
razziale. Erano presenti: Hervé Ryssen, condannato a sua volta a più riprese per
dichiarazioni antisemite, Jérôme Bourbon, direttore del giornale negazionista
Rivarol, e Yvan Benedetti, ex membro del movimento di estrema destra l' Oeuvre
française e sostenitore del maresciallo collaborazionista Pétain. "Il mio nome è
stato fatto, ma non sono andato a quell' incontro. La riunione mi era stata
annunciata come patriottica. Avrei dovuto illustrare la mia visione della
protezione delle identità nazionali. In Francia, non si riesce a capire che si
può partecipare a una riunione politica anche senza condividere le idee degli
organizzatori - ha detto Elie Hatem a Mediapart -. Quali frasi antisemite mi
possono essere rimproverate? È l'Uejf a tacciarmi di antisemitismo. Io sono
"anti-niente" - ha commentato infastidito -. Non ho pregiudizi. Ho cugini di
confessione ebraica e drusi, quindi non posso essere contro una comunità o una
nazione. Posso essere in disaccordo con delle idee o con delle figure politiche,
o anche con dei progetti politici". Eppure, al quotidiano Libération, il
franco-libanese aveva spiegato di non essere andato all' incontro di gennaio
solo per "motivi di agenda", ma di aver "acconsentito a tenere un discorso a
nome di Action française su invito di Yvan Benedetti". Dopo l' episodio della
riunione intorno a Alain Soral, persino la stessa Action française aveva finito
col prendere le distanze da Hatem. L' organizzazione, tramite il suo portavoce
Antoine Berth, aveva spiegato all' epoca a Mediapart che Elie Hatem, "rinchiuso
nella sua follia razzista", non faceva più parte di Action Française e del suo
comitato di direzione. L' università Paris XIII aveva a sua volta annullato il
corso di diritto che l' avvocato franco-libanese teneva nell' ateneo, in
particolare dopo la protesta degli studenti ebrei dell' Uejf. Elie Hatem aveva
risposto su Facebook, denunciando una "cabala mediatica" contro di lui. Ma c'è
di più. Intervenendo più volte sui media di estrema destra, il franco-libanese
ha anche difeso delle teorie cospirazioniste. Lo aveva fatto notare il Journal
du Dimanche: Hatem ritiene che l' Isis e il Fronte Al-Nusra siano degli
"esecutori", si "interroga" sulle responsabilità degli Stati Uniti e di Israele,
ed è apparso in un video in cui "rende omaggio alla memoria" del maresciallo
Pétain. Nel febbraio 2016, in un' intervista alla tv saudita Al Arabiya, aveva
dichiarato che i "movimenti sionisti e la massoneria controllano la stampa e il
governo in Francia". Hatem non ha mai neanche nascosto la sua vicinanza a
Jean-Marie Le Pen, fondatore del Front National (oggi Rassemblement national, la
cui leader, Marine Le Pen, è la figlia di Jean-Marie, ndt), il quale, nel corso
degli anni, ha moltiplicato le dichiarazioni a sfondo antisemita. Nel 2016, Elie
Hatem aveva raccontato a Mediapart come è nata la sua amicizia con la famiglia
Le Pen: "Ho incontrato Marine quando aveva 18 anni, in una serata tra amici.
Avevamo probabilmente delle conoscenze in comune. Ho solo due o tre anni più di
lei. Siamo diventati amici. Un giorno mi ha chiesto: "Ti interessa conoscere un
po' di gente?". Abbiamo cominciare a fare delle interviste, delle altre cose, ed
è così che sono diventato amico di Jean-Marie Le Pen", ci aveva raccontato. Ci
aveva anche spiegato perché non ha mai aderito al Front National: "È contrario
alle mie idee e al mio concetto di democrazia diretta, in altre parole alle idee
di Maurras. Ritengo che i partiti politici deformino il gioco democratico,
perché gli elettori votano per le idee e non per le persone". L'avvocato invece
è stato candidato per il Front National alle municipali di Parigi nel 2014. Alle
elezioni legislative del 2017, si è presentato nel dipartimento del Var (sud)
con l' etichetta comune dei comitati "Jeanne au secours" di Jean-Marie Le Pen,
di Civitas e del Parti de la France, altro partito di estrema destra. Nel
febbraio 2017, Elie Hatem era intervenuto inoltre per agevolare il viaggio di
Marine Le Pen in Libano e il suo incontro con il presidente Michel Aoun. Ben
inserito a Cipro e a Mosca, si è anche mostrato al fianco dell' oligarca russo
Konstantin Malofeev, che dice di frequentare regolarmente. Il mecenate e uomo d'
affari, accusato in particolare di aver finanziato i separatisti russi in
Crimea, ha incontrato almeno due volte Jean-Marie Le Pen: a Montretout, la
dimora dei Le Pen, a fine 2013, e nella sede del suo fondo di investimenti, a
Mosca, nell' ottobre 2014. Malofeev è sospettato di aver svolto un ruolo attivo
nel prestito russo ottenuto quell' anno dal fondatore del Front National: nel
2014, infatti, a cavallo dei due incontri citati sopra, 2 milioni di euro erano
comparsi nelle casse di Cotelec, il micro partito di Jean-Marie Le Pen. Il
bonifico era stato effettuato via una società con sede a Cipro.
Ritratto di
Charles De Gaulle, l’uomo che terrorizzò l’Italia.
Paolo Guzzanti de Il Riformista il 21 Febbraio 2020. Probabilmente la battuta su
come si possa governare un Paese con più di 250 qualità di formaggi fu inventata
da News Week, mentre l’altra è certa: «Signor generale, lei non può accettare la
proposta di governare la Francia senza prima fucilare tutti gli imbecilli». Si
narra che Charles de Gaulle riflettesse a lungo prima di scartarla come
eccessiva: «Vaste programme», disse. E passò a progetti più solidi. Ma la sua
idea non era esattamente quella di essere il “Sindaco di Francia”, come oggi
propone Matteo Renzi per se stesso e per l’Italia. Ma l’argomento, proprio a
causa della crisi della IV Repubblica francese che portò al presidenzialismo di
Charles de Gaulle, cominciò a serpeggiare da allora, ogni volta che si parla di
una possibile Costituzione presidenzialista in cui o il Presidente o il capo del
governo siano eletti direttamente dal popolo, senza passare attraverso il
metabolismo misterioso del Parlamento. La crisi francese del 1958 si abbatté di
riflesso anche sull’Italia come una bomba atomica. I giovani di sinistra come me
si affrettarono a gridare al colpo di Stato fascista, ignorando un bel po’
quello che era accaduto prima. L’ultimo primo ministro della Quarta
Repubblica (del tutto identica alla Terza) si chiamava Pflimlin e il suono di
quel nome, un po’ ridicolo, spingeva mio padre a provocarmi sfidando la mia
avversione a De Gaulle, che invece piaceva a tutta quell’Italia conservatrice
che in un modo o nell’altro avrebbe gradito di nuovo il ritorno della figura
dell’hombre fuerte, qualcuno come Francesco Crispi, se non proprio un duce
democristiano, da votare per plebiscito. Il democristiano Amintore
Fanfani (definito con Aldo Moro un “cavallo di razza”) aretino di sinistra ma
anche ex fascista “sociale” nutriva aperte ambizioni golliste e allo stesso
tempo detestava de Gaulle.
L’ANOMALIA
ITALIANA. Nell’Italia della decade 1955- 1965 era vigile e forte la religione
del parlamentarismo. Guai, allora, ad offendere le istituzioni parlamentari e i
loro abitanti. Sul Parlamento era stato realizzato il grande compromesso che
aveva posto fine alle minacce di una impossibile guerra civile e il Pci aveva
rinunciato da tempo al controllo delle armi della Resistenza. Il patto
parlamentare era rigido e solidale fra centro e sinistra e la sola idea di avere
a che fare con un potere concentrato su una sola persona scatenava le ire non
soltanto di comunisti e socialisti, ma degli stessi democristiani. Il mondo
democristiano era del resto una confederazione di correnti e poteri di destra e
di sinistra che si misuravano con il bilancino dei codici che stabilivano il
turn over dei governi con tutte le loro clientele, erroneamente percepito come
una fragilità. L’errore era dovuto al fatto che la Dc, con i suoi primi
alleati Psdi e Pri cui si aggiunse negli anni Sessanta il Psi di Pietro Nenni,
doveva accontentare a turno i suoi capicorrente e dunque provocava improvvisi
cambi di governo. Ciò costituiva la perfetta normalità e non l’anomalia. Ma
esternamente era percepito come un’anomalia: «Gli italiani cambiano governo
continuamente, le loro istituzioni sono inconsistenti». Era vero il contrario:
poiché il potere democristiano era coeso e condiviso, la continua
redistribuzione delle carte e delle cariche garantiva un felice raccolto a tutte
le componenti e poi anche a quelle dei loro alleati. Gli accordi con il Partito
comunista erano estremamente solidi, l’arco costituzionale provvedeva a
mantenere in quarantena perenne soltanto i neofascisti del Msi che costituivano
la casta inferiore degli intoccabili. Quando nel 1960 Fernando
Tambroni, esponente della sinistra democristiana, fu imposto a Palazzo Chigi dal
Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, anche lui della sinistra,
l’organismo multiplo e sovrano del partito democristiano si ribellò al tentativo
“gollista” del Capo dello Stato di mantenere al potere un suo presidente del
Consiglio, rifiutò di votare la fiducia al governo del Presidente. E Tambroni
compì la spregiudicata follia di accettare i voti determinanti dei neofascisti
provocando a Genova la rivolta dei portuali che si este a macchia d’olio nel
terribile luglio del 1960 con moltissimi morti e feriti con la situazione
politica totalmente sfuggita di mano. Tambroni fu costretto a dimettersi e
l’episodio gollista italiano finì in un bagno di sangue, trovando impreparato
persino il Pci di Palmiro Togliatti che si trovò di fronte agli automatismi
reattivi della forza organizzativa del partito. Ciò ebbe delle gravi conseguenze
sulla latente voglia italiana di importare una forma di gollismo senza de
Gaulle. Gli Stati Uniti e gli altri alleati della Nato sostennero che l’Italia
non era in grado di reggere un eventuale colpo di mano di sinistra e imposero la
formazione di una brigata corazzata dell’Arma dei Carabinieri affidata al
generale De Lorenzo che si alternava al comando sia dell’Arma che del servizio
segreto, con la conseguenza di un altro, temuto o immaginario o ipotetico, colpo
di Stato nel 1964 quando sarebbe stato testato il famoso “Piano Solo” con cui
arrestare tutti i leader della sinistra e del sindacato, cosa mai dimostrata e
che secondo la leggenda provocò uno scontro violentissimo fra il Presidente
della Repubblica Antonio Segni e il leader socialdemocratico Giuseppe
Saragat, con un finale drammatico: Segni fu colpito da ictus e dopo una lunga
degenza morì. I fatti di quell’estate furono poi ricostruiti, ma anche
contestati, da Lino Jannuzzi e Eugenio Scalfari sull’Espresso nel 1967, sicché
quando i due giornalisti furono condannati in primo grado, il segretario del
partito socialista Giacomo Mancini li mise in salvo facendo eleggere Scalfari a
Milano per la Camera e Jannuzzi al Senato a Sapri. Su quella vicenda pesò poi la
questione degli “omissis” sui documenti citati dall’inchiesta giornalistica,
imposti da Aldo Moro, che poi si rivelarono del tutto innocui.
REFERENDUM IN
ALGERIA. Ma intanto, si può dire che la crisi francese del 1958 aveva prodotto
in Italia una forte voglia di presidenzialismo, chiesto a viva voce da persone
come Edgardo Sogno, medaglia d’oro della Resistenza e poi incriminato per
tentativo di colpo di Stato. Non tutto quel che accadde in Italia dalla presa
del potere di De Gaulle in poi fu addebitabile all’influenza della vicina
Francia, ma la tentazione era palpabile. Da noi seguitavano a succedersi le
crisi di governo, mentre la Francia appariva stabile e coesa. Inoltre, De Gaulle
non esitò a tradire il suo stesso elettorato colonialista concedendo il
referendum sull’indipendenza dell’Algeria, vinto dai patrioti algerini sul suolo
francese. E quando l’Oas, l’organizzazione terroristica militare degli
oltranzisti di destra, cominciò a colpire sul territorio tripolitano, il
generale de Gaulle, seguendo una tradizione francese nata con Robespierre,
proseguita con Napoleone e mai abolita (chi ricorda il film Nikita sa di che
cosa si parla) istituì gruppi di assassini di Stato, i barbouzes, che
procedettero all’eliminazione fisica di tutti coloro che non erano stati
arrestati e messi in galera. La Francia era un paese incomparabilmente diverso
dall’Italia, malgrado il persistente mito della cuginanza. E il suo
comportamento ambiguo e diviso durante la seconda guerra mondiale era stato a
malapena riscattato dalla resistenza di De Gaulle e dei gollisti ai tedeschi,
quando i comunisti ancora non sapevano decidersi, ma in realtà americani e
inglesi non avevano alcuna simpatia per Charles De Gaulle neppure durante il suo
periodo d’esilio a Londra quando pretendeva di avere pari dignità e al quale sia
Roosevelt che Churchill avevano inflitto, d’accordo con Josef Stalin,
l’offensiva esclusione dagli accordi di Yalta. Eisenhower detestava il generale
francese e così lo detestava John Kennedy. Inoltre il generale non voleva
un’Europa che includesse gli inglesi, ma aperta fino agli Urali, cioè con una
relazione speciale con i sovietici. Mise in crisi la Cia quando si recò a Mosca
e pronunciò un impeccabile discorso in russo, sorprendendo tutti perché non si
sapeva che lo sapesse parlare. Infatti non parlava russo, ma aveva imparato a
memoria un discorso in russo. La Francia aveva, e ancora ha, un impero. La
Francia aveva e ancora ha colonie (la Nuova Caledonia) e Territori d’oltre mare
in America, oltre a un’armata che risiede e combatte le sue silenziose guerre
nell’Africa Occidentale francofona dove protegge o depone despoti.
L’ENI DI
ENRICO MATTEI. L’Italia del dopoguerra era un Paese totalmente piegato al
filoamericanismo di facciata, con una fortissima componente filoaraba necessaria
specialmente all’Eni per la sua politica estera in conflitto con quella
francese. Secondo molte ricostruzioni il creatore e presidente dell’Eni, Enrico
Mattei, fu assassinato dai servizi francesi che sabotarono il suo aereo. L’Eni
del resto sosteneva apertamente l’indipendenza delle colonie francesi ed era
considerato a Parigi un’entità nemica. Charles de Gaulle era un uomo altissimo,
ufficiale studioso della guerra meccanizzata ed era l’uomo che aveva mantenuto
la Francia unita dal suo rifugio a Londra (accolto e odiato da Winston
Churchill, mentre la patria battuta ignominiosamente dai tedeschi, inferiori per
numero e armamenti, marciavano sotto l’Arco di Trionfo a Parigi. Il brutto era
che i comunisti francesi, mentre era in corso l’alleanza fra Hitler e Stalin
fino al giugno del 1941, riempivano la capitale di manifesti in cui scrivevano
“Bravo, camarade allemand” che combatti insieme a noi contro l’imperialismo
inglese e il capitalismo borghese. Jacques Duclos, segretario, andava in ufficio
nell’ambasciata sovietica scortato dalle SS e la flotta francese, passata ai
tedeschi, era stata attaccata e affondata dagli inglesi. Il generale era l’unico
vice della Resistenza ed era una voce militare e di destra. Poi Hitler rovesciò
il fronte invadendo l’Urss e le cose cambiarono, ma la memoria francese registrò
che il giovane genarle era l’unico degno di rappresentare la nazione. L’Italia
nel dopoguerra non ha dovuto combattere guerre di decolonizzazione e questa è
una fortuna che non valutiamo mai abbastanza. Ma la Francia non aveva smesso di
essere in guerra in tutte le sue colonie, aveva concesso l’indipendenza a
Marocco e Tunisia, mentre l’Algeri dei pieds noir (i bianchi francesi) erano
pronti alla secessione e avevano tentato un colpo di Stato. In più, la Francia
aveva perso l’Indocina a Dien Bien Phu nel 1954 contro l’esercito nordvietnamita
che non era affatto composto da guerriglieri, ma era uno dei più forti eserciti,
dotato di artiglieria mobile pesante, sostenuto da Urss e Cina. Poi, aveva
subito il tracollo insieme agli inglesi nella crisi di Suez del 1956,
quando Nikita Krusciov, con il tacito consenso americano, minacciò; di
bombardare Londra e Parigi se l’Egitto non fosse stato sgombrato dalle truppe
d’invasione anglofrancesi, cui si erano aggiunti anche gli israeliani. Insomma,
era un altro mondo, duro e armato, e la Quarta Repubblica era stata una
barzelletta democratica, con continui cambi di governo fra centristi, Sfio e
comunisti che erano sempre di pari forza. De Gaulle fu chiamato dai generali
ribelli di Algeri, alteri e magri nelle loro uniformi coloniali, sprezzanti. Io
ero allora un liceale molto radicale e molto vicino al Fln algerino, quello
splendidamente ricordato nella Battaglia d’Algeri di Gillo Pontecorvo. De Gaulle
si suicidò un po’ come il primo Renzi con un referendum su stesso, quando sfidò
l’onda lunga del “joli mai” francese, la rivoluzione delle barricate di maggio,
e chiamò il popolo a decider se volevano un paese governato dalle nuove forze
della rivoluzione estetizzante o se preferissero lui, “mon general”. E i
francesi lo rimandarono a casa, la sua di Colombey les Deux Églises, dove erano
venuti a supplicarlo di prendere il potere e dove aveva rinunciato alla
fucilazione di massa di tutti gli imbecilli, perché sarebbe stato davvero un
programma troppo vasto. E scrisse le proprie memorie finché una decorosa morte
lo colse, già imbalsamato nel mito e nel nome dell’aeroporto più bello di
Parigi.
·
Quei razzisti dei
Paesi Bassi.
Paesi Bassi, scoperta una "camera della tortura" nel covo di
una banda criminale. Fonte: Ministero olandese della
Giustizia. All'interno di un capannone nel Nord-Brabant la polizia ha trovato
seghe, cesoie, pinze e altri strumenti del martirio. Sei persone sono state
arrestate con l'accusa di pianificare sequestri di persona. Pietro Del Re l'08
luglio 2020 su la Repubblica. I poliziotti che hanno fatto irruzione in un
capannone nel Wouwse Plantage, località olandese nella regione del Nord Brabant,
vicino alla frontiera con il Belgio, devono aver immediatamente pensato a una
scena di una serie tv sui narcos o comunque a un film dell'orrore. Infatti,
all'interno del capannone hanno trovato una "camera della tortura" con tanto di
seghe, cesoie, pinze, scalpelli, martelli e altri spaventosi strumenti per
arrecare dolore. Oltre ai ferri del martirio, i poliziotti hanno anche scoperto
una sedia da dentista, con delle stringhe ai braccioli per immobilizzare i
malcapitati attirati in quel luogo. Il capannone, composto da sette container da
nave, si trova nei pressi di una splendida villa del Settecento, di solito
visitata da parecchi turisti, e non lontano da un club di golf. Perciò, per
evitare che le urla delle vittime valicassero le pareti, queste erano state
insonorizzate con dei pannelli in vetroresina. Sei uomini sono stati arrestati,
tra i quali un quarantenne che gli inquirenti sospettano essere il capo
dell'organizzazione criminale. L'uomo, originario dell'Aia, ha precedenti con il
traffico di droga ed era sotto pedinamento da mesi. Lo scorso aprile, i
poliziotti sono riusciti a intercettare alcuni suoi messaggi inviati in una chat
in cui parlava di sequestri e torture. Il pregiudicato specificava anche i piani
dei rapimenti che gli uomini della sua banda travestiti da poliziotti si
apprestavano a compiere. Tanto che nei container sono anche state ritrovate
finte uniformi, giubbetti anti-proiettile, pistole e manette d'ordinanza. Il 22
giugno scorso, dopo aver seguito da lontano l'allestimento del capannone, la
polizia è finalmente intervenuta effettuando perquisizioni in tredici località e
arrestando i membri della in diverse città olandesi con l'accusa di pianificare
dei rapimenti. Gli agenti hanno anche sequestrato tre furgoni rubati e due Bmw,
e in un covo di Rotterdam 24 chili di pasticche di Ecstasy, una ventina di
pistole e una variante cinese del Kalashnikov AK-47. Da un comunicato della
Questura si apprende che nei container erano state predisposte anche diverse
celle dove tener prigionieri gli ostaggi, e che in ognuna erano fissate delle
manette sia sul soffitto sia sul pavimento per incatenare qualcuno in piedi con
le braccia alzate. In un container vicino era stata allestita una zona notte,
destinata a chi avrebbe dovuto occuparsi degli ostaggi. Nel settimo container
era stata invece organizzata la "stanza della tortura", che nei loro messaggi
intercettati i criminali chiamavano "stanza dei trattamenti speciali".
Luciana Grosso per "it.businessinsider.com" l'8 maggio 2020. Chi
è stato ad Amsterdam e dintorni avrà fatto caso alla facilità con cui, dalla
strada, è possibile sbirciare nelle case degli olandesi: finestre ad altezza
d’occhi, nessuna tenda, nessuna persiana, nessun balcone. Perché? La questione
ha colpito anche i giornalisti americani di CNN Travel che hanno indagato un po’
sulla questione. A quel che hanno potuto ricostruire, la buona disposizione
d’animo con cui gli olandesi lasciano che si guardi nei loro soggiorni ha a che
fare con la religione calvinista, che insiste sul fatto che i cittadini onesti
non hanno nulla da nascondere, mentre chiudere le tende potrebbe indicare il
contrario. Questa convinzione religiosa si è anche ben innestata, dagli anni ’60
in poi con un altro fenomeno, ossia la diffusione del benessere e del
consumismo (secondo i dettami del calvinismo, il successo economico e
lavorativo è un segnale del fatto che si è benvoluti da Dio). Per questo, il
fatto di non avere niente da nascondere, da un certo punto in poi, si è sommato
al fatto di voler esibire quel che si aveva (un frigorifero o un televisore,
cinquant’anni fa erano beni di lusso). L’abitudine però si sta lentamente
perdendo. Secondo CNN, dal momento che c’è stato un aumento di expat e che i
giovani tendono a voler avere più privacy (gli stessi giovani che poi però
spiattellano tutto sui social) sempre più, in Olanda, stanno facendo capolino
tende e persiane.
Mai più Olanda, solo Paesi Bassi. Il governo cambia: “Più
corretto”. Una rivoluzione linguistica e di marketing
per evitare di essere identificati solo con la regione di Amsterdam e le sue
“luci rosse”. Pietro Del Re su La Repubblica il 27 dicembre 2019. Per sostenere
i loro idoli, i tifosi della nazionale di calcio olandese saranno costretti a
scrivere un nuovo inno che non contenga la parola Holland. Il governo dell’Aia
ha infatti deciso di abolire la doppia toponomastica per definire il regno
d’Olanda, che d’ora in poi si chiamerà soltanto Paesi Bassi. E poco importa se
non si potrà più dire “squadra olandese”, ma solo “squadra dei Paesi Bassi”,
espressione decisamente meno felice. Entro il prossimo gennaio, verrà anche
cambiato lo storico logo usato negli ultimi venticinque anni per promuovere
l’Olanda, quello del tulipano accanto al sostantivo Holland. Sarà sostituito da
NL, sigla fin troppo amministrativa (la stessa usata sulle targhe
automobilistiche) di Nederland, che in olandese significa appunto Paesi Bassi.
Lo scorso novembre, la ministra al commercio estero, Sigrid Kaag, ha così
spiegato questa riforma, di cui è promotrice: «Vogliamo costruire un’immagine
più semplice del Paese, che sarà positiva per il nostro export e che servirà ad
attirare investimenti e talenti nell’high-tech, lo sport e la cultura». In
realtà, dietro questa decisione ci sono altri motivi. A sentire le autorità
olandesi, che da ora, a rigore di logica andrebbero chiamate nederlandesi o
neerlandesi, il brand “Olanda” è ormai inflazionato, perché troppo legato al
quartiere a luci rosse di Amsterdam, il “red light district” della prostituzione
e dei coffee shop dove si fuma liberamente la marijuana. C’è poi un’altra
ragione, più geografica. Olanda sono in realtà solo due delle dodici province
del Paese, entrambe sulla costa occidentale: l’Olanda settentrionale, che
comprende Amsterdam e Harlem, e l’Olanda meridionale, con città quali l’Aia,
Rotterdam e Leida. Nel Medioevo, l’antica contea d’Olanda fu un’entità politica
autonoma, ma già nel Seicento, con la nascita della Repubblica delle Sette
Province Unite, si trasformò in suddivisione amministrativa. Nel 1840, dopo
l’effimero regno d’Olanda creato da Napoleone, il territorio fu diviso in due
province. Questa rivoluzione linguistica è tuttavia una scelta controversa
perché sebbene la confusione tra provincia e Paese infastidisca gli olandesi, è
anche vero che per gran parte del pianeta Nederland, o peggio NL, evocherà
difficilmente la terra delle grandi dighe, delle innovazioni e dei tulipani.
Fatto sta che il nuovo logo sarà adottato dai ministeri, le ambasciate, le
università, i municipi e le organizzazioni che collaborano con il governo. E ciò
costerà 200 mila euro. La dicitura sarà usata nelle grandi manifestazioni
culturali e sportive, sin dal festival musicale di Eurovision che si terrà a
Rotterdam a maggio o dai Giochi Olimpici di Tokyo della prossima estate. «In
quelle occasioni sarebbe curioso promuovere all’estero soltanto una parte della
nazione», dice un portavoce del ministero degli Esteri, secondo cui il cambio di
nome servirà anche a promuovere una nuova strategia turistica per arginare
l’arrivo di chi sbarca con voli low cost e la cui unica meta sono poche strade
nel centro di Amsterdam. Secondo le stime dell’ente del turismo locale, il
numero dei visitatori raggiungerà i 30 milioni entro il 2030, quasi il doppio
dei turisti attuali. Ma basterà chiamarsi diversamente per fermare il turismo di
massa?
·
Quei razzisti come i Belgi.
“L’inquisitore di Giava”, viaggio nelle ex colonie: Olanda e
Indonesia ricordano il nostro presente. Eraldo
Affinati su Il Riformista il 19 Settembre 2020. Spesso la letteratura aiuta a
capire la storia più di quanto i manuali possono fare. In occasione del
sessantesimo anniversario dell’indipendenza congolese, il sovrano belga, re
Filippo, ha chiesto pubbliche scuse per le ferite coloniali inferte dal suo
Paese alla repubblica democratica centroafricana. Vecchi scheletri lasciati per
lungo tempo nascosti negli armadi sono tornati ad affacciarsi gettando lunghe
ombre sul tormentato passato europeo. Quali, fra le antiche nazioni del Vecchio
Continente, le stesse che oggi si fanno belle
fra Bruxelles e Strasburgo, potrebbero dire di avere la coscienza pulita? Forse
nessuna. Noi italiani abbiamo fatto la nostra brutale parte in Africa in un
periodo storico tutto sommato abbastanza ristretto. Per quanto riguarda
l’Olanda, i suoi misfatti asiatici risalgono al diciassettesimo secolo quando le
isole di Sumatra, Giava, il Borneo e le Molucche caddero sotto il dominio
della Compagnia delle Indie Orientali capitanata dai mercanti
di Amsterdam e Rotterdam. I Paesi Bassi governarono l’Indonesia fino
alla Seconda guerra mondiale. L’indipendenza giunse solo nel 1949 dopo che i
movimenti nazionalistici, guidati dal presidente Sukarno, misero fine anche
all’effimera egemonia dei giapponesi che, sfruttando il vuoto di potere causato
dall’invasione nazista, nel frattempo s’erano insediati in Oceania dove
spadroneggiarono fino al momento in cui vennero sganciate le bombe atomiche
a Hiroshima e Nagasaki. Tutto questo è lo specchio interno di un romanzo in
molti sensi straordinario: L’inquisitore di Giava di Alfred Birney (Mondadori,
pp. 463, 15 euro). La stessa estrazione indo-olandese dell’autore, nato a L’Aia
nel 1951, introduce al tema profondo del libro: da cosa deriva la nostra
identità? Dalla lingua? Dal luogo in cui siamo nati? Dai genitori che abbiamo
avuto? Dalle idee che ci sono state inculcate? Dagli incontri che ci è capitato
di fare? Si può scegliere ciò che si diventa, oppure siamo destinati ad essere
quello che siamo? È sempre difficile per chiunque rispondere a queste domande,
intime e politiche al tempo stesso, ma nel caso di Alan Noland, il protagonista
narrante del testo, l’impresa pare addirittura azzardata. Egli infatti,
scrutinando le memorie del padre Arto, figlio peraltro non riconosciuto di un
europeo e di una indigena, scopre il suo oscuro passato, caratterizzato da
crudeltà quasi indicibili. Arto le aveva perpetrate, quale agente coloniale al
servizio della dinastia degli Orange, ai danni della popolazione locale a cui
lui stesso tuttavia, seppure parzialmente, apparteneva: interrogatori brutali,
omicidi, soperchierie, nefandezze,con passaggi improvvisi da uno schieramento
all’altro. Un po’ eroe, un po’ spia, un po’ traditore, quest’uomo torvo e rude
dalla giovinezza incendiaria, cresciuto a Giava come un indish, meticcio spesso
inviso a entrambi i popoli il cui sangue scorre nelle sue vene, sarà costretto
ad abbandonare la terra d’origine dove molti lo ritengono un traditore e altri
un salvatore. Dopo essere approdato ad Amsterdam, quale marinaio fedele alla
regina Giuliana d’Orange, avrà subito voglia di tornare indietro, fra i suoi
amati indigeni, ma non potrà farlo. Così trascorrerà gli ultimi anni a Malaga,
da vero espatriato, pensionato di lusso, esule inconsolabile, mercenario privo
di radici. «Era impazzito durante la guerra o era nato proprio così?» si chiede
il figlio, chiamato a sanare in se stesso i dissidi del padre. E scrive: «Doveva
avercelo avuto dentro. Aveva solo bisogno di uno scenario per manifestarsi.
Karma. Sfortuna. Maledizione. Whatever». Fino alla frase più importante: «Non
importa, non abbiamo il controllo sul tipo di persona che siamo quando veniamo
al mondo e sulla strada che seguiremo nella vita». Alfred Birney, nel suo
resoconto impietoso, travolgente, spesso informe e traumatico, comunque
doloroso, ci consegna lo spartito delle cosiddette “seconde generazioni”, nelle
quali egli si riconosce: una musica cupa e solenne che, a ben pensare, riguarda
tutti noi, perché nessuno può illudersi di appartenere soltanto a se stesso. È
la canzone a volte triste ma sempre affascinante del sangue misto: imparare ad
ascoltarla diventa imprescindibile, se non vogliamo che le società
multiculturali si riducano agli articoli di legge presenti nei codici. Questo
significa anche progettare una scuola capace di far maturare tale consapevolezza
nei più giovani. Possiamo dire che oggi l’Olanda e l’Indonesia siamo noi. Mentre
gli emigranti avanzano verso l’ignoto e piantano le loro bandiere sulle nuove
terre in cui sbarcano, i loro discendenti, avuti magari, con la dolcezza o con
l’arroganza, dalle donne o dagli uomini del posto, dovranno affrontare e
risolvere il compito di fondere le diverse culture di cui sono il frutto. Se i
padri non lo fanno, saranno i figli a dover tappare i buchi. Non sarà semplice,
si tratterà di mettere insieme violenza e amore, ma da questa promiscuità,
ricordiamolo anche a chi ottusamente s’illude di poterla evitare, nascerà la
civiltà del futuro.
Belgio, re Filippo chiede scusa "per le ferite coloniali in
Congo". Pubblicato martedì, 30 giugno 2020 da La
Repubblica.it. "Tengo a esprimere il mio più profondo rammarico per queste
ferite del passato, il cui dolore è oggi alimentato dalle discriminazioni ancora
presenti nelle nostre società". Parole storiche di re Filippo del
Belgio contenute in una lettera inviata al presidente della Repubblica
Democratica del Congo, Félix Tshisekedi, oggi, giornata che celebra 60 anni
dall'indipendenza. È la prima volta nella storia del Paese che un regnante
rivisiti la propria storia coloniale facendo un mea culpa. Al tempo dello Stato
indipendente del Congo, quando il territorio era di proprietà non belga ma
esclusiva di re Leopolo II, che non mise neanche mai piede in terra africana,
furono commessi atti di inaudita violenza e crudeltà "che continuano a pesare
sulla nostra memoria collettiva", ha detto re Filippo, che regna dal 2013. "Il
periodo coloniale che seguì (quello del Congo belga dal 1908 al 1960 quando il
Congo passò dalle mani di Leopoldo a quelle dello Stato belga, ndr) causò
sofferenza e umiliazione", ha aggiunto sottolineando che intende impegnarsi a
"combattere tutte le forme di razzismo". rep Approfondimento Il Belgio pronto a
processare il suo passato colonialista e i crimini di Leopoldo II in Congo dal
nostro corrispondente ALBERTO D'ARGENIO George Floyd è arrivato anche in Belgio.
La sua morte per soffocamento causata dalla stretta di un agente di polizia
bianco a Minneapolis, ha rilanciato il dibattito sulla violenza del periodo
coloniale in Congo e il controverso ruolo del defunto re Leopoldo II, accusato
di aver ucciso milioni di congolesi. Dal 1879, giorno in cui l'esploratore
britannico Stanley partì alla volta del Congo assoldato da Leopoldo, che aveva
intuito l'immensa ricchezza che si nascondeva in quella fitta foresta pluviale,
al 1885, il re belga consolidò il suo potere esclusivo sul Paese africano. Se ne
impossessò con il beneplacito di tutta la comunità internazionale, meno
visionaria del monarca. Da allora la storia della Rdc plasmata del regnante ha
conosciuto solo sfruttamento, violenze e torture. I reati venivano saldati con
l'amputazione di piedi o mani, per dirne una. "Porcheria immonda", titola David
van Reybrouck nel suo libro "Congo", la parentesi leopoldiana. Depredata di
tutte le sue materie prime e trasformata in un Paese schiavo nella mani di un
potente capriccioso, la Rdc è stata governata da Leopoldo fino al 1908. Non è
andata meglio dopo, quando è passata nelle mani di Bruxelles, e neanche dopo,
raggiunta l'indipendenza nel 1960. Il Paese è uno dei più ricchi del continente
africano tra miniere di diamanti, rame, uranio e altri minerali, tutte risorse
concentrate maggiormente nella regione del Katanga e sfruttate però da compagnie
straniere. Per questo paga da sempre il prezzo più alto.
In Belgio il colonialismo e il razzismo non sono storia
passata: sono nella vita di tutti i giorni. Le statue
di re Leopoldo II sono solo il simbolo più evidente di un Paese che non ha fatto
i conti con il suo passato di schiavismo e sfruttamento. E dove la società
ancora oggi è frammentata e divisa in base al colore della pelle. Federica
Bianchi il 12 giugno 2020 su L'Espresso. La torta è scartata davanti a 5 o 6
bambini italiani, in un tripudio di grida gioiose alla vista di tutti quei
colori. È una domenica di febbraio del 2019 a Bruxelles, il carnevale impazza e
la migliore pasticceria del quartiere di Woluwe Saint-Lambert, De Baere, ha in
bella esposizione irresistibili dolci di cioccolato a forma di pagliaccio. O
almeno quelli che io credevo fossero pagliacci, con tanto di cappellino a tuba
con fiore e naso grosso. «Ma da quando compriamo torte razziste?». Mio marito mi
gela, sussurrando in un orecchio. Solo allora mi accorgo: la torta non è a forma
di pagliaccio ma di testa di moro, ovvero di “negretto”, con tanto di labbroni
in evidenza. Una presa in giro di chi ha la pelle nera e che per decenni in
Belgio e in Olanda è stato oggetto prima di sfruttamento e poi di divertimento
dei colonizzatori bianchi. L'idea che esistesse oggi una possibilità simile non
mi aveva nemmeno sfiorato. E nessuno degli amici italiani in quella stanza se
n'era accorto. Solo l'unico americano presente, a dimostrazione della distanza
abissale di sensibilità e consapevolezza che in Occidente ancora resta sul tema.
«È questioni di tradizioni e le tradizioni si rispettano», aveva detto solo
l'anno scorso il premier olandese Mark Rutte, il campione dell'austerità
europea, quando gli hanno fatto presente che aspetti della festa di Saint
Nicholas sono anti storici e offensivi. Il 6 dicembre uomini bianchi travestiti
da Saint Nicholas, il vescovo di Bari del 300 (da cui è nata la figura di Babbo
Natale) offrono regali ai bambini negli uffici e nelle palestre di Olanda e
Belgio. Saint Nicholas non si muove da solo ma dal 1850, quando la figura fu
introdotta, in coppia con il suo schiavo Pete il Nero, oggi impersonato da un
bambino bianco dal volto tinto di nero, che, due passi indietro, gli regge il
cesto dei doni. «Alcuni ragazzi di colore mi hanno spiegato quanto questa
tradizione li ferisca», ha spiegato solo pochi giorni fa, al culmine delle
proteste razziali scoppiate negli Stati Uniti: «Solo adesso capisco». In Belgio,
come è forse più dell'Olanda, i postumi del colonialismo, con tutta la loro
portata di sentimenti e visioni razziste, sono attualità, non storia. Presente,
non passato da museo. Sensibilità contemporanea. Milioni di persone di colore,
discendenti dagli schiavi congolesi, sono ancora considerati di serie B in una
società elitaria e classista. E la loro sofferenza si unisce a quella più
recente dei discendenti dei marocchini arrivati in Belgio negli anni 80 e 90 per
rimpiazzare gli italiani nella manodopera di basso livello. Quasi mezzo secolo
dopo vivono in quartieri ghetto quasi monocolore. Il più bel parco nel cuore di
Bruxelles, con tanto di lago dei cigni e liceo d'élite sulle sue sponde, così
come innumerevoli strade in tante città., è ancora intestato a Leopoldo II, re
del Belgio e del Congo tra il 1865 e il 1909, durante il cui regno morirono tra
i 10 e i 15 milioni di africani. Quello di Leopoldo II fu il primo massacro per
cui venne utilizzato il termine “crimine contro l'umanità”. Quel passato in
Belgio vive ancora. Il parco di Tervuren, l'ex immensa distesa di caccia reale a
poco più di mezz'ora di bicicletta dal centro di Bruxelles, ospita il Museo
reale dell'Africa centrale voluto da re Leopoldo nel 1904 per celebrare le sue
conquiste in Congo. Fino a sei anni fa, nulla era stato toccato o cambiato: era
ancora il luogo dove apprendere come il Belgio avesse portato la civiltà in
Africa, con tanto di statue di neri nudi e missionari bianchi. Poi il museo ha
chiuso per 70 milioni di euro di lavori mirati alla sua modernizzazione, e ha
riaperto l'anno scorso in pompa magna. Poche settimane dopo la riapertura, ecco
la dimostrazione che nulla fosse davvero cambiato. Le sue sale hanno ospitato
una festa Afrohouse il cui dresscode erano abiti leopardati, facce dipinte di
nero e costumi di epoca coloniale che la borghesia belga tiene ancora
nell'armadio. «Come è possibile che un evento simile abbia ancora luogo nel
2019?» si è chiesto su Facebook il gruppo di attivisti Cafe Congo. In Belgio è
possibile. Così come solo sessanta anni fa, nel 1958, era ancora possibile per
gli organizzatori dell'Expo, la stessa per cui fu costruito l'Atomium, il
monumento che rappresenta l'atomo e che è diventato il simbolo della capitale,
trasportare 267 congolesi nel parco di Tervuren e costringerli a vivere seminudi
nella riproduzione di un villaggio africano. Obiettivo: esporli al mondo al pari
degli animali. La maggior parte di loro morì di freddo durante l'inverno. Ma
perfino questi ultimi 60 anni sembrano essere passati invano. A un'ora di
macchina da Bruxelles si trova Pari Daiza, forse lo zoo più bello d'Europa, in
cui le gabbie degli animali sono in realtà la ricostruzione di interi ecosistemi
e palazzi: la tigre bianca vive in un immenso tempio indiano, per i panda è
stato ricostruito un palazzo nobile cinese con tanto di gigantesca vasca di
pesci al centro del cortile principale e gong lungo le mura. Lì dove vivono
leoni e giraffe sono stati ricostruiti villaggi africani e una serie di caverne.
All'interno, la sorpresa: tanti oggetti coloniali, da valige a vestiti di pelle
di leopardo. Ma non solo. Appese alle mura ci sono decine di fotografie in
bianco e nero di africani seminudi accanto a uomini bianchi che li espongono
come trofei. A quanto pare molti di loro erano fieri di farsi fotografare a
fianco di una donna nera nuda, il braccio intorno al collo e le dita della mano
sul seno, a stringere un capezzolo. I bambini di oggi a guardare, a testa in su
e cuore in giù. Intanto, all'indomani dell'omicidio di George Floyd negli Stati
Uniti, che ha causato un'epocale rivolta civile contro il razzismo negli Stati
Uniti e nel Nord Europa, e mentre si moltiplicano in Belgio le petizioni
cittadine per la rimozione delle statue di Leopoldo II dal suolo pubblico,
l'attuale principe Laurent ha tranquillamente dato un'intervista a Sudpresse, in
cui ha detto di non capire come Leopoldo II «avesse potuto far soffrire delle
persone» visto che in Congo - che festeggerà questo 30 giugno i 60 anni
dell'indipendenza - non si era mai recato. E difatti da parte della casa reale
belga, è dai tempi di re Baduino, l'ultimo re del Congo, morto nel 1993, che il
nome di Leopoldo II non è più fatto. L'ultima volta fu il 30 giugno 1960 in
occasione dell'indipendenza del Paese. Dunque, nessuna critica. Nessun mea
culpa. Il principale quotidiano belga, Le Soir, ha riportato la frase di una
fonte reale che sintetizza la posizione ufficiale: «Se dispiace che ancora non
sia stata fatta luce su quel periodo storico, dal punto di vista del sentimento
familiare, nessuno nella famiglia reale ha piacere di vedere questa campagna
contro Leopoldo II». E ovviamente nessuno di loro è in favore della rimozione
delle statue. Ma le statue al di fuori di un museo non sono solo statue. Non
solo arte. Non storia. Sono la rappresentazione della coscienza sociale del
momento. E se ci sono ancora persone che da quelle statue si sentono
personalmente offese, allora vuol dire che la società non ha ancora fatto i
conti con se stessa. E rimane drammaticamente divisa. Tanto più in Belgio, dove
le divisioni di ieri si sommano a quelle di oggi, gli schiavi di cento anni fa a
quelli di sessanta anni fa e perfino a quelli attuali, in una società dove il
lavoro manuale è riservato per lo più ai non belgi. E il risultato è una città
divisa per colore della pelle e una rabbia sociale costante che esplode quando
le circostanze permettono. Come due mesi fa nel quartiere povero e islamico di
Anderlecht, al sud della città, dove un ragazzo marocchino di 19 anni è morto,
inseguito dalla polizia mentre era su un monopattino elettrico durante il
divieto imposto dal lockdown. O come quando una mamma marocchina spiega di non
sentirsela a iscrivere i suoi gemelli nella stessa scuola elementare pubblica e
gesuita in cui vanno i figli della borghesia, perché «con i ragazzi di colore si
comportano in modo diverso, e se poi non sono bravi, usano proprio parole
diverse e li ignorano completamente, incoraggiandoli a lasciare». Il fantasma di
Leopoldo, per dirla con Adam Hochschild, è sempre tra noi.
Da liberoquotidiano.it il 14 febbraio 2020. Per quale motivo un liberale belga
dovrebbe mai commentare pubblicamente le vicende di Matteo Salvini e dell'Italia
senza avere il polso della situazione? Magari Guy Verhofstadt svelerà in
tribunale il motivo per il quale ha sparato a zero, all'indomani
dell'autorizzazione a procedere contro il leader della Lega per il caso della
nave Gregoretti. L'ex premier del Belgio ha esultato su Twitter: "Via libera a
processare Salvini per sequestro di persona. Brava Italia! Giustizia deve essere
fatta. Speriamo che lo stesso avvenga anche per la sua massiccia corruzione con
tangenti petrolifere russe". Una frase, quest'ultima, di una gravità inaudita
dato che non c'è alcuna sentenza che sorregge quanto sostiene Verhofstadt. Una
diffamazione in piena regola che infatti non è sfuggita a Salvini: "Questo
fenomeno eurosinistro ha vinto una bella querela. Affronterà il tribunale, come
ho deciso di fare io, o userà l'immunità?".
Belgio da
un anno senza governo (ma nel 2011 andò molto peggio).
Pubblicato
martedì, 24 dicembre 2019 su Corriere.it da Claudio Del Fante. Felici, contenti
e senza governo: da un anno (precisamente dal 18 dicembre del 2018) il Belgio è
privo di un esecutivo nei suoi pieni poteri e rischia di superare il record già
stabilito a cavallo del 2010 e 2011 quando il vuoto durò per ben 540 giorni.
Filippo, re dei belgi, nel suo discorso annuale alla nazione ha esortato i
partiti a trovare una soluzione e formare una coalizione in grado di dare
stabilità politica a un esecutivo «condannato» da un anno solo all’ordinaria
amministrazione. Nonostante ciò, l’opinione pubblica non sembra mostrare
preoccupazione in cui il Belgio rischia (di nuovo) di barcamenarsi. «Un
esecutivo deve essere formato il più rapidamente possibile» per «prendere
decisioni equilibrate», ha detto il re, indossando un abito blu e una cravatta
arancione, seduto di fronte a un albero di Natale nel suo palazzo di Bruxelles,
in un discorso registrato e trasmesso in televisione. Il sovrano ha invitato
tutti a lasciare da parte «la violenza esplicita nel linguaggio e nei gesti che
distruggono» e si è rivolto al suo popolo parlando in francese. Ma proprio la
lingua è una dei fattori di divisione che tengono il paese nordeuropeo in
continua fibrillazione politica. Lo stallo che si trascina da un anno è frutto
infatti delle divisioni sempre più profonde tra la comunità francofona
concentrata nel sud del Paese (e in maggioranza socialista) e quella fiamminga
che abita la metà settentrionale (e che da anni vota in massa il partito
nazionalista N-Va). Il governo di coalizione, guidato da Charles Michels è
caduto il 18 dicembre del 2018 dopo che proprio i nazionalisti fiamminghi gli
hanno tolto l’appoggio: motivo della rottura l’intenzione dell’esecutivo di
sottoscrivere il Migration Act. Dopo le elezioni del maggio 2019 le redini del
paese sono passate in mano a Sophie Wilmes, prima donna premier in 189 anni di
storia del Belgio, alla guida di una formazione di centrodestra priva però della
maggioranza in Parlamento. Lo stallo è destinato a proseguire, punti di incontro
tra le due anime del Paese per ora non se ne vedono. Il Belgio rivive così la
paradossale situazione protrattasi dal 13 giugno del 2010 e il 5 dicembre del
2011, quando non risultò possibile formare un governo sorretto da una
maggioranza. Anche allora fu la rigidità delle posizioni tra fiamminghi e
valloni a prolungare lo stallo. Dopo molti tentativi andati a vuoto il
socialista Elio Di Rupo riuscì a ricucire una fragile coalizione. Nonostante
l’anno e mezzo di vuoto, l’economia del paese non sembrò risentirne. La
situazione, stavolta, non sembra altrettanto rosea. Secondo le previsioni il
Belgio è tra gli stati dell’area euro quello dove il debito pubblico aumenterà
maggiormente (+0,9%, l’Italia è a +0,2%) ed è tra i Paesi sotto osservazione da
parte della commissione europea proprio per uno «squilibrio macroeconomico» nei
suoi conti pubblici. Secondo Eurostat a luglio del 2019 il pil segnava una
crescita annuale dello 0,4%.
Giampiero
Gramaglia per il “Fatto quotidiano” il 16 gennaio 2020. Qualche tempo fa, quando
ancora si spedivano le lettere e in Italia affidarne una alla posta metteva l'
ansia - arriverà?, e quando? -, in Belgio, se una cosa filava liscia, senza un
intoppo, si diceva "Comme une lettre à la poste", come una lettera in posta: le
lettere partivano e arrivavano, esattamente come in Belgio continuano a fare i
treni e gli aerei, che un governo ci sia o - spesso - non ci sia. Il giorno che
si va a votare, la domenica, in mezza giornata si raggiungono percentuali d'
affluenza altissime - il voto è obbligatorio -, senza perdere un giorno di
scuola: a sera gli scrutini sono fatti e le aule sgomberate. Eppure il Belgio
non ha un popolo e neppure una lingua: i fiamminghi, che sono circa i due terzi
della popolazione, al nord, sono conservatori e cattolicissimi e parlano,
appunto, il fiammingo, simile all' olandese; i valloni, al Sud, socialisti e
mangiapreti, parlano francese; lo Stato è la somma di tre entità fortemente
autonome, le Fiandre, la Vallonia e Bruxelles, capitale bilingue. I simboli
dell' unità nazionale sono la monarchia - i Sassonia Coburgo Gotha vengono,
però, dalla Germania -; la Brabanconne, l' inno che celebra l' indipendenza
acquisita nel 1831; e la nazionale di calcio, specie quando, come in questo
momento, è forte, anzi fortissima, in testa al ranking Fifa, davanti - che
goduria, per i belgi abituati a essere oggetto di sfottò - alla Francia. Che ci
sia o meno un governo, le cose funzionano (quasi) sempre come ci si aspetta che
funzionino. Ciascuno fa il suo lavoro, magari senza fantasia, ma con
applicazione e concretezza. E il Paese se la cava: nel 2010, gestì senza governo
un semestre di presidenza di turno del Consiglio dell' Unione; e, questa volta,
senza governo, è riuscito a promuovere il suo premier in carica per gli affari
correnti, Charles Michel, alla Presidenza del Consiglio europeo e a insediare al
suo posto la prima donna premier nella storia belga, Sophie Wilmès - è la
"custode" del potere, in attesa che qualcuno politicamente legittimato lo
reclami -. E l' economia non ne soffre troppo: il debito pubblico continua a
scendere - era al 101% del Pil nel 2018, calerà al 98% quest' anno -, il
disavanzo s' attesta all' 1,6%, le tasse scendono, la disoccupazione è intorno
al 6,5%, il turismo è uscito dal tunnel nero degli attentati terroristici del
2016 e 2017. Ci stiamo avvicinando ai 400 giorni senza un governo nella pienezza
dei poteri. È dal 18 dicembre 2018, giorno in cui il partito nazionalista
fiammingo N-Va pose fine alla coalizione di centrodestra del premier Michel, d'
ispirazione liberale, che il governo è ridotto agli affari correnti. Siamo
ancora lontani dal record mondiale - ovviamente belga - di 541 giorni, stabilito
tra 2010 e 2011; e un altro lungo periodo simile si ebbe fra il 2007 e il 2008,
oltre sei mesi. Oggi, le distanze fra i partiti di diversi schieramenti nelle
Fiandre e in Vallonia non fanno ancora intravedere un accordo di coalizione all'
orizzonte. Né se ne avverte l' urgenza, visto che le cose funzionano lo stesso:
i treni, come gli aerei, partono e arrivano in orario. Nonostante la crisi fosse
stata dichiarata a fine 2018, per le elezioni si attese il 26 maggio, sfruttando
l' Election Day europeo. Poi, due giorni prima che Michel dovesse assumere la
presidenza del Consiglio europeo, il 28 ottobre, la Wilmès, 44 anni, anch' essa
d' ispirazione liberale, ne ha preso il posto. Quasi 250 giorni sono passati
dalle elezioni politiche, che hanno visto una netta affermazione delle diverse
sigle del nazionalismo fiammingo: da allora, diversi "formatori" - così in
Belgio si chiamano coloro incaricati di formare il governo, di cui non devono
necessariamente divenire premier - si sono succeduti, senza trovare la formula
giusta per un accordo. Ma, sbarcando all'aeroporto di Zaventem o arrivando alla
Gare du Midi, non avrete l' impressione di un Paese sull' orlo di una crisi di
nervi. Con 11,4 milioni di abitanti, una superficie pari a quella di Lombardia e
Liguria insieme, il Belgio ha un' economia diversificata, forte soprattutto nei
servizi. E gli indici di qualità della vita sono eccellenti su scala mondiale:
libertà civili, diritti politici, persino il funzionamento dello Stato. È stata
la politica a ostinarsi sull' opzione del federalismo, allentando i vincoli
dell' unità nazionale; e, adesso, la gente antepone alla politica l' ordinaria
amministrazione. Vivendo ugualmente bene.
·
Quei razzisti come
gli Ungheresi.
La censura dei media di stato ungheresi:
bavaglio di Orban a Greta Thunberg, diritti umani e Unione Europea.
Redazione de Il Riformista il 3
Marzo 2020. I giornalisti della tv di Stato ungherese per poter parlare
pubblicamente delle politiche dell’Unione Europea o di Greta Thunberg,
l’attivista 17enne svedese per il clima, hanno bisogno di un permesso speciale,
mentre è severamente vietato parlare di organizzazioni come Amnesty
International o Human Rights Watch, note in tutto il mondo per l’impegno nella
difesa dei diritti umani.
IL PUGNO DURO DI ORBAN – La censura di Stato è
al centro di un’inchiesta pubblicata da Politico, noto quotidiano americano di
approfondimento. I giornalisti che hanno firmato l’indagine hanno ottenuto
infatti le mail interne dello staff della tv pubblica del Paese, governato col
pugno duro da Viktor Orban, tra i leader politici di riferimento in Italia per
la destra populista di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, nelle quali ai redattori
viene richiesto di inviare bozze dei contenuti dei loro articoli su argomenti
delicati.
LA CENSURA – Secondo un’email visionato da
Politico, per poter realizzare un servizio sull’attivista svedese Greta Thunberg
i giornalisti ungheresi devono avere un permesso ancora prima di iniziare a
scrivere. Ai dipendenti dei media statali, fermamente controllati da Orban, è
invece esplicitamente vietato di menzionare nei loro servizi e articoli i report
diffusi da organizzazioni umanitarie come Amnesty International e Human Rights
Watch. In una email firmata da Tamás Pintér, senior editor della tv pubblica,
indirizzata ai colleghi, il giornalista rivela di essere stato informato
da Balázs Bende, capo del personale della televisione di Stato, “che non
pubblichiamo i materiali di Human Rights Watch e di Amnesty International”. Una
seconda email ottenuta da Politico evidenzia ancor di più il clima che si vive
nella tv pubblica. Sándor Végh, altro senior editor, scrive infatti che tra i
temi che hanno bisogno di un’autorizzazione speciale prima della pubblicazione
ci sono “migrazione, terrorismo europeo, Bruxelles, questioni ecclesiali”, oltre
alle elezioni negli altri paesi dell’Unione.
LE REAZIONI – La diffusione dell’inchiesta di
Politico ha provocato subito forti reazioni nel mondo dell’informazione. Julie
Majerczak, di Reporter senza frontiere, ha definito la censura “inaccettabile e
molto preoccupante. I media pubblici non sono i portavoce del governo,
dovrebbero essere neutrali e indipendenti”. Sulla stessa linea Lydia Gall, di
Human Rights Watch: “Questo è un altro esempio di come il governo ungherese mina
la libertà dei media e tenta di mettere a tacere e interferire con il lavoro
vitale delle organizzazioni della società civile”.
Andrea Tarquini per repubblica.it il 4 marzo 2020. Il premier
ungherese Viktor Orbán ha trovato un nuovo nemico necessario, o meglio nemico
immaginario della Nazione europea cristiana che dice di voler difendere. Questa
volta non si tratta di migranti, né dell'Unione europea, né di Soros. No: l'uomo
forte magiaro, massimo stratega dei sovranisti europei, ha i Rom e soprattutto i
bimbi rom nel mirino. Egli in persona e il suo governo, come ha scritto Politico
sono decisi a bloccare le sentenze della magistratura ungherese che impongono
all'esecutivo di versare risarcimenti a bimbi rom vittime di discriminazioni
gravi e di segregazione a scuola. Segregazione, come in Sudafrica ai tempi
dell'apartheid quando Nelson Mandela era rinchiuso nel famigerato carcere di
Robben Island.
Il fatto iniziale. La pietra dello scandalo è quanto accade nel
povero villaggio di Gyöngyöspata. Le autorità locali hanno chiesto e ottenuto
finanziamenti pubblici per la scuola, poi hanno deciso su ordine da Budapest di
istituire classi separate e malissimo organizzate per i bimbi rom. Le famiglie
rom del posto hanno sporto denuncia alle autorità giudiziarie, e i giudici in
uno tra i loro difficili tentativi di difendere l'indipendenza della
magistratura hanno dato loro ragione: occorre che il governo paghi un
risarcimento danni e modifichi la situazione a vantaggio dei bimbi rom, a
Gyöngyöspata e altrove. Per consentire loro di imparare lingua cultura
matematica e tutto a scuola come gli altri bimbi ungheresi e sperare in un
futuro di lavoro, non di emarginazione.
La dichiarazione di Orbán. Orbán non ne vuol sapere, e lo ha
detto in pubblico. "Mi chiedo perché dobbiamo spendere soldi per chi non lavora;
i veri discriminati sarebbero i bambini ungheresi, non i rom, se io cambiassi la
situazione". E ancora: "Se io fossi un cittadino ungherese di Gyöngyöspata mi
chiederei perché si devono spendere soldi pubblici per gente che poi non va a
lavorare". Ed è imminente in tutta l'Ungheria - per volere di Orbán che si sente
minacciato nel suo potere decennale dalla crescita delle opposizioni vittoriose
alle recenti municipali a Budapest e in una decina di altre importanti città -
tenere una "consultazione nazionale", cioè un referendum le cui domande sono
formulate in tal modo dal regime sovranista che una sua vittoria sarebbe
scontata in caso di sufficiente partecipazione al voto.
La "consultazione nazionale". La "consultazione nazionale",
nell'approssimarsi del decennale del ritorno di Orbán al potere (aprile 2010)
chiederà ai cittadini se ritengono giusto spendere soldi pubblici per i rom che
non lavorano e non si integrano e anche per i detenuti (di carceri
sovraffollate, I) "aiutati dai loro avvocati comunisti".
La reazione della comunità Rom. Le organizzazioni della comunità
Rom reagiscono, con pacifiche proteste nella capitale Budapest e in altre città.
I Rom in Ungheria sono da secoli abitanti stanziali, e non nomadi. L'ottanta per
cento di loro vive sotto la soglia di povertà definita dalle autorità nazionali,
discriminata o emarginata da istruzione e mercato del lavoro, spesso in villaggi
cui non vengono fornite acqua potabile ed elettricità.
La denuncia delle Ong. È la prima volta, denunciano opposizioni e
Ong per i diritti umani, che il premier ungherese sceglie come bersaglio un
"nemico interno". Una minoranza appunto, non già la Ue, le ondate migratore o
gli immaginari complotti del filantropo George Soros. In tal modo il premier e
il suo partito-Stato, la Fidesz sospesa dal Partito popolare europeo, copiano
gli slogan lanciati dieci-undici anni fa dall'ultradestra. Come quando attorno
al 2009 ci furono marce di gruppi paramilitari in villaggi rom e furono uccisi
per motivi razzisti nove rom tra cui un bimbo, Robert Csorba, i cui funerali
furono un momento alto della protesta dell'etnía Rom in tutta l'Europa di mezzo.
L'appello all'Europa. I Rom ungheresi chiedono aiuto all'Europa
contro il premier sovranista che attacca i bambini come nemici e pericolo per la
patria. Orbán procede sulla sua strada, inasprendo anche la censura. Da pochi
giorni i media pubblici hanno bisogno del permesso da chiedere ogni volta alle
autorità censorie (quindi di fatto a esecutivo e servizi segreti) per parlare di
Greta Thunberg o di qualsiasi Ong o del tema "Diritti umani". I bimbi rom
magiari sono sotto il tallone di una politica razzista, da Bruxelles non è
ancora venuta una chiara risposta né una denuncia.
Emigrazione a messimi livelli. Nel frattempo l'emigrazione di
giovani qualificati stanchi del clima politico dall'Ungheria tocca nuovi record
nonostante il boom economico, la scuola ungheres è scesa per indice di qualità
dal 37mo al 96mo posto nelle classifiche internazionali, e scuola e sanità
affrontano una gravissima crisi di mancanza di fondi e strutture.
·
Quei razzisti come i Rumeni.
Francesco
Battistini per “7 – Corriere della Sera” il 14 aprile 2020. Camminava da solo.
Passo lento, silenzioso, sospettoso. I segreti del bosco vecchio di Maramures
non hanno fretta d’essere svelati e il guardaparco Liviu Pop lo sapeva. Le
solite regole di prudenza, le stesse da sette anni: spegnere il motore,
abbassare il volume della radio, togliere la suoneria allo smartphone
(troveranno la sua jeep posteggiata, mezz’ora di sentiero più sotto). Aveva
fatto tutta quella strada in salita, calpestando cauto i rami caduti da farnie e
tigli, scavalcando indagatore i tronchi delle querce già abbattute, seguendo col
fiatone il lamento delle motoseghe sempre più vicino, sempre più assassino. A un
certo punto gli vibrò in tasca il cellulare: era la moglie. La prima volta non
rispose, continuò a camminare. Ma pure lei continuava a chiamare, perché si
sentiva qualcosa di strano e stava insistendo. Liviu si fermò un attimo e tirò
su sbrigativo, forse un filo spazientito: «Ciao, scusa, adesso non posso, ci
parliamo dopo, sto per fare un arresto, ladri di legna...». Si sa com’è, chi
lavora sul serio: avanti, forza, è un mestiere pericoloso, ma qualcuno deve pur
farlo. E quel mercoledì mattina, in quel taglio, c’era da zittire il grido di
quelle motoseghe. Liviu camminò ancora un po’. Qualche centinaio di metri.
Svoltò per un tratturo. Scese in una gola. Alla fine li vide, e fu perduto. Era
entrato nel bosco, verticale. Senza immaginare che ne sarebbe uscito
orizzontale. Hanno ammazzato Liviu: a colpi d’ascia, in ottobre. Hanno picchiato
un’altra guardia, Raducu Gorcioaia: a morte, il mese prima. Hanno ucciso quattro
ranger, negli ultimi tre anni. E dieci, ancora, li hanno minacciati e inseguiti
e pestati sino a mandarli in ospedale. In Transilvania, i vampiri succhiano la
linfa delle foreste e di tutti noi. Mafia del legno che bastona e non perdona.
«Quando ho investigato sul parco di Retezat», racconta Gabriel Paun, capo
dell’ong Agent Green, «una banda di teppisti mi ha aggredito e mi ha rotto le
costole, le mani, la testa. Non mi hanno ammazzato perché sono scappato. Non è
stato arrestato nessuno, per mesi sono rimasti a piede libero in attesa del
processo. No, devo essere chiaro: non mi aspetto che gli assassini dei ranger la
paghino». Il guardaparco Liviu aveva trent’anni, tre bambini, trecento euro di
stipendio. Conosceva i suoi killer e molti sanno chi sono, ma quando le troupe
tv di Bucarest salgono fino ai boschi primordiali di Maramures, dove di legna si
campa e si muore, le interviste sono regolarmente di spalle e con la voce
criptata. L’omertà è tale che il giudice Bogdan Gabor, messi in galera tre
sospetti, ha dovuto usare la macchina della verità per interrogare i pochi
testimoni disponibili. E sui social si discute se l’omicidio, in fondo, non sia
stato solo un atto di legittima difesa. E in cambio della pensione di
reversibilità, la vedova Pop ha finito per accettare un referto surreale stilato
dai medici locali: c’è scritto che Liviu non è morto per il torace squarciato,
ma a causa di un’emorragia interna e della sua salute precaria. «Forse è stato
un suicidio», ha postato qualche amico degli amici. Il buio è ben oltre la
siepe. Nella regione di Maramures, prima del comunismo, i padroni delle terre
avevano potere tanto sui buoi quanto sul boia: poco è cambiato. A Rusu
Bargaului, il “borgo rosso” fatto di casette misere che stanno lungo uno
stradone verso l’Ucraina, 800 abitanti tutti disoccupati e nemmeno un
ambulatorio medico o un negozio d’alimentari, c’è un prete ortodosso che
all’affollatissima messa della domenica punta il dito sui guardaparco e sui
poliziotti corrotti, sui politici a libro paga, su quelli che si voltano
dall’altra parte. Prova a dire la verità: è stato arrestato tre volte, malmenato
anche di più, gli hanno ucciso il padre, suo figlio ranger è stato mobbizzato
dietro una scrivania perché non desse fastidio e l’altro figlio, pope pure lui,
viene minacciato ogni giorno. «I mafiosi del legno hanno alleati potenti e
arrivano ovunque», dice padre Ioan Platon: «Per screditarmi davanti alla mia
comunità, si sono inventati che il ladro di legna sono io. Da vent’anni, il
potere e il traffico illegale li controllano sempre gli stessi ». Tutti legati
dall’affare: i sindaci con le mogli che mettono i cugini a capo della polizia
locale, i capi della polizia che nominano altri cugini al controllo dei
boschi...«I clan sono familiari, hanno legami con deputati di Bucarest,
diventano ogni giorno più ricchi mentre la gente è sempre più povera. Usano la
forza e corrompono chiunque: mi hanno mandato in chiesa perfino un mio vecchio
compagno di scuola, per consigliarmi di tacere». Nel borgo rosso non c’è niente,
le industrie hanno chiuso e la terra non è buona per coltivare, il legno è
l’unica risorsa: agli inizi del secolo scorso, i carpentieri di qui erano famosi
per l’abilità nel fare incastri e nel costruire campanili in abete alti settanta
metri, senza usare un solo chiodo. Poi arrivò il comunismo e il legno diventò un
tabù: di proprietà statale, ovvero del partito e del sindaco. Oggi, chi abita a
Rusu Bargaului non può segare un ramo, né arderlo, né venderlo. È ancora e
soltanto roba loro, di chi comanda. Basta percorrere i bordi delle foreste:
hanno chiuso i boschi con cancelli & lucchetti e piazzato agli ingressi brutti
ceffi armati di kalashnikov, che allontanano i curiosi nelle settimane del
taglio illegale. Appena un giornalista va a curiosare, com’è capitato a 7, prima
deve pagare cento euro di permesso al sindaco e poi un suv nero gli s’appiccica
h24, per pedinarlo. «Quando vedo i film sulla mafia in Sicilia», dice N., un
ranger collega di Liviu Pop che non autorizza a scrivere nemmeno l’iniziale del
cognome, «penso che dovrebbero farne uno su come si vive qui. Nessuno fa
rispettare la legge, perché la legge la fanno loro». Se cancellassimo la
Transilvania e la sua natura preistorica, scriveva un grande geografo
dell’Ottocento, Simion Mehedinti, la Romania sarebbe come una ruota senza raggi.
Non solo la Romania: in questi Carpazi sopravvive la metà delle ultime, grandi
foreste vergini d’Europa cresciute dopo l’era glaciale. Ci scorrazzano orsi e
lupi, linci e gatti selvatici che non hanno mai visto uomo. Ci crescono larici
d’ottanta metri e faggeti così fitti che non hanno mai fatto ombra a una strada
o a una macchina. Dagli inizi degli anni Novanta, ci s’arricchiscono bande che
tagliano tre ettari l’ora e vendono illegalmente i tronchi a segherie, cartiere,
industrie dell’arredamento nell’Ue e in Giappone. Secondo l’Onu, dopo il
traffico di droga, d’armi, d’esseri umani e d’avorio, quello del legname
proibito è il più lucroso affare del crimine internazionale: cento miliardi di
dollari l’anno, tra il 20 e il 30 per cento del mercato mondiale di legna. Ma se
molto sappiamo dei disboscamenti di mogano, teak e palissandro ai Tropici o in
Amazzonia, il silenzio copre quel che accade ai confini dell’Europa, nasconde
gli effetti sull’economia e sull’ambiente provocati da questi clan dell’Est. Che
sfuggono a controlli e a tassazioni per almeno cinque miliardi di euro; drogano
il mercato del truciolare e del legno pregiato, abbattendo i prezzi e
danneggiando i produttori onesti; deforestano senza limiti, finendo per alterare
i tassi d’anidride carbonica nell’atmosfera e aumentando il riscaldamento
globale. Nei villaggi intorno a Slanic Moldova, ogni inverno si vedono i
risultati del disboscamento: valanghe di fango, incontrollate, che travolgono
case e cose. Rusu Bargaului, una abitante del villaggio riceve la visita di
padre Ioan Platon, prete ortodosso che da sempre denuncia i clan che depredano
il territorio, impoverendo la gente che vi abita Rusu Bargaului, una abitante
del villaggio riceve la visita di padre Ioan Platon, prete ortodosso che da
sempre denuncia i clan che depredano il territorio, impoverendo la gente che vi
abita. L’Università del Maryland e Greenpeace hanno incrociato centinaia di foto
satellitari e calcolato che in quindici anni sono stati tagliati almeno 280 mila
ettari di rarissima foresta primordiale, circa nove milioni di metri cubi
d’alberi: la metà stava in parchi nazionali, teoricamente protetti. Tre ong
hanno chiesto in settembre l’intervento del Consiglio europeo e Bruxelles ha
dato una strigliata al governo romeno, che peraltro nel 2016 s’era già dotato di
un’inutile legge per la tutela dell’ambiente. Nel Paese governato da una classe
politica fra le più corrotte d’Europa, la mafia dei boschi non è una priorità:
quando l’Interpol ha tentato d’usare droni e gps, per bloccare i ladri di legno,
un ministro ha risposto che è complicato, che non ci sono risorse finanziarie,
che non è chiaro dove operino esattamente le gang... «La domanda è perché il
nostro governo permetta questa devastazione», s’interroga Paun, dandosi una
risposta: «Forse è una cosa che fa comodo a tanti». Ci sono complicità. Gravi
complicità. Il traffico d’alberi si svolge da sempre lungo il confine ucraino:
la porta d’ingresso per legname che gli ambientalisti sospettano arrivi da zone
poco controllate o addirittura contaminate (una su tutte: la regione di
Chernobyl) e venga poi smerciato in tutt’Europa come romeno. Un affare che fa
gola. Uno sfruttamento intensivo che dura da trent’anni e che ormai ha
trasformato Maramures in una miniera illegale del legno. Com’è accaduto? Deposto
Ceausescu, nel 1989, Bucarest aprì agli investitori stranieri e fu così che pure
i boschi del profondo Nord vennero invasi. Un Far East senza controlli, prateria
adatta alle scorribande di spregiudicate aziende europee. Una di queste,
l’austriaca Holzindustrie Schweighofer, vecchia di 400 anni, clienti che vanno
dal Giappone alla Germania, dall’Italia alla Gran Bretagna, è finita al centro
d’inchieste giudiziarie e di manifestazioni di protesta: i suoi manager
avrebbero offerto bonus per l’acquisto di legno illegale proveniente da
Maramures, rivendendolo poi come biomassa e materiale per arredo a grandi catene
commerciali. Gli attivisti di Agent Green, che hanno rivelato i traffici, sono
stati aggrediti con spray al peperoncino e manganelli da misteriose squadre
armate, mentre investigavano sugli stabilimenti e sugli stoccaggi di legna a
Sebes. Sui giornali è finita una lettera del ceo di Schweighofer, indirizzata al
primo ministro romeno, in cui si minacciavano gravi conseguenze nelle relazioni
diplomatiche con Vienna, nel caso fosse stata approvata una legge che limitava
lo sfruttamento. Lo scandalo ha fatto un po’ di rumore, subito inghiottito.
Nessuno ha sloggiato gli austriaci, nessuno ha dato un taglio al taglio
selvaggio, nei boschi di Maramures le motoseghe continuano a gridare. «Voi non
ve ne rendete conto», dice padre Ioan, «ma probabilmente la sedia su cui sedete,
il tavolo a cui mangiate, il letto in cui dormite è fatto con legna illegale».
Hanno ammazzato Liviu, Liviu è vivo: ma solo nella memoria di chi sa.
·
Quei razzisti come i Kosovari.
Francesco Battistini per il “Corriere della Sera” il 6 novembre
2020. Chissà se stavolta racconterà qualcosa della Casa Gialla, come la
chiamavano durante la guerra del '99: la clinica fantasma dove si diceva
espiantassero le cornee dei prigionieri, per rivenderle all'estero. O dei
traffici d'armi e di droga. O del mistero dei corpi gettati e mai trovati in
certi laghetti. O magari dei soldi fatti con la prostituzione e la tratta
d'esseri umani Thaci, il nemico ti ascolta: dopo aver tanto negato e insabbiato
e minacciato e ostacolato, dopo dieci anni di denunce e di sussurri, il
«Serpente» s' è arreso. È arrivata l'incriminazione formale del Tribunale
dell'Aja. E ieri mattina Hashim Thaci, capo storico della guerriglia Uck,
padrino politico e presidente del Kosovo, alla fine s' è dimesso. L'hanno messo
su un volo militare per l'Olanda e coi fidati Kadri Veselj e Rexhep Selimi,
detto il Sultano, è andato in una cella. Per farsi interrogare da quei giudici
che considera ostili «negazionisti della verità», vogliosi solo di «riscrivere
una storia eroica che nessuno può cambiare». È l'inizio della sua fine? A 52
anni, «il più pericoloso dei boss criminali dell'Uck» (definizione d'un rapporto
firmato dal senatore svizzero Dick Marty) è sospettato d'essere stato a capo
d'un «depravato sistema di potere» (parole dell'ex procuratrice Carla Del Ponte)
e dovrà rispondere di crimini contro l'umanità, di guerra e torture su un
centinaio di serbi, rom e albanesi. Il Tribunale dell'Aja ci ha abituato alle
sorprese e nessun esponente Uck è mai stato condannato, nonostante manchino
all'appello 1.641 desaparecidos «non giustificati». Ma questo processo, basato
sul codice penale kosovaro e con giudici internazionali, è anche al famoso
Gruppo di Drenica, il manipolo che ai tempi parlava col Pentagono: Thaci è
finito alla sbarra con una decina di vecchi compagni di guerriglia. A
dimostrazione che si fa sul serio, a Pristina è stato arrestato un altro ex
presidente a interim, Jakup Krasniqi. Perché L'Aja sostiene che almeno un paio
di volte la dirigenza kosovara abbia cercato di sabotare le indagini e ci siano
state fughe di notizie: «S' è impiegato vent' anni a demolire una certa cultura
dell'impunità - commenta un portavoce di Amnesty International - ma ora le
vittime di guerra potranno sapere la verità su delitti orribili». Non abbiamo
niente da nascondere, ci disse Thaci poco tempo fa in un'intervista: «A
differenza dei serbi, noi siamo sempre andati all'Aja senza resistenze. Nessuno
è mai scappato. È questo il prezzo della nostra libertà. Ma giudicare noi, è
un'ingiustizia: le vittime vengono equiparate ai carnefici. È come se si fossero
processati gli ebrei anziché i nazisti». Ieri il Serpente ha ripetuto cose
simili, «orgoglioso d'aver combattuto al fianco della Nato contro Milosevic». Ha
spiegato che le sue dimissioni da presidente sono per «proteggere l'integrità
dello Stato», anche se ad aprile scade il mandato e il suo partito, il Pdk,
difficilmente riuscirà a mantenere la poltrona. L'interim è stato dato alla
giovane presidente del Parlamento, Vjosa Osmani. È una giurista, ha difeso
l'indipendenza del Kosovo nelle corti internazionali. Ai tempi della guerra,
andava ancora al liceo. E con quei laghetti, con quelle case gialle lei non
c'entra proprio.
Kosovo,
Thaci si difende in aula dalle accuse di crimini di guerra: "Mi dichiaro non
colpevole".
La Repubblica
il 9 novembre 2020. L'ex presidente ed ex leader dell'Uck (nome di battaglia "Il
serpente") compare davanti ai giudici del Tribunale speciale dell'Aja. “Vostro
onore, queste accuse sono infondate. E io mi dichiaro non colpevole”. Hashim
Thaci, l’ex presidente del Kosovo, dimessosi la scorsa settimana dopo la
conferma delle accuse di crimini di guerra e contro l’umanità, si è presentato
con queste parole oggi in aula durante la prima udienza al Tribunale speciale
dell’Aja che sta indagando sui crimini dell’Uck, l’Esercito di liberazione del
Kosovo. I capi d'accusa indicano che crimini di guerra relativi ad arresti e
detenzioni illegali o arbitrarie, trattamento crudele, tortura e omicidi, e
crimini contro l'umanità relativi a imprigionamento, altri atti disumani,
tortura, omicidio, sparizioni forzate di persone e persecuzione, sono stati
commessi "quantomeno" dal marzo 1998 al settembre 1999, durante la guerra contro
la Serbia. Tali crimini sarebbero stati perpetrati da Thaci, l'ex leader del
Partito democratico del Kosovo (Pdk) Kadri Veseli, Rexhep Selimi e Jakup
Krasniqi - tutti ex leader dell'Uck - in diverse località del Kosovo, oltre che
a Kukes e Cahan nel nord dell'Albania, "contro centinaia di civili e persone che
non prendevano parte alle ostilità". Le vittime includevano persone sospettate
di essere oppositori dell'Uck: nello specifico serbi, rom, ashkali, cattolici,
civili considerati presunti collaboratori delle autorità della Serbia, albanesi
affiliati o sostenitori della Lega democratica del Kosovo o altri partiti
considerati anti-Uck, albanesi che non si univano alla lotta dell'Uck. Giovane
indipendentista, rifugiatosi in Svizzera all'inizio degli anni '90 dove
partecipa alla fondazione dell'Uck, durante gli anni della guerra con la Serbia
Thaci diventa il leader politico dell'Esercito di liberazione: nome di battaglia
"Il serpente". Primo ministro per tre mandati, dal 2016 al 2020 è stato
presidente della Repubblica del Kosovo, autoproclamatasi indipendente dalla
Serbia nel 2008 e che il governo di Belgrado continua a non riconoscere.
·
Quei razzisti come
i Greci.
Alba Dorata: da terzo partito a organizzazione criminale.
Emanuel Pietrobon su Inside Over l'8 ottobre 2020. Il
7 ottobre è stata messa la parola fine a uno dei capitoli più controversi e
violenti della storia recente greca: Alba Dorata. Il fu terzo partito più votato
della Grecia negli anni più bui e drammatici della crisi economica è stato
dichiarato ufficialmente un’organizzazione criminale e i suoi membri, incluso il
fondatore, sono in attesa di ricevere delle sentenze che si preannunciano molto
severe.
La sentenza. Al termine di cinque anni di udienze, iniziate
nell’aprile 2015, il tribunale di Atene presieduto dalla giudice Maria
Lepeniotou ha raggiunto il verdetto: Alba Dorata non è un partito politico, è
un’organizzazione criminale che ha fatto ricorso alla violenza sistematica per
intimidire immigrati e sinistra radicale, lasciando a terra decine di feriti e
anche dei morti. L’intera dirigenza è stata condannata per reati legati
all'”aver guidato un’organizzazione criminale”: Nikos Michaloliakos, il
fondatore, e gli ex parlamentari Christos Pappas, Artemis Matthaiopoulos, Ilias
Panagiotaros, Ilias Kasidiaris, Yiannis Lagos e Giorgos Germenis. Altri due ex
parlamentari, Giorgos Patelis e Anastasios Pantazis, sono stati invece accusati
di reati legati alla “partecipazione ad un’organizzazione criminale”. Sotto
processo si trovano complessivamente sessantotto persone fra ex dirigenti, ex
parlamentari e attivisti, le quali, adesso, sono in attesa di ricevere le
sentenze che, sulla base di quanto stabilito dalla corte, si prospettano molto
severe. Sulla base delle prove raccolte degli investigatori, che la giustizia ha
ritenuto essere valide, Alba Dorata è stata bollata come “un’organizzazione
criminale che, assumendo la forma legale di un partito, ha goduto di una
protezione costituzionale rafforzata”. Ma quel periodo di tutela, garantita
dall’entrata in Parlamento del 2012, dal 7 ottobre è finito definitivamente e
per il partito-organizzazione criminale è iniziato ufficialmente il conto alla
rovescia verso lo smantellamento. Un ruolo fondamentale nell’allestimento
dell’intero processo, e nel raggiungimento di un simile verdetto, è stato
giocato dall’assassinio del rapper antifascista Killah P, compiuto nel 2013 da
un commando di Alba Dorata. Per quella morte sono imputate quattordici persone,
ognuna di essere accusata di partecipazione nell’omicidio, anch’esse in attesa
di ricevere la sentenza.
Terza forza politica nazionale. Quella di Alba Dorata è una
parabola divisa in due fasi: una lenta ascesa e una caduta repentina. Fondata
nel 1985 da Nikos Michaloliakos, un nostalgico della dittatura dei colonnelli,
si trasforma in un partito politico nella decade successiva ma senza mai
ottenere risultati tali da permettere l’elezione di politici, neanche a livello
locale. Alle parlamentari del 1996, il primo appuntamento elettorale per il
partito, Alba Dorata ottenne lo 0.1% dei voti. Sedici anni dopo, alle
parlamentari di maggio 2012 – ripetute il mese successivo nell’impossibilità di
formare un esecutivo – il partito ottenne un risultato straordinario: quinta
forza politica nazionale con il 7% dei voti, ossia quasi 441mila schede. La
storica prestazione fu replicata in giugno (6.9% dei voti), consacrando
l’entrata definitiva di Alba Dorata nel parlamento ellenico, anche se in
opposizione. Nonostante l’ostilità dei partiti tradizionali e della grande
stampa e la presenza di deputati fuori dalle righe, spesso espulsi dalle sedute
per il loro comportamento aggressivo e/o per il ricorso ad un bagaglio
comunicativo neonazista, Alba Dorata continuò a crescere ininterrottamente nei
tre anni successivi alle parlamentari del 2012, convertendosi nella terza
forza della nazione alle legislative del 2015, dove ottenne nuovamente il 7%
delle preferenze. Ma il risultato più elevato che il partito abbia mai raggiunto
è stato conseguito nel 2014. Quell’anno, in occasione delle europee,
il 9.4% dell’elettorato decise di inviare politici di Alba Dorata a Bruxelles,
ossia 536mila votanti; un chiaro messaggio indirizzato all’Unione Europea da
parte del martoriato popolo greco.
Alba Dorata, non solo neonazismo. Nel 2015, quindi, i greci
votarono in massa due partiti caratterizzati da delle piattaforme ideologiche
diametralmente opposte: Syriza, di sinistra radicale, e Alba Dorata, di estrema
destra. Quest’ultima viene spesso dipinta (a ragione) come un’entità di
ispirazione neonazista, mescolante nostalgia della dittatura dei colonnelli ed
euroscetticismo, ed è proprio su quest’ultimo punto che si concentra la grande
maggioranza degli analisi effettuate sul fenomeno Alba Dorata. In breve, la
letteratura ha interpretato Alba Dorata come un prodotto scaturito dalla
tremenda crisi economica che ha avvolto la Grecia a partire dal 2009, devastando
ogni settore produttivo e cambiando profondamente ogni aspetto della
quotidianità, ma si tratta di una lettura semplicistica che non tiene conto di
altri fattori. Alba Dorata è stata qualcosa di più che il frutto del malessere
popolare legato alla disoccupazione e ai dettami della celebre Troika: oltre
alle mense e alle raccolte fondi per i poveri, essa aveva istituito dei
programmi ed eventi culturali per esaltare l’identità nazionale in un’epoca di
vergogna per la propria condizione e aveva allestito delle ronde per riportare
l’ordine nei quartieri più pericolosi delle grandi città, sostituendosi alle
forze dell’ordine. Non è un caso, quindi, che il fenomeno Alba Dorata sia stato
visto in maniera estremamente positiva da parte della polizia ellenica,
quantomeno dal 2009 al 2013. Secondo alcune indagini, in occasione delle
legislative del 2012 più di un poliziotto su due avrebbe dato il proprio ad Alba
Dorata. In breve, questo partito non proponeva soltanto un piano di rinascita
economica, era fautore di una visione nazionale basata sul recupero di valori
tradizionali, sulla costruzione di una società fondata su ordine, giustizia e
disciplina, e sulla riattivazione di una politica estera autonoma: fu votato
anche, e soprattutto, per questo.
Il declino: dai raid anti-immigrati agli omicidi. Il declino di
Alba Dorata è iniziato nello stesso momento in cui ha fatto ingresso nel
parlamento ellenico: un’assioma, più che un’ipotesi. La caduta rapida, rovinosa
e inarrestabile è stata provocata dalla stessa dirigenza, con a capo
Michaloliakos, la quale non ha mai compreso una verità molto semplice, ovvero
che un partito, legale e istituzionalizzato, non può agire al di fuori e al di
sopra della legge come, appunto, un’organizzazione criminale. Il consenso
avrebbe potuto essere incrementato in svariati modi, come ad esempio l’utilizzo
ingegnoso di una parte degli stipendi dei parlamentari per finanziare attività
caritatevoli già in essere, ma, paradossalmente, l’ingresso nell’architettura
istituzionale ha dato impulso ad un processo di regressione culminato in
un’involuzione criminale. Le ronde contro il degrado e la criminalità hanno
assunto la forma di cacce all’immigrato, al di là dell’appartenenza effettiva o
meno delle vittime a delle bande, i deputati eletti si sono resi protagonisti di
attacchi fisici contro i colleghi e altri gesti eclatanti che hanno screditato
l’immagine del partito anche presso gli stessi elettori e, infine, la lotta
contro la sinistra radicale è stata spostata dalle scuole alle piazze, toccando
periodicamente dei nuovi picchi di violenza. Ed è in quest’ultimo ambito che si
origina la fine del fenomeno Alba Dorata: il 18 settembre 2013 alcuni militanti
del partito uccidono a coltellate il rapper antifascista Pavlos Fyssas, in
arte Killah P, provocando un’ondata di sdegno a livello nazionale che ha delle
ripercussioni legali immediate. A un mese e mezzo di distanza dalla scomparsa
del rapper avviene la rappresaglia: un commando appartenente alla galassia
dell’anarco-comunismo fa fuoco contro gli uffici di Alba Dorata ad Atene,
lasciando a terra due morti. Sullo sfondo dell’accoltellamento e dell’attentato
aumenta sensibilmente l’insicurezza nelle strade greche per via degli scontri
sempre più frequenti tra opposti estremismi, ragion per cui le autorità decidono
di smorzare la tensione con uno stratagemma: utilizzare la morte violenta di
Killah P per montare un caso contro l’intero partito. La combinazione
di indagini delle forze dell’ordine, auto-sabotaggio continuo, crimini efferati
e pressione mediatica, si rivela fatale in occasione delle legislative dello
scorso: Alba Dorata non riesce a superare la soglia di sbarramento, ottenendo il
2.93% delle preferenze e uscendo dal parlamento. La pesante sconfitta spiana la
strada all’accelerazione del maxi-processo, di cui si attendono, ormai, soltanto
le sentenze.
·
Quei razzisti come i Giapponesi.
Da theguardian.com il 17 dicembre 2020. La decisione del Giappone
di resistere alle pressioni internazionali per migliorare le condizioni delle
galline ovaiole è finita sotto esame dopo le accuse di corruzione che
coinvolgono un ex ministro dell'agricoltura. Takamori Yoshikawa, membro del
Partito Liberal Democratico (LDP) e ministro dell'agricoltura da ottobre 2018 a
settembre 2019, avrebbe accettato donazioni non dichiarate di 5 milioni di yen
(36.000 sterline) da un ex rappresentante di un importante produttore di uova a
Hiroshima, Giappone occidentale. Secondo quanto riferito, il primo dei tre
presunti pagamenti sarebbe stato effettuato circa due mesi dopo che
l'Organizzazione mondiale per la salute animale (Oie) ha emesso una nuova bozza
di linee guida per i produttori di uova con l’obiettivo di liberare i polli
dalle loro gabbie anguste e installare invece nidi e posatoi più grandi e più
comodi. Yoshikawa, che rappresenta un distretto di Hokkaido, la più
settentrionale delle isole principali dell'arcipelago giapponese, parlando coi
giornalisti ha negato di aver ricevuto denaro contante. I pubblici ministeri
stanno indagando sulle accuse, che sono fonte di imbarazzo per il primo ministro
giapponese, Yoshihide Suga, noto per essere vicino a Yoshikawa. Dato che quasi
tutti i produttori di uova giapponesi utilizzano gabbie vietate dall'Ue nel
2012, conformarsi al cambiamento avrebbe significato effettuare costose
ristrutturazioni agli allevamenti. L'industria del pollame giapponese ha
tradizionalmente fatto pressioni per tenere i polli nell’attuale situazione, con
più galline stipate in gabbie metalliche: una pratica che l'Autorità europea per
la sicurezza alimentare ha condannato, affermando che così gli animali sono più
a rischio malattie. Nonostante il cambiamento globale verso l'abolizione di
questo tipo di gabbie, il 94% degli allevatori di pollame in Giappone continua a
usarle per le galline domestiche, secondo un rapporto del 2019
dell'International Egg Commission citato dal Japan Times. Nel gennaio 2019, il
governo ha dichiarato di opporsi alla bozza di linee guida dell'Oie sulla base
del fatto che le nuove disposizioni per l'allevamento del pollame aumenterebbero
il numero di uova rotte e sporche e porterebbero a un più alto tasso di
mortalità tra i polli. L'Oie, di cui fa parte il Giappone, da allora ha
annacquato le sue indicazioni, affermando che l'uso di cassette nido e trespoli
era "desiderabile" invece che obbligatorio. Ovviamente sulla questione sono
intervenuti anche gli attivisti per i diritti degli animali. L'Animal Rights
Center Japan ha affermato che invece di prolungare la sofferenza dei polli
l'industria dovrebbe “lavorare con i governi e i legislatori per migliorare il
benessere degli animali”. Ha esortato l'industria a "tenere il passo con le
tendenze globali del benessere degli animali piuttosto che aggrapparsi allo
status quo" per proteggere i suoi profitti. Yoshikawa, 70 anni, si è dimesso da
due incarichi LDP all'inizio di questo mese, dicendo che era in cura in ospedale
per un problema cardiaco. Ha promesso di "rispondere sinceramente" agli
investigatori se convocato per un interrogatorio.
Francesca
Pierantozzi per “il Messaggero” il 7 dicembre 2020. «Eravamo solo dei ragazzi.
Uguali a quelli che oggi vanno al liceo. Non eravamo pazzi esaltati, non eravamo
eroi. Eravamo solo dei ragazzi». Se Kazuo Odachi si è deciso a parlare, a 93
anni, è perché sa che se non lo farà lui, sui kamikaze scenderà il silenzio per
sempre. Resterà solo un' iconografia tradizionale e spesso superficiale di pazzi
suicidi, in fondo privi di ogni umanità, obiettivi da abbattere. Odachi è uno
degli ultimi superstiti di un gruppo che non avrebbe dovuto sopravvivere. A 17
anni, nel 1943, si arruolò nella marina imperiale e entrò a far parte della
Yokaren, un programma di addestramento veloce per studenti volontari. Divenne un
kamikaze. Sette volte partì in missione, sette volte fallì: sopravvisse, non
avendo incontrato nemici. L' ottava volta, mentre stava per decollare con una
bomba da tonnellate, arrivò la notizia della resa del Giappone. Tornò a casa il
giorno dell' ultimo dell' anno del '45. Il treno passava per la città di
Hiroshima: capì quello che la resa significava. Bruciò nel caminetto del salone
la sciabola del giuramento e ricominciò a vivere, cercando di dimenticare. Del
suo passato di kamikaze non ha parlato a nessuno per decenni: non a sua moglie,
non ai colleghi poliziotti, non ai figli, non agli amici. Ma mai ha smesso di
andare a raccogliersi al santuario di Yasukuni, dove si venerano «le anime dei
soldati morti per l' imperatore». Poi, alcuni anni fa, ha deciso che avrebbe
raccontato. Non tanto il suo «segreto», ma la «verità» su quei ragazzi. La sua
'Biografia di un Kamikaze'' è uscita prima in giapponese, poi, meno di due mesi
fa, in inglese, 'Memoir of a kamikaze'', pubblicato da Tuttle. Dopo una carriera
nella Polizia, Odachi è libero di praticare oggi la sua vera passione, il kendo,
arte marziale che insegnava anche ai bambini, prima che l' epidemia lo
costringesse a casa. Vorrebbe solo, come ha spiegato anche al New York Times,
che non si dimenticasse che «il meraviglioso paese che il Giappone è diventato,
si è costruito anche sulle loro morti».
GLI
AEREI. Nato vicino alla base aerea di Tokorozawa, racconta come fin da
piccolissimo fosse affascinato dagli aerei, e come fin da piccolissimo avesse
assimilato l' idea che non sarebbe vissuto a lungo. Arruolarsi volontario fu
naturale e, dice, «oggi non lo rimpiango, so che non avrebbe potuto essere
altrimenti». Nel 1944 si ritrovò con la sua squadra nella Taiwan occupata dai
giapponesi. «In fondo sapevamo che la sconfitta era inevitabile», dice, ma fu
proprio allora che i superiori ci chiesero il più grande sacrificio: «Eravamo
pronti a morire per proteggere chi amavamo, non perché ci esaltava buttare via
le nostre vite». Le istruzioni erano succinte, anche se con retorica: «ci
dicevano che dovevamo scolpire il nemico con le nostre eliche», il che
significava lanciare i loro caccia Zero zavorrati con bombe che pesavano
tonnellate sulle portaerei e gli incrociatori alleati per distruggerli,
«significava morte certa, ma almeno avremmo portato il nemico con noi». Nell'
ottobre del 1944 partecipa alla battaglia per il Golfo di Leyte, che si concluse
con una disfatta per il Giappone. «La prima volta che chiesero chi si portava
volontario, nessuno rispose racconta Soltanto quando gli ufficiali cominciarono
ad arringare, qualcuno, cominciò ad alzare la mano. In poche parole: ci
istigavano al suicidio». Per sette volte toccò a lui, ma ogni volta qualcosa
andò storto e lui tornò alla base. «Ogni sera gli ufficiali annunciavano chi
sarebbe andato il giorno dopo, ci sentivamo come condannati a morte». Odachi è
oggi un signore in piena forma, molto sorridente e pieno di spirito. Pensa che
la costituzione pacifista del Giappone sia la migliore del mondo, ma anche che
ogni paese «ha il diritto sacrosanto di difendersi».
"Affrontare la massa di schiavi". Mishima e la guerra al mondo
moderno. Nel 1968, Mishima pubblica La difesa della
cultura - ora disponibile per la prima volta ai lettori italiani grazie a
Idrovolante edizioni - in cui si scaglia contro la debolezza del Giappone
moderno. Matteo Carnieletto e Andrea Indini, Domenica 11/10/2020 su Il Giornale.
Visse poco, Yukio Mishima. Appena 45 anni: dal 1925 al 1970. In mezzo la Seconda
guerra mondiale, una carneficina tremenda alla quale non partecipò. Un po'
perché suo padre era un alto funzionario della corte dell'imperatore, un po'
perché Kimitake Hiraoka (questo il suo vero nome) finse i sintomi di una
tubercolosi e se ne stette a casa. Vide i suoi amici partire per il fronte e mai
più ritornare. Lui, gracile e con gli occhiali, se ne stava ore e ore a
studiare. Un topo di biblioteca in grado di alzare solamente la penna. Pallido e
magro, dedicava le sue giornate alla lettura e a racimolare qualche notizia sul
conflitto. Come è noto, per il Giappone le cose andarono molto male. Sfidò il
colosso americano nel Pacifico, ma non potè nulla. Gli aerei dei kamikaze si
fiondavano sulle navi americane. Sotto di loro c'era solo l'oceano. Sopra,
invece, il cielo sempre più bianco. In mezzo i velivoli con la bandiera del sol
levante. È la guerra, ma per Mishima diventerà filosofia vissuta e arte. Che
cos'è il coraggio se non guardare?, scriverà anni dopo ne La voce degli spiriti
eroici. Ma guardare a volte è impossibile. Nell'agosto del 1945 gli americani
sganciarono le bombe atomiche su Hiroshima e Negasaki. Un'azione non necessaria,
volta più a impaurire la Russia sovietica che a piegare un Giappone già fiaccato
da anni di guerra. Una tragedia umana infinita, alla quale ne seguirà una
spirituale: l'imperatore venne costretto ad ammettere di essere un comune
mortale. Non era più dio. Era solo un uomo. Per migliaia di giapponesi fu la
fine di un'era. Nei palazzi imperiali gli uomini sguainarono le spade, si
tastarono il ventre e poi affondarono la lama. Offrirono la loro vita all'impero
che fu. Mishima visse tutto questo quando aveva solamente vent'anni. I suoi
coetanei erano pochi e, quei pochi, erano visti con sospetto. Perché la loro
vita era stata risparmiata? Perché non avevano versato il sangue per salvare la
divinità dell'imperatore? Dalle macerie, il Giappone si rialzò tutto sommato in
fretta. Negli anni Sessanta si trovò - come il nostro Paese, altro grande
sconfitto del conflitto - in pieno boom economico. Emerse una nuova figura
all'interno della nazione, quella del lavoratore indefesso, inchiodato per
dodici e più ore al proprio posto, per poi tornare a casa sfinito e magari, come
riportano i video dei giorni nostri, distrutto dall'alcool. Una vita svuotata,
da larve. Che, verrebbe da dire, non è vita. O almeno vita che val la pena
vivere. Nel 1968, Mishima pubblicoò La difesa della cultura - che ora esce per
la prima volta in Italia grazie a Idrovolante edizioni - in cui si scagliò
contro il "culturalismo", "quel borioso disvalore che costringe i popoli ad
ostentare solo alcuni aspetti della propria cultura a scapito di altri quasi da
"rinnegare", "nascondere", o "disorcere" fino quasi all'autodistruzione", come
scrive Daniele Dell'Orco nella sua prefazione al volume. Non era un nostalgico,
Mishima. Sapeva che un'epoca era ormai chiusa e che ne era iniziata un'altra. Ma
lui, in questo nuovo Giappone, non poteva vivere. Forse perché, proprio come
durante la guerra, era rimasto l'unico superstite. Solo, con un drappello di
amici e commilitoni del Tate no kai, il suo esercito privato. Sapeva di
essere minoranza: "Noi invece ci mettiamo dalla parte dei forti e partiamo come
minoranza. La limpidezza, la franchezza, l'onestà, l'elevatezza morale dello
spirito giapponese, sono cosa nostra". I nemici, per Kimitake Hiraoka, erano
due: il comunismo e l'americanismo, che tolgono la dimensione verticale - quindi
spirituale - dalla vita. Una battaglia culturale e, per ciò stessa, violenta:
"La nostra controrivoluzione consiste nel respingere il nemico sul bagnasciuga,
e il bagnasciuga non è quello del territorio giapponese, ma la diga dei
frangiflutti dello spirito di noi giapponesi uno ad uno. Bisogna affrontare la
massa degli schiavi rivoluzionari, con il gegato di chi va anvanti da solo anche
se gli atlri fossero milioni. Non bisogna curarsi degli insulti e delle
calunnie, dello scherno e delle provocazione della folla, ma bisogna affrontarla
decisi fino alla morte, per riscegliare quello spirito giapponese che ha corrso.
Noi siamo coloro che incarnano la tradizione di bellezza del Giappone". Parole
che divennero azione. Il 25 novembre del 1970, insieme a quattro uomini del Tate
no Kai, Mishima entrò nell'ufficio del generale Mashita. Lo fece portar via e si
affacciò dal balcone, di fronte a un migliaio di uomini. "Dobbiamo morire per
restituire al Giappone il suo vero volto! È bene avere così cara la vita da
lasciare morire lo spirito? Che esercito è mai questo che non ha valori più
nobili della vita? Ora testimonieremo l'esistenza di un valore superiore
all'attaccamento alla vita. Questo valore non è la libertà! Non è la democrazia!
È il Giappone! È il Giappone, il Paese della storia e delle tradizioni che
amiamo". Rientrò nell'edificio. Mishima replicò quanto fatto dai funzionari
dell'imperatore al termine della seconda guerra mondiale: sguainò la spada, si
tastò il ventre e poi affondò la lama. Offì la sua vita all'impero che fu.
Da ilmessaggero.it il 28 agosto 2020. Il premier giapponese
Shinzo Abe ha deciso di dimettersi per motivi di salute. Le preoccupazioni per
la salute di Abe sono aumentate dopo i due ricoveri in ospedale nella scorsa
settimana. Nei giorni scorsi funzionari del partito di governo, Lpd, avevano
cercato di smentire le voci riguardo alla possibilità che Abe potesse per motivi
di salute non completare il mandato che scade a settembre del prossimo anno. «Il
mio attuale stato di salute, a seguito dei recenti controlli, non mi consente di
concentrarmi sulle questioni più importanti che riguardano il governo, ed è il
motivo per cui intendo farmi da parte», ha detto il premier nel corso di una
conferenza stampa trasmessa in diretta dalle reti nipponiche. Abe è stato già
costretto dalla sua malattia, un disturbo intestinale chiamato rettocolite
ulcerosa, a rinunciare all'incarico di premier nel 2007, appena un anno dopo
l'elezione. È tornato al potere nel dicembre del 2012 e lunedì scorso, con 2799
giorni consecutivi al potere, ha superato il precedente record di longevità di
un premier giapponese, ce era stato registrato da un suo prozio, Eisaku Sato, al
governo dal novembre del 1964 al luglio del 1972. Se confermata la notizia delle
dimissioni, Abe lascia il governo in un momento in cui il Giappone deve fare i
conti con una ripresa dell'epidemia di Covid, con bilanci quotidiani che ad
agosto hanno di frequente superato i mille casi, e con la conseguente crisi
economica. Sulla scia delle indiscrezioni delle imminenti dimissioni del premier
giapponese Shinzo Abe, è già partito il totonomine dei media nipponici sul
possible successore del capo dell'esecutivo. A guidare la lista ancora un a
volta il 63enne Shigeru Ishiba, già ministro della Difesa e precedente sfidante
di Abe alla guida del partito liberal-democratico. Tra i favoriti anche
l'attuale ministro della Difesa Taro Kono, che ha ricoperto anche il ruolo di
ministro degli Esteri nel precedente consiglio dei ministri di Abe. Nella lista
anche l'attuale capo della commissione di vigilanza del partito conservatore,
Fumio Kishida, il 71enne capo di Gabinetto Yoshihide Suga - uno dei più fedeli
alleati di Abe - e il ministro delle Finanze Taro Aso, che ha già servito come
capo del governo per un breve periodo alla fine del 2008.
(ANSA il 28 agosto 2020) - Sulla scia delle indiscrezioni delle
imminenti dimissioni del premier giapponese Shinzo Abe, è già partito il
totonomine dei media nipponici sul possible successore del capo dell'esecutivo.
A guidare la lista ancora un a volta il 63enne Shigeru Ishiba, già ministro
della Difesa e precedente sfidante di Abe alla guida del partito
liberal-democratico. Tra i favoriti anche l'attuale ministro della Difesa Taro
Kono, che ha ricoperto anche il ruolo di ministro degli Esteri nel precedente
consiglio dei ministri di Abe. Nella lista anche l'attuale capo della
commissione di vigilanza del partito conservatore, Fumio Kishida, il 71enne capo
di Gabinetto Yoshihide Suga - uno dei più fedeli alleati di Abe - e il ministro
delle Finanze Taro Aso, che ha già servito come capo del governo per un breve
periodo alla fine del 2008. La Borsa di Tokyo vira subito in negativo dopo le
anticipazioni dei media nipponici sulle dimissioni del premier giapponese Shinzo
Abe. Quando mancava più di mezz'ora dalla chiusura il Nikkei cedeva oltre il 2%,
tornando sotto quota 23.000 e perdendo quasi 500 punti. Sul mercato valutario lo
yen guadagna terreno sul dollaro a un livello di 106,70 e a 126,20 sull'euro.
Abe si è dimesso: così ha cambiato il Giappone.
Andrea Muratore il 28 agosto 2020 su Inside Over. Il premier
giapponese Shinzo Abe, annuncia le proprie dimissioni dopo quasi otto anni
consecutivi di governo. La motivazione sarebbe da ricondurre ai dolorosi affanni
causati da un male cronico, la colite ulcerosa, di cui Abe soffre dall’età di 17
anni. Quando nell’arco di pochi giorni, nelle scorse settimane, è circolata la
notizia che il primo ministro giapponese si era recato nell’Ospedale
dell’Università di Keio per dei controlli sulla sua condizione fisica le voci
hanno iniziato a circolare, per poi diventare in seguito sempre più pressanti.
La salute personale del premier potrebbe dunque riuscire laddove tre elezioni
(2012, 2014, 2017) e numerose sfide alla sua leadership nel Partito
Liberal-Democratico da lui guidato non sono riuscite: sottrarre ad Abe il
controllo dell’agenda politica giapponese e dell’azione di governo, da lui
rilanciata a partire da quel 26 dicembre 2012 in cui la Dieta del Giappone, il
parlamento nipponico, lo elesse nuovamente primo ministro dopo la fugace
esperienza di governo del 2006-2007. Abe, nato nel settembre 1954 nella capitale
nipponica da una famiglia usa da tempo a frequentare i palazzi del potere di
Tokyo, figlio di Abe Shintaro, che fu Ministro degli Esteri negli Anni
Ottanta, nipote di un deputato per via paterna (Abe Kan) e di un primo ministro
(Kishi Nobusuke, in carica dal 1957 al 1960) per via materna, nel corso della
sua lunga leadership ha collezionato importanti risultati che hanno cambiato il
quadro politico giapponese. Abe ha impostato una piattaforma politica
estremamente ambiziosa capace di rilanciare le prospettive strategiche ed
economiche di Tokyo nel contesto globale e mirato a stimolare un’innovazione
profonda dell’architettura istituzionale e costituzionale emersa dalla sconfitta
giapponese nella seconda guerra mondiale. Fieramente conservatore, membro
dell’ala più rigorista del partito di centro-destra di cui fa parte, Abe ha
portato nei palazzi del potere di Tokyo una mentalità più aperta a iniziative
strategiche consolidate rispetto ai suoi predecessori, a lungo focalizzati sul
mantenimento del benessere economico e materiale del Paese con politiche di
piccolo e medio cabotaggio. Membro della società Nippon Kaigi, che si batte per
rilanciare il senso di orgoglio e appartenenza nazionale nel sistema-Paese
nipponico, valorizzare nuovamente la figura politica dell’imperatore e superare
l’eredità ideologica e materiale della seconda guerra mondiale Abe ha trasmesso
in proposte politiche la sua visione. Ed è significativo per capire la sua
parabola politica partire dalle opere incompiute: Abe ha per otto anni inseguito
il superamento della clausola pacifista insita nell’Articolo 9 della
Costituzione elaborata dopo la resa agli Alleati nel 1945. Paravento
istituzionale per giustificare strategie più assertive sul fronte
internazionale, rafforzamenti dell’apparato militare, rilancio di una retorica
patriottica che in Giappone non si vedeva dai tempi della guerra. Obiettivo che
si è rivelato, in fin dei conti, quasi utopico in una società come quella
giapponese, abituata da tempo al benessere diffuso, ma che dà l’idea della
duplice natura del leader Abe: un concentrato di idealismo e realismo, un uomo
forte capace di leggere lucidamente la sua epoca ma saldo nelle proprie
convinzioni ideologiche. Sotto certi punti di vista, ma con tutti i dovuti
distinguo del caso, un personaggio non troppo diverso dal presidente cinese Xi
Jinping in quanto a differenza rispetto ai disegni dei predecessori. Abe ha
comunque sdoganato la possibilità per le forze armate nipponiche di partecipare
a missioni internazionali, inserito la competizione con la Cina e l’alleanza con
gli Stati Uniti in un’architettura più ampia in cui Tokyo ha potuto coltivarsi
autonomamente spazi diplomatici (come i progetti geoeconomici o l’alleanza con
India e Australia) e tornare attore di primo piano. Poco successo hanno avuto
invece le pressioni sul neo-imperatore Naruhito affinché, dopo l’abdicazione
del padre Akihito assumesse un più spiccato ruolo politico. “Ordine e armonia”,
il significato del termine Reiwa con cui Naruhito ha denominato la sua era
imperiale, non coincide fino in fondo con l’idea politica di Abe. Sull’economia
Abe ha rotto la tradizionale linea rigorista e neoliberista del suo partito
lanciando le politiche di ampio respiro della Abenomics, un programma
ultra-keynesiano di spesa pubblica alimentato dalla dilatazione dei bilanci
della Bank of Japan e finalizzato a riportare livelli di crescita e investimento
sostenuti nel Paese. Il programma ha aumentato, sotto diversi punti di vista,
la sostenibilità del debito pubblico giapponese incrementando la presa su di
esso della BoJ, ma al contempo ha risentito di tutti i problemi tipici dei
quantitative easing: un’eccessiva postura finanziaria. “Sebbene gli investimenti
privati in Giappone siano aumentati negli ultimi anni, gli analisti sono
concordi sul fatto che quelli aziendali dovrebbero essere molto più sostenuti,
alla luce delle riforme fatte”, fa notare l’Ispi. Nonostante i profitti record
delle società, negli ultimi sei anni, gli investimenti hanno registrato solo un
aumento moderato ma l’aumento previsto dei salari giapponesi – una delle
condizioni preliminari di una sana inflazione – non si è ancora materializzato.
Tutto ciò ha determinato crescenti preoccupazioni relative alla sostenibilità
delle riforme intraprese.” Sul lungo periodo Abe ha individuato nella riduzione
delle imposte alla classe media, passate dal 37 al 32% con prospettive di tagli
al di sotto del 30%, nell’attrazione di manodopera straniera nei settori
qualificati e nell’inversione del declinante trend demografico le politiche da
attuare contemporaneamente ai progetti di espansione della base monetaria. Tali
progetti, dopo le dimissioni, saranno lasciati in campo al suo successore, che
potrebbe essere l’unico membro del governo con esperienza da premier, il vice di
Abe Taro Aso, in carica tra il 2008 e il 2009 alla guida del Paese e dal 2012
“zar” della politica economica come ministro delle Finanze. Cattolico, prossimo
agli 80 anni, Aso è un custode della linea politica portata avanti da Abe nel
lungo periodo da premier, ed è forse addirittura più tenace nelle sue
convinzioni rispetto al compagno di partito. La successione non sarebbe, dunque,
una vera eredità, ma avverrebbe nella continuità, con l’unica differenza del
diverso carisma tra Abe e il più schivo Aso. Una scelta che sostanzialmente non
modificherebbe le linee prospettiche disegnate da Abe alla guida del Paese.
Quelle donne dai corpi tatuati che sfidavano religione e
leggi. Per molto tempo in Giappone i tatuaggi sono
stati visti come il simbolo del male. Poi qualcosa è cambiato...Andrea Indini,
Domenica 23/08/2020 su Il Giornale. “Kenzo non poteva vedere il viso del
tatuatore, che gli dava le spalle, ma riusciva a distinguere il movimento
preciso delle mani. Con il pollice e l’indice della mano sinistra tendeva la
pelle, mentre nel medio e l’anulare della stessa mano stringeva tre pennelli.
Servendosi poi del polpastrello sinistro come di una leva, con la destra faceva
penetrare nella pelle uno dopo l’altro, su e giù, gli aghi raccolti in un mazzo,
producendo una specie di lievissimo scoppiettio”. Nel secondo dopo guerra gli
irezumi, i tatuaggi tradizionali, sono ancora vietati per legge in tutto il
Giappone. Solo gli uomini della yakuza, le donne di malaffare e, più in
generale, le classi sociali più basse sono disposti ad arrischiarsi in uno
studio illegale per farci incidere tutta la schiena. Ed è in una Tokyo sordida,
ancora devastata dai bombardamenti è resa insicura dalla povertà, che viene
ritrovato in una stanza chiusa dall’interno il cadavere di una donna bellissima.
È stato fatto a pezzi e ne sono rimasti solo gli arti. Il tronco, prima
completamente ricoperto da un serpente e da un Orochimaru. Il drammatico
omicidio di Kinue è solo il primo di una lunga scia di sangue che si dipana nel
romanzo di Takagi Akimitsu (1920-1995): Il mistero della donna
tatuata (Einaudi). “Pochi al mondo conoscono la bellezza dell’irezumi - il
tatuaggio. E ancora meno sono coloro che subiscono il fascino insito nel gesto
di imprimere una vita segreta su un corpo umano. Quell’ignoranza è probabilmente
dovuta a tenaci pregiudizi”. Akimatsu, che dopo la laurea decise di fare lo
scrittore seguendo la profezia che gli fece un indovino divenendo uno dei più
importanti e famosi autori di gialli giapponesi, ci porta in un mondo in cui
questo pregiudizio è violentissimo. La maggior parte delle “persone perbene” dà
“per scontato che a farsi tatuare sia soltanto la feccia della società”. Questo
perché per i giapponesi educati dal pensiero confuciano credono che il corpo
ricevuto dai genitori debba essere preservato intatto. Così accade,
nell’immediato dopo guerra, che gli irezumi inizino a “contagiare” gli
occidentali che si trovano in Oriente. È l’esercito di occupazione che inizia a
portarne disegni e tecnica negli Stati Uniti ed è qui che iniziano a tenersi i
primi concorsi per eleggere il disegno più bello a cui partecipano anche le
persone più in vista. Al concorso organizzato dal Circolo tatuati di Edo, che
Akimatsu descrive nel romanzo pubblicato nel 1948, partecipano solo avanzi di
galera. E tra questi pure una ventina di donne, il peggio del peggio. La
vincitrice è proprio Kinue, figlia di un grande tatuatore Hori’yasu. Troppo
sfrontata, troppo bella, troppo disinibita. Così succede che qualcuno la ammazza
con qualche goccia di cianuro nascosto in un bicchiere di birra e le deturpa il
corpo nel modo peggiore. Il caso viene affidato all’ispettore capo Matsushita
che finisce per indagare nei bassi fondi di Tokyo. Qui entra in contatto con
spietati uomini d’affari, che fanno i soldi nel mercato nero che prolifera sulle
macerie del conflitto mondiale, violenti uomini della yakuza, che entrano ed
escono dal carcere, maniaci appassionati di irezumi, che sono disposti a pagare
per “strappar via” la pelle tatuata da un cadavere, e una maledizione che grava
sulla stessa Kinue e sui suoi due fratelli, anche loro completamente disegnati.
Nonostante lo stigma del Confucio e della legge quello che Akimatsu fa emergere
in un racconto tanto veloce quanto asciutto è la bellezza di una tecnica e di
una una cultura che non può essere relegata nei bassi fondi. Perché soffrire e
spendere tanto per poi essere additati da tutti? Nella regione del Kansai
l’irezumi viene chiamato anche gaman, ovvero pazienza, perché chi decide di
farlo sa che dovrà sopportare sia la spesa sia il dolore. Le sedute dei tatuaggi
tradizionali sono molto brevi e l’infezione che ne consegue porta sempre a
puntate di febbre a 39 gradi. Eppure molti sono disposti a sfidare tutto questo
per avere addosso un disegno che li segnerà per sempre. Tutto questo perché,
secondo un noto psicologo, il tatuaggio è un istinto umano primordiale:
l’incarnazione perfetta della libido. “Da una parte - spiega - abbiamo un ago
acuminato, dall’altra l’epidermide perforata, e il liquido che sgorga. C’è chi
dà e chi riceve: si possono chiaramente vedere, in quest’atto, le due facce di
una stessa medaglia”. È forse per questo che, quando in Giappone sembrava che la
legge è il sentire comune fossero riusciti a sradicare l’irezumi, ecco che
questo è risorto dalle sue stesse ceneri. Come la Fenice.
Jing-Jing Lee: «Vi racconto l’inferno delle “donne di
conforto” alla mercé dei giapponesi». Orlando Trinchi
su Il Dubbio il 23 agosto 2020. Quando Tokyo occupò Singapore nella Seconda
guerra mondiale, migliaia di coreane, cinesi e filippine furono ridotte a
schiave sessuali. Una vicenda rimossa, oggi raccontata nell’ultimo romanzo di
Jing-Jing Lee: “Storia della nostra scomparsa”. Wei an fu, “donna di conforto”:
questo l’appellativo riservato alle ragazze – migliaia di coreane, filippine,
cinesi – rapite e rinchiuse, nel mezzo dell’occupazione militare da parte del
Giappone durante la Seconda guerra mondiale, nelle cosiddette comfort stations (
prigioni- bordello) con l’obiettivo di trasformarle in schiave sessuali. Wang
Di, protagonista dell’intenso ed evocativo romanzo di Jing- Jing Lee, Storia
della nostra scomparsa ( Fazi Editore), ha soltanto tredici anni quando viene
allontanata dal villaggio e dalla sua famiglia all’epoca dell’invasione
nipponica di Singapore per essere rinchiusa in una comfort house e diventare un
oggetto alla mercé dei militari giapponesi. La sua vicenda si incrocia,
sessant’anni dopo, con quella di Kevin, un ragazzo intenzionato a scoprire la
verità sulla propria famiglia dopo aver ascoltato le confessioni della nonna in
punto di morte. Un romanzo scomodo, doloroso: per scriverlo l’autrice – anche
lei nata e cresciuta a Singapore – ha dovuto scavare nella propria storia
familiare e riportare alla luce la memoria tormentata di un’intera generazione
di donne destinate all’oblio.
Ms. Jing- Jing Lee, cosa l’ha spinta a scrivere una storia
drammatica quanto delicata come quella delle comfort women, consumatasi durante
l’invasione giapponese di Singapore? Cos’ha significato per lei raccontarla?
«Non avevo intenzione di scrivere un
romanzo basato su fatti storici. Ho iniziato a farlo perché uno dei personaggi
di una precedente raccolta di racconti ha continuato a indugiare nella mia mente
molto tempo dopo la pubblicazione del libro. È stato solo mentre lo scrivevo che
ho realizzato che gran parte del romanzo doveva essere ambientato nella
Singapore occupata dai Giapponesi. Avvertivo una grande responsabilità nel
descrivere le comfort women e la Singapore del 1940 in modo accurato – a tal
fine, ho impiegato molto tempo a documentarmi».
Nel romanzo ha evidenziato come alle ragazze recluse vengano
imposti dei nomi giapponesi. Cosa questo ha significato per loro?
«A mio avviso, ciò significò molto
per loro in termini di proprietà e colonizzazione. È indicativo anche della
mentalità del Giappone imperiale nei confronti del resto dell’Asia – ritenevano
i non giapponesi alla stregua di subumani. Non so come abbiano giustificato
l’attribuzione di un nuovo nome imposto alle ragazze: forse avranno affermato
che sarebbe stato più semplice per il personale pronunciare nomi giapponesi,
forse era solo per rendere più anonime le ragazze».
«Nella casa bianca e nera – ricorda Wang Di – parlavamo
soltanto dei nostri corpi». Cosa rappresentava per le ragazze il loro stesso
corpo durante la prigionia nelle confort stations?
«Credo che per loro i corpi
rappresentassero principalmente un rimando alla loro vergogna e vulnerabilità.
Anche quando sono diventate più grandi, i corpi delle comfort women fungevano
come una sorta di promemoria degli orrori che avevano attraversato. Molte di
loro hanno contratto malattie sessualmente trasmissibili ( che non sono state
adeguatamente trattate in tempo) e hanno avuto problemi di salute per il resto
della loro vita; alcune di loro non poterono avere figli per quello che avevano
passato. In un documentario intitolato “Because We Were Beautiful”, le vittime
indonesiane dell’esercito imperiale giapponese hanno espresso rammarico per
essere state tanto desiderabili da avere attirato l’attenzione dei soldati ( da
qui il titolo del documentario)».
«Nessuna di noi pronunciò mai la parola "stupro". Non dovevamo
farlo». Quanto la creazione di zone grigie – che deriva anche dal non dare il
giusto nome alle cose – ha contribuito a dinamiche di violenza e prevaricazione?
«Penso che in realtà non nominare
l’atto derivi da un tabù sociale che riguarda lo stupro, cosa che ha contribuito
a perpetuare più a lungo il tabù stesso. Si tratta di un circolo vizioso: queste
dinamiche creano un contesto in cui alle donne non è permesso parlare di tali
problemi – a costo di venire punite per averlo fatto – e il silenzio che
circonda la violenza sessuale fa sì che questi tabù rimangano intatti. Il
silenzio delle vittime è parte integrante della “scomparsa” di queste donne».
«È una confort woman!» : la vergogna provata dopo la
liberazione può essere quasi maggiore delle violenze subite? L’isolamento
familiare e sociale ha fatto seguito all’isolamento fisico della detenzione?
«Non credo che queste donne siano
state detenute dopo la guerra, ma, in realtà, molte di loro si vergognavano di
parlare di quanto era loro accaduto con i familiari. L’isolamento sociale che
hanno esperito potrebbe essere terribile quanto la detenzione: in alcuni casi
esse sono rimaste nelle stesse zone in cui erano state tradotte ( molte donne
coreane, ad esempio, sono state condotte in Manciuria e in Cina), in isolamento
sociale, lontane dalle loro comunità e dalle loro famiglie per il resto delle
loro vite».
Pio D'Emilia per ''Il Messaggero'' il 7 settembre 2020. Nessuno
sa bene quanti siano. Diecimila, ventimila. Qualcuno dice addirittura centomila.
È l' esercito dei johatsusha, coloro che evaporano. Mentre diminuisce il numero
dei suicidi che resta comunque uno dei più alti al mondo, circa 20 mila l' anno,
uno ogni mezz' ora, con preoccupante incremento della fascia dei minori tra i 6
e i 14 anni, tra i quali è la causa di morte più diffusa) ed irrompe il triste
fenomeno della kodokushi (morte in solitudine, persone, soprattutto anziani, che
si lasciano morire di fame in casa, pur di non disturbare familiari oramai
lontani e disinteressati) in Giappone aumenta quello delle persone che, ogni
anno, spariscono. Come avviene nel resto del mondo, Italia compresa, si può
decidere di sparire per tanti motivi. Quello che è difficile è riapparire,
magari a centinaia di km di distanza, e riuscire a condurre una vita (quasi)
normale. Senza documenti, e con una, o più, identità inventate. Niente di più
facile, in Giappone. Paese in genere percepito come uno stato di polizia, con le
autorità che controllano in modo rigoroso ed efficace la popolazione. In parte è
vero, ma si tratta di un controllo soft, reso possibile dal consenso sociale e
dalla disponibilità dei cittadini a collaborare. Ma in realtà, non è così.
Intanto, in Giappone non esiste l' obbligo di possedere e tanto meno di
circolare con un documento di identità. Per espatriare, certo, ci vuole il
passaporto, per guidare devi avere una patente, e per farsi curare una tessera
sanitaria. Ma nessuno di questi documenti è obbligatorio e nessun cittadino può
essere fermato come succede da noi per un normale controllo e portato in
questura perché non ha documenti. La propria identità, generalmente, viene
semplicemente dichiarata, e spesso, ma non indispensabilmente, confermata dalla
presentazione di un biglietto da visita. Sul quale, volendo, ci si può scrivere
qualsiasi cosa. Stesso discorso per trovare un lavoro. A meno che non si tratti
di concorsi pubblici dove occorre allegare una serie di documenti, compreso il
cosiddetto koseki - equivalente del nostro stato di famiglia per essere assunti
anche a tempo indeterminato basta inviare un semplicissimo curriculum vitae
(rirekisho) con una foto. Certo, le aziende possono chiedere ulteriori
informazioni, ma in genere non lo fanno. Ancora più facile è accedere al mercato
del lavoro precario, vero punto di forza dell' economia giapponese, capace di
assorbire ed espellere a seconda della contingenza, milioni di persone. Per
lavorare part time, a ore, presso un benzinaio, un conbini (piccoli supermarket
aperti 24 ore su 24), un bar o ristorante, basta presentarsi, dare un nome
qualsiasi, fare un bell' inchino e darsi da fare. A fine giornata, o settimana,
si verrà pagati, in contanti (non è quindi necessario possedere un conto in
banca). Insomma, un vero e proprio paradiso per chiunque voglia evaporare, quale
che sia il motivo, e in qualche modo riprovarci. Ho conosciuto un ricercato che
è riuscito a girovagare per tutto l' arcipelago per 15 anni, periodo dopo il
quale in Giappone scatta la prescrizione, per qualsiasi tipo di reato. Diverso
tuttavia è l' impatto ed il giudizio, sociale. Che mentre per chi si suicida è
improntato al rispetto, per chi evapora è invece molto negativo. Questo sia per
motivi etico-culturali – il suicidio in Giappone ha una lunga e condivisa
tradizione positiva: la vita appartiene all' individuo, e chi si suicida mostra
coraggio e capacità di assunzione di responsabilità – che pratici. Soprattutto
per quanto riguarda le famiglie. Che, mentre nel caso di evaporazione debbono
aspettare almeno 7 anni per ottenere una dichiarazione di morte presunta, e sono
dunque costrette a subire tutte le conseguenze economiche e sociali del
fallimento e della fuga del loro congiunto, in caso di suicidio hanno la
possibilità di mantenere il loro status e le loro condizioni di vita grazie ai
più che cospicui risarcimenti delle assicurazioni. Che nonostante negli ultimi
tempi impongano alcune condizioni (tipo aver stipulato il contratto almeno da un
anno) sono tra le poche al mondo a pagare anche in caso di suicidio.
Chris Weller per "it.businessinsider.com" il 16 luglio 2020. In
giapponese, la parola è johatsu, o gli “evaporati”. Tormentati dalla vergogna
per aver perso il lavoro, per un matrimonio fallito, o per un debito, migliaia
di cittadini giapponesi pare si siano iniziati a lasciare alle spalle le proprie
identità per cercare un rifugio nell’anonimato, mettendosi fuori dalla
circolazione. Questo secondo un libro di recente pubblicato chiamato “The
Vanished: The ‘Evaporated People’ of Japan in Stories and Photographs (Gli
evaporati del Giappone attraverso storie e fotografie) della coppia, lei autrice
e lui fotografo, francese Léna Mauger e Stéphane Remael. Il libro, anche in
francese, riporta una serie di aneddoti su gente che è scappata dalla società
moderna in cerca di una vita più riservata e con meno vergogna. Mauger e Remael
hanno trascorso cinque anni viaggiando per il Giappone, iniziando nel 2008,
guadagnando la fiducia della gente del luogo per arrivare a conoscere a fondo la
triste tendenza. Hanno anche incontrato le persone care di quelli che sono
scomparsi: padri, mogli, ed ex amanti abbandonati. Non esistono dati
ufficiali del governo su questa tendenza, ma secondo la ricerca della coppia
oltre 100mila persone spariscono ogni anno. Nessuna di queste persone scompare
fisicamente, in sé e per sé; l’“evaporazione” è più una scomparsa
amministrativa. Come per le persone nei Programmi di Protezione Testimoni negli
Stati Uniti, i johatsu optano per cambiare i loro nomi, indirizzi, e legami
professionali. Possono praticamente fare tabula rasa. In Giappone questa fuga
può essere sorprendentemente facile, sostiene Public Radio
International (PRI). Le leggi sulla privacy giapponesi danno ai cittadini una
grande libertà nel mantenere segreti i loro movimenti. Soltanto in casi
criminali la polizia scava nei dati personali della gente, e i parenti non
possono consultare i dati finanziari. Come ha detto Mauger al New York Post a
dicembre, i casi di scomparsa sono causati dall’enorme pressione che la cultura
giapponese mette sul "salvare la faccia". “È un tabù enorme” ha detto Mauger. “È
qualcosa di cui non si può realmente parlare. Ma la gente può sparire perché c’è
un’altra società sotto la società giapponese. Quando la gente scompare sa che
può trovare un modo per sopravvivere”. I casi di johatsu sembrano essere
emersi alla fine degli anni Sessanta, supportati da un film del 1967 intitolato
“A Man Vanishes”, in cui un uomo improvvisamente si lascia alle spalle lavoro e
fidanzata e sparisce. Alla fine degli anni Settanta, sono emersi più casi di
giovani lavoratori cresciuti in campagna che scappavano dal lavoro duro verso le
città, dice Hikaru Yamagishi, che studia Scienze Politiche a Yale. Un uomo che
Mauger e Remael hanno incontrato ha detto che il suo lavoro era quello di
trasferire questi johatsu in villaggi e città lontane durante gli anni Novanta.
Lui e altri come lui si autodefinivano “traslocatori notturni”. Il loro lavoro
consisteva nel portare la gente in nuove location segrete, sotto la copertura
dell’oscurità. Secondo PRI gli anni Novanta furono un’epoca di boom per questi
“traslocatori notturni”. L’economia era appena crollata e tante persone
cercavano una via d’uscita. “È una cosa folle, ma in quegli anni la scomparsa
divenne un business” ha detto Mauger a PRI. Nel loro libro, Mauger e Remael
gettano anche una nuova luce sulle persone care che vengono lasciate
indietro. Spesso le famiglie dei johatsu hanno detto che avrebbero preferito
che la persona scomparsa non avesse provato tanta vergogna. “Vogliamo soltanto
avere sue notizie, non deve tornare a casa. Se ha bisogno di soldi, glie li
mandiamo” ha detto un genitore di un johatsu a Mauger e Remael. L’ossessione
giapponese del "salvare la faccia" si manifesta anche in altri modi. Ad
esempio la lingua giapponese ha una parola per descrivere i suicidi dovuti ad
eccessivo lavoro: karoshi. Lo scorso ottobre, una relazione ha scoperto che
oltre il 20 per cento della gente in un sondaggio su 10mila ha detto di lavorare
almeno 80 ore di straordinari al mese. Metà di quelli che hanno risposto ha
detto di rinunciare a prendersi vacanze retribuite. Negli ultimi mesi,
il governo giapponese ha fatto piccoli passi per ridurre i casi di karoshi, come
incoraggiare le società a lasciare che i propri dipendenti lavorino meno il
venerdì. Secondo gli esperti, comunque, la cultura del lavoro è così forte che
per molti gli incentivi ancora non compensano i lati negativi dell’abbandonare.
Questo sempre che non scelgano di fare come i johatsu, andandosene sì, ma per
sempre.
·
Quei razzisti come i Cinesi.
Giulia Zonca per “la Stampa” il 14 dicembre 2020. Per giocare
bisogna avere i capelli neri. La regola è capricciosa così come sembra, sbucata
in mezzo a molte altre nel codice di comportamento destinato a chi vuole
rappresentare la Cina. In qualsiasi modo, anche su un campo da calcio
universitario dove le ragazze con la tinta vengono squalificate. Niente colori
strani, proibite le meches, per non parlare dei colpi di sole, severamente
osteggiati gli schiarimenti, vade retro la decolorazione, i ciuffi vivaci e
soprattutto il rosa che spopola nel calcio femminile perché lo porta Megan
Rapinoe: campionessa mondiale, Pallone d’oro e faccia di ogni ribellione. Lei si
è messa in ginocchio contro la discriminazione, si è presentata in tribunale per
la parità di salario, si è votata al fucsia per mettere un accento che ora in
molte replicano, richiamano e omaggiano. Ma la Cina oggi ha un solo punto di
riferimento concesso, il presidente Xi Jinping che pretende un immagine sobria,
soprattutto unica, standardizzata. La studentessa media è nera, liscia e così
deve restare, la massa così deve passare, per dare l’idea di un popolo
ubbidiente e giudizioso. Il divieto è recente, scritto in un regolamento più
fresco del colore sulle ciocche. Un paio di settimane fa il primo arbitro
zelante ha deciso di appellarsi al cavillo, la centrocampista striata di rosa è
rimasta in tribuna per punizione e la notizia ha viaggiato veloce su Weibo, il
social più diffuso in Cina. Quasi tutte le colleghe impegnate nel torneo in
corso hanno cercato di levare le sfumature della testa, non tanto per evitare
guai, quanto per giocare. Si sono ripresentate senza code striate e frange punk,
più o meno uniformi, solo lontane dal nero naturale e l’incontro tra Fuzhou e
Jimei è saltato. Una squadra ha accusato l’altra di essere fuori protocollo:
rivendicazioni e dita puntate fino a che non è scattata la contestazione su ogni
singola acconciatura. Le scampate al giudizio universale erano meno di sette per
parte, sotto il numero legale. A casa. Per l’ultima sfida della competizione
tutte, nessuna esclusa, si sono tinte di nero. Un trucco per tornare alle
origini, una facciata che viene via con il tempo e ben rappresenta questo regime
impegnato a essere insieme globale e autarchico. Da quando il calcio ha un peso
nelle strategia di Stato, ha anche una linea da seguire. I professionisti non
possono mostrare tatuaggi, hanno diritto alla convocazione in nazionale solo se
li coprono. Maniche lunghe, bendaggi e poco importa se la norma si scontra con
nomi che ormai si sono disegnati collo e mani, se spesso sbuca la coda di un
drago da un polsino o il carattere di una parola da un colletto. Conta il colpo
d’occhio, la Cina che somiglia a se stessa, tutti uguali e di conseguenza
controllati. Per un braccialetto sfuggito al dogma anti gioielli, il difensore
Wang Shenchao ha preso 12 mesi di sospensione. Essere uno sportivo di successo
significa essere un modello e gli esempi non perdono tempo dietro ai vezzi, come
se scegliersi il colore dei capelli fosse davvero un gesto così superficiale. I
rivoluzionari contro la parrucca, i contestatori capelloni, il caschetto corto
alla Giovanna d’Arco per celebrare l’indipendenza, la storia è piena di tagli
dimostrativi. E pure di scomposti tentativi di osteggiarli. Dalle tv cinesi sono
scomparsi i cartoni con le eroine fluorescenti, a partir dalle «Shining Star»,
animazione coreana in cui ogni protagonista ha un colore diverso, censurate per
il desiderio poco onorevole di diventare cantanti pop e probabilmente per i
testi politici sui gusti del gelato. Le «shining» sono pensate per un pubblico
tra i 7 e 9 anni, futuri adolescenti che potrebbero spingere per un cambio
culturale. La Cina di Xi è connessa al mondo, è tecnologica, viaggia (quando
può), si confronta e sa come trovare spunti oltre un cartone bandito, però il
dress code del calcio è più subdolo. Il sistema è troppo rigido per concedere
una possibilità a chi ha talento e vuole tenersi la propria identità, i giovani
vogliono giocare e accettano l’imposizione. Tinta nera per tutte, può sempre
gocciolare, come quella di Rudy Giuliani, e mostrare la sua precarietà.
Filippo Santelli per “la Repubblica” il 13 novembre 2020. La
prima è stata una professoressa di una scuola media. Qualche settimana fa ha
portato in classe una scatola di assorbenti e detto alle ragazze di servirsi
ogni volta che ne hanno bisogno, magari riportandone un altro in seguito. Quando
Jiang Jinjing, attivista per i diritti delle donne, ha visto la foto della
scatola girare sui social l' ha subito rilanciata. Da tempo Jiang si batte
contro la "povertà mestruale", la difficoltà di accesso agli assorbenti
frequente in molti Paesi in via di sviluppo, comprese alcune aree più arretrate
della Cina, e contro lo stigma associato al ciclo femminile. La foto ha iniziato
a circolare e spinto tante altre donne a fare lo stesso. Confezioni di
assorbenti sono comparse fuori dai bagni di scuole medie, superiori e università
cinesi, oltre 300 secondo il New York Times . «Basta con la vergogna delle
mestruazioni », si legge su un foglietto appeso vicino a una di queste scatole.
Quella raccontata dal quotidiano americano è solo l' ultima delle sfide in tema
di corpo e sessualità lanciate alla cultura patriarcale della Cina: negli ultimi
giorni ha fatto discutere la storia di un assistente di volo che, dopo essere
stato licenziato dalla compagnia di Stato China Southern per il video di un suo
bacio omosessuale, ha fatto causa alla società. Sul tema, come su tutto ciò che
riguarda la sessualità, l' atteggiamento delle autorità è ambivalente. Da un
lato lasciano spazio al dibattito. Dall' altro procedono con estrema prudenza
nel riconoscimento dei diritti: per l' omosessualità per esempio vige la
politica dei "tre no": non approvata, non disapprovata, non promossa. Più in
generale, una nuova legge prevede che dal prossimo anno l' educazione sessuale
diventi obbligatoria nella scuola dell' obbligo. È la prima volta che il governo
usa ufficialmente il termine "educazione sessuale". La battaglia sugli
assorbenti in questo contesto è particolarmente significativa, proprio perchè la
cultura patriarcale rende molti argomenti, soprattutto quelli che riguardano la
sessualità femminile, tabù: oltre il 60% delle donne cinesi usa delle perifrasi
per indicare il ciclo mestruale. Ma non solo: di recente l' Associazione per la
pianificazione familiare e l' Università Tsinghua ha proposto a quasi 50mila
universitari un questionario, nove domande che spaziavano dall' efficacia del
coitus interruptus come metodo contraccettivo alle malattie sessualmente
trasmissibili, e oltre un terzo dei partecipanti ha risposto correttamente solo
a tre quesiti o meno. Neppure un terzo ne ha azzeccati più di sei. Una mancanza
di conoscenza che qualche esperto arriva a definire «analfabetismo sessuale».
Eppure la travolgente modernizzazione sta cambiando anche la sensibilità dei
cittadini, in particolare gli abitanti più istruiti delle grandi città. Ha
suscitato indignazione per esempio il fatto che ai medici eroi di Wuhan non
siano stati forniti assorbenti, nonostante le donne fossero la metà dei dottori
e la maggioranza degli infermieri. Il Partito comunista non permette che le
rivendicazioni diventino movimenti organizzati, ma alcuni attivisti come Jiang
Jinjing riescono a portarle avanti. E singoli cittadini, come l' assistente di
volo, lottano per i propri diritti in tribunale.
Michelangelo
Cocco per “il Messaggero” il 2 novembre 2020. Messa sotto controllo l' epidemia
di Covid-19, calato il sipario sul Comitato centrale del Partito comunista, per
i cinesi è arrivato il momento di contarsi. Da ieri milioni di cinesi hanno
iniziato a registrare i loro connazionali per il settimo censimento nazionale,
evento che si ripete ogni dieci anni da quando, nel 1949, venne proclamata la
Repubblica popolare. A quanto ammonta oggi la popolazione più numerosa del
pianeta, composta da 56 etnie sparse sul quarto Paese più esteso del mondo? Il
censimento precedente, nel 2010, aveva registrato poco meno di 1,4 miliardi di
abitanti (esattamente 1.339.724.852). Per raccogliere i dati delle famiglie sono
stati sguinzagliati 7 milioni di lavoratori socialmente utili che, per due mesi,
busseranno alle porte di scintillanti grattacieli shanghaiesi, come a quelle
delle case di remoti villaggi tibetani, delle yurte, le tende mongole abitate da
popoli nomadi ai confini col Pakistan. Parte della popolazione invece risponderà
al censimento attraverso una app, nonostante un numero crescente di cittadini
abbia mostrato segni d' insofferenza verso la raccolta di loro dati personali,
perfino durante l' emergenza Covid, quando i cellulari erano diventati veri e
propri lasciapassare (per stazioni, negozi, condomini), trasmettendo le
informazioni sanitarie degli utenti. In un Paese in cui due giganti - Tencent e
Alibaba - si dividono il business miliardario dei pagamenti elettronici, l'
Ufficio nazionale di statistica (Nbs) ha provato a rassicurare: i dati raccolti
verranno utilizzati solo per il censimento e rimarranno segreti. Sesso, età,
etnia, occupazione, reddito: miliardi di informazioni confluiranno nella
capitale Pechino dove verranno classificate ed elaborate dal Nbs, che avrà
bisogno di un paio d' anni per restituirci l' immagine aggiornata della Cina
della «Nuova era» proclamata dal presidente Xi Jinping. La tendenza è quella di
un Paese che invecchia, rapidamente, con gli ultra sessantenni che sono ormai il
18% della popolazione. E questo preoccupa la leadership del Partito: il timore è
che la Cina il cui reddito pro capite ha raggiunto 10.000 dollari annui -
diventi vecchia prima che ricca. Per questo c' è grande attesa per capire se,
dopo l' abolizione l' anno scorso della «politica del figlio unico», i cinesi
(400 milioni dei quali si sono trasformati da contadini e operai in ceto medio)
facciano di nuovo figli, confidando nella crescita dell' economia nazionale. Ora
che tutte le famiglie possono avere un secondo bebè senza incorrere in sanzioni,
arriverà il tanto atteso baby-boom? Pare proprio di no, dal momento che il tasso
di natalità registrato l' anno scorso è stato il più basso da quando Mao, il 1
ottobre 1949, si affacciò da Tienanmen annunciando la nascita della Repubblica
popolare. E il motivo è semplice: i cinesi oggi affrontano il continuo aumento
del costo della vita costruendo mini-famiglie. E così le stime del governo per
il 2020 sono di un incremento della popolazione del 5,99%, con i cinesi che
diventerebbero 1,43 miliardi. Anche se questo calcolo potrebbe rivelarsi
ottimistico e perciò Evergrande invita il governo a legalizzare anche il terzo
figlio: «Se non verranno apportati dei correttivi, ciò danneggerà seriamente il
ringiovanimento della Cina e la sua ascesa come grande potenza», avverte una
ricerca del colosso del settore immobiliare. Negli spazi consentiti dalla
censura, la gente comune chiede più assistenza. I servizi essenziali forniti
dallo Stato in Cina sono davvero essenziali, mentre tutto il resto si paga a
caro prezzo. Secondo i demografi, ci vorranno almeno quindici anni prima che la
politica del secondo figlio contribuisca a svecchiare la popolazione, perché le
donne ritardano il momento della gravidanza per far carriera e perché la classe
media cinese non vuole rinunciare al benessere raggiunto per un altro bebè.
La Cina, gli Uiguri e i campi di prigionia segreti.
Le Iene News il 15 dicembre 2020. Gli Uiguri sono una minoranza etnica turcofona
e di fede musulmana che vive in Cina: il governo di Pechino sembra aver usato la
sua forza militare e tecnologica per perseguitarli. Con l’aiuto di una ex
prigioniera e del portavoce di Amnesty International Italia, Riccardo Noury,
Roberta Rei ci fa conoscere cosa sembra accadere nei campi di prigionia segreti.
E perché questo ci riguarda da vicino. “Se non l’avessi visto, non ci avrei
creduto. Ma ho visto tutto, anche la morte”. Gli Uiguri sono una minoranza
etnica turcofona di fede musulmana che vive in Cina. Roberta Rei ci racconta la
storia di questo popolo, composto di milioni di persone, e di come la potenza
militare e tecnologica del governo di Pechino sembrerebbe esser stata usata
contro di loro per annientarli. Le più autorevoli organizzazioni che si occupano
di diritti umani pensano che gli Uiguri siano vittime del più grande
internamento di massa dalla Seconda guerra mondiale. Anche Papa Francesco ha
definito gli Uiguri “perseguitati”. Gli Uiguri sono circa 16 milioni, di cui 11
vivono nella regione dello Xinjiang, nel nord ovest della Cina. Dopo una lunga
storia di tensioni con il governo di Pechino, le cose sono precipitate con
l’avvento al potere del presidente Xi Jinping, anche a causa di una serie di
attentati terroristici compiuti da Uiguri. Da qui il governo cinese ha lanciato
un’offensiva durissima, che però non toccherebbe solo i terroristi ma tutto il
popolo degli Uiguri. “È parte della strategia cinese etichettare come terrorismo
tout-court una richiesta di diritti culturali”, ci dice Riccardo Noury,
portavoce di Amnesty International Italia. “Da qui questa politica di chiuderli
in luoghi eufemisticamente chiamati Centri per la formazione professionale
che sono campi di concentramento veri e propri”. Roberta Rei ci racconta cosa
sembra accadere in quei campi grazie a una testimone diretta. “Sono stata lì
dentro un anno, tre mesi e dieci giorni. Ho contato ogni singolo giorno”, ci
racconta la donna. “Lo stupro è all’ordine del giorno”, ci racconta una
testimone diretta di quanto avverrebbe in quei campi di prigionia. “Ho visto
donne impazzire. Andavano nei bagni, prendevano gli escrementi e si disegnavano
baffi e barba. Dicevano: ‘guarda, sono diventata un uomo’”.
Carlo Nicolato per “Libero Quotidiano” il 15 ottobre 2020. La
Repubblica Popolare Cinese, oltre a Cuba, la Russia e altri ameni Paesi che non
sono certo universalmente riconosciuti per le loro incontestabili tradizioni
democratiche, sono tra i nuovi membri eletti nel Consiglio dei diritti umani
dell'Onu dall'Assemblea Generale. Il nuovo mandato durerà tre anni e avrà inizio
dal primo gennaio del prossimo anno. Si noti che la Cina l'avrebbe spuntata in
un testa a testa agghiacciante sull'Arabia Saudita e che alla fine quest' ultima
è stata scartata in quanto ritenuta in un modo o nell'altro responsabile del
truculento assassinio del giornalista dissidente Jamal Khashoggi, fatto a pezzi
due anni fa nel consolato saudita di Istanbul. La Cina invece nel frattempo ha
fatto sparire qualche blogger e giornalista che denunciava la diffusione del
Coronavirus, ha internato centinaia di migliaia di uiguri, di tibetani e di
mongoli in campi di rieducazione, ma ancora una volta l'ha fatta franca e
dall'alto della sua secolare esperienza avrà il compito di vigilare sul rispetto
dei diritti umani degli altri Stati. Peraltro, come solo una settimana fa ha
denunciato l'associazione Chinese Human Right Defenders (Chrd), Pechino non ha
ancora risposto ad alcuna delle raccomandazione che la stessa Onu due anni fa
aveva avanzato nei suoi confronti proprio relativamente al rispetto dei diritti
umani. Ogni quattro anni infatti gli Stati membri vengono sottoposti a una sorta
di test di buona condotta chiamato "Esame periodico universale" del quale si
occupa appunto il Consiglio appena rieletto. Nel 2018 il Consiglio ha formulato
346 raccomandazioni per la Cina, cioè 346 punti sul quale Pechino avrebbe dovuto
rendere conto e migliorare. Nel marzo 2019 Xi Jinping ne ha accettate 284. Il
Chrd ha concentrato il suo esame su 47 raccomandazioni, le più importanti, che
il governo cinese ha dichiarato di aver "già attuato" e su altre 11 che
sarebbero in "in corso di attuazione", riguardanti in sostanza la situazione
delle donne, delle persone Lgbt, delle minoranze etniche e religiose e dei
gruppi emarginati e svantaggiati. L'indagine ha evidenziato al contrario che la
Cina non ha attuato alcuna delle 58 raccomandazioni prese in considerazione e
che in gruppi di cui sopra sono stati e sono tuttora sistematicamente
discriminati se non perseguitati. La situazione degli uiguri ad esempio è
peggiorata sostanzialmente con la costruzione di campi di detenzione e di
rieducazione. La stessa sorte spetta ai tibetani per i quali è in programma
perfino la ridistribuzione famigliare nelle altre province del Paese secondo un
quadro generale neomaoista di autoproduzione (autarchia) che verrà rilanciato
nel prossimo piano quinquennale. I diritti umani per Pechino sono dunque noiose
quisquilie, ma facendo parte ora dello stesso organo che dovrebbe controllarne
il rispetto avrà ora buon gioco a evitare che sull'argomento che la riguarda si
torni sopra. in brutta compagnia Per assurdo Louis Charbonneau, direttore di
Human Rights Watch per l'Onu, ha commentato il risultato delle votazioni per il
Consiglio sostenendo che «il fallimento dell'Arabia Saudita nel conquistare un
seggio nel Consiglio dei diritti umani è un gradito promemoria della necessità
di una maggiore concorrenza nelle elezioni delle Nazioni Unite» e che «se ci
fossero stati altri candidati, anche Cina, Cuba e Russia avrebbero potuto
perdere». Come dire che non c'erano alternative e che il Consiglio dei diritti
umani dell'Onu ha perso di conseguenza qualsiasi credibilità. Eppure l'Onu
rimane convinta che l'elezione «di questi Paesi immeritevoli non impedirà al
Consiglio di far luce sugli abusi e di parlare per le vittime», e che anzi,
«essendo nel consiglio, questi molestatori saranno direttamente sotto i
riflettori». Quali riflettori? Oltre a Cina, Russia e Cuba il Consiglio dei
diritti umani sarà composto da Costa d'Avorio, Gabon, Malawi, Senegal, Nepal,
Pakistan, Uzbekistan, Ucraina, Bolivia, Messico, Francia e Gran Bretagna. A
parte i due Paesi europei che già hanno qualche fatica ad accusare i cinesi per
i troppi interessi economici che li legano a loro, c'è da dubitare che gli altri
membri abbiano la forza, l'indipendenza e la limpidità necessaria per dire la
loro. Anzi, Pakistan e Uzbekistan sono costantemente sotto la lente di
ingrandimento per le continue violazione dei principi basilari di umanità e
almeno il 60% delle nazioni del Consiglio è composto da Paesi che non rispettano
gli standard minimi di una democrazia libera. E poi ci si stupisce se l'America
di Trump, tenendo presente anche il trattamento sistematicamente riservato a
Israele da tale Consiglio, lo abbia definitivamente abbandonato nel 2018.
Guido Santevecchi per il “Corriere della Sera” il 15 ottobre
2020. I Bts, idoli mondiali del K-pop sudcoreano, hanno molti record. Ultimo
quello del singolo Dynamite, visto 101 milioni di volte in 24 ore su YouTube. Ma
sono anche specializzati nel genere delle polemiche politiche a sfondo storico.
L' ultima riguarda la Guerra di Corea e li ha messi nei guai in Cina. La band
rischia di perdere contratti pubblicitari di aziende di Seul che temono Pechino.
È successo che durante l' ennesima premiazione a New York il leader del gruppo,
Kim Nam-joon, nome d' arte RM (che sta per Rap Monster), ha pensato di
commemorare i 70 anni della Guerra di Corea con un pensiero riconoscente per la
«storia di sofferenza comune» vissuta da Stati Uniti e Sud Corea durante il
conflitto che devastò la penisola coreana tra il 1950 e il 1953. «Non
dimenticheremo mai il sacrificio di tanti uomini e donne delle nostre due
nazioni», ha detto RM. La dichiarazione non è passata inosservata a Pechino,
dove i sette cantanti di Seul contano cinque milioni di seguaci su Weibo,
principale social network mandarino. Anche la Cina partecipò alla guerra e molti
si sono indignati per la mancanza di sensibilità dei Bts, accusandoli di essersi
schierati con gli americani, al momento piuttosto impopolari a Pechino. In rete
sono comparsi gli hashtag «I Bts hanno mancato di rispetto alla Cina» e «Non ci
sono idoli musicali che vengano prima della Patria». E commenti minacciosi: «I
BTS non debbono più guadagnare soldi cinesi, visto che non rispettano i
sentimenti del popolo cinese». Il problema è che nella Guerra di Corea
combatterono anche i cinesi, dalla parte dei nordcoreani che avevano invaso il
Sud. Mao inviò un corpo di «volontari» che si sacrificarono anch' essi, per tre
anni, salvando l' esercito e il regime nordista di Kim Il-sung dalla disfatta.
Quando nel 1953 fu firmato il cessate il fuoco a Panmunjom sul 38° Parallelo,
con gli eserciti inchiodati sulle stesse posizioni territoriali in cui i due
governi nemici erano attestati all' inizio, erano caduti 200 mila soldati del
Sud, 400 mila del Nord, 36 mila americani e 180 mila cinesi oltre a due milioni
di civili. A Pechino arrivano ancora oggi i resti dei morti in battaglia,
accolti da cerimonie che alimentano il nazionalismo. La superstar RM però ha
parlato solo del sangue versato da americani e sudisti ed è scoppiata la
polemica. «I BTS hanno ferito i sentimenti dei ragazzi cinesi», ha scritto il
Global Times , giornale comunista e fieramente nazionalista di Pechino. Nella
storiografia ufficiale cinese la campagna di Corea è definita «Guerra di
resistenza all' aggressione americana» e oggi che i rapporti con gli Stati Uniti
sono nuovamente deteriorati, la propaganda torna a parlarne per mobilitare l'
opinione pubblica. «I Bts negano la storia», conclude il quotidiano. È
intervenuto anche Zhao Lijian, combattivo portavoce del ministero degli Esteri
di Pechino: «Bisognerebbe imparare dalla storia e tener cara la pace per nutrire
l' amicizia tra i popoli». Il caso sta avendo ripercussioni commerciali: temendo
un danno d' immagine 0 un boicottaggio in Cina (ci sono diversi precedenti),
alcuni grossi marchi di Seul, da Samsung a Fila a Hyundai, hanno cancellato
dalla rete i loro spot pubblicitari con i Bts. Non è la prima volta che gli
idoli del K-pop finiscono in una crisi storica: nel 2018 uno membro della band
indossò una T-shirt celebrativa della liberazione della Corea dal giogo
giapponese alla fine della Seconda guerra mondiale nella quale era ben visibile
il fungo atomico che annientò Hiroshima e Nagasaki. La tv di Tokyo oscurò i Bts.
Coronavirus: ecco le responsabilità della Cina.
Milena Gabanelli e Luigi Offeddu su Dataroom de Il Corriere della Sera il 28
settembre 2020. È accaduto anche con la pandemia da Coronavirus: la Cina, dal
1945 membro del Consiglio di sicurezza dell’Onu con diritto di veto, tace o nega
da sempre quando le si chiede conto di come rispetta i diritti umani, in questo
caso la libertà di informazione. Stavolta però il suo silenzio viene pagato
anche da molti altri Paesi. Il South China Morning Post, storico quotidiano di
Hong Kong, riporta più volte informazioni da fonti governative: il primo
contagio del nuovo morbo è stato registrato in Cina il 17 novembre 2019.
L’informazione all’Oms dovrebbe essere immediata, ma le autorità attendono fino
al 31 dicembre prima di comunicare al corrispondente ufficio di Pechino una
«strana polmonite» sviluppatasi a Wuhan nel mercato di animali vivi. I «wet
market» erano già i principali indiziati del precedente Sars-Cov1 del 2002. Però
solo il 9 gennaio 2020 Pechino parla di «nuovo coronavirus» simile al precedente
Sars. Il 30 gennaio l’Oms dichiara l’emergenza internazionale. Nel frattempo il
business e il turismo mondiale va e viene dalla Cina come se nulla fosse. Solo
nel mese di dicembre e solo con l’Europa i voli sono 5.523 (dati Eurocontrol).
Secondo fonti dell’Enac – l’Ente nazionale italiano dell’aviazione civile – il
13 gennaio, mentre si prepara il lockdown di Wuhan, Pechino firma con l’Italia
(ignara) un memorandum d’intesa per un aumento fino a 164 voli settimanali per
parte, di cui 108 con decorrenza immediata. Poi c’è stato il blocco. Il prezzo
di quel mese e mezzo di silenzio è incalcolabile. La Cina nega ogni
responsabilità e reagisce alla perdita di credibilità aumentando la repressione
con lo schiacciamento della libertà a Hong Kong, con le nuove mire strategiche
nel Mar Cinese Meridionale, con il pugno sempre più pesante sulle minoranze
etniche, sulla libertà di espressione interna, con il gelo nei rapporti con la
chiesa cattolica, con arroganti minacce agli Stati sovrani.
La notte di Hong Kong. È stata tenuta segreta fino a poche ore
prima della pubblicazione, la notte del 30 giugno: settemila parole, 66
articoli. La nuova «legge sulla sicurezza» punisce con condanne fino
all’ergastolo ipotesi di reato come «secessione, sovversione, collusione con
Paesi stranieri per minacce alla sicurezza nazionale». Elaborata a Pechino, ha
posto fine a un anno e mezzo di proteste a Hong Kong, oggi regione
amministrativa speciale, ma con il patto Pechino-Londra di conservarne alcune
libertà civili fondamentali fino al 2047: «un solo Paese, due sistemi». Le
proteste erano iniziate perché la Cina pretendeva di processare nei tribunali di
Pechino gli imputati di presunti reati (anche politici) commessi a Hong Kong. La
pretesa è stata poi ritirata, ma intanto «Pechino – spiega una fonte – ha
approfittato della distrazione dell’Occidente causata dalla pandemia per varare
la legge sulla sicurezza nazionale». Così, rinviate di un anno le elezioni
previste per metà settembre (i sondaggi davano già al 60% l’opposizione
liberal), fuggiti in esilio i principali leader democratici, centinaia di
arresti solo nei primi giorni, in manette anche l’editore liberal Jimmy Lai, con
i due figli, ufficialmente per «collusione contro l’unità dello Stato cinese».
Dodici cittadini di Hong Kong sono invece stati arrestati nelle ultime
settimane, mentre cercavano di raggiungere Taiwan in barca. Londra ha offerto
«una nuova via di immigrazione» ai 3 milioni di cittadini residenti a Hong Kong
che nel 1997 scelsero, con l’accordo di Pechino, di conservare il loro
passaporto inglese. La risposta di Pechino: «non considero validi quei
passaporti».
Il nodo Taiwan. Dal gennaio 2021 Taiwan avrà un nuovo passaporto.
In copertina la parola «Repubblica di Cina» non si legge quasi più, al suo posto
«Taiwan». Un segno preoccupante per Pechino che ha sempre ammonito: se «quelli
dichiareranno l’indipendenza, attaccheremo militarmente». Perché Taiwan,
indipendente di fatto dal 1949, non è uno Stato indipendente di diritto, non
siede – per volontà di Pechino – nelle organizzazioni internazionali. Per la
Cina è una «entità ribelle», e solo 14 Stati la riconoscono diplomaticamente. Un
solo esempio: Pechino ha impedito che l’Oms invitasse al suo vertice annuale
2020 Taiwan come esempio di buona gestione sanitaria. E l’Oms ha obbedito. Non è
solo questione di orgoglio imperiale, ma soprattutto geostrategica, perché il
Mar Cinese Meridionale è al centro dei suoi piani di espansione: gremito di
isole artificiali cinesi, è una miniera sottomarina con 11 miliardi di barili di
petrolio e 190 trilioni di piedi cubi di gas naturale. Taiwan si è attrezzata:
tutti i suoi piani militari sono calibrati su un’ipotesi di invasione anfibia
proveniente dalla Cina, che a sua volta si è armata con tecnologia in grado di
distruggere e uccidere senza intervento umano.
Le esecuzioni. Secondo Amnesty International la Cina ha il
primato mondiale delle esecuzioni capitali, previste per 46 diversi reati,
inclusa la sovversione. Le esecuzioni sarebbero «migliaia all’anno», ma Pechino
dice che non esistono «statistiche separate», che il numero include gli
ergastoli e le pene oltre i 5 anni. In pratica le considera un segreto di Stato.
Solo nel 2014 l’Onu ha approvato 20 raccomandazioni contro la pena di morte,
tutte non vincolanti, lasciate cadere da Pechino come «inapplicabili e in
contrasto con la realtà cinese». Senza risposta anche le proteste del Consiglio
Onu per i diritti umani: anzi, nell’aprile 2020, proprio in quel Consiglio da
cui nel 2018 si è dimesso il rappresentante americano, la Cina, bocciata dalle
periodiche «revisioni» del Palazzo di Vetro in tema di libertà e giustizia, ha
ottenuto un suo seggio fino al 2021. Forse perché, sostiene il «Centro per una
Nuova Sicurezza Americana», sta riempiendo il vuoto lasciato da Trump nelle
organizzazioni internazionali, e perché ha appena promesso una donazione all’Onu
di 2 miliardi di dollari nell’arco dei prossimi due anni.
Repressione delle minoranze etnico-religiose. Il Tibet è una
regione autonoma, i suoi 3,1 milioni di abitanti sono quasi tutti buddisti, con
una loro lingua e una identità nazionale risalenti al 127 a.C. Hanno sempre
rivendicato l’indipendenza da Pechino e hanno pagato un prezzo: templi distrutti
e repressione sanguinosa. Il Dalai Lama, premio Nobel per la Pace, vive in
esilio nell’India del Nord, ha rinunciato a ogni potere temporale e alla linea
indipendentista. Chiede però ancora «compassione» e il rispetto dei diritti
umani. Nella regione autonoma occidentale dello Xinjiang vivono 23 milioni di
abitanti, il 47% sono musulmani uiguri. Inaccettabile per Pechino la loro
richiesta di libertà religiosa. Alla repressione violenta si alterna la
«rieducazione politica» o «formazione ideologica e civile» attraverso il lavoro
forzato. Lo scorso 1 settembre il World Uyghur Congress, in occasione della
visita a Berlino del ministro degli Esteri cinese Wang Yi, chiede aiuto al
governo tedesco: da 1 a 3 milioni di uiguri sono detenuti senza accuse nei campi
di «rieducazione», dove avvengono torture e sterilizzazioni forzate. La Germania
ha protestato più volte, anche se nello Xinjiang si trovano fabbriche tedesche
come la Volkswagen (a Urumqi), la Siemens, la Basf. I 4022 campi di rieducazione
sono stati formalmente aboliti nel 2013, ma un drone inglese ha catturato
immagini di un campo nello Xinjiang dove migliaia di persone produrrebbero
giocattoli, abiti, e merce a basso costo poi venduta in Occidente. Pechino l’ha
liquidata come propaganda trumpiana, ma non autorizza l’accesso agli ispettori
Onu chiesto nel 2019 da 22 Stati con una lettera del Consiglio per i diritti
umani. Dalla lettera mancava la firma americana, ritirata ormai da un anno.
Intanto gli uiguri emigrati in Europa, e ormai cittadini di Olanda o Finlandia,
quando denunciano il dramma dello Xinjiang vengono minacciati da agenti
cinesi: «Pensa alla tua famiglia». Nella Mongolia esterna, indipendente dal 1921
e popolata dagli eredi di Gengis Khan, da quest’anno l’insegnamento non avverrà
più nella lingua locale, ma sarà obbligatorio il mandarino.
Rapporti Cina-Vaticano. Oggi in Cina ci sono 10 milioni di
cristiani, 101 vescovi, 146 diocesi, 4000 preti, circa 4500 suore. È in scadenza
l’accordo provvisorio Pechino-Roma del 2018. Dovrebbe confermare che l’ultima
parola nell’ordinazione dei vescovi spetta al Papa. Un compromesso teorico,
insomma. Ma la situazione reale è ben diversa, sostengono proprio fonti
cattoliche: i patti non sono stati rispettati dal regime, le chiese sono
sbarrate e dominate dalla bandiera del partito, e chi aspira a essere assunto in
un ufficio governativo deve prima rinunciare a ogni fede religiosa. O meglio: lo
Stato proclama la libertà religiosa e riconosce ufficialmente 5 fedi, ma poi
spiega ai membri del partito che ogni culto è «anestesia spirituale»,
incompatibile con l’iscrizione al partito. Però la tessera di quel partito è
almeno nei fatti indispensabile per accedere agli impieghi pubblici. Intanto i
missionari italiani devono tornare a casa, incluso Bernardo Cervellera,
direttore di AsiaNews.
Le minacce agli Stati sovrani. Che succede alle voci
critiche? Cheng Lei, cittadina australiana di nascita cinese e nota conduttrice
di una Tv pubblica di Pechino, è finita agli arresti domiciliari in un luogo
sconosciuto, senza un’accusa esplicita. I leader di Tienanmen sono in esilio fra
Usa, Francia, Australia e anche Italia. Le minacce si estendono anche agli Stati
sovrani. «Con gli amici noi usiamo del buon vino, e i fucili con i nemici», ha
ringhiato l’ambasciatore cinese a Stoccolma quando il governo svedese ha
annunciato di voler premiare l’editore e scrittore Gui Minhai, svedese nato in
Cina, dove era stato condannato a 10 anni per presunto spionaggio. Durante il
suo tour europeo il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha fatto tappa il 3
settembre nella Repubblica Ceca, e rivolgendosi al Presidente del Senato Miloš
Vystrčil, che era appena stato in visita a Taiwan, ha dichiarato
testualmente «pagherete caro il vostro opportunismo politico». Il 31 agosto era
passato dalla Norvegia. Un giornalista aveva chiesto al ministro cosa pensasse
della possibilità di estendere «ai ragazzi di Hong Kong» il Nobel per la Pace.
Risposta: «la Norvegia non usi il Premio per interferire nei nostri affari
interni, pensi piuttosto a coltivare relazioni “sane” che si sono finalmente
realizzate dopo il “gelido inverno” seguito al Nobel conferito nel 2010 al
dissidente incarcerato Liu Xiaobo».
Il prezzo del silenzio. Quanto conta la libertà di parola in un
mondo sempre più interconnesso, che dovrà fare i conti con minacce sanitarie e
riscaldamento globale, e dove la Cina ha un ruolo centrale? Il giurista
dell’università di pechino He Weifang ha dichiarato: «l’assenza in Cina di
libertà di parola e di espressione ha favorito il diffondersi del contagio», lo
aveva ribadito un suo illustre collega, Xu Zhangrun, arrestato. Li Wenliang,
l’oculista cinese che per primo individuò il virus è stato prima fermato, poi
censurato, e infine ne fu vittima. Oggi nel mondo si contano quasi un milione di
morti, e una recessione globale. La Cina non si è scusata, ed esalta la
superiorità del modello cinese, che avrebbe gestire in modo straordinario la
pandemia, mentre i paesi democratici non sono in grado. Oggi dichiara di avere
solo 8 casi su 1,4 miliardi di abitanti. Impossibile sapere se quel numero sia
reale. Non c’è dubbio che Stati Uniti, Brasile, e qualche Paese europeo abbiano
sottovalutato, ma come sarebbero andate le cose se le autorità cinesi avessero
subito informato la comunità internazionale della gravità di ciò che stava
succedendo? Non lo sapremo mai, come non sapremo esattamente cosa è successo
perché l’inchiesta internazionale indipendente votata all’Oms all’unanimità a
maggio, è ancora un pezzo di carta.
La nuova campagna di “epurazione e rettifica” in Cina.
Alessandro Maran, Consulente aziendale, appassionato di
politica estera, su Il Riformista il 27 Agosto 2020. La Cina ha lanciato una
nuova campagna di “epurazione e rettifica” contro la corruzione. Come ha
riportato di recente il South Morning Post, le forze dell’ordine hanno
annunciato una campagna per epurare dalle proprie fila gli “elementi corrotti” e
creare un esercito inattaccabile. La campagna avrà inizio quest’anno con una
serie di progetti pilota in cinque città e quattro contee per poi proseguire a
livello nazionale nel 2021. Mentre la testata francese RFI paragona l’iniziativa
ad una purga stalinista nel partito, altri analisti avvertono l’eco del
“Movimento di rettifica” Yan’an, che 78 anni fa servì al consolidamento della
posizione di Mao Zedong (il primo febbraio 1942, nella famosa base rossa di
Yan’an, fu ufficialmente inaugurato il “zheng-feng”, traducibile come “movimento
per il raddrizzamento delle tendenze” o “campagna di rettificazione”, che durò
per due anni) e della lotta contro la corruzione (ed il repulisti) che ha
aiutato il presidente Xi Jinping a neutralizzare le minacce e a consolidare il
suo potere all’inizio del mandato. La pratica della rieducazione e del controllo
sistematico del comportamento segnano, si sa, tutta la storia della Cina
comunista. Su China Story, Ling Li ha scritto tuttavia che “l’ultima volta che
una campagna di rettificazione è stata organizzata dal vertice del partito,
prendendo di mira istituzioni giudiziarie (corti e procuratori, in particolare),
fu la campagna per la ‘riforma della giustizia’ dal 1952 al 1953 (che è durata
per sette mesi). Quella campagna fu lanciata per sradicare il ‘veleno’ della
prassi giudiziaria vigente sotto il governo nazionalista” che ha preceduto il
regime comunista cinese. Il nuovo sforzo, invece, “sembra focalizzarsi
maggiormente sulla cattiva condotta della polizia”. Del resto, “la polizia è
considerata l’apparato coercitivo più importante tra tutte le istituzioni
politiche e giudiziarie” e, perciò, la sua lealtà è cruciale per i leader del
partito. Sullo stesso sito, Adam Ni osserva che l’iniziativa la dice lunga sulla
concezione che Xi ha della leadership e su come pensa di evitare il destino
delle passate dinastie. In altre parole, Xi sembra pensare che, per mantenersi
in sella, il Partito comunista cinese abbia bisogno “di una vigilanza e di un
adattamento costanti”. Sebbene, come scrive Ni, la retorica totalitaria del
partito, il tentativo di controllare capillarmente la società in tutti gli
ambiti di vita, rischi di “portare la Cina in una direzione preoccupante”. Fatto
sta che Xi Jinping torna ad issare la bandiera della “questione morale”, che
resta il principale mezzo per legittimare e consolidare il suo potere. Del
resto, tutto il mondo è paese.
Tunnel e sottomarini nucleari nel Mar Cinese Meridionale.
Federico Giuliani il 21 agosto 2020 su Inside Over.
La Yulin Naval Base, situata nell’isola di Hainan, la più meridionale delle
province cinesi, rappresenta una base strategica fondamentale per le ambizioni
di Pechino. Il motivo è semplice: Hainan si trova a due passi dal Mar Cinese
Meridionale, un’area attraversata da molteplici tensioni nonché uno degli
scenari principali nel quale si sta giocando il braccio di ferro del secolo. Da
una parte troviamo il Dragone, ansioso di ristabilirsi al centro dell’Asia e,
indirettamente, desideroso di espandere la propria influenza nel mondo intero.
Dall’altra ecco gli Stati Uniti di Donald Trump che, in parte per le imminenti
elezioni presidenziali e in parte per bloccare l’avanzata cinese nella regione
indo-pacifica, ha alzato la temperatura delle acque asiatiche. Bombardieri che
sorvolano isole rivendicate, portaerei che sfilano in acque contese, armi
mostrate pubblicamente per lanciare un messaggio ai nemici: questa è l’aria che
si respira da mesi nel Mar Cinese Meridionale. L’ultima novità, in ordine di
tempo, arriva dalla Cina. La società americana di imaging Planet Labs ha
immortalato un’immagine satellitare più unica che rara, rilanciata sui social
da Radio Free Asia. Nella foto si vede quello che sembrerebbe essere
un sottomarino d’attacco cinese a propulsione nucleare Shang class/Type 093
entrare in un tunnel sotterraneo della base navale di Yulin.
Un’arma in più. È la prima volta che un sottomarino nucleare
cinese entra nel complesso di grotte sotterranee predisposto ad Hainan. Le foto,
tra l’altro, arrivano in un momento delicatissimo. A luglio le portaerei
americane USS Nimitz e USS Ronald Reagan si sono riunite assieme ai caccia F-18
e a un bombardiere B-52 per effettuare esercitazioni militari nella regione
contesa. La Cina ha quindi accusato gli Stati Uniti di aver deliberatamente
inviato le loro navi nel Mar Cinese Meridionale per “mostrare i muscoli” e
minare la stabilità dell’area. Fonti americane, citate dal Daily
Mail, sostengono che in questo momento Washington perderebbe una guerra
combattuta con la Cina nel Pacifico, non sarebbe in grado di difendere Taiwan da
un’ipotetica invasione e rischierebbe di veder evaporare perfino la propria base
a Guam. Una simulazione del Pentagono, inoltre, afferma che nel 2030, quando
Pechino potrà contare su nuovi sottomarini d’attacco, portaerei e
cacciatorpedinieri, il Dragone riuscirà a sopraffare le forze americane senza
troppe difficoltà. Al di là di proiezioni e previsioni, è indubbio quale sia la
strategia delle due superpotenze. La Cina si sta potenziando, facendo filtrare
di tanto in tanto i progressi raggiunti dal proprio esercito; gli Stati Uniti
puntano a risolvere la questione quanto prima, proprio per evitare di perdere
una partita che potrebbe protrarsi nel lungo periodo a vantaggio della
controparte cinese. I sottomarini nucleari, e l’idea che possano essercene
chissà quanti nascosti nelle profondità di Hainan, servono semplicemente a
spaventare gli Stati Uniti.
I tunnel sottomarini cinesi. Abbiamo parlato delle caverne
sotterranee situate nell’isola di Hainan. Secondo un rapporto del 2008 stilato
dalla Federation of American Scientists la struttura della grotta comprenderebbe
un canale lungo almeno quanto un sottomarino, varie sale per stoccare
attrezzature e altre sale per accogliere il personale. I tunnel di Yulin,
costruiti almeno 12 anni fa, non sono le uniche grotte sottomarine su cui può
contare la Cina. Altri tunnel sottomarini, ha scritto Forbes, si trovano
nella base navale di Jianggezhuang, vicino a Qingdao. Come se non bastasse
la base di Xiachuan Dao può contare su un piccolo tunnel appena dentro le mura
del porto. E anche un cantiere navale in cui vengono solitamente riparati
sottomarini e grandi navi da guerra, vicino alla base di Xiangshan, ha un
tunnel. Per capire come la Cina può utilizzare queste caverne è interessante
leggere la parole di Drew Thompson, un ex funzionario del Dipartimento della
Difesa Usa. “I cinesi hanno una straordinaria esperienza nella costruzione di
strutture sotterranee – ha affermato Thompson alla Cnn – È in linea con la loro
cultura strategica”. È attraverso questi complessi sistemi di grotte sotterranee
che il governo cinese nasconde gran parte del suo hardware militare, dai
sottomarini ai sistemi missilistici. Oggi Pechino vanta una flotta di
sottomarini in crescita, che sta migliorando in termini di qualità anno dopo
anno. Ebbene, il Dragone è in grado di proteggere tale flotta affidandosi a
strutture sotterranee, così da tenere le proprie armi lontane dalla vista di
occhi indiscreti. Per poi farle apparire quando nessuno se lo aspetta.
La resistenza dei tibetani e le amnesie dell'Occidente.
Negli anni '50 il Paese delle Nevi insorse contro l'invasore
cinese. Ma poi gli Usa scelsero la "politica del ping pong"...Rino Cammilleri,
Sabato 22/08/2020 su Il Giornale. Data l'attuale situazione e le liaisons
dangereuses tra il nostro governo e la Cina, non stupisce che siano passati
sotto silenzio i sessant'anni dell'insorgenza tibetana contro la Cina maoista.
Per la verità cadevano l'anno scorso, ma quest'anno, di anniversari, ce n'è un
altro che fa il paio: i 2500 anni della battaglia delle Termopili, in cui un
pugno di eroi si sacrificò contro un impero sterminato pur sapendo di essere
senza speranza. Quello tibetano fu, come le insorgenze antinapoleoniche, un
movimento di popolo del tutto spontaneo e altrettanto destinato alla sconfitta.
Ne parla un recentissimo libro di Gianluca Frinchillucci e Laura Bacalini, Il
Dorje e la Spada. La resistenza armata tibetana contro l'invasione cinese
(1950-1974) edito da Il Cerchio (pagg. 84, euro 18). Quando tutto iniziò, il
Dalai Lama, Tenzin Gyatso, era già scappato a Dharamsala, nel nord dell'India,
inizialmente accolto con imbarazzo dal premier indiano, il Pandit Nehru, nello
stato dell'Himachal Pradesh, dove ancora risiede il governo tibetano in esilio.
L'invasione del Tibet era stata annunciata da Mao Zedong già nel 1949, appena
sconfitto il rivale nazionalista Chang Kaishek e praticamente all'atto
dell'insediamento al potere. Bisognava liberare il Paese delle Nevi dalle
«influenze imperialiste occidentali», secondo un frasario tipicamente comunista
(nelle guerre precedenti si invadeva e basta, ma con i giacobini si cominciò a
ricorrere a quelle ipocrisie retoriche che da allora non ci hanno più
abbandonato, dall'«intervento fraterno» all'«esportazione della democrazia»).
Così, nell'ottobre 1950 l'immensa armata «popolare» si mosse verso il Tetto del
Mondo. Tutte le «influenze imperialiste occidentali» in Tibet erano
rappresentate da tre (tre!) uomini: uno era il telegrafista Robert Ford, unico
ingi (cioè inglese) regolarmente assunto dal governo tibetano; gli altri due li
abbiamo visti al cinema, erano gli alpinisti austriaci Heinrich Harrer (l'autore
di Sette anni in Tibet) e Peter Aufschnaiter, scappati da un campo di
concentramento inglese in India e arrivati, dopo mille avventure, a Lhasa. La
capitale, Lhasa appunto, fu aggirata dai cinesi, che preferirono penetrare in
Tibet da vari punti. Uno di questi era la fortezza di Chamdo, nel distretto di
Kham, che conservava il più importante deposito di armi del Paese. Il
governatore Ngapo Ngawang Jigme, vista l'impossibilità di resistere, si arrese
senza neppure combattere, limitandosi a far saltare in aria il deposito. Ma così
il popolo si ritrovò disarmato, e la successiva resistenza dovette procurarsi i
pochi residuati bellici che riuscì a racimolare oltre confine. Nel 1951 Ngapo
fece parte della delegazione che, praticamente deportata a Pechino, fu costretta
a firmare l'«Accordo dei diciassette punti», che i cinesi puntualmente non
rispettarono. Cominciarono le angherie, gli espropri forzati, le uccisioni anche
per futili motivi, le razzie per approvvigionare gli occupanti, le distruzioni
di monasteri da parte dei nuovi padroni atei. Non solo. Anche il Tibet conobbe
le riforme agrarie maoiste e semplicemente folli che provocarono carestie e
relativi morti per fame a migliaia. Nel 1956 il generale tibetano Andrung Gompo
Tashi radunò un esercito di volontari, detto Chushi Gangdruk (letteralmente:
Quattro Fiumi e Sei Montagne), con tanto di bandiera (spade con il Dorje,
simbolo di energia pura, come elsa). Seimila irregolari armati alla men peggio
intrapresero una guerriglia contro gli occupanti scendendo dai loro nascondigli
in montagna e attaccando gli avamposti militari cinesi. La popolazione li
appoggiava e aiutava in ogni modo. Ma anche i tibetani avevano i loro
collaborazionisti, compensati, paradossalmente, dai cinesi che non sopportavano
Mao. Uno di questi fu l'ufficiale di artiglieria Chang Hoter che addirittura
passò con i partigiani. L'americana Cia inizialmente aiutò la resistenza, ma la
abbandonò al suo destino quando Nixon e Kissinger aprirono alla Cina con la
«politica del ping-pong». Nel 1959 i cinesi decisero di prendere il Dalai Lama e
portarlo a Pechino. Questi, travestito, scappò in India seguito da 150mila
tibetani che non intendevano lasciare il loro dio-re. Nel 1974, Sua Santità
Gyatso ordinò la «Via di Mezzo», cioè la politica di non-violenza contro la
Cina. E fu a quel punto che i rivoltosi deposero le armi, sia per obbedienza che
per impossibilità, a quelle condizioni, di proseguire la lotta. Furono in molti
allora, tra i tibetani, a scegliere il suicidio.
Come funziona il Partito comunista cinese.
Federico Giuliani il 9 agosto 2020 su Inside Over. Il Partito
comunista cinese può contare su 91 milioni di iscritti. È il cardine principale
attorno al quale ruota il potere politico cinese. In cima al vertice del Pcc c’è
Xi Jinping, segretario del partito è presidente della Cina. Molti liquidano il
modello decisionale cinese definendolo nei modi più disparati, anche se da un
punto di vista accademico le dinamiche di potere sono molto più complesse. Non è
corretto pensare che il Paese sia governato dal solo Xi, così come è fuorviante
considerare il Pcc un blocco granitico privo di divisioni interne. Innanzitutto
partiamo dalla cima della piramide. Il signor Xi è senza ombra di dubbio l’uomo
più potente della Cina, anche se le sue decisioni devono spesso essere condivise
con altre personalità di spicco. Facciamo un passo indietro, per capire come si
muove il potere di Xi e il meccanismo che regola il partito unico cinese. Ai
tempi di Deng Xiaoping, per evitare che un uomo solo al comando potesse
posizionarsi al di sopra del partito, come capitato con Mao Zedong, si decise di
fare affidamento alla cosiddetta “democrazia interna al partito“. Si tratta di
una perifrasi per descrivere un aspetto di primaria importanza. I membri del
gruppo decisionale del Pcc formano una macchina organica. Ognuno occupa una
posizione, un ruolo, un compito, e tutti sono indispensabili al suo
funzionamento. Chi sta al vertice della catena di comando è ovviamente
circondato dal prestigio, anche se non può violare le regole del partito.
Il cuore del Partito. Dicevamo del vertice: questa posizione è
occupata da Xi Jinping. Il cuore del partito coincide tuttavia con il Comitato
Permanente dell’Ufficio Politico del Pcc. Al suo interno risiedono sette membri,
ovvero i più importanti esponenti del Partito, dello Stato e del potere militare
cinese. Oltre all’immancabile Xi, troviamo il primo ministro Li Keqiang e altri
cinque membri eletti dal Comitato Centrale durante il 19esimo congresso del Pcc
risalente all’ottobre 2017. Si tratta di Wang Yang, Han Zheng, Zhao Leji, Wang
Huining e Li Zhanshi. Tutti questi personaggi, compreso Xi, hanno avuto il loro
bel da fare prima di ricoprire le attuali posizioni. I membri che occupano le
posizioni di vertice, infatti, vengono selezionati attraverso una ferrea
selezione meritocratica. Tale selezione è spiegata nel dettaglio da Daniel Bell
nel suo fondamentale libro Il modello Cina. Meritocrazia politica e limiti della
democrazia. “In Cina il principale ideale politico – ha scritto lo studioso –
condiviso da funzionari di governo, riformatori, intellettuali e persone in
genere è quel che io definisco meritocrazia verticale, intendendo una democrazia
ai livelli inferiori di governo e un sistema politico che diventa
progressivamente più meritocratico ai livelli più alti”. Detto altrimenti, dopo
un periodo caotico, coinciso con il dramma rappresentato dalla Rivoluzione
culturale, la Cina sarebbe arrivata ad adottare un governo i cui vertici sono
funzionari scelti per meriti. Da questo punto di vista l’élite del Partito è
composta da attori che hanno meriti verificabili, tanto in ambito accademico
(titoli di studio) quanto sul campo (esperienze governative pregresse).
Come si entra nel Partito. Nel 1921, anno di fondazione del Pcc,
il partito era formato da poche decine di intellettuali marxisti. Oggi lo
scenario è completamente cambiato, visto che al suo interno troviamo anche
imprenditori e altre personalità pubbliche di rilievo. Come ha sottolineato in
un approfondimento il think tank Marco Polo, quando il presidente della Cina era
Hu Jintao i membri del partito sono cresciuti con una media del 2,4% all’anno,
passando dai 68,2 milioni del 2002 agli 85,1 milioni del 2012. Durante il primo
mandato di Xi, questo trend si è interrotto e la crescita media è scesa
drasticamente intorno all’1% (addirittura la crescita è stata di appena lo 0,1%
nel 2017). La scelta dell’attuale presidente cinese ha una spiegazione molto
semplice: Xi Jinping non voleva (e non vuole) avere a che fare con gli
“opportunisti”. Chi entrava nel partito, insomma, non doveva farlo per ottenere
vantaggi. Calcolatrice alla mano, il 6,6% della popolazione cinese fa parte del
Pcc. I suoi membri, adesso, devono dedicare diverso tempo allo studio e alle
riunioni, durante le quali vengono affinati i temi e le battaglie da portare
avanti. Ma come si entra nel Partito Comunista cinese? A differenza del passato,
oggi conta la qualità del singolo. Xi ha pensato di rendere la selezione
d’ingresso più dura così da poter contare solo su profili di un certo spessore.
In ogni caso, aderire al Pcc, almeno sulla carta, è facilissimo: ogni cinese che
abbia raggiunto i 18 anni può fare domanda per entrare nell’unità del Partito
della propria località di residenza o del proprio datore di lavoro. Il difficile
sta nell’essere accettati. Il processo di selezione è estremamente arduo. I
candidati devono superare una serie di test, tenere colloqui, essere sottoposti
a indagini, ricevere voti ed effettuare prove sul campo per un periodo compreso
tra i 2 e i 3 anni. Soltanto a quel punto, forse, potrà scattare il semaforo
verde.
Benvenuti a Luoshui: il “Regno delle donne” Mosuo.
Federico Giuliani il 4 agosto 2020 su Inside Over. La temperatura
annuale media oscilla intorno ai 15 gradi. La vegetazione è fitta. Le montagne
dominano il paesaggio incontaminato. A quasi 3mila chilometri di distanza da
Pechino, cuore della superpotenza cinese, sorge la provincia dello Yunnan. Siamo
nell’estremo sud-ovest della Cina, in un’area che collega la Repubblica Popolare
a Birmania, Laos e Vietnam. In una superficie che si estende per circa 394mila
chilometri quadrati, ovvero un’area maggiore dell’Italia, vivono 50 milioni di
abitanti e ben 25 minoranze etniche, molte delle quali suddivise in comunità
tribali. Dimenticatevi i palazzoni scintillanti di Shanghai, le Mercedes che
sfrecciano attorno agli anelli che circondano la Città Proibita e le esclusive
boutique di Calvin Klein e Dior.
La patria dei Mosuo. Lo Yunnan è considerato uno degli ultimi
baluardi della Cina rurale, la “vera Cina“, il volto del Paese ancorato alle
vecchie tradizioni millenarie, e che vive a contatto con la natura. Da un punto
di vista turistico la zona è ricca di attrazioni. Dai campi di riso terrazzati
costruiti 1300 anni fa dalla minoranza etnica degli Hani, nella contea
Yuanyiang, alla particolare architettura di Lijiang, una città-prefettura
abitata dai Naxi, altra minoranza etnica locale. E ancora: le pagode di Dali, la
foresta di pietra Shilin, il Monte del Drago di Giada, il capoluogo della
provincia Kumming e tanti altri villaggi remoti. Eppure, sperduta tra queste
valli, vive ancora oggi un’etnia unica nel suo genere. A Luoshui, proprio di
fronte al Lugu Lake, un lago di montagna tra i più grandi di tutta l’Asia,
vivono i Mosuo, una minoranza formata da circa 40mila persone. La loro storia è
avvolta nel mistero, tra leggende e racconti tramandati di generazione in
generazione in forma orale. Gli antropologi hanno il loro bel da fare. Secondo
il governo cinese i Mosuo sono una ramificazione dell’etnia tibetana Naxi, anche
se lingua (un dialetto locale), credenze (per lo più buddismo) e cultura
(struttura familiare sui generis) mettono in discussione quanto sostenuto da
Pechino.
Il matrimonio ambulante. In ogni caso la più grande particolarità
sociale dei Mosuo è quella di basarsi su strutture matriarcali che non prevedono
il matrimonio o analoghe forme di unione. Molti viaggiatori hanno raccontato nei
loro scritti di essersi ritrovati davanti a una comunità semi tribale che parla
al femminile. Dove la responsabilità della stabilità familiare spetta alle
donne, l’eredità si trasferisce di madre in figlia e gli uomini hanno ben poca
voce in capitolo, anche in ambito economico. Non solo: il matrimonio
tradizionale, cioè il rapporto di convivenza tra uomini e donne, è sostituito
dal cosiddetto walking marriage, traducibile in italiano con il termine
di matrimonio ambulante (in cinese zouhun). Alcuni parlano di libero amore,
altri di relazioni senza impegno, rigorosamente portate avanti dal gentil sesso.
In realtà tale pratica sociale è molto più complessa di quanto non si possa
pensare. Uomini e donne si incontrano di notte, senza diventare “mariti” o
“mogli”. I figli, di fatto, crescono senza padre. Quindi, così come il concetto
di matrimonio è inconcepibile, anche la figura paterna è sostanzialmente
inutile. Choo Waihong, autrice del libro The Kingdom of Women, ha sottolineato
un aspetto fondamentale della cultura Mosuo. “Per loro – ha dichiarato – il
matrimonio è un concetto inconcepibile e un bambino è senza padre semplicemente
perché la società non presta attenzione alla paternità. La famiglia nucleare per
come la comprendiamo esiste, solo in una forma diversa”.
Il ruolo della donna. Il motivo è semplice: la società dei Mosuo
non presta attenzione al padre. Il Guardian ha usato queste parole per
illustrare uno scenario inedito al mondo: “I Mosuo non hanno adottato né il
matrimonio né la monogamia. Le donne sono libere di scegliere gli amanti, e i
bambini che ne risultano sono allevati nelle case di famiglia guidate dalla
donna più anziana. Inclusi nella famiglia troviamo i suoi fratelli, le sue
figlie e i loro figli. Non ci sono i padri dei bambini, che vivono con le
proprie madri”. E ancora: “Le donne sono trattate in modo uguale, se non
superiore, agli uomini. Entrambi hanno il maggior numero di partner sessuali che
desiderano, liberi da qualsiasi giudizio. Le famiglie allargate allevano i
bambini e si prendono cura degli anziani”. Tutto il peso familiare, come detto,
è spostato sulla donna, alla quale spettano i compiti più importanti. Le coppie,
se così possono essere definite, non vivono mai insieme. Si riuniscono soltanto
per il piacere di una reciproca compagnia. Scendendo nel dettaglio, in un
matrimonio ambulante entrambi i partner vivono sotto il tetto della loro
famiglia allargata durante il giorno; di notte, invece, l’uomo visita e
soggiorna fino all’alba presso la casa delle donne. Certo, questo può avvenire
soltanto nel caso in cui riceva il permesso di farlo. L’antropologo Chuan Kang
Shih ha spiegato che quando una donna Mosuo (o un uomo) esprime interesse per un
potenziale partner, “è la donna che può dare l’uomo il permesso di farle
visita”. Qualora dovesse nascere un bambino, il padre non ha alcun obbligo
morale, culturale o giuridico di prendersene cura. Il pargolo sarà invece
allevato dalla famiglia allargata della donna.
L’ultimo matriarcato? Come può essere definita una società del
genere? Difficile dirlo con certezza. Il tema è tutt’ora dibattuto. A differenza
di un matriarcato, ovvero un’organizzazione in cui l’autorità è detenuta da una
matriarca, nella comunità Mosuo il potere politico è in effetti nelle mani degli
uomini. I maschi, pur ricoprendo un ruolo di contorno, si occupano inoltre di
pesca, allevamento del bestiame e costruiscono case. È per questo che certi
studiosi preferiscono definire quella dei Mosuo una “cultura matrilineare”. Di
tutt’altro spessore, invece, la carica ricoperta dalle donne, che gestiscono
l’economia familiare. Non sappiamo quale sia l’origine di un simile stile di
vita, anche se viene narrato che nella notte dei tempi, migliaia e migliaia di
anni fa, una aristocrazia patriarcale scelse di imporre alla popolazione locale
il matriarcato con l’obiettivo di mantenere la propria discendenza pura da ogni
possibile contaminazione esterna. Questa pratica ha resistito a secoli di
cambiamenti. Benvenuti, dunque, nella comunità cui regna il gentil sesso, il
matrimonio è solo un lontano retaggio occidentale e tutto ruota attorno alla
linea di sangue materna. Benvenuti nel Regno delle donne.
La Cina, gli uiguri e la missione del cristiano-rinato.
Piccole Note il 3 luglio 2020 su Il Giornale. La controversia
Cina – Stati Uniti (e Gran Bretagna) si infiamma dopo la ratifica della legge
sulla Sicurezza nazionale a Hong Kong. Secondo Stati Uniti e Gran Bretagna, che
hanno emanato sanzioni, chiude la parentesi libertaria dell’isola. L’iniziativa
di Pechino mira a chiudere spazi di manovra ai suoi antagonisti esterni, che in
quest’ultimo anno hanno supportato in vario modo i moti di secessione
dell’isola, che hanno disastrato l’hub finanziario della Cina. La mossa della
Cina era inevitabile: non poteva sostenere una nuova ondata di manifestazioni,
non con la guerra alzo zero iniziata da Washington, decisa a ridimensionare
drasticamente il suo competitor globale, cui si è aggiunto il nuovo fronte
indiano, aperto da uno scontro su un tratto di frontiera contesa tra Pechino e
New Delhi. Non è andata come speravano gli antagonisti della Cina: Hong Kong non
ha visto una nuova Tienanmen, che avrebbe devastato l’immagine internazionale
del Dragone per sempre, ma comunque l’introduzione di una legge sulla Sicurezza
nazionale può essere egualmente usata per alimentare la narrativa sul regime
repressivo cinese.
La fine della guerra dell’oppio. “Hong Kong è tornata a essere
una colonia”, titola The Atlantic. In realtà è tornata alla madrepatria cinese,
dalla quale fu strappata grazie alla vittoria della guerra dell’Oppio, mossa da
Londra per liberalizzare il narcotraffico nel Celeste impero, che Pechino voleva
impedire (peccato che nessun critico della Cina ricordi mai tale
particolare, non secondario). Detto questo, si resta interdetti dallo scandalo
sollevato da una legge volta a tutelare la Sicurezza nazionale, che esiste in
tutte le nazioni del mondo. Certo, ha un intento politico, e quindi può destare
sospetti, ma resta che se Washington e Londra avessero evitato di supportare,
con mezzi e soldi, le proteste di stampo secessionista, non si sarebbe arrivati
a ciò. Tant’è. Alle sanzioni Usa si è unita la Gran Bretagna, che non si
rassegna a perdere la sua colonia, che ha lanciato un’iniziativa irrituale: ha
offerto la propria cittadinanza alla popolazione di Hong Kong, conferendogli
così diritti negati in epoca coloniale (finita nel 1997!), durante la quale non
avevano voce in capitolo sulla gestione della loro terra, affidata a un
Governatore nominato da Londra. Per la Cina è una sfida,, dato che ciò sarebbe
causa di conflittualità. Piccolo esempio: un movimento secessionista di
nazionalità britannica avrebbe difese, legali e non, molto forti che potrebbero
metterlo al riparo dalla legge sulla Sicurezza nazionale…Insomma, la contesa su
Hong Kong continua, ma per ora su un livello diplomatico, mentre le speranze
riposte nella rivoluzione colorata sono svaporate. Per questo gli antagonisti
della Cina hanno riacceso un fronte che negli ultimi tempi era andato in secondo
piano: lo Xinjiang, una regione molto estesa della Cina occidentale, abitata per
lo più da islamici, che Washington sostiene siano vessati in varie maniere.
Le scoperte del cristiano rinato. Ad accendere di nuovo le
polveri un dossier di Adrian Zenz, nel quale sarebbero documentate varie
nefandezze del regime, accusato più o meno di genocidio. Pechino ha respinto le
accuse, accusando di nefandezze il relatore, che non è certo un osservatore
oggettivo, essendo membro dell’Heritage Foundation, un Think Tank conservatore
molto influente sulla politica estera Usa. Peraltro, Zenz è uno specialista di
irredentismo anti-cinese, come evidenzia un suo studio del 2018 per l’Heritage
Foundation, dal titolo: “Gli Stati Uniti dovrebbero continuare a promuovere la
libertà per i tibetani“, stavolta sui diritti negati ai tibetani che vivono nel
Celeste impero. Teologo evangelico tedesco nonché antropologo, Zenz collabora
con varie Università in Germania e negli Usa e si
dichiara cristiano-rinato (genia cristianista diventata famosa grazie
all’adesione di George W. Bush, The Guardian). “Guidato da Dio”, come spiega lui
stesso, la sua missione è combattere il comunismo, da cui l’adesione alla
Victims of Communism Memorial Foundation. Secondo il al Wall Street Journal,
l’uomo, “stando alla sua scrivania” e “cercando ostinatamente i dati negli
angoli oscuri dell’internet cinese” ha scoperto quel che era sfuggito a tutti…
chissà quali angoli ha visto. Di angolature, su internet ce ne sono tante, reali
e virtuali.
L’estremismo nello Xinjiang. Per inciso, in Germania, a Monaco, è
basato anche il Word Uighur Congress, che identifica lo Xinjinag come Turkestan
orientale e chiede la fine dell’occupazione cinese della terra uigura.
L’organismo, recita Wikipedia, è stato fondato anche grazie al National
Endowment for Democracy, ong legata al Dipartimento di Stato Usa che ha
supportato le manifestazioni di Hong Kong. C’è del bizzarro in tutto ciò. Non
che lo Xinjiang sia un paradiso di libertà: Pechino è retto da un governo
comunista e soprattutto teme l’irredentismo della regione, che non può
permettersi di perdere, dato è parte considerevole del suo territorio nazionale
(da qui l’interesse dei suoi antagonisti che, se riuscissero, disintegrerebbero
la Cina). Pechino esercita un controllo stretto sull’area, soprattutto per via
dell’irredentismo, che ha messo a segno anche colpi a sorpresa, come il
bombardamento di una stazione ferroviaria dopo una visita di Xi Jinping nella
regione. Non solo, lo Xinjiang ha dato migliaia di militanti all’Isis (Reuters),
che in un video ha anche dichiarato guerra a Pechino (Foreign Policy). Insomma,
per Pechino l’attenzione nell’area è d’obbligo. Per il resto è guerra aperta,
anche di opposte narrative.
Niente figli per i musulmani, così la Cina controlla gli
uiguri. Pubblicato giovedì, 02 luglio 2020 da La
Repubblica.it. Nei rapporti sempre più tesi tra Cina e Stati Uniti potrebbe
aprirsi un nuovo fronte, lo Xinjiang. Secondo fonti a conoscenza del dossier,
citate da Bloomberg, il governo americano sarebbe pronto a varare delle sanzioni
contro i funzionari cinesi responsabili della violazione dei diritti umani ai
danni della minoranza musulmana della provincia occidentale della Cina,
sottoposta da mesi a una campagna di rieducazione forzata sotto le apparenze di
lotta al terrorismo. Finora Donald Trump, per cui la difesa dei diritti umani
(nello Xinjiang come a Hong Kong) non è una priorità, ha sempre rimandato
l'entrata in vigore delle sanzioni, per timore che potessero compromettere
l'accordo commerciale siglato con Pechino. La scorsa settimana però il
presidente ha firmato una legge bipartisan approvata dal parlamento Usa che lo
impegna a punire i funzionari della Repubblica Popolare protagonisti
dell'oppressione delle minoranze. E considerate le tensioni crescenti con
Pechino, ulteriormente accentuate dalla stretta su Hong Kong, il presidente
potrebbe decidere di passare ai fatti. La Cina ha sempre respinto al mittente le
accuse sullo Xinjiang, sostenendo che i campi per le minoranze, di cui
all'inizio negava l'esistenza, sono centri di formazione professionale e che la
sua campagna contro il terrorismo, volontaria, sta avendo successo. In passato
frange estremiste e indipendentiste della minoranza uigura hanno compiuto
attentati, contro la polizia ma anche contro i civili. La narrativa di Pechino
però è difficile da conciliare con le informazioni che filtrano dalla provincia,
nonostante la cortina informativa creatale attorno. Giovedì mattina le autorità
americane hanno sequestrato un carico di extension per capelli che si sospetta
siano state prodotte nei centri di lavoro dello Xinjiang, dove molti musulmani
vengono mandati per essere "formati". Il governo Usa aveva già messo in guardia
le società americane rispetto al rischio che dei fornitori cinesi potessero fare
uso di lavoro forzato. Ma ancora più inquietanti sono le rivelazioni di uno
studio condotto su documenti ufficiali del regime e con interviste a donne
uigure da Adrian Zenz, ricercatore indipendente considerato uno dei massimi
esperti di Xinjiang. La sua ricerca ricostruisce una strategia di limitazione
delle nascite messa in atto dalle autorità comuniste nei confronti della
minoranza musulmana. In alcune contee dove la presenza degli uiguri è massiccia
risultano centinaia di interventi di aborto o di installazione di dispositivi
contraccettivi, imposti attraverso pressioni e minacce anche alle donne che non
avevano superato il numero massimo di due figli previsto dalla legge cinese. Il
tasso di natalità, tra i più alti del Paese, negli ultimi anni è crollato in
maniera drammatica. Un portavoce del governo cinese ha definito le accuse "prive
di fondamento". Diverse organizzazioni per i diritti umani e alcuni esperti
delle Nazioni Unite hanno condannato le violazioni dei diritti della minoranza
musulmana. L'architetto della campagna di stabilizzazione dello Xinjiang è Chen
Quanguo, segretario del partito locale e membro del Politburo comunista, già
protagonista della "normalizzazione" del Tibet. Potrebbe essere lui il primo
bersaglio delle sanzioni della Casa Bianca. Sempre che Trump decida davvero di
aprire anche questo fronte con la Cina.
CINA, DONNE UIGURE STERILIZZATE A
FORZA: COSÌ PECHINO CANCELLA UN POPOLO. Carlo Pizzati
per “la Stampa” il 2 luglio 2020. Due indagini rivelano che negli ultimi due
anni il governo cinese ha ingaggiato una radicale campagna di sterilizzazione
tra le donne della minoranza islamica degli uiguri che vivono nella regione
occidentale dello Xinjiang. I dati emersi sono raccapriccianti e sarebbero in
violazione della Convenzione Onu per la prevenzione e punizione dei crimini di
genocidio che proibisce di «imporre misure che intendono prevenire le nascite di
un gruppo specifico». Immediata la condanna della delegazione del Parlamento
europeo per le relazioni con la Repubblica popolare cinese che ricorda la
condanna della detenzioni di massa degli uiguri nei «campi di rieducazione»
politici. «Un’atrocità senza precedenti, potremmo assistere all’attuazione di un
genocidio». Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha definito queste
rivelazioni «scioccanti e inquietanti». Secondo i dati raccolti dalla Associated
Press e dal ricercatore Adrian Zenz della Fondazione americana Vittime del
Comunismo, la fase di repressione degli uiguri in atto dal 2017 assume una
chiave di lettura grottesca. A finire nei campi di rieducazione sono stati prima
i capifamiglia della minoranza musulmana cinese, accusati di avere avuto troppi
figli. Molti sono stati condannati a un anno di prigionia per ogni figlio, come
nel caso del fruttivendolo Abdushukur Umar che, avendo sette figli, resterà in
prigione per sette anni. A portare l’accusa da genocidio culturale al livello
del genocidio demografico è il fatto che mentre un milione di uiguri finivano
nei campi di concentramento «per assicurarsi che non diventassero estremisti
religiosi», la polizia radunava donne incinte per farle abortire, donne da
sterilizzare e figli non autorizzati dalla legge del «figlio unico», in realtà
già abolita nel 2016. La strategia è delineata negli obiettivi di performance
governativi per lo Xinjiang. «Provincia di Hotan: applicare la spirale a 524
donne e sterilizzarne 14.872. Provincia di Guma, inserire 5970 spirali e
sterilizzare 8.064 donne». L’intento è di bloccare le nascite dal 14 al 34 % tra
donne uigure dai 18 ai 49 anni. Si parla di più sterilizzazioni pro capite di
quante la Cina abbia fatto in tutto il Paese dal 1998 al 2018. A parte gli
aborti obbligatori, i metodi sono iniezioni sterilizzanti, inserimento forzato
della spirale e la sterilizzazione chirurgica. Dal 2015 al 2018 la crescita
naturale della popolazione uigura nelle province di Kashgar e di Hotan è
crollata dell’80 %. Nel 2019 si è ottenuto un ulteriore calo del 24%, in alcune
zone arrivando a meno 30 e meno 56%. Nel 2018, l’80 % delle spirali di tutta la
Cina sono state applicate nello Xinjiang, dove vive appena l’1,8 % della
popolazione nazionale. Nel 2020, in questa regione, sono state fatte sette volte
più sterilizzazioni pro capite della media nazionale. Il motivo? Come ha scritto
Li Xiaoxia dell’Istituto di Sociologia dello Xinjiang: «La popolazione uigura è
pericolosa poiché indebolisce l’identità nazionale e l’identificazione con la
Nazione-Razza cinese, con impatto a lungo termine destabilizzante». Nel
frattempo, invece, l’influsso di operai e coloni han, la maggioranza in Cina, è
aumentato con l’incentivo, per ogni capofamiglia han sotto i 35 anni, di campi
da coltivare, un appartamento nuovo, posto fisso da statale con stipendio di 12
mila euro superiore alla media nazionale. Mentre gli han, in alcune province,
per fare più figli ricevono esenzioni fiscali, sussidi per i matrimoni e per i
parti, le donne uigure vengono costrette a cantare in coro queste parole,
durante gli alza-bandiera obbligatori: «Se abbiamo troppi figli, siamo
estremiste religiose e così finiamo nei campi di rieducazione».
Da rainews.it l'1 luglio 2020. I funzionari della dogana di New
York hanno dichiarato di aver sequestrato una spedizione di 13 tonnellate di
prodotti per capelli per un valore stimato di 800.000 dollari. "La produzione di
questi beni costituisce un grave problema di diritti umani e questo sequestro ha
lo scopo di inviare un messaggio chiaro e diretto a tutti coloro che cercano di
fare affari negli Stati Uniti che pratiche illecite e disumane non saranno
tollerate nelle catene di approvvigionamento delle merci." Sono parole di Brenda
Smith, vice commissario dell'Ufficio del Commercio del CBP (Customs and Border
Protection), l'autorità doganale Usa. È la seconda volta quest'anno che il CBP
ha eseguito un ordine di sequestro su una spedizione di articoli per capelli
provenienti dalla Cina, sulla base dei sospetti che vengano prodotti in
violazioni dei diritti umani. I sequestri servono per bloccare i container nei
porti d'ingresso degli Stati Uniti fino a quando l'autorità giudiziaria non avrà
concluso l'indagine sulle ipotesi di reato. Rushan Abbas, un attivista uiguro
americano la cui sorella, un medico, è scomparsa in Cina quasi due anni fa e si
ritiene sia rinchiusa in un campo di detenzione, ha detto che le donne che usano
le 'extension' per i capelli dovrebbero pensare a quale potrebbe essere
l'origine di questi prodotti: "È straziante per noi. Voglio che la gente pensi
alle persone che vivono in schiavitù oggi. Mia sorella è seduta da qualche parte
costretta a fare cosa, 'extension' di capelli?" Le spedizioni sequestrate sono
state importate da produttori che hanno sede nella regione cinese dell'estremo
ovest dello Xinjiang, dove, negli ultimi quattro anni, il governo cinese ha
imprigionato oltre un milione di persone appartenenti alle minoranze etniche di
ceppo turco. Alla serie di denunce della persecuzione delle minoranze etniche
nello Xinjiang ieri si è aggiunto il capitolo delle sterilizzazioni forzate. Da
tempo invece circolano le accuse a Pechino circa la detenzione degli uiguri nei
campi di internamento, eufemisticamente definiti centri di formazione
professionale, dove subiscono maltrattamenti fisici, vengono sottoposti a
disciplina ideologica, costretti ad abiurare la loro religione (principalmente
musulmana) e obbligati a non parlare la propria lingua. Pechino sospetta da
tempo che gli uiguri rappresentino una minaccia separatista all'intergrità dello
Stato proprio a causa delle loro differenze di cultura, lingua e religione. Le
inchieste di AP e di altre agenzie giornalistiche hanno più volte dimostrato
come le persone recluse all'interno di questi campi di lavoro forzato, che gli
attivisti chiamano "fabbriche nere", confezionino capi di abbigliamento sportivo
anche per popolarissimi marchi statunitensi. Più di un anno fa AP aveva cercato
di visitare lo stabilimento della Hetian Haolin Hair Accessories Co. (una della
aziende i cui prodotti sono stati coinvolti nel sequestro) per una inchiesta sui
lavori forzati all'interno dei campi. Ma la polizia aveva chiamato il tassista
che stava portando i giornalisti nella zona, ordinando al conducente di fare
inversione, avvertendolo che le coordinate dell'auto erano state tracciate.
Dalla strada, era chiaro che la fabbrica - sormontata dall'insegna "Haolin Hair
Accessories" in grandi lettere rosse - era protetta con recinzioni in filo
spinato e telecamere di sorveglianza, e l'ingresso era presidiato da agenti di
polizia. è stato bloccato dalla polizia con il casco. Dall'altro lato della
strada, quella che sembrava essere una struttura educativa, era sormontata da
slogan politici tipo "La nazione è forte" ed esortazioni a obbedire al Partito
Comunista. Non era chiaro se la fabbrica fosse parte integrante di un centro di
detenzione, ma ex detenuti in altre parti dello Xinjiang hanno raccontato di
venire spostati in strutture recintate e sorvegliate per lavorare durante il
giorno per poi essere riportati nei campi di internamento di notte. Il Ministero
del Commercio ha negato l'esistenza di lavori forzati, e anche la detenzione
delle minoranze etniche. "Speriamo che certe persone negli Stati Uniti possano
togliersi gli occhiali di parte, capire correttamente e vedere in modo oggettivo
e razionale la normalità della cooperazione economica e commerciale tra imprese
cinesi e americane", si legge in un comunicato del ministero. Mentre le
schermaglie sui dazi e gli embarghi su questioni politiche sono abbastanza
comuni, è estremamente raro che il governo degli Stati Uniti blocchi le
importazioni di merce sulla base dell'accusa che sia prodotta con il lavoro
forzato. Il Tariff Act del 1930 proibisce tali importazioni, ma il governo ha
usato questa legge solo 54 volte negli ultimi 90 anni. La maggior parte di
questi blocchi, il 75%, ha riguardato merci provenienti dalla Cina e
l'applicazione della legge si è intensificata dal 2016 dopo che il Presidente
Barack Obama aveva rafforzato il divieto. Chris Smith, un rappresentante
repubblicano nel Congresso, dice che le accuse di lavoro forzato sono
spaventose ma tutt'altro che sorprendenti: "È probabile che molti prodotti del
lavoro degli schiavi continuino ad arrivare di nascosto nei nostri negozi."
Smith è l'estensore di un disegno di legge contro il traffico di esseri umani.
Il 17 giugno, il presidente Donald Trump ha firmato una legge bipartisan sui
diritti umani degli uiguri che condanna "le gravi violazioni dei diritti umani
di specifici gruppi della minoranza etnica musulmana nella regione dello
Xinjiang in Cina". In precedenza la presidente della Camera Nancy Pelosi, nel
sostenere in Aula l'approvazione della legge, aveva stigmatizzato le
incarcerazione di massa, la sterilizzazione forzata e la repressione della
libertà di stampa in Cina: "Le azioni barbare di Pechino contro il popolo uiguro
sono un oltraggio alla coscienza collettiva del mondo."
Federico Punzi per atlanticoquotidiano.it il 2 luglio 2020. Con
l’entrata in vigore della legge sulla sicurezza nazionale voluta da Pechino,
Hong Kong ha perso de facto la sua autonomia e le sue libertà, che il Partito
Comunista Cinese si era impegnato a rispettare con la dichiarazione
sino-britannica del 1984, a tutti gli effetti un trattato internazionale. Forte
la condanna del segretario di Stato Usa Mike Pompeo, che ha anche denunciato la
brutale e disumana repressione nello Xinjiang, ha chiamato le altre nazioni a
battersi per la dignità del popolo cinese e confermato le sanzioni annunciate,
tra cui la fine dello status speciale di Hong Kong. Citando, tra l’altro,
l’articolo 38 della nuova legge, che estende la sua applicazione anche alle
trasgressioni commesse al di fuori di Hong Kong, e anche dai non residenti,
inclusi quindi anche i cittadini americani. Un “vergognoso affronto a tutte le
nazioni”. Insolitamente dura anche una dichiarazione del ministro degli esteri
tedesco Heiko Maas, significativa perché nel giorno in cui Berlino assumeva la
presidenza di turno dell’Ue: “Quello che sta accadendo è estremamente
preoccupante, perché riteniamo che l’autonomia di Hong Kong venga erosa in modo
graduale e alla fine i rapporti tra Cina ed Europa ne risentiranno. L’Ue deve
adottare rapidamente una posizione forte su questo”. Parole che sembrano
confermare quella “consapevolezza transatlantica” sulla sfida cinese di cui
aveva parlato il segretario Pompeo pochi giorni fa, lo scorso 25 giugno,
intervenendo al Bruxelles Forum del German Marshall Fund. “Inizio a vedere anche
più realismo in Europa per quanto riguarda la minaccia del Partito Comunista
Cinese”, aveva detto. “Gli Stati Uniti e le nazioni europee hanno preso
coscienza della realtà del ruolo della Cina come regime autoritario in ascesa e
delle implicazioni per la nostra società libera. Il cover-up del PCC
sull’epidemia di coronavirus da Wuhan – che ha ucciso migliaia di persone – ha
accelerato la nostra presa di coscienza”. Comprensibile che il segretario di
Stato Usa voglia guardare con ottimismo ai rapporti tra Stati Uniti e “nazioni
europee” sulla Cina, che voglia guardare al bicchiere mezzo pieno. Ma sulla
questione, come molte altre indicative purtroppo del pessimo stato di salute dei
rapporti transatlantici, il quadro è piuttosto disomogeneo, se non
contraddittorio. Non a caso, Pompeo ha parlato di “nazioni europee”, e non Ue.
Perché, certo, deve tener conto di alleati europei che non fanno parte dell’Ue,
ma anche perché il “risveglio” più convincente sulla minaccia cinese è quello
del governo Johnson a Londra. Qualcosa, però, si sta muovendo anche dalle parti
di Bruxelles. La dichiarazione congiunta dei ministri del G7, firmata anche da
importanti stati membri dell’Ue come Germania, Francia e Italia. La Commissione
europea che ha espresso “forte preoccupazione” per la disinformazione cinese, la
situazione dei diritti umani, la repressione e la violazione del principio “un
Paese, due sistemi” a Hong Kong. La dichiarazione già citata, sulla stessa
linea, del ministro tedesco Maas, che ha azzardato un “alla fine i rapporti tra
Cina ed Europa ne risentiranno”. Fin qui parole, di sanzioni nemmeno a parlarne.
Il passo più concreto però è la proposta dell’Alto rappresentante Ue Josep
Borrell di creare un Dialogo Usa-Ue sulla Cina, apprezzata e prontamente accolta
da Washington. Una “svolta”, come l’ha definita Maurizio Molinari su Repubblica?
I rapporti con Pechino sono finalmente entrati nell’agenda transatlantica? Sì e
no. Diciamo che una riflessione importante sulla Cina sta lentamente maturando
in sede Nato. E lentamente anche tra Usa e Ue con il dialogo strutturato
proposto da Borrell. Il merito di questi progressi è indubbiamente degli sforzi
e delle pressioni, anche brusche nei modi, dell’amministrazione Trump – e ci
sono voluti quattro anni…Ma sul reale significato di questo “risveglio”, di
questa nuova consapevolezza europea sulla minaccia cinese, saremmo più cauti. Il
“Dialogo” per la diplomazia Ue è spesso inteso come fine a se stesso, una camera
di compensazione che serve a smussare gli angoli, ma quasi mai ad elaborare
azione politica, mentre gli americani si aspettano l’esatto opposto. La
posizione dell’Ue su Pechino è ancora una e trina. Come ha ricordato la
presidente Von der Leyen, “la Cina è simultaneamente un partner, un competitor
economico e un rivale sistemico che promuove un modello alternativo di
governance”. L’espressione “rivale sistemico”, affiancata per la prima volta nel
2019, è certamente un passo avanti dal punto di vista lessicale. Ma l’Ue ha
avuto fino ad oggi un approccio economicistico con la Cina, non sistemico o
strategico. In effetti, qualcuno potrebbe pensare che i campi di concentramento
e la sorveglianza di massa nello Xinjiang, le minacce a Hong Kong e Taiwan, le
provocazioni nel Mar Cinese meridionale (e in generale nel quadrante
indo-pacifico), siano dossier lontani dagli interessi strategici Ue, ma sarebbe
un errore, date le ambizioni egemoniche di Pechino e i tragici effetti che
abbiamo sperimentato su scala globale del suo cover-up sul virus di Wuhan.
Quanto sono sinceri, dunque, i segnali di “risveglio” europeo sulla Cina? L’Ue a
guida tedesca ha investito molto nel rapporto con Pechino, sia dal punto di
vista economico che politico, inseguendo l’idea velleitaria (e pericolosa come
ripetiamo su Atlantico) di un’autonomia strategica da ritagliarsi proprio
nell’equidistanza tra Usa e Cina. Da una parte, non può fare a meno
dell’ombrello Nato per la sua difesa (cioè di “scroccare” sicurezza dai
contribuenti americani), ma dall’altra la sua economia, e in particolare quella
tedesca, è notevolmente esposta alla Cina. Le dichiarazioni già citate, in cui
si esprime “forte preoccupazione” per gli sviluppi a Hong Kong, non devono
essere sopravvalutate. Di recente, la cancelliera Merkel ha spiegato che proprio
le giustificate preoccupazioni per i diritti umani non sono motivo sufficiente
per compromettere i rapporti con la Cina, che anzi vanno preservati ad ogni
costo, soprattutto ora che Washington e Pechino sono ai ferri corti. Quasi a
voler dire: approfittiamone. Sarà Berlino a gestire i rapporti dell’Ue con
Pechino per i prossimi sei mesi. E non è un caso, naturalmente, che il vertice
Ue-Cina di Lipsia, inizialmente convocato per metà settembre, sia stato
rinviato. La cancelliera Merkel punta a tenerlo entro fine anno, quindi entro la
fine del semestre di presidenza tedesca dell’Ue, ma dopo le elezioni
presidenziali americane che si terranno il 3 novembre. La sua ambizione è quella
di concludere con Pechino il difficile accordo sugli investimenti bilaterali,
riuscendo così a posizionare l’Europa “tra le grandi potenze Cina e Stati
Uniti”, e a mettere sul giusto binario i rapporti Ue-Cina prima di dare l’addio
al cancellierato e alla vita politica attiva. Per l’Ue a guida tedesca quindi è
il momento di temporeggiare e aspettare di scoprire chi sarà l’inquilino della
Casa Bianca per i prossimi quattro anni. Con Joe Biden, infatti, si aprirebbe
una prospettiva di progressivo allentamento delle tensioni Usa-Cina e Berlino
potrebbe puntare ad un risultato più ambizioso al vertice di Lipsia senza
irritare Washington. Fino ad allora, posizioni di inusuale fermezza su Hong Kong
e l’ostentazione di un dialogo più stretto con l’amministrazione Trump sulla
sfida cinese, possono persino rivelarsi elementi utili, funzionali ad aumentare
la leva negoziale Ue in vista delle difficilissime trattative con Pechino a
novembre o dicembre. Che Trump sia rieletto o che vinca Biden, ha avvertito nei
giorni scorsi il ministro degli esteri tedesco Maas, l’Europa dovrà trovare una
propria strada sui temi di politica estera, “anche senza Stati Uniti”. Bisogna
fare i conti con Pechino, però. Anche Xi Jinping sta probabilmente aspettando
l’esito delle presidenziali americane di novembre prima di muovere i suoi
prossimi passi nelle relazioni con l’Ue. E 29 round di negoziati in otto anni ci
dicono che non ha alcuna fretta di raggiungere un accordo sugli investimenti
bilaterali. Anzi, forse gli sta bene lo status quo, che nonostante le recenti
misure adottate da Bruxelles – le linee guida sulla sicurezza della rete 5G e lo
screening sui nuovi investimenti – ancora gli consente di proseguire con il suo
approccio predatorio. Il fatto, osserva Wolfgang Münchau riprendendo un’analisi
di François Godement (European Council on Foreign Relations), è che agli occhi
della leadership cinese l’Ue è “disperatamente divisa e non sufficientemente
strategica” e Pechino sta iniziando a mettere i Paesi europei l’uno contro
l’altro. Proprio Angela Merkel è il massimo esponente della “doppiezza europea”:
da una parte, “il suo dichiarato sostegno per una posizione comune dell’Ue sulla
Cina”; dall’altra, Berlino “agisce con unilateralismo mercantilista nelle sue
relazioni bilaterali”. Mentre ciò che dovrebbe fare l’Ue, è avvertire la
leadership cinese che se rifiuta di accordare una piena reciprocità nei rapporti
economici e commerciali, ciò porterà al decoupling delle catene di
approvvigionamento. Godement giunge alla stessa conclusione che da tempo noi di
Atlantico vi proponiamo sui rischi dell’idea di “autonomia strategica” e di
un’Europa equidistante tra Usa e Cina. A Pechino interpretano la discussione
europea sull’autonomia strategica non come la prova di un’Europa più unita, più
matura e forte, ma, al contrario, come un segno di indebolimento, dato che in
questo modo l’Ue si sta allontanando, separando dal principale garante della sua
sicurezza: gli Stati Uniti. Lo smantellamento dell’alleanza transatlantica –
opera da tempo dell’Ue a guida tedesca, non dell’amministrazione Trump come
molti pensano – non è accompagnato da un rafforzamento della difesa europea.
Ferruccio Michelin per formiche.net. In Xinjiang va tutto bene,
parola del Blog di Beppe Grillo. Mentre i media mondiali riprendono un poderoso
lavoro giornalistico del New York Times che ha portato allo scoperto altre
corpose informazioni sulla repressione dello Stato cinese contro i musulmani
uiguri che vivono nella regione, il vangelo grillino ospita un articolo che
segue nettamente la linea di Pechino. Ossia quella della narrazione contro i
nemici della Cina, e sostiene che è in atto “una campagna mediatica sui diritti
umani volta a screditare l’operato del governo cinese”. Passo indietro. Lo
Xinjiang è una regione autonoma della Cina nord-occidentale dove vive una
maggioranza etnica turcofona e musulmana; è un’area geograficamente strategica
da sempre, perché è il prolungamento fisico-politico del Regno di Mezzo verso
l’Europa, e ora acquisisce ancora più importanza nell’ambito della
macro-infrastruttura geopolitica Belt & Road. Il Partito Comunista cinese da
sempre non vive serenamente quella presenza, anche perché ha creato negli anni
problematiche autonomiste al governo centrale, ed è stata interessata da
fenomeni di radicalizzazione islamica. Da alcuni anni si sa che la Cina ha
avviato una “campagna di rieducazione” sugli uiguri, attraverso campi di
detenzione che hanno ricevuto diverse denunce da parte delle associazioni per i
diritti umani. Sia sul funzionamento, sia sulla gestione. L’articolo sul blog di
Grillo è scritto da Fabio Massimo Parenti, professore associato dell’Istituto
Internazionale Lorenzo de’ Medici a Firenze (non nuovo su certe letture), che
cita a sua volta un libro scritto dall’archeologa Maria Morigi proprio sullo
Xinjiang (i due spesso scrivono, anche insieme). Morigi scrive che nella regione
c’è “una buona convivenza tra Han e Uiguri e non si percepisce alcun tipo di
discriminazione”. E “non vi sono corrispondenze reali, dunque, alle accuse di
repressione, se non addirittura di genocidio culturale”. Parenti e Morigi
arrivano al loro nocciolo, che è identico a quello cinese: le denunce, dicono,
partono dalle organizzazioni umanitarie perché sono collegate al governo degli
Stati Uniti – “Ong e interventismo umanitario” è il titolo di un capitolo nel
libro di Morigi. E dunque diventerebbe tutto un gioco di disinformazione
americana, chiaramente collegato alla competizione in corso tra potenze secondo
l’opinione che il centro di controllo grillino diffonde ai simpatizzanti. È
esattamente quello che Pechino sta cercando di raccontare al mondo riguardo
questo genere di dossier, dallo Xinjiang a Hong Kong. Situazioni create ad arte
dai nemici, dicono i cinesi, con l’atteggiamento tipico dei governi autoritari
alle prese con crisi interne. Da notare che per portare avanti certe narrazioni
la Cina fa leva sui Paesi con cui ha più collegamenti: per esempio, l’avvio di
questo storytelling riguardo alle proteste contro la cinesizzazione di Hong Kong
è stato dato durante una conferenza stampa a Roma, in cui il neo-ambasciatore
cinese ha accusato gli americani di essere dietro alle manifestazioni nel Porto
Profumato. Su Hong Kong, si ricorda che il leader del Movimento 5 Stelle nella
squadra di governo, il ministro degli Esteri Luigi di Maio, ha detto che
l’Italia deve cavalcare la strada della “non interferenza” – anche questo è
esattamente cià che chiede la Cina. La situazione nello Xinjiang in realtà è
piuttosto diversa da come viene raccontata nel blog di Grillo. Gli “Xinjiang
Papers” – come vengono chiamate dalla stampa internazionale le 400 pagine di
documenti riservati ottenuti dal New York Times – ne sono un’altra
certificazione formidabile. Aggiungono informazioni ai vari report di ong e
testimonianze dirette raccolte dai giornalisti che secondo l’Onu sono tutte
“credibili”. Sulla base delle denunce più strutturate rispetto al post made in
Grillo sarebbe in corso un piano per la detenzione di massa e la trasformazione
socio-culturale del Paese. La Cina dice che ci sono semplicemente dei campi di
rieducazione contro la minaccia terroristica. Nessuno li ha mai potuti visitare,
però. Tanto meno Parenti – che racconta di essere stato nello Xinjiang
recentemente e di non aver notato niente di particolarmente rilevante; fu un
viaggio di quattro giorni organizzato dal governo cinese, anche quello oggetto
di un intervento sul blog di Grillo in cui si contestava il silenzio (in realtà
per niente vero) dei media occidentali sul terrorismo nello Xinjiang e
fondamentalmente si giustificavano le attività cinesi. Da notare, a proposito
delle visite nello Xinjiang: l’Unione europea sta discutendo con il governo
cinese per tour a livello di ambasciatori nella regione occidentale, ma è
improbabile che il viaggio si concretizzerà a meno che non siano soddisfatte
determinate condizioni. Che è molto difficile che Pechino conceda. Non ci
saranno accessi reali a quei campi e possibilità di libero movimento per gli
europei. La Cina si limiterà a concedere una visita accompagnata e guidata,
filtrata sulle esigenze che vuol mostrare. La Cina e il blog di Grillo negano
gli arresti di massa, che invece sono parte fondamentale di un piano con cui
Pechino intende procedere con la “trasformazione” della società nello Xinjiang –
il virgolettato è ripreso direttamente da quanto il segretario del Partito
Comunista cinese, il capo dello Stato Xi Jinping, ha detto tempo fa in un
discorso. I documenti del Nyt sono scritti interni di estrema importanza in cui
si parla apertamente di questo piano. Di più: dimostrano che è un progetto non
regionale, ma centralizzato. Ci sono ordini di esecuzione e gestione che partono
dai massimi vertici del Partito, e dunque dello Stato. Ancora: raccontano che
all’interno del Partito c’è qualcuno che non è d’accordo con Xi e che ha voluto
svergognare le attività nello Xinjiang rendendole pubbliche alla stampa. Xi,
dalla verbalizzazione di riunioni orali e dai documenti scritti in possesso del
Nyt, avrebbe ordinato l’uso di “strumenti della dittatura” contro le derive
collegate a “terrorismo, infiltrazione e separatismo” e di farlo “senza nessuna
pietà”. Dovrebbe essere la risposta contro le attività di certi gruppi presenti
nello Xinjiang, protagonisti da anni di dozzine di azioni terroristiche di vario
genere (alcuni di loro hanno anche compiuto il jihad califfale). Secondo le
varie denunce però, il governo cinese per sradicare il problema avrebbe preso la
strada di una sorta di pulizia etnica, con arresti e detenzioni anche
arbitrarie, sulla base di metodi di polizia predittiva; persone che vengono
rinchiuse solo perché corrispondono a canoni dettati da un algoritmo che li
considera potenziali terroristi. Non ci sono prove dirette, ma tantissime
segnalazioni: ma secondo il blog di Grillo non ci sono problemi di alcun genere.
(ANSA l'1
luglio 2020) - Il segretario di stato americano ha minacciato "rappresaglie"
degli Usa dopo quello che ha definito "un triste giorno" per Hong Kong in
seguito all'approvazione della nuova legge sulla sicurezza nazionale.
(ANSA l'1
luglio 2020) - La legge sulla sicurezza nazionale, appena entrata in vigore e
tarata da Pechino per Hong Kong, è il "più importante sviluppo" nei legami
bilaterali. La governatrice Carrie Lam, alla cerimonia del 23/mo avversario del
ritorno dei territori sotto la sovranità cinese, ha ribadito che l'alto livello
di autonomia o l'indipendenza giudiziaria non saranno intaccati. "E' uno storico
passaggio nel miglioramento del meccanismo di tutela della sovranità,
dell'integrità e della sicurezza del Paese", ha aggiunto, ricordando la legge
dell'ex colonia che ora punisce l'oltraggio all'inno nazionale cinese. Lam,
nella tradizionale cerimonia dell'alzabandiera all'Hong Kong Convention and
Exhibition Center di Wan Chai, ha rimarcato che la legge è una "inevitabile e
pronta decisione per ristabilire l'ordine e la stabilità nella società" nell'ex
colonia britannica. Lo scorso anno, il sito, nella stessa occasione, su teatro
di pesanti contestazioni nate dalla controversa proposta di legge sulle
estradizioni in Cina, proprio nell'area del porto dove 23 anni fa l'ultimo
governatore coloniale britannico, Chris Patten, fortemente critico verso la
legge sulla sicurezza nazionale, restituì in lacrime i territori alla Cina. Un
piccolo gruppo di manifestanti ha protestato contro la nuova legge che, secondo
i più critici, è destinata a frantumare l'ampia autonomia e libertà che Pechino
aveva promesso di mantenere a Hong Kong per almeno 50 anni, fino al 2047,
secondo il modello 'un Paese, due sistemi'. La grande marcia tenuta ogni anno
dagli attivisti pro democrazia è stata vietata dalla polizia, ufficialmente per
le cautele legate al Covid-19.
(ANSA l'1
luglio 2020) - La polizia di Hong Kong ha eseguito il primo arresto in base alla
nuova legge sulla sicurezza nazionale dopo la sua entrata in vigore: si tratta
di un uomo, secondo i media locali, che possedeva una bandiera della Hong Kong
indipendente a Causeway Bay, dove è attesa a breve una manifestazione non
autorizzata. La polizia, nel frattempo, ha usato per la prima volta anche la
nuova bandiera viola che vale come monito ai manifestanti che utilizzano
bandiere o striscioni illegali o che scandiscono cori e slogan che esprimono
propositi di secessione o sovversione.
Michelangelo
Cocco per ''Il Messaggero'' l'1 luglio 2020. Il parlamento di Pechino ha
approvato all'unanimità la controversa Legge sulla sicurezza nazionale per Hong
Kong, che prevede pene fino all'ergastolo per i reati di secessione, eversione,
attività terroristiche, e collusione con un paese straniero o elementi esterni
per mettere in pericolo la sicurezza nazionale. Le nuove norme (66 articoli
divisi in sei capitoli), dopo la firma del presidente cinese, Xi Jinping, sono
entrate in vigore ieri alle 23:00, alla vigilia del ventitreesimo anniversario
dello handover, il passaggio dell'ex colonia dalla Gran Bretagna alla Repubblica
popolare cinese il 1° luglio 1997. La legge è stata fortemente voluta dalla
leadership del Partito comunista, che manda così anche un chiaro segnale
d'intransigenza all'Occidente che ha simpatizzato con i milioni di hongkonghesi
che negli ultimi 12 mesi sono scesi in piazza centinaia di volte per difendere
le loro libertà: la Cina della Nuova era proclamata da Xi tutela l'ordine e
l'integrità del suo immenso territorio nazionale nelle forme (e con le leggi)
che ritiene più consone alle sue esigenze del suo sistema politico autoritario.
LE REAZIONI.
Le reazioni internazionali sono state immediate. Gli Stati Uniti hanno reso
effettiva la misura annunciata nelle scorse settimane che toglie lo status
commerciale privilegiato a Hong Kong, un provvedimento che però potrebbe avere
l'effetto indesiderato di spingerla sempre più tra le braccia di Pechino.
L'Amministrazione Trump ieri ha annunciato che partirà dallo stop alle
esportazioni delle tecnologie Usa più avanzate. Il presidente del Consiglio
europeo, Charles Michel, ha dichiarato che l'Ue «deplora questa decisione (la
Legge, ndr)» che «rischia seriamente di danneggiare l'alto grado di autonomia di
Hong Kong e avrà un impatto negativo sul sistema giudiziario e sullo stato di
diritto». La presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, ha fatto sapere
che l'Ue sta discutendo possibili contromisure con i «partner internazionali».
La nuova legge prevede pene anche per gli stranieri, che potranno essere
espulsi, e per le aziende, che rischiano multe salate. Ma l'obiettivo centrale
della Legge, che Pechino inseguiva dal 2003 - quando il tentativo di vararla
provocò una crisi nel governo di Hong Kong è quello di isolare
(criminalizzandola) l'ala più radicale (numericamente minoritaria, ma
fondamentale per le sua capacità di mobilitazione) dal grosso del movimento di
protesta, e normalizzare Hong Kong contando sul sostegno della maggioranza
silenziosa che secondo Pechino sostiene le politiche del governo centrale. La
Legge sulla sicurezza nazionale servirebbe insomma a evitare il ripetersi di
proteste durante le quali sono andati in scena atti di violenza estrema e hanno
trovato spazio appelli sempre più espliciti all'indipendenza. Le nuove norme
però riducono l'indipendenza del sistema giudiziario di Hong Kong, uno dei
pilastri della semi-autonomia della quale gode la metropoli finanziaria. Nei
casi in cui il governo di Hong Kong si dimostri incapace di agire, oppure si
verifichi un'interferenza straniera, o sia immediatamente in pericolo la
sicurezza nazionale, sarà infatti l'Agenzia per la sicurezza nazionale
controllata direttamente da Pechino e non la Commissione per la sicurezza
nazionale di Hong Kong (controllata da Pechino indirettamente, attraverso il
Chief executive di Hong Kong) a condurre le indagini ed emettere le sentenze.
L'ACCUSA. Per
questo motivo, e per non aver nemmeno consultato il Consiglio legislativo, i
deputati all'opposizione a Hong Kong hanno accusato Pechino di aver «insultato»
il parlamentino di Hong Kong. Dennis Kwok, del Civic Party, ha definito
«ridicolo» il fatto che Pechino abbia reso pubblici gli articoli della nuova
legge solo poche ore prima che entrasse in vigore. Al momento del varo della
Legge, Joshua Wong, Nathan Law e Agnes Chow i volti più noti del movimento
giovanile si sono dimessi dal partitino indipendentista Demosisto, che poco dopo
ha annunciato il suo scioglimento. Eppure secondo Wong nessuna «legge
draconiana» fermerà il movimento. «Continuerò a restare a casa mia, Hong Kong ha
dichiarato il leader della protesta in risposta alle voci che lo vogliono esule
in Occidente -, finché mi silenzieranno e mi spazzeranno via. Ormai la città è
uno stato di polizia».
Francesco
Bechis per formiche.net il 30 giugno 2020. Oggi Hong Kong, domani chissà. Una
sola cosa è certa dei piani di Pechino, spiega a Formiche.net Zack Cooper,
esperto di strategia militare dell’American Enterprise Institute (Aei) con un
trascorso al Pentagono e al National security council (Nsc): con l’approvazione
definitiva della nuova Legge sulla sicurezza nazionale e l’imminente apertura
della agenzia di sicurezza del governo cinese, il Porto Profumato ha perso la
sua autonomia e non c’è (quasi) niente che la comunità internazionale possa fare».
Cooper, ora
i manifestanti a Hong Kong hanno paura.
«Hanno
ragione. È con ogni probabilità la peggiore crisi a Hong Kong fin dalla cessione
nel 1997. La legge sulla sicurezza nazionale, di cui peraltro sappiamo poco e
nulla, è solo un tassello. Pechino vuole sbarazzarsi della divisione dei sistemi
giudiziari, e accelerare il già rapido soffocamento dei diritti e delle libertà
civili».
Quanto
tempo c’è?
«Non
sarei sorpreso se le cose cambiassero da domani. Il primo luglio cade
l’anniversario degli accordi del ’97, come ogni anno ci saranno enormi proteste
di piazza. Quest’anno le autorità le hanno vietate con il pretesto del virus.
Non escludo una mossa preventiva di Pechino».
Quale?
«Usare
le manifestazioni di questo mercoledì per dare il colpo di grazia al movimento
di protesta, arrestare i leader, le figure più mediatiche nel giro di un paio di
settimane. E poi inaugurare il nuovo sistema giudiziario. Ovvero non processarli
a Hong Kong, ma direttamente nella Mainland China. È un approdo ormai
inevitabile».
Ci sono
precedenti?
«C’è
stato qualche caso, come un venditore di libri arrestato a Hong Kong e
processato nella Cina continentale, ma parliamo di casi isolati, che hanno
suscitato un grande clamore mediatico. Adesso c’è il serio rischio che diventi
la norma. Anche perché con la nuova legge diventeranno reati gesti che non
dovrebbero esserlo, come la non meglio definita “sovversione”, o anche solo le
critiche al governo cinese».
La comunità
internazionale ha fatto troppo poco?
«La
verità è che non poteva e non può salvare Hong Kong. Per il Partito comunista
cinese (Pcc) è questione di vita o di morte, ne va della sua presa sulla società
cinese. Pechino non vuole correre il rischio. Questo ovviamente non significa
che la comunità internazionale non dovrebbe fare qualcosa».
Cosa?
«Alzare
la voce, ad esempio. Non cambierà le carte in tavola, ma tiene i riflettori
accesi sulle violazioni dei diritti umani. Se le proteste dei prossimi giorni
saranno represse con la forza, speriamo che qualcuna delle democrazie
occidentali coinvolte negli accordi del ’97 così come altri Paesi asiatici
vogliano dire la loro».
Dopo Hong
Kong è il turno di Taiwan?
«Hong
Kong e Taiwan sono due realtà completamente differenti. Lo sono senz’altro dal
punto di vista strategico americano. Quando Hong Kong è passata in mano cinese
nel 1997 nessuno, né gli Usa né il Regno Unito, ha pensato di mettere in conto
un intervento militare nel caso in cui i patti fossero violati. Se la Cina
invadesse domani Taiwan, ci sarebbe una reazione molto forte e immediata da
parte degli Stati Uniti e di altri Paesi della regione».
A
proposito, le insofferenze verso la Cina aumentano fra le potenze della regione.
C’è la possibilità che uniscano le forze?
«Temo
che questa sia un’idea figlia di una percezione europea della politica estera e
di sicurezza. La Nato è nata come baluardo contro l’Urss, oggi non ci sono le
condizioni per una “Nato anticinese” nel Pacifico».
Ci spieghi
meglio.
«Semplice.
Perché quello europeo è per gran parte un teatro di terra. La regione fra
l’Oceano Pacifico e Indiano è fatta di potenze marittime. Diverse potenze
regionali, Corea, Giappone, Vietnam, Taiwan, Malesia, Indonesia, Filippine,
India, hanno dispute territoriali aperte con Pechino. Ma ognuno di questi conti
in sospeso è diverso dagli altri. Non esiste una situazione simile a quella
degli Stati baltici, che condividono tutti il timore per il revisionismo
territoriale russo. Un’alleanza regionale è dunque improbabile. Anche perché la
leadership cinese si è dimostrata brava a prendere di mira questi Paesi uno alla
volta, fino a farli desistere».
Gli Usa
proveranno comunque a metterla in piedi?
«All’interno
degli apparati c’è più di una persona convinta di questo. Il problema è che,
ora, Washington non è la sede ideale per fare da regia a una simile alleanza.
Mettere insieme i Paesi del G7, l’India, l’Australia, la Corea del Sud richiede
una leadership di ferro che mal si sposa con la strategia dell’America First di
Donald Trump».
E con Joe
Biden?
«Con
lui le carte sul tavolo possono cambiare. La vocazione democratica è quella di
costruire alleanze regionali con un ruolo di primo piano degli Stati Uniti,
anche in Asia. Ma fino alle elezioni di novembre queste rimangono idee sulla
carta».
La ricorrenza. Non dimentichiamo la strage di Tienanmen e
quello che significa oggi. Antonio Selvatici su Il
Riformista il 2 Giugno 2020. Vietato pronunciare, cancellare la
memoria: Tienanmen rimane una parola, un’idea, un’utopia inafferrabile non
consentita. L’imminente anniversario sarà ancora più amaro. Disgustoso
per Pechino, aspro e indigeribile per Hong Kong. Da allora, e sono trascorsi
trentuno anni, le libertà dei cittadini cinesi hanno subito delle ulteriori
restrizioni: la tecnologia si è evoluta, la digital repression e la
disinformazione anche digitale sono diventati i nuovi raffinati strumenti dello
Stato padrone. Il 4 giugno, anniversario della strage di piazza Tienanmen,
a Hong Kong a Victoria Park si ricordava l’avvenimento. Un’affollatissima e
silenziosa marcia notturna dove le candele delle migliaia di manifestanti
illuminavano la memoria. Un raduno puntuale e pacifico che veniva ripreso dalla
stampa internazionale. Quello di quest’anno sarà un ricordo ancora più
significativo: la “sicurezza nazionale” espressione del potere di Pechino tra
pochi mesi imporrà a Hong Kong delle restrizioni che, di fatto, cancellano parte
di quella “piena autonomia” che nel 1997 era stata pattuita con il Regno
Unito al momento della cessione del territorio. La “grande Cina” mal sopporta la
relativa indipendenza delle due appendici Taiwan e Hong Kong. Tutti sanno che
quella della “sicurezza nazionale” è un grande ombrello che non riesce a celare
il suo vero scopo: il controllo totale, la fine del “un Paese due sistemi”.
Il “nuovo ordine globale” dell’onnipotente Presidente Xi Jinping non può
permettersi di presentarsi al di fuori dei confini cinesi come garante, amico e
protettore senza prima aver risolto le sue “questioni interne”. La memoria di
quelle tragiche settimane, le manifestazioni del 1989 incominciarono a metà
aprile e si conclusero in un bagno di sangue il 4 giugno quando Deng
Xiaoping usò la forza autorizzando anche l’intervento dei carri armati, sono
passate alla storia anche attraverso il celebre scatto che immortala il ragazzo
in camicia bianca che da solo contrasta l’avanzata della fila dei tank. Quei
movimenti di piazza di Tienanmen hanno anticipato di qualche mese la caduta
del muro di Berlino (novembre 1989) e il successivo sgretolamento dell’impero
sovietico. Il Partito comunista cinese è sopravvissuto alle vicende del “secolo
breve” e negli ultimi trenta anni, con la complicità dell’avido Occidente alla
ricerca delle produzioni a basso prezzo, ha inventato e realizzato il modello
del “socialismo con caratteristiche cinesi”. Il mondo travolto dal virus
democratico a guida autoritaria sta vivendo quel “disordine globale” che si
manifesta con i fatti di Minneapolis e la repressione di Hong Kong.
Probabilmente avvenimenti tutti figli dello stesso Coronavirus: il sistema
neoliberista degli Stati Uniti ha immediatamente espresso milioni di
disoccupati, colpendo soprattutto le fasce più deboli particolarmente esposte e
con poche tutele travolte da una crisi senza precedenti. In Cina il virus
obbliga il regime di Pechino a limitare ulteriormente le libertà
individuali. Sembra proprio che il virus cinese ci abbia condannato, anche in
Italia abbiamo vissuto/subito un periodo (temporaneo, ci si augura) di “libertà
sospese”, a ripensare modelli di governance che non sono stati in grado
d’affrontare l’emergenza Coronavirus. Che per difendersi e sopravvivere a se
stessi devono utilizzare strumenti repressivi. Il virus è sopportabile, ma non
lo è la museruola.
Perché dopo la strage di Piazza Tienanmen la Cina è diventata
una potenza globale. Biagio De Giovanni su Il
Riformista il 4 Giugno 2020. Anno cruciale, il 1989, per il comunismo reale. Due
avvenimenti: la rivolta di piazza Tienanmen fra aprile e giugno, con l’esito di
una repressione di massa di cui ancora non si conosce il numero di vittime; la
caduta del muro di Berlino, anticamera della fine dell’Urss avvenuta due anni
dopo, che segnò la fine del “1917”. L’opposto in Cina: Tienanmen coincise con
l’avvio della sua potenza globale, che domina l’Asia e si appresta da allora a
giocare una partita mondiale. Come mai? La rivoluzione del 1917 ha vissuto
sempre di una intima contraddizione: nata da un colpo di stato, reso possibile
dalla parola d’ordine della fine della guerra, divenne un fatto periodizzante
per il destino dell’umanità, nella politica, ma soprattutto nell’immaginazione
di una intellettualità mai così affascinata da quella vicenda: le due
rivoluzioni, 1789 e 1917, ecco compiersi il destino di liberazione dell’umanità.
Peraltro più d’uno, della classe dirigente bolscevica, si era formato nelle
università francesi. Lenin non era un marxista, ma un hegeliano di sinistra,
educato alla Scienza della logica di Hegel. Da questo insieme nacque una
gigantesca superfetazione anche ideale e culturale che ha scaldato i motori
politici del colpo di stato, dandogli dimensione mondiale. Questo accadeva in
una Russia euroasiatica, dove, in vari modi, la vita intellettuale si era
svolta, lungo tutto l’800, nel grande dibattito tra occidentalisti e slavofili.
Insomma, una vicenda contrastata, profondamente europea, almeno in una sua parte
decisiva, caduta quando l’Occidente, cui pure essa si era abbeverata, ne mise
allo scoperto il sostanziale fallimento politico-ideale. Tutt’altra cosa è
accaduta in Cina. La rivoluzione del 1949, nata da una guerra civile, fu
profondamente radicata nel popolo. Insomma, due “nazioni” furono di fronte; ma
l’una, quella di Mao, rappresentava una dimensione
nazional-popolare profondissima, armata di una cultura lontana
dall’occidentalismo, e che viveva delle proprie radici. Il dibattito sulla
democrazia non è mai entrato nei suoi confini. L’Occidente era semplicemente una
realtà ostile e prevaricatrice. Asia, dunque, contro Occidente, l’opposto che in
Russia. Le conseguenze di Tienanmen si spiegano così. Una ribellione, di giovani
studenti, soprattutto, che non toccava la sterminata massa di un popolo
contadino, ribellione che rivendicava le libertà civili senza possedere
strumenti capaci di egemonia, quasi una rivolta per sofferenze e bisogni
esistenziali, mai diventati per davvero collettivi. Per tutto questo, diversi
furono gli effetti, nel comunismo mondiale, dei due accadimenti del 1989: caduta
dell’Urss e, sul fronte opposto, nascita della Cina come potenza globale che
aveva reagito con la violenza alla ribellione studentesca. Partì allora,
abolendo sul nascere ogni alternativa; la sua immensa capacità tecnica e
produttiva andò alla conquista dell’egemonia in Asia, e poi, possibilmente, nel
mondo. Tutto dunque sta nell’origine delle due rivoluzioni. La prima, con sempre
un tarlo al suo interno, ha mescolato egemonia culturale nel mondo, da un certo
momento in progressivo declino, e dispotismo totalitario all’interno. La
seconda, quella cinese, si è concentrata su se stessa, divenne la religione
della nazione, ebbe perfino un richiamo nell’Occidente intellettuale, dopo il
1968, negli anni della rivoluzione culturale, ma fu infine un’influenza
ristretta a gruppi politici iperideologici. Non passò nella cultura generale. E
allora, oggi? L’Urss è un ricordo, anche se la fine del suo sistema ha lasciato
sul terreno memorie che parlano di democrazia “sostanziale” come un miraggio che
noi immaginiamo essere una possibilità della storia. La Cina ha incominciato
intanto il suo cammino, radicato in una vera rivoluzione politica che ha
sollevato dalla miseria e dalla fame la massa contadina, una rivoluzione assai
cólta nelle sue gerarchie. Ha urbanizzato milioni e milioni di contadini poveri,
un mondo da fantascienza dove si mescolano i mercati di animali selvatici, privi
di garanzie igienico-sanitarie, con le più sottili conquiste tecnologiche. Un
immenso laboratorio all’insegna del dispotismo. Ora è la Cina che va alla
conquista dell’Occidente, la sua potenza nasce da questo. La vittoria dei
giovani a Tienanmen sarebbe stata un semplice intralcio verso un mondo
sconosciuto, e perciò andava repressa. Da allora, quelle rivendicazioni non sono
state più sollevate, se non da piccoli gruppi di dissidenti presto incarcerati o
duramente colpiti. Tienanmen è diventato un tabù. Ha vinto una classe dirigente
nata dalla rivoluzione di Mao, trasvalutata dal geniale Deng Xiaoping, sapendo
oggi che il comunismo come tale non è più una potenza che può parlare al mondo.
E da allora, la Cina si muove con l’aiuto di Confucio, della tecnologia e del
lavoro di massa, più che di Marx. E così essa irrompe come potenza mondiale, una
grandiosa smentita della tesi occidentale sul rapporto necessario tra sviluppo
economico e democrazia. Tutto un altro modello sta diventando potenza globale,
penetrando dappertutto anche nelle maglie indebolite di un Occidente diviso e
incerto nella sua dimensione geo-politica. Questo stato di cose produce un
effetto che sia i sinologi sia gli analisti politici giudicano pressoché
obbligato: più cresce la potenza politica, più si aggrava il dispotismo nella
società, come se la dimensione globale nella quale la Cina è impegnata, avesse
come riscontro politico la repressione interna, per rafforzare l’unità della
decisione di un Presidente a vita. Il mondo oggi si confronta con la potenza
cinese, comunismo reale trasformatosi in capitalismo di Stato dispotico con
tendenze espansive. Non aggiungo altro su un tema che si apre in questo quadro:
avvertiamo la sempre maggiore divisione del “sistema Occidente”, America-Europa,
in una fase di transizione difficile, non si sa verso dove, e molto dipenderà da
questo “dove”. Difficile decifrare il mondo che viene. La Cina è di certo un
interlocutore necessario, ma sapendo che si può preparare, nell’orizzonte della
politica mondiale, una prevalenza delle democrazie illiberali anche entro i
confini di civiltà che hanno provato a mettere insieme, con molta fatica, e
talvolta con varie ritirate, democrazia e liberalismo. Ora tutto è in
discussione, bisogna saperlo.
Razzismo in
Cina? "Cacciato da hotel e spiaggia perché straniero”.
Le Iene News
il 29 aprile 2020. Pietro racconta a Giulia Innocenzi per Iene.it tutti gli
episodi che gli sono successi in Cina in quanto straniero una volta uscito dalla
quarantena: "è razzismo di stato". “In Cina è stato ufficialmente avviato il
razzismo di stato”. Parte così l’email che ci scrive Pietro (nome di fantasia,
ndr), italiano che vive da diversi anni in una città a circa 500 chilometri da
Wuhan. Giulia Innocenzi lo ha intervistato per Iene.it: aspettando Le Iene, e
Pietro ha messo in fila una serie di episodi che gli sono successi da quando è
uscito dalla quarantena. Episodi che vanno ad aggiungersi a notizie allarmanti
di taglie sugli stranieri e africani buttati fuori casa. Ma andiamo con ordine.
Pietro rientra in Cina un mese fa, per la precisione tre giorni prima che il
paese vieti agli stranieri anche residenti l’ingresso. “Così parte la mia
quarantena. Prima in un albergo a mie spese, poi, quando viene fuori grazie al
tracciamento dell’app che il passeggero seduto vicino a me in aereo è risultato
positivo al coronavirus, vengo trasferito in una struttura per quelli più a
rischio. Questa era bella fatiscente, ma comunque finisco i miei giorni e
finalmente torno a casa”. Con il certificato alla mano che attesta che non ha
contratto il coronavirus può finalmente tornare ad abbracciare la sua famiglia,
moglie cinese e due figli, 9 e 6 anni. Ma da lì cominciano i problemi. “Dovevo
rinnovare il passaporto”, racconta alla Innocenzi, “e così decidiamo di andare
al consolato di Canton e approfittiamo per trascorrere un finesettimana in
famiglia”. Al telefono la prima brutta scoperta: “in quanto straniero non potevo
prenotare un albergo. Ho provato con diverse strutture, ma mi hanno risposto
tutte allo stesso modo: ‘per disposizioni governative non sono ammessi gli
stranieri’”. Partono lo stesso, grazie all’ospitalità offerta a casa di amici, e
lì il secondo brutto episodio. “Entro in un garage sotterraneo e il
parcheggiatore si sbraccia invitandomi a fermarmi. Ci spiega che in quanto
straniero non posso entrare”. Pietro gli mostra il certificato che attesta la
sua negatività al coronavirus, ma non c’è niente da fare. “Sono dovuto scendere
dalla macchina e uscire, ha parcheggiato mia moglie”. Ma non è finita qui. Con
la famiglia e gli amici decidono di trascorrere qualche ora al mare. Anche lì,
non appena vedono che Pietro è straniero, mostrano un cartello che recita
testuale: “Per disposizioni governative, momentaneamente non possiamo
autorizzare l’accesso agli stranieri”. E tutto questo davanti agli occhi dei
suoi figli, con la più grande pronta a intervenire per spiegare che il papà non
è infetto. La bambina è intervenuta anche qualche giorno fa, mentre era con
altri bambini in una salagiochi. Quando hanno visto il suo papà gli hanno
puntato il dito e hanno cominciato a gridare che aveva il coronavirus, così
ancora una volta è dovuta intervenire la bambina, che ha spiegato che straniero
non equivale a infetto. “E poi gli ha anche detto che i contagiati erano loro”,
chiosa Pietro. Che da questa serie di episodi è molto provato, soprattutto
perché ci vanno di mezzo i suoi figli. “Ma lo sapete che mia figlia, che fra
poco tornerà a scuola, ha dovuto fare il tampone perché ha il papà
straniero? Gli altri bambini cinesi non l’hanno dovuto fare”. E non si può stare
tranquilli nemmeno a casa propria. “Nel nostro centro residenziale hanno messo
un avviso di segnalare tutte le persone sospette che sembrano rientrate
dall’estero”. A Pietro scappa un sorriso: “Se io vedo un cinese in
giro difficilmente posso sospettare che sia rientrato dall’estero, ma se vedi
uno come me, lo pensi immediatamente”. E il suo condominio non è l’unico che ha
disposto nuove regole contro gli stranieri. Greta Pesce, studentessa italiana
che vive a Shanghai, ha dovuto prendere in affitto un nuovo appartamento (leggi
qui l'articolo), perché non è potuta rientrare nel suo perché il condominio ora
non ammette stranieri. Pietro parla di una vera e propria “caccia allo
straniero”. “L’altro giorno mentre passeggiavo uno mi ha scattato una foto e poi
ha fatto una telefonata. Ho continuato a camminare e me lo sono trovato girato
l’angolo, mi stava seguendo”. Ma la situazione è molto più problematica in altre
due province in Cina, a Heilongjiang e a Guangdong. Nel nordest della Cina, al
confine con la Russia, le autorità offrono una vera e propria taglia sugli
stranieri: 3000 yuan, circa 390 euro, per chi aiuta a beccare chi è entrato nel
paese illegalmente. Somma che sale a 5000 yuan, 650 euro, per chi li cattura e
consegna alle forze dell’ordine. Misure che prendono di mira gli
stranieri adottate dopo che la curva dell’epidemia è salita a causa del
cosiddetto contagio di ritorno da chi rientrava dall’estero, in particolare
dalla Russia. Nella provincia di Guangdong, a sud nella Cina, e in particolare
nella città di Guangzhou, a essere attenzionati sono gli africani, per la
maggior parte nigeriani. Gli africani infatti sono stati letteralmente buttati
fuori dalle case e dagli alberghi dove soggiornavano, come mostriamo in questo
video (clicca qui per vederlo), nonostante la maggior parte di loro non mettesse
piede fuori dal paese da tempo. A Guangzhou risiede la più grande comunità
africana in Cina, e la tensione sarebbe scoppiata quando si sono registrati dei
casi di coronavirus anche fra loro. Secondo la CNN, oltre ad aver cacciato dalle
proprie abitazioni diversi africani, che sono rimasti senza un tetto sotto cui
dormire, a molti è stato imposto il tampone e altri avrebbero dovuto fare la
quarantena, nonostante non fossero rientrati dall’estero. Il consolato americano
ha consigliato gli afroamericani di evitare di recarsi in viaggio in città.
Nella dichiarazione del consolato si legge che “la polizia ha ordinato ai bar e
ai ristoranti di non servire clienti che sembrano di origini africane”. Al
centro delle polemiche è finita anche McDonald’s, dopo che sui social è comparso
un video che mostrava come in uno dei punti della catena americana a Guangzhou
fosse stato esposto un cartello che recitava: “Siamo stati informati che d’ora
in poi le persone di colore non possono entrare nel ristorante”. McDonald’s, una
volta a conoscenza dell’accaduto, ha chiuso quel ristorante e ha chiesto scusa.
Il consolato americano inoltre informa che “le autorità locali hanno imposto
tamponi obbligatori e quarantene per chiunque abbia avuto ‘contatti africani’,
senza tenere conto se siano rientrati da un viaggio o meno”.
Letizia
Tortello per “la Stampa” il 28 aprile 2020. L' arma utilizzata per combattere
secoli di cultura patriarcale è Weibo, uno dei principali social network cinesi.
Un po' per caso, tra un blog e l' altro di questa piattaforma utilizzata da
milioni di persone, è nato il primo forum dedicato al tema delle madri che
vogliono attribuire il proprio cognome ai figli. Ed è diventato un successo: 29
milioni di visualizzazioni. Troppo esplosivo per non tirarsi subito dietro un
fiume di critiche. Già, le donne vogliono avere uguali diritti, hanno detto in
molti, poi non sono disposte ad assumersi gli oneri degli uomini, come ad
esempio pagare un mutuo. Ma sui social, la campagna per tramandare il cognome
materno ha fatto discutere anche con un altro post, diventato famoso tra gli
utenti di Weibo. Una donna raccontava di aver divorziato dal marito perché lui
si rifiutava di riconoscere al loro bimbo il suo nome: subito, 240 mila «mi
piace». E anche qui, furioso dibattito. La discussione è stata definita «troppo
estrema» anche da molte donne, che si vergognano di parlare di rivendicazioni
come queste in pubblico. Il governo controlla le comunicazioni e negli ultimi
anni ha dato un giro di vite su questi temi, punendo i movimenti femministi
perfino col carcere. Ma la battaglia per l' affermazione dei diritti femminili
cresce, di pari passo con la consapevolezza di molte donne di vivere in una
società profondamente diseguale, in matrimoni e famiglie in cui il figlio
maschio riceve molte più attenzioni e sostegni materiali, spesso vitali, della
femmina. Chi è in grado di tramandare il cognome, non ottiene solo favori, ma
anche l' eredità. La politica del figlio unico costata la vita a molte neonate,
in fin dei conti, in Cina è rimasta in vigore fino al 2013. Ancora oggi, come ti
chiami ha una bella importanza, come dimostra un' indagine condotta nel 2019
dalla All-China Women' s Federation, organizzazione no profit legata a Xi
Jinping: oltre l' 80% delle donne cinesi, nelle zone rurali, non vede nemmeno
comparire il proprio cognome sui documenti. Così com' era prima del 1950, quando
il governo comunista ha sancito il diritto per le spose di mantenere la propria
identità. Ora, il desiderio di non sparire si sposta sui figli. La legge già
consente di chiamare i bimbi col cognome materno, ma la cultura del
Confucianesimo fondato sul valore del patriarcato ha consolidato la tradizione
maschilista. Quando capita, il nome della madre passa al secondo nato, ma solo
nelle zone più ricche come a Shanghai (dove quasi un bambino su 10 ha ricevuto
il cognome materno nel 2018). Ben diversa è la situazione nelle campagne e nella
stragrande maggioranza della popolazione. Tanto che una delle portavoci di
questo movimento femminista alla cinese, la professionista della finanza di
Pechino Lydia Lin (270 mila seguaci su Weibo) ha capito che era il momento di
insorgere. Ha rilanciato la campagna nata con l' hashtag «nome della madre
tramandato» e ha fatto centro. Migliaia di millennial si sono fatte sentire con
coraggio: «Dobbiamo imporci nella nostra cultura, siamo qualcuno, possiamo
farcela, non subito, ma possiamo farcela!», è lo slogan. Perché virale non è
solo il Covid-19, ma anche la voglia di conquistare diritti.
Andrea Morigi per “Libero quotidiano” il 10 aprile 2020. Pechino
ha tutto sotto controllo, perfino le cornee, il fegato, il cuore, i reni e i
polmoni dei suoi cittadini. È tutto di proprietà dello Stato, in linea con la
dotttrina maoista. Quando si rende necessario, anche un corpo umano può
rientrare nella disponibilità del Partito comunista. Magari a pezzetti. Quando,
il 1° marzo scorso, nell' Ospedale del Popolo di Wuxi, nella provincia dello
Jiangsu, ha annunciato l' esecuzione, avvenuta il giorno precedente, 29 febbraio
di un trapianto di polmoni a un malato di coronavirus, all' associazione
internazionale di medici contro il prelievo forzato di organi, la Dafoh, hanno
acceso i riflettori. Ieri, durante una conferenza stampa online. la dottoressa
Katerina Angelakopulou, rappresentante della Dafoh in Italia, ha sollevato il
caso di almeno altre otto operazioni di trapianto: dieci in tutto. Il primo
intervento era stato eseguito su un uomo da un' équipe medica guidata dal dottor
Chen Jingyu Liang Tingbo, uno dei principali chirurghi per trapianti di organi
in Cina. Ufficialmente, si fa risalire il prelievo a un donatore della provincia
centrale cinese dello Hunan e sono stati trasportati per via aerea. Alla prima
operazione ne fanno seguito altre tre: il primo, l' 8 e il 10 marzo. Nello
stesso tempo, entra in azione anche il team del First Affiliated Hospital della
Scuola di Medicina della Zhejiang University, guidato dal dottor Liang Tingbo,
uno dei principali chirurghi per trapianti di organi in Cina nonché capo del
Partito comunista cinese presso l' ospedale. Gli organi trapiantati provenivano
da un donatore della provincia centrale cinese dello Hunan e sono stati
trasportati per via aerea a Hangzhou. Una reperibilità improvvisa di organi in
così poco tempo ha del miracoloso. Senza considerare le difficoltà di un Paese
in emergenza sanitaria, in Cina vi sono appena 1,35 milioni di donatori per una
popolazione di più di 1,4 miliardi di persone. Una percentuale irrisoria.
Oppure, come ha rivelato la vicepresidente della U.S. Commission on
International Religious Freedom (USCIRF), Nadine Maenza, in un' intervista al
quotidiano The Epoch Times, l' unico modo in cui i polmoni trapiantati possono
essere giunti al malato, è attraverso la predazione su prigionieri di coscienza.
Ma secondo i protocolli internazionali di chirurgia, che prevedono la massima
trasparenza sulla donazione, in Cina i dati dovrebbero essere rintracciabili nel
China Organ Transplant Response System (COTRS), un sistema informatico unificato
per il reperimento e l' assegnazione di organi in Cina. La trasparenza, del
sistema sanitario cinese in realtà è scarsa. Huang Jiefu, direttore del Comitato
cinese per i trapianti e le donazioni di organi, aveva assicurato alla fine del
2014 che, a far data dal primo gennaio 2015, sarebbe cessata definitivamente la
predazione sugli organismi dei condannati a morte. Si trattava più di un'
ammissione rispetto al passato che di una garanzia per il futuro.
Da rainews.it
il 16 marzo 2020. Scompare, in Cina, il magnate Ren Zhiqiang, noto per le sue
critiche esplicite al presidente Xi Jinping, dopo un nuovo durissimo attacco al
leader cinese, definito un "pagliaccio" affamato di potere per la gestione
dell'epidemia e per il bavaglio messo a chi per primo aveva lanciato l'allarme
riguardo al nuovo coronavirus. Lo scrive il New York Times, citando amici
dell'ex imprenditore che si dicono preoccupati per la sua scomparsa. "Siamo
molto preoccupati per lui. Continuerò a cercarlo", ha dichiarato una ex
imprenditrice Wang Ying, sua amica. Anche un docente dell'Università del Popolo
di Pechino, Zhang Ming, citato oggi dal South China Morning Post, ha dichiarato
di non essere in grado di contattare l'amico. Ren, fino al 2014 a capo del
gruppo immobiliare Huayuan Properties, non è nuovo ad attacchi contro Xi, che
gli fecero guadagnare il soprannome di "cannone": nel 2016, ne criticò la visita
ai principali media statali per chiedere un maggiore allineamento alla linea del
Partito Comunista. I media, fu la obiezione allora, dovrebbero servire il
popolo, che paga le tasse, e non il partito. Dopo questa critica, il suo account
Weibo, il Twitter cinese dove aveva 37 milioni di followers, venne bloccato.
Egli stesso membro del Pcc e figlio di un esponente dei rivoluzionari della
prima ora che contribuirono a fondare la Repubblica Popolare Cinese, Ren
Zhiqiang ha attaccato direttamente l'immagine di Xi, leader vittorioso nella
"guerra di popolo" contro il coronavirus in un saggio circolato tra le elite di
Pechino. Non è chiaro se la sua scomparsa sia direttamente collegata
all'articolo, ma il magnate ha usato toni durissimi: nella traduzione fornita
dal sito web China Digital Times, Ren fa riferimento alla videoconferenza tenuta
da Xi di fronte a circa 170mila funzionari del Pcc il 23 febbraio scorso e
scrive che "ho visto non un imperatore che esibiva le sue nuove vesti, ma un
pagliaccio che si è spogliato nudo e che insisteva a continuare a essere
imperatore". Il discorso di Xi, mai citato esplicitamente per nome, rifletteva
anche "una crisi di governance all'interno del partito" a detta del magnate
pechinese e lasciava aperti interrogativi sui fatti antecedenti al primo
intervento del presidente cinese nella crisi, fatto risalire al 7 gennaio
scorso. Il Pcc, ha scritto Ren, ha tenuto nascosta la causa dell'epidemia e ha
usato il suo potere per ingannare l'Oms e ottenere il plauso a livello
internazionale. I cinesi, ha aggiunto, sanno che "questa epidemia e tutta
l'inutile sofferenza che ha portato provengono direttamente da un sistema che
proibisce la libertà di stampa e di parola".
·
Quei razzisti come i Vietnamiti.
Raimondo
Bultrini per “la Repubblica” il 12 maggio 2020. Crescete e moltiplicatevi. È l'
esplicito invito del primo ministro del Vietnam comunista, Nguyen Xuan Phuc, che
sull' onda dell' entusiasmo per aver sconfitto - primo tra gli asiatici - il
coronavirus, si è rivolto ai suoi cittadini affinché facciano figli per il bene
della nazione, annunciando speciali bonus ai futuri papà e mamme che lo faranno
in giovane età. Le decisioni prese al massimo livello e comunicate a fine
aprile, assegnano al Comitato Centrale il ruolo di paraninfo, di un vero e
proprio cupido tra le cui frecce sono stati inclusi decreti come quello sulla
creazione di "luoghi d' incontro" per i candidati sposi, facilitazioni per rette
di asili, scuole e appartamenti. Ma sono previste anche penalizzazioni per chi
non segue il consiglio governativo e si sposa dopo i 30 anni, come ha spiegato
il premier in fondo al testo del suo comunicato pubblico col quale fissa a 35
anni l' età massima delle donne per avere il secondo figlio. Il suo decreto
indica la necessità di mantenere un tasso di fertilità totale compreso tra i 2 e
i 2,2 bambini per ogni donna (oggi è del 2,04), aumentandolo «nelle aree dove è
attualmente troppo basso e viceversa ». Ma è proprio sul viceversa che sono
sorti i dubbi di organizzazioni umanitarie e dissidenti. Nel piano di aiuti alle
coppie annunciato da Nguyen non c'è accenno al come si farà a convincere le
genti di antiche etnie e regioni "eccessivamente" prolifiche a ridurre il numero
di figli, spesso indispensabili per garantire il diritto sancito dalla
costituzione a ereditare l' usufrutto delle terre. Gruppi popolosi spesso con un
milione di anime ciascuno hanno subìto in passato la forte pressione demografica
- e parecchi abusi - della maggioranza Kinh, o Viet, l' 85% dei 95 milioni di
abitanti. Tra questi i Cham (di origine islamica) i Khmer Krom indo- buddhisti,
i Montagnard, o Degar, in alte percentuali seguaci del cristianesimo come i
Hmong. Altri vedono dietro alla mossa del partito anche un tentativo di
mantenere salda l' etnia di maggioranza per frenare la minaccia sempre più
incombente di una nuova potenziale "invasione" han cinese, come quelle ben
impresse sui libri di storia dove si insegna a diffidare del più popoloso paese
dell' Asia sotto qualunque bandiera si presenti. È stato grazie a questo
scetticismo che ha subito convinto politici e scienziati vietnamiti a
mobilitarsi per monitorare i contagi di coronavirus previsti in arrivo. Per ora
è solo una coincidenza il fatto che l' invito ufficiale a fare più figli giunga
all' apice di questa battaglia apparentemente vinta anche grazie ad app di
tracciamento scaricate da gran parte della popolazione senza proteste. Il
partito sa bene che è nel Dna della sua gente la disponibilità a unirsi nei
momenti di emergenza. Ora bisognerà vedere se seguiranno anche le nuove
direttive. Il primo ministro affida alle autorità locali la scelta del tipo di
club di incontri - bar, sala da tè, discoteche. Saranno impiegati consulenti
matrimoniali per incoraggiare i fidanzamenti e spiegare alle coppie i vantaggi
di avere due figli in età giovanile in cambio di accesso prioritario alle
scuole, sostegno finanziario e alloggi sociali. Per chi si attarda, le
istruzioni prevedono un innalzamento dei «requisiti per ottenere il contributo
sociale». I vietnamiti tra 15 e i 64 anni sono il 68% della popolazione. La
popolazione è cresciuta di 10,4 milioni tra il 2009 e il 2019, e secondo l' Oms
i giovani fanno in media sesso per la prima volta tra i 16 e i 17 anni, con l'
effetto di un tasso di aborti tra i più alti del mondo.
·
Quei razzisti come i Nord Coreani.
Tutti i
segreti nucleari di Kim.
Per gentile
concessione di Salerno editrice pubblichiamo un estratto di La Corea di Kim.
Geopolitica e storia di una penisola contesa di Stefano Felician Beccari.
Stefano Felician Beccari, Martedì 10/11/2020 su Il Giornale. Per gentile
concessione di Salerno editrice pubblichiamo un estratto di La Corea di Kim.
Geopolitica e storia di una penisola contesa di Stefano Felician Beccari.
La Corea del Nord vanta il non piacevole primato di essere il solo stato al
mondo a effettuare test atomici nel XXI secolo e probabilmente uno dei piú
attivi in materia di proliferazione nucleare, ovvero il rapido aumento del
proprio arsenale nucleare. Ma per inquadrare correttamente la dimensione
militare della Corea del Nord occorre allontanare lo sguardo dal mero elemento
militare (arsenale disponibile, vettori, numero di testate, presenza di armi
termonucleari) o da quello scientifico (esperimenti svolti, portata) per
esaminare quali siano le ragioni che hanno spinto la Corea del Nord a creare
questo arsenale e quali siano le implicazioni che sostengono, ancora oggi, una
scelta ritenuta moralmente inaccettabile agli occhi della comunità
internazionale. Come ricorda Clemens, la «ricerca di una capacità nucleare è un
elemento perdurante nella politica nordcoreana» e praticamente si può far
risalire alla creazione della stessa Corea del Nord. Anzi, la minaccia del
generale MacArthur di usare le armi nucleari nel conflitto coreano (« il suo
dito era sul grilletto nucleare») retrodata indirettamente la “presenza”
nucleare nella penisola ai primi anni '50. Con il ricordo ancora vivido dei
bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki di pochi anni prima e conscio delle
implicazioni geopolitiche, militari e morali che l’uso delle armi nucleari
avrebbe avuto, l’allora presidente Truman decise di rimuovere MacArthur proprio
perché in disaccordo con l’opzione suggerita dal generale. Lo spettro nucleare,
quindi, da quel momento iniziò a stagliarsi sulla penisola coreana. Dopo la
guerra, già negli anni ’50, Kim Il-sung chiese ripetutamente ai sovietici la
fornitura di capacità nucleari civili, cosa cui Mosca acconsentí sulla base di
alcuni accordi bilaterali. Negli anni ’60 venne cosí costruito il famoso
reattore di Yongbyon, principale installazione nucleare della Corea del Nord e
spesso al centro delle polemiche inerenti alle capacità atomiche di Pyongyang.
Il progressivo isolamento del Nord negli anni ’70 e poi ’80 portò a una latente
sfiducia della leadership del Nord nei confronti dei due importanti vicini, e
consolidò quindi le intenzioni di Kim Il-sung di rafforzare autonomamente il
programma nucleare, andando ben oltre i legittimi scopi civili inizialmente
prefissati; eppure, sotto le pressioni sovietiche, nel 1985 Pyongyang firmò il
Trattato di non proliferazione nucleare (Npt). L’opzione nucleare sembrava
allontanarsi dalla penisola quando, nel 1991, gli Stati Uniti ritirarono le
proprie armi nucleari dal Sud; una seguente dichiarazione fra le due Coree
(1992, Dichiarazione congiunta sulla denuclearizzazione della penisola di
Corea) sembrava quindi chiudere la porta a ulteriori sviluppi nucleari. Gli
intenti, per quanto nobili, furono ben presto perturbati dalla reticenza del
Nord a permettere le ispezioni dell’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica
(Iaea) e dalla minaccia di abbandonare il Npt; nel 1993 il tentativo di
abbandono venne evitato in extremis, ma rappresentò un pericoloso precedente
nella travagliata storia nucleare del Nord. In cambio Pyongyang ricevette aiuti
in petrolio e altre risorse, disperatamente necessarie vista la pesante crisi
che si era abbattuta sul paese. Nel corso degli anni ’90, data la grave
situazione interna, il programma nucleare non fece grandi passi avanti; con
l’arrivo del XXI secolo, invece, vi fu una ripresa di attività che perdura
praticamente sino ad oggi, ed è stata contrassegnata dal ritiro della Corea del
Nord dal Npt (2003) e dall’ammissione della presenza di un programma militare
nucleare. I successivi tentativi di negoziazione con Pyongyang nell’ambito dei
cosiddetti “dialoghi a sei” (Six-Party Talks, che coinvolgono Usa, Cina, Russia,
Giappone e le due Coree), nonostante le iniziali premesse positive, non ebbero
riscontri concreti; anzi, il primo esperimento di un ordigno nucleare, avvenuto
il 9 ottobre 2006, segnò la “definitiva” conquista dell’arma atomica da parte di
Pyongyang. Per quanto la potenza dell’ordigno fosse limitata (meno di un
kilotone) la “linea rossa” sembrava ormai passata, e la retorica del governo
esaltava con forza l’importante successo della tecnologia nordcoreana.
L’immediata adozione di sanzioni da parte delle Nazioni Unite iniziava una
procedura “standard” che è rimasta in vigore fino ad oggi, e che ha sempre visto
aumentare il peso delle costrizioni internazionali dopo i vari esperimenti
nucleari del Nord, in un insieme complesso di negoziazioni e
contro-negoziazioni, aperture e minacce, tensioni e momenti di détente: il
risultato finale, però, non è stato quello dell’agognata denuclearizzazione
della penisola. Anzi, nel corso degli anni Pyongyang ha lentamente ma
costantemente insistito con la sua capacità nucleare effettuando diversi altri
test che sono stati puntualmente criticati dalla comunità internazionale e anche
dalla stessa Cina. L’arrivo al potere di Kim Jong-un non ha rallentato il ritmo
dei test, ma anzi, in forza dell’approccio ideologico “informalmente” adottato
dal terzo Kim, ha portato un loro intensificarsi, fino al culmine del 2016, in
cui vennero testati due ordigni. L’ultimo test, in ordine cronologico, è quello
del 3 settembre 2017, quando la Corea del Nord ha annunciato di aver testato
nientemeno che una bomba all’idrogeno (nota anche come bomba H o bomba
termonucleare), un salto in avanti notevole per l’arsenale di Pyongyang. Gli
ultimi test, frutto anche delle crescenti tensioni geopolitiche, hanno
continuato a catalizzare le critiche internazionali, portando a un inasprimento
delle sanzioni e a un sostanziale isolamento del paese. Ma allora, viene da
chiedersi, per quale motivo la Corea del Nord sta così insistentemente
continuando la sua ricerca nucleare?
Francesco De Remigis per “Il Giornale”
il 26 ottobre 2020.
Quando arrivò sugli schermi «The Interview», la commedia prodotta
dalla Sony che metteva in scena l' uccisione di Kim Jong-un, la reazione
nordcoreana si spinse fino a un hackeraggio dei server della major. Era solo
fiction. L' attacco riuscì e si cancellò la «prima». Sei anni dopo, un copione
diverso imbarazza Pyongyang. Un docu-film coprodotto dalla Bbc che proverebbe l'
elusione delle sanzioni internazionali sulla vendita di armi da parte del
regime. Protagonista uno chef, il danese Ulrich Larsen, oggi 44enne,
infiltratosi per dieci anni in un' associazione pro Corea del Nord. Infine
giunto, a detta sua, a negoziare contratti con emissari di Kim Jong-un. Il
giorno dopo la messa in onda, lo scorso 13 ottobre, i ministri degli Esteri
danese e svedese hanno detto di voler portare il girato alle Nazioni Unite. Per
Hugh Griffiths, ex coordinatore della commissione Onu sulla Corea, il
documentario «The Mole» è altamente credibile. «Tutto falso» per il regime. Ma
chi c'è dietro l'opera che sta facendo vacillare Pyongyang? Un cuoco disoccupato
che s' inventa un mestiere. Infiltrarsi in Corea e smascherare triangolazioni
per vendere armi pesanti al miglior offerente. Tutto comincia dieci anni fa.
Larsen vede un film su un viaggio in Corea del connazionale Mads Brügger, «The
Red Chapel», e contatta il cineasta chiedendogli di continuare il lavoro. Da
chef in degenza si trasforma in 007. Nel 2009 si unisce a una filiale della
Korean Friendship Association (Kfa). Si guadagna la fiducia del capo, si
«cucina» un intermediario spagnolo. Recluta un altro personaggio per
interpretare un uomo d' affari scandinavo con molti soldi e senza morale. Con
costui, vola in Corea dove, in un bunker, alcuni funzionari mostrano un «menu»
di armi, missili, carri armati da acquistare. Un altro aspetto del film, d'
interesse per l' Onu, è l' apparente coinvolgimento di diplomatici per schivare
le sanzioni. In una sequenza, Larsen è all' ambasciata a Stoccolma, riceve i
piani di un progetto in Uganda da tale Mr Ri. Filma tutto con telecamere
nascoste. Mr Ri chiede discrezione: «Se accade qualcosa, l' ambasciata non ne sa
niente, ok?».
Come è andata la parata militare di Kim Jong-un.
Federico Giuliani su Inside Over l'11 ottobre 2020. La commozione
di Kim Jong Un nel corso di un raro discorso presidenziale tenuto in pubblico in
un elegante completo occidentale grigio. Le parole al miele usate dal leader
nordcoreano per augurare una pronta guarigione alle persone di tutto il mondo
che stanno combattendo contro il coronavirus. I ringraziamenti ai soldati per il
loro impegno nella lotta contro l’epidemia di Covid-19, nella quale la Corea del
Nord ha dichiarato di non avere registrato contagi, e contro i disastri naturali
che hanno colpito il Paese nelle scorse settimane. E ancora: la speranza che le
due Coree possano presto tornare a “tenersi per mano”. È un Kim in formato
inedito quello che si è affacciato dal balcone della Grande Biblioteca del
Popolo di Pyongyang, di fronte a una mastodontica folla formata da militari e
cittadini festanti in occasione del 75mo anniversario della fondazione del
Partito dei Lavoratori. Primo particolare subito balzato all’occhio: nessuno
alla parata militare indossava mascherine né rispettava il distanziamento
sociale. Il motivo lo ha probabilmente spiegato poco dopo lo stesso
presidentissimo nordcoreano. “Grazie per essere in salute – zero contagi da
Covid-19 – grazie molte”, ha dichiarato il leader rivolto al suo popolo.
Insomma, a sentire le autorità locali, in Corea del Nord “neanche una sola
persona” sarebbe stata contagiata dal coronavirus.
La commozione di Kim. In ogni caso, al di là dell’aspetto
sanitario, è importante analizzare il discorso di Kim. Il presidente si
è scusato in prima persona per le difficoltà economiche del Paese, di cui
attribuisce la responsabilità alle sanzioni “dure e di lunga durata” a cui è
sottoposta la Corea del Nord per lo sviluppo del suo programma nucleare, oltre
che alla pandemia di Covid-19 e ai disastri naturali. “Mi vergogno di non essere
stato in grado di ripagarvi appropriatamente della vostra fiducia”, ha detto in
un passaggio il leader nordcoreano. “I miei sforzi e la mia devozione non sono
stati in grado di portare la nostra gente fuori dalle difficoltà di
sostentamento”, ha poi concluso. Kim ha quindi ringraziato i soldati per la loro
“devozione patriottica” sia sul fronte della quarantena che su quello dei
“soccorsi in caso di catastrofi naturali”. Una devozione che “non può essere
trattata senza lacrime di gratitudine”. Kim è apparso commosso nel pronunciare
queste parole, e ha persino faticato a trattenere le lacrime. Per la prima volta
il leader nordcoreano ha mostrato il suo lato “umano”, tradendo l’aura
divina che ha sempre circondato la famiglia Kim. E questo è un aspetto inedito,
probabilmente motivato da una precisa strategia politica da parte di Pyongyang.
In vista dell’imminente futuro è probabile – si possono fare soltanto ipotesi –
che la Corea del Nord stia pensando di riallacciare i rapporti con Washington.
Dal momento che ancora non sappiamo quale sarà il prossimo presidente americano,
non è da escludere che Kim Jong Un voglia apparire subito come leader
responsabile prima che qualcuno possa affermare il contrario. Soprattutto se i
colloqui futuri dovessero avvenire con Joe Biden e non con Donald Trump.
La parata militare. L’ultimo aspetto da considerare riguarda
la sfilata militare, l’evento più atteso della giornata assieme al discorso di
Kim. Il leader ha spiegato che la Corea del Nord rafforzerà il suo apparato
militare per contrastare i pericoli, tra cui anche la minaccia nucleare.
“Continueremo a rafforzare la deterrenza bellica per impedire, controllare e
gestire tutti gli attentati pericolosi e gli atti intimidatori, incluse le
minacce nucleari in costante crescita dalle forze ostili”, ha scandito Kim. Dopo
il suo intervento le telecamere della televisione di stato hanno inquadrato la
grande piazza. Due sono le nuove armi mostrate da Pyongyang al mondo intero: un
inedito tipo di missile balistico intercontinentale (Icbm) a 11 assi e un
missile che si lancia da sottomarino (Slbm). “Sono assolutamente enormi. Si
tratta probabilmente dei missili balistici intercontinentali mobili più grandi
mai costruiti”, ha dichiarato un’analista al sito NkNews. Kim, mantenendo
l’aplomb di abile statista, ha tuttavia spiegato che i suoi militari non
attaccheranno mai per primi un’altra nazione. Al contrario, nel caso in cui la
Corea del Nord dovesse essere attaccata, “useremo tutto per rispondere”.
Manila Alfano per “il Giornale” il 13 Ottobre 2020. Le lacrime di
Kim Jong-un. Ovvero, anche i cattivi piangono. Era già successo nel 2011 in
realtà, alla morte del padre. Il giovane erede ha da sempre un approccio più
emozionale con il suo popolo, discorsi emotivi, motivazionali. Venerdì scorso,
nella gigantesca, scenografica parata hanno sfilato per le via di Pyongyang le
nuove armi strategiche, un nuovo missile balistico intercontinentale. Ma quello
che ha fatto il giro del mondo è il suo volto rigato dalle lacrime. Commozione o
piuttosto una colossale messinscena? Che sia l' effetto di quella malattia
tenuta il più possibile segreta che lo stia rendendo fragile? Antonio Razzi, che
lo conosce bene giura sulla sua assoluta buonafede. «Sono state sicuramente
sincere, perché ha un cuore grande». Eppure bisognerebbe ascoltare i racconti
terrificanti dei pochi fuggitivi dal regime per capire il cuore di Kim. E poi,
come se non fosse già abbastanza sconcertante vederlo commosso, anche le scuse.
Il dittatore nordcoreano si è scusato per non esser stato sempre all' altezza
delle aspettative dei suoi concittadini. È successo sabato, davanti a centinaia
di occhi strabuzzanti, durante la parata militare per i 75 anni dalla fondazione
del Partito dei Lavoratori, al potere nel Paese; e a giudicare dalle immagini,
il giovane dittatore ha avuto anche un moto di commozione. «La nostra gente ha
riposto fiducia in me, ma non sono riuscito ad essere sempre all' altezza. Mi
dispiace davvero per questo». Completo grigio chiaro d' ordinanza e occhiali da
vista ben piantati, la pelle lucida e sudata, sintomo di un' emozione non
filtrata, Kim si è scusato per le difficoltà che sta affrontando il Paese. Un'
occasione perfetta per poi incolpare gli altri della situazione in cui versa da
anni il suo Paese allo stremo delle forze. Si è scagliato contro le sanzioni
«dure e di lunga durata» a cui è sottoposto il regime per lo sviluppo dei suoi
programmi missilistici e nucleari; una crisi a cui si aggiungono le difficoltà
derivanti dalla pandemia di Covid-19 e dai disastri naturali che hanno
recentemente colpito il Paese. «Mi vergogno di non essere stato in grado di
ripagarvi appropriatamente della vostra fiducia», ha detto in un passaggio. «I
miei sforzi e la mia devozione non sono stati in grado di portare la nostra
gente fuori dalle difficoltà di sostentamento». «La nostra gente ha riposto in
me un livello di fiducia profondo come il mare ma ho fallito nel ripagarlo
sempre in modo soddisfacente». Kim ha ringraziato i soldati per gli sforzi nel
contenimento dell' epidemia di Covid-19 e nel soccorso alle aree colpite dai
disastri naturali. Motivo di orgoglio a livello ufficiale, per il giovane
dittatore, sarebbe l' assenza di contagi, «zero casi». «Grazie per essere in
salute grazie molte», ha proclamato durante il suo discorso, arrivando a fare
gli auguri alla vicina Corea del Sud per una veloce ripresa dalla pandemia.
Secondo l' agenzia Kcna, né il leader né i presenti hanno indossato la
mascherina. Per mesi, la situazione del contagio nel Paese è rimasta poco chiara
e i continui annunci da parte dei media statali sull' assenza di infezioni, non
hanno fatto altro che rinvigorire le convinzioni opposte degli scettici. «Non
una sola persona ha contratto il virus», Kim ha promesso che continuerà a
rafforzare l' apparato militare e non sono mancati toni anche più forti. Eccolo,
il vecchio volto. Quello a cui il suo popolo è abituato da sempre.
Cosa nascondono le lacrime di Kim Jong Un.
Federico Giuliani su Inside Over il 13 ottobre 2020. Mentre stava
parlando al pubblico in occasione del 75esimo anniversario della fondazione del
Partito dei Lavoratori, Kim Jong Un si è sfilato gli occhiali color mogano e ha
lasciato scendere dai suoi occhi quelle che sembrerebbero
essere lacrime sincere. Un gesto insolito per il presidente della Corea del
Nord, a maggior ragione se consideriamo il contesto. In diretta nazionale, dal
balcone della Grande Biblioteca del Popolo di Pyongyang, nella centralissima Kim
Il Sung Square, gremita in ogni ordine di posto da soldati di ogni guarnigione,
Kim si è scusato con il proprio popolo. Lacrime e scuse: un doppio gesto
insolito che ha sorpreso gli osservatori di tutto il mondo. A dire il vero non è
la prima volta che Kim Jong Un viene visto piangere. È successo nel 2011 durante
il funerale di suo padre Kim Jong Il e, più recentemente, nel 2015, quando il
Grande Maresciallo ha salutato per l’ultima volta Kim Yang Gon, gerarca morto in
un incidente d’auto. In quest’ultima occasione Kim si è chinato sul feretro,
sfiorando il volto del defunto e versando qualche lacrima. Attenzione però,
perché eventi del genere sono pressoché unici nel loro genere. In Corea del
Nord tutti i Kim, dal presidente eterno Kim Il Sung a Kim Jong Un, fanno parte
della sacra famiglia che proviene dal Monte Paektu, monte venerato da tutti i
coreani e annoverato tra i simboli nazionali del Paese. Questo significa che Kim
Jong Un non è soltanto un capo politico, come potrebbe essere un qualsiasi
presidente di un qualsiasi Paese al mondo. È anche una specie
di semidio incaricato di guidare il popolo (nord)coreano verso la prosperità.
Il legame con il popolo. Ci sono due chiavi di lettura che
possono essere usate per spiegare le lacrime versate da Kim Jong Un. La prima
riguarda il legame tra il presidente nordcoreano e il popolo, che è molto più di
una semplice relazione sovrano-suddito. È come se Kim fosse il padre putativo di
ogni singolo cittadino della Corea del Nord, colui che appartiene alla famiglia
che ha dato origine al popolo nordcoreano e che ha il dovere di salvaguardarne
l’esistenza. Secondo il confucianesimo, filosofia morale che influenza
l’ideologia ufficiale del Paese, il principe ideale dovrebbe possedere una virtù
elevata all’ennesima potenza, traducibile come benevolenza. Ebbene, il sovrano
deve curare innanzitutto il benessere del popolo. Tornando al discorso di Kim,
la parte più toccante è stata quella in cui il presidente ha affermato di non
“essere stato in grado di ripagare l’enorme fiducia” che il popolo aveva riposto
in lui. Per questo è arrivato persino a vergognarsi. “La nostra gente ha riposto
fiducia in me, alta come il cielo e profonda come il mare, ma non sono riuscito
ad essere sempre all’altezza in modo soddisfacente. Mi dispiace davvero per
questo”, ha dichiarato il leader. È possibile che in un momento particolarmente
complesso Kim abbia scelto volutamente di “umanizzarsi”, di scendere dal
piedistallo dal quale ha sempre guardato la Corea del Nord e di comunicare ai
cittadini da pari a pari. Quello apparso sabato non era la figura di un
presidente infallibile ma di un padre che sa di aver commesso degli errori
nonostante l’impegno messo in campo. La pandemia di Covid-19 ha isolato ancora
di più la Corea del Nord, costringendo il popolo a enormi sacrifici, mentre le
violente inondazioni potrebbero aver dato il colpo di grazia alla nazione. Non a
caso nei giorni in cui la parte meridionale del Paese era travolto dalle
inondazioni, Kim è stato fotografato a bordo di un suv in mezzo ai contadini, e
poi perlustrare alcune abitazioni colpite dal maltempo con addosso una
semplice t-shirt bianca a maniche corte.
La strategia comunicativa. L’altra chiave di lettura riguarda il
piano prettamente geopolitico. Nel mostrarsi fragile come ogni uomo, Kim
potrebbe aver voluto lanciare un messaggio al mondo intero, facendo capire di
essere un leader coscienzioso ed empatico. Non è infine da escludere il fatto
che Kim Jong Un possa sentirsi sotto pressione in uno dei periodi più duri da
quando è al comando del Paese, tra l’economia in affanno e la leadership –
secondo alcune voci non confermate – minata dall’ascesa della sorella Kim Yo
Jong. Certo è che, da quando è riapparso dopo essere stato per morto, Kim ha
totalmente cambiato atteggiamento, così come il suo modo di porsi. Vedremo quale
sarà la prossima mossa di Pyongyang.
(ANSA il 7
ottobre 2020) L'ex incaricato d'affari presso l'ambasciata nordcoreana a Roma,
Jo Song-gil, scomparso a fine 2018, si trova in Corea del Sud. "Si è scoperto
che l'ex ambasciatore (ad interim) Jo Song-gil è entrato in Corea del Sud a
luglio 2019 ed è sotto la protezione delle autorità", ha scritto su Facebook il
deputato di opposizione Ha Tae-keung, del People Power Party. Diverse fonti
citate dalla Yonhap hanno poi confermato che Jo ha trovato rifugio al Sud con la
moglie dopo il passaggio in un Paese terzo. Se confermato in via ufficiale, Jo
sarebbe uno dei massimi funzionari del Nord a disertare al Sud.
(ANSA il
21.02.2019) - "Chiedetelo al ministero degli esteri, è una questione di
ambasciate. Io non ne sapevo nulla, non c'entro nulla". Così il ministro
dell'Interno Matteo Salvini ha risposto a 'Radio Anch'io' ad una domanda sulla
vicenda della figlia dell'ex ambasciatore nord coreano a Roma che è stata
rimpatriata dopo la diserzione dei genitori. Il ministro ha sottolineato che non
andrà dunque a riferire sulla vicenda in Parlamento, come chiesto da diversi
esponenti dei Cinquestelle. "Se c'è una ragazza che è voluta tornare dai nonni
nel suo paese - ha detto - ha preso un aereo di linea arrivando tranquillamente
in aeroporto, superando i controlli di polizia e facendo il check in senza dire
nulla, cosa c'entra il ministro dell'Interno?". Dunque "è un problema di
rapporto tra ambasciate" e la questione va posta al ministro degli esteri. "Io
vado a riferire su quello che è di mia competenza e di mia conoscenza - ha
concluso Salvini - Qui non ne sapevo un accidente e non c'entravo un accidente.
Cosa vado a riferire?"
C. Man.
per “il Messaggero” il 21.02.2019. Sono mesi che il destino di Jo Song-gil, il
diplomatico nordcoreano sparito nel nulla dalla sede di Roma, resta un mistero.
Ma ora il giallo diventa ancora più fitto, perché nella vicenda si è inserita
una nuova sparizione, quella della figlia di 17 anni, che viveva con lui, la
madre e studiava nella Capitale. «È stata rimpatriata», ha detto in una
conferenza stampa a Seul Thae Yong-ho, ex viceambasciatore a Londra di Pyongyang
e a sua volta disertore, spiegando di essere riuscito a verificare la notizia
con delle fonti interne. «Ora si trova in Corea del Nord sotto il controllo
delle autorità», ha aggiunto. Non è chiaro, però, se la ragazza sia stata
riportata con la forza a Pyongyang dagli 007 di Kim Jong-un oppure se sia
rientrata volontariamente. Ci sarebbe un video che mostra la sua partenza da
Fiumicino. Ce n' è abbastanza, comunque, per creare fibrillazione nella
maggioranza di governo: il M5S ha parlato di «fatti gravi», chiedendo al
ministro dell' Interno Matteo Salvini di riferire in Parlamento.
LE DATE.
Quello che è certo è soltanto che Jo è tra le figure di maggior peso nella
nomenclatura del Nord ad aver optato per la diserzione. Anche se per Pyongyang
le cose sono andate diversamente: Jo e la moglie hanno lasciato l' ambasciata di
Roma il 10 novembre e la figlia è rientrata di sua volontà 4 giorni dopo, perché
aveva chiesto di stare con i nonni. O almeno questo è quanto la sede diplomatica
nordcoreana ha comunicato, ma a cose fatte, alla Farnesina, il 5 dicembre, come
riferito dallo stesso ministero degli Esteri. Di certo per fare chiarezza su
quei 20 giorni di novembre mancano ancora diversi tasselli. Si sa però che in
campo è entrata l' intelligence italiana, e la conferma arriva dall'
interessamento del Copasir che si è attivato da tempo e segue con attenzione la
vicenda. E allora, viene spiegato, che sia l' ambasciatore Jo sia la moglie, una
volta stabilito il contatto con i nostri 007, sono stati messi a conoscenza dei
rischi che poteva correre la ragazza alla luce delle loro scelte. Questo però
non avrebbe cambiato la loro volontà di disertare e i due si troverebbero
tuttora sotto la protezione dei servizi segreti italiani, anche se non è chiaro
se siano ancora nel nostro paese o in un altro vicino. La protezione di cui
godono, infatti, sarebbe anche il frutto di una iniziativa concordata con altri
stati occidentali. Resta comunque l' ombra di un possibile blitz degli agenti
segreti di Kim in territorio italiano, e questo ha già messo in allarme i 5
Stelle, con il rischio che si apra un nuovo fronte nei fragili equilibri di
governo con la Lega. «La storia di Jo Song-gil e di sua figlia, rapita dall'
intelligence nordcoreana in Italia, se confermata, sarebbe un caso di una
gravità inaudita e chi ha responsabilità pagherà», ha avvertito il
sottosegretario agli Esteri Manlio Di Stefano. Evocando un nuovo caso
Shalabayeva, la moglie del dissidente kazako rimpatriata dal suolo italiano tra
mille polemiche. Altri deputati pentastellati, a partire dalla vicepresidente
della Camera Maria Edera Spadoni, hanno chiesto al ministro Salvini di «chiarire
in aula quanto prima». Così come l' opposizione, dal Pd a Leu, da Forza Italia a
Fratelli d' Italia. «Non sono sicuro di quanti figli avesse Jo, ma quella che
era in Italia è stata rimandata in Corea del Nord - insiste Thae Yong-ho - Jo è
attualmente con la moglie», e si trova probabilmente ad affrontare una
«situazione difficile, nella quale non gli è possibile far sapere dove si trovi
o apparire in pubblico per il timore legato alla sicurezza della figlia».
LA CARRIERA Jo
Song-gil era arrivato in Italia con un nuovo mandato diplomatico a maggio del
2015, divenendo incaricato d' affari e quindi reggente della sede fino a
novembre 2018, a seguito dell' espulsione dell' ambasciatore Mun Jong-nam a
ottobre 2017 in risposta al sesto test nucleare fatto dal Nord appena un mese
prima. «Non posso più dirgli pubblicamente di venire in Corea del Sud», conclude
Thae, ricordando che il Nord è solito procedere ad aspre ritorsioni nei
confronti dei familiari delle persone che decidono di disertare a Seul piuttosto
che in Paesi terzi.
Cristiana
Mangani per “il Messaggero” il 21.02.2019. Sono usciti a poca distanza l' uno
dall' altra, i coniugi Song-gil. Hanno lasciato l' ambasciata della Nord Corea
il 10 novembre scorso, abbandonando l' Eur a piedi, mentre la loro figlia di 17
anni è rimasta sola all' interno della sede diplomatica. Abbandonata dai
genitori che cercavano una via di fuga dal rientro in patria sperando in una
accoglienza da parte degli Stati Uniti. Invece, il governo Trump, per ora,
avrebbe scelto di non farsene carico. Probabilmente perché in piena trattativa
politica con l' ex nemico Kim John-un. E per questo, il diplomatico avrebbe
chiesto protezione ad altri organismi dello Stato italiano, come le agenzie di
intelligence. E dunque, dopo un passaggio in Svizzera, sarebbe rientrato in
Italia sotto la protezione dei nostri 007, convinti che la permanenza nel nostro
paese sarebbe stata più sicura.
LA SCELTA. Una
conclusione, almeno temporanea, che lascia comunque qualche ombra sul caso della
figlia di 17 anni. La ragazza non sarebbe stata abbandonata «come una valigia in
autostrada», viene spiegato. Bensì avrebbe scelto di andare dai nonni, secondo
la versione che è stata fornita dalla Farnesina e che, ieri, ha trovato
parecchie conferme. Nonni importanti in Nord Corea, una famiglia di noti
diplomatici, dove avrebbe trovato accoglienza e protezione, soprattutto dopo la
scelta di non restare a Roma e non continuare a seguire i genitori. Se si tratti
di un vero abbandono o di un tentativo di non trascinare la ragazza in una vita
difficile, questo difficilmente verrà chiarito. Il caso rimane comunque molto
complesso. L' ex ambasciatore era considerato dal regime uomo di grossa
caratura. A questo punto, se Pyongyang chiedesse una riconsegna, il nostro
governo si troverebbe davanti a un grosso problema, perché restituirlo
significherebbe condannarlo. Mentre potrebbe arrivare nei confronti della coppia
il riconoscimento dello status di rifugiato politico o l' accoglimento di una
eventuale richiesta di asilo, che l' ambasciatore dovrebbe aver presentato da
qualche mese. Forse anche negli uffici immigrazione di altri paesi occidentali.
Quando la notizia della sparizione venne diffusa a gennaio, la Farnesina aveva
fatto sapere che nessuna richiesta di asilo era stata presentata. Quello che
viene ribadito anche oggi, è la comunicazione che venne fatta al ministero per
il cambio ai vertici della sede diplomatica. «Sono state ricevute due note
formali - è il contenuto della nota ufficiale - La prima, datata 20 novembre
2018, con la quale veniva data notizia dell' assunzione delle funzioni di
Incaricato d' Affari a Roma da parte del Signor Kim Chon. La seconda, datata 5
dicembre 2018, informava che l' ex Incaricato d' Affari Jo Song Gil e la moglie
avevano lasciato l' Ambasciata il 10 novembre e che la figlia, avendo richiesto
di rientrare nel suo paese dai nonni, vi aveva fatto rientro, il 14 novembre
2018, accompagnata da personale femminile dell' Ambasciata». Una comunicazione
arrivata dopo più di venti giorni dagli spostamenti.
L' EPURAZIONE.
Nel frattempo, Kim Jong-un ha messo in atto una vera e propria epurazione. Ha
mandato una squadra a Roma, per cercare il fuggiasco e ha licenziato anche
diversi funzionari di alto livello della Corea del Nord, tra cui un suo lontano
cugino, che era incaricato di monitorare la lealtà dei diplomatici nordcoreani,
e se attuavano - come stabilito dal regime - le politiche estere del Partito dei
lavoratori al governo. E che si sia trattato di una fuga molto importante lo
dimostra il fatto che, quando nel 2016, Thae Yong-ho è fuggito dall' ambasciata
nordcoreana a Londra ed è arrivato in Corea del Sud, nessuno ci aveva rimesso il
lavoro.
Cristiana
Mangani per “Il Messaggero” l'8 ottobre 2020. Scomparso nel nulla alla fine del
2018, è riapparso ora a Seul, dopo che la sua presenza era stata segnalata a
Roma, in Europa e anche in Asia. Jo Song-gil, ex ambasciatore nordcoreano in
Italia, ha trovato rifugio in Corea del Sud, aprendo il fronte a una guerra
diplomatica tra lo stato del Nord e quello del Sud. La notizia è arrivata
attraverso la pagina Facebook di un deputato dell' opposizione da Seul. E il
rifugio inaspettato scelto da Jo Song-gil lo rende il più alto funzionario di
Pyongyang a disertare dal 1997 quando a fuggire al Sud fu Hwang Jang-yop, un
dirigente del partito dei lavoratori al potere che era stato molto vicino a Kim
Jong Il, padre dell' attuale leader Kim Jong Un. «Si è scoperto che l' ex
ambasciatore (ad interim) Jo Song-gil è entrato in Corea del Sud a luglio 2019
ed è sotto la protezione delle autorità», ha scritto sul social il deputato Ha
Tae-keung, del partito di opposizione sudcoreano People Power Party. Diverse
fonti citate dalla Yonhap hanno poi confermato che Jo, 49 anni, è al Sud con la
moglie, dopo il passaggio in un Paese terzo. La notizia non ha ancora l'
ufficialità e, probabilmente, non la avrà mai. Di certo intorno alla sua fuga si
sono scatenate vendette, diserzioni, rapimenti e richieste di asilo. Le ipotesi
su che fine avesse fatto il diplomatico si sono rincorse per settimane. Gli
elementi per una spy story internazionale c' erano tutti, anche perché dopo la
sua scomparsa e quella di sua moglie, con una mossa che ha creato un certo
imbarazzo al nostro paese, la figlia 17 enne è stata rimpatriata a Pyongyang
dopo che agenti speciali nordcoreani avevano effettuato un blitz nell'
abitazione dell' Eur per prelevarla. In un primo momento si è parlato anche di
un possibile rapimento di Song-gil, ma a smentire questa ipotesi a fine gennaio
del 2019, è stata la notizia della furia del leader nordcoreano Kim Jong-un per
la sparizione del suo ambasciatore, tanto che aveva licenziato diversi esponenti
di alto livello, incluso un suo lontano cugino, Ho Chol, funzionario del
ministero degli Esteri a capo della divisione che controlla la lealtà dei
diplomatici alla leadership. E ora la presenza al Sud di Jo è la conferma della
diserzione, che mesi fa era stata attribuita alla pressione alla quale era
sottoposto per procurarsi beni di lusso a favore di Pyongyang. E la sede
diplomatica di Roma pare che fosse un nodo cruciale per operazioni di questo
tipo. A dare una mano alla fuga, secondo i media di Seul, sarebbe stato il
gruppo dissidente nordcoreano Free Joseon, autoproclamatosi governo in esilio.
Non si sa ancora dove sia stato ospitato Jo prima di arrivare in Corea del Sud,
ma a quanto chiarito in passato proprio da Seul il diplomatico era in cerca di
asilo in un Paese terzo sotto la protezione del governo italiano e di altri. Il
National Intelligence service, l' agenzia di 007 sudcoreana, non «ha potuto
confermare» i dettagli della vicenda per motivi di sicurezza. Lo stesso gruppo,
in passato, aveva aiutato la famiglia di Kim Jong-nam, fratellastro del leader
nordcoreano, dopo il suo omicidio all' aeroporto di Kuala Lumpur, in Malesia,
nel 2017. Jo avrebbe voluto tenere segreta la sua presenza in Corea del Sud per
i timori di ritorsioni contro sua figlia e altri familiari residenti in Corea
del Nord. Di solito, proprio per prevenire le fughe, i diplomatici del Nord sono
costretti a lasciare in patria diversi componenti della famiglia, soprattutto i
bambini. A lui, invece, era stato concesso di raggiungere Roma nel maggio 2015
con moglie e figlia in quanto - ha ricostruito nei mesi scorsi il quotidiano
sudcoreano JoongAng Ilbo - appartiene a una famiglia privilegiata: «figlio o
genero di un funzionario dei livelli più alti». Prima di Jo, Thae Yong Ho, ex
funzionario dell' ambasciata nordcoreana a Londra, era stato il più anziano
diplomatico a disertare in Corea del Sud. Trasferitosi a Seul nel 2016 è stato
eletto all' Assemblea Nazionale quest' anno. In questi giorni ha rilasciato una
dichiarazione nella quale esortava i media ad astenersi dall' esporre troppo Jo,
per le possibili rappresaglie contro sua figlia. La fuga degli ambasciatori va
ad aggiungersi ai circa 33.000 nordcoreani scappati al Sud dalla fine degli anni
90 per evitare la repressione politica e la povertà.
·
Quei razzisti come
i Russi.
La vera “Caccia a Ottobre Rosso”.
Paolo Mauri su Inside Over il 15 novembre 2020. 8 novembre 1975, porto di Riga,
Lettonia. La capitale di quello che è oggi uno Stato indipendente che si
affaccia sul Mar Baltico, a quel tempo, faceva parte dell’Unione Sovietica ed
era uno dei suoi porti principali, sede anche di una base navale tra le più
importanti. Il giorno prima, il 7, l’Urss aveva celebrato il 58esimo
anniversario della Rivoluzione d’Ottobre e, come da tradizione, nei porti sedi
di basi navali era stata effettuata una parata con le unità militari ivi
stanziate. Tra le varie navi basate a Riga in quel periodo spiccava la
fregata Storozhevoy, della classe Burevestink o project 1135 (Krivak I in
codice Nato): una classe di navi che, per armamento, erano a forte
vocazione antisom essendo armate, tra le altre cose, di un lanciatore quadrinato
per i grossi missili Rpk-3 Metel (o Ss-N-14 Silex). La Storozhevoy era nuova
fiammante: varata nel marzo del 1973 era entrata in servizio nella Flotta del
Baltico a dicembre dello stesso anno. Quel giorno di novembre, successivo alla
parata navale, era ormeggiata nel porto sul fiume Daugava della capitale lettone
insieme ad altre unità militari, anch’esse reduci dalla manifestazione, e la sua
sagoma moderna spiccava tra le altre sulle placide acque nebbiose della città.
Una quiete ingannevole quella di Riga, perché di lì a poche ore si sarebbe
scatenata una tempesta che avrebbe potuto causare una guerra. Tra i duecento
uomini di equipaggio della Storozhevoy c’era anche Valerij Michajlovich
Sablin, capitano di corvetta della Flotta Rossa e zampolit, ovvero ufficiale
politico. Zampolit è la contrazione di Zamestitel Po Politcheskim Delom, che è
traducibile dal russo come “vicecomandante degli affari politici”.
Nell’organizzazione militare sovietica, infatti, veniva nominato dal Pcus un
commissario politico suo rappresentante presso tutti i reparti dell’Esercito,
dell’Aviazione e su ogni singola unità della Marina militare. Il commissario era
responsabile del rispetto dell’ortodossia comunista dell’unità alla quale veniva
assegnato, affiancando il comandante militare, e tra le sue funzioni c’erano
anche l’indottrinamento politico, la valutazione dell’affidabilità politica
degli ufficiali, sottufficiali e truppa, nonché occuparsi del morale. In linea
teorica, quale rappresentante del Partito, lo zampolit era escluso dalla catena
di comando militare, ma in pratica poteva sollevare obiezioni e talvolta
annullare ordini del comandante nonostante la sua impreparazione specifica.
Sablin nacque nel 1939 a Leningrado (oggi San Pietroburgo), figlio di un
ufficiale di marina, Mikhail Sablin. Entrambi i suoi fratelli maggiori non
seguirono le orme del padre, e quindi tutte le speranze per la continuazione
della tradizione marittima di famiglia erano riposte su Valery. Nel 1960 Sablin
si laureò alla Frunze Higher Naval School di Leningrado, dove fu eletto
segretario del comitato di facoltà del Komsomol ed entrò nel Pcus nel 1959:
allora veniva visto da tutti come un uomo fedele agli ideali sovietici. Nel 1963
venne inviato presso la Flotta del Mar Nero, ma considerò la disciplina e
l’addestramento locali molto deboli, e quindi chiese ed ottenne di essere
trasferito presso la Flotta del Nord, dove prestò servizio per diversi anni.
Successivamente Sablin entrò nell’Accademia Lenin per gli studi
politico-militari, un istituto specializzato nella formazione di funzionari
politici per le Forze Armate, laureandosi con lode. Essendo un eccellente
studente, Sablin fu inviato alla Storozhevoy: l’equipaggio della nave, nuova
fiammante, fu formato da zero e venne selezionato il personale migliore. Doveva
essere l’orgoglio della Flotta del Baltico. Il capitano di corvetta, però,
nascondeva in sé un seme di ribellione che germogliò proprio in quella sera di
novembre del 1975. Già durante gli studi all’Accademia Navale, Sablin si era
fatto notare dagli insegnanti per le sue esigenze di parità di trattamento di
tutti gli studenti, indipendentemente dalla famiglia di origine.
Successivamente, dopo la laurea, per molto tempo non ha potuto ricevere il grado
di luogotenente anziano a causa di una lettera che inviò al segretario generale
del Comitato centrale del Pcus Nikita Kruscev. Come spiegò in seguito lo stesso
Sablin, si era sentito in dovere, da buon comunista, di condividere le sue
opinioni sullo stato della Marina e del Partito. Un errore che avrebbe potuto
costargli anche più caro in una società dove l’autorità non poteva essere messa
in alcun modo in discussione. Sappiamo anche che dopo aver studiato
all’Accademia Lenin, Sablin raccontò a una sua vecchia amicizia che aveva
bisogno di acquisire le conoscenze necessarie per cambiare il Paese e il
Partito. Il compagno, senza pensarci due volte, lo denunciò alle autorità, ma
siccome il curriculum dello stesso informatore non era molto intonso,
il Kgb considerò la denuncia una calunnia e la ignorò. Il capitano di corvetta
era quindi un idealista, un fedelissimo comunista, anzi, un integralista della
dottrina sovietica al punto da considerare il tempo in cui viveva “corrotto”, e
pertanto, come vedremo, era dovere di un ufficiale politico come lui fare
qualcosa per svegliare le coscienze e ristabilire l’ideale originario di Lenin.
Torniamo ora a quel giorno di novembre. Sono le 22:30. La bruma sale dalle acque
della Daugava ad ammantare di un velo bianco ed impenetrabile le unità navali
ormeggiate in porto. Sul ponte del sottomarino S-263, una vecchia unità della
classe project 613 (o Whiskey per la Nato), davanti alla guardia sbucano, dal
buio, due uomini: sono il tenente Firsov e un marinaio, entrambi facenti parte
dell’equipaggio della fregata Storozhevoy. Entrambi sono in uno stato di
agitazione evidente e sostengono di essere fuggiti dalla fregata, poiché la nave
era stata catturata. L’ufficiale di guardia è incredulo e chiama il comandante
del sottomarino a cui Firsov riferisce che sulla Storozhevoy è in corso
un ammutinamento, che il comandante è stato arrestato e che la rivolta è guidata
dallo zampolit. All’inizio gli ufficiali sono a dir poco perplessi: la storia
raccontata dal tenente non può essere vera. Gli ufficiali non sanno che fare e
ragionano su quanto affermato dai due uomini scappati dalla fregata e così
perdono più di un’ora di tempo per decidere se avvisare il comando della base,
ma alle 23:50, quando la fregata molla gli ormeggi e leva l’ancora, non hanno
più dubbi. La Storozhevoy si è ammutinata. Poche ore prima della fuga dei due
uomini, il capitano di corvetta Sablin aveva fatto imprigionare con un
sotterfugio il comandante della nave, il capitano di fregata Anatoly Potulny,
nel locale della stazione idroacustica, nel cuore della Storozhevoy, facendolo
sorvegliare da un militare armato.
Una volta sistemato il comandante, Sablin aveva convocato a
rapporto gli ufficiali e i sottufficiali dell’unità per informarli della sua
decisione: portare la nave a Kronstadt, farla dichiarare territorio
indipendente, e lanciare un messaggio alla nazione per condannare la corruzione
della politica e scatenare la rivolta popolare per riportare l’Unione Sovietica
alle intime origini del pensiero leninista. Sablin, in quella riunione, aveva
sottolineato i problemi nel commercio in Urss, le violazioni delle regole per
l’ammissione alle università e casi di abuso di potere da parte dei funzionari.
Lo zampolit aveva anche spiegato che, a suo avviso, la leadership del Pcus si
era allontanata dalle posizioni di Lenin nella costruzione del socialismo. Era
ora, pertanto, di portare la classe politica dirigente “in un tribunale
nazionale” e chiedere conto delle sue azioni nella misura massima consentita
dalla legge. Negli intenti di Sablin, l’azione, fortemente connotata da
riferimenti storici, avrebbe dovuto dare l’impulso per l’inizio di una nuova
ondata rivoluzionaria. Ovviamente non tutti i presenti a quella riunione si sono
trovati d’accordo con lo zampolit ribelle: almeno la metà degli ufficiali venne
imprigionata essendosi schierata contro Sablin. L’ammutinamento, però, era ormai
cominciato, in quanto anche buona parte dell’equipaggio era dalla parte del
capitano di corvetta, ora diventato comandante della fregata. Poco prima della
mezzanotte, quindi, la Storozhevoy molla, letteralmente, gli ormeggi e comincia
una difficile navigazione nello stretto fiume di Riga, a luci e radar spenti,
per poter prendere il largo. A quel punto il comandante della base, il vice
ammiraglio Anatoly Kosov, viene avvisato e tenta di mettersi in contatto con
l’ufficiale ribelle per cercare di farlo desistere dai suoi intenti, che gli
erano ignoti, e quindi ricondurre la nave in porto. Sablin, però, si rifiuta di
parlargli e tanto meno di obbedirgli, e a quel punto Kosov avvisa le massime
cariche politiche e militari della nazione: il ministro della Difesa Andrei
Grechko e l’ammiraglio comandante della Flotta Rossa Sergeev Nikolai
Dmitrievich. Nei comandi sovietici si agita il sospetto che Sablin
possa disertare e portare la nuova fregata in Svezia, come fece qualche anno
prima un altro ufficiale, il capitano Jonas Pleskis, che nel 1961 giunse nel
Paese scandinavo con un nave appoggio sottomarini e successivamente ottenne
asilo politico negli Stati Uniti, dove morì nel 1993 all’età di soli 58 anni.
Pertanto una flottiglia di piccole navi missilistiche della Flotta del Baltico
viene immediatamente mandata ad inseguire la Storozhevoy con l’ordine di aprire
il fuoco se i ribelli avessero attraversato il meridiano a 20 gradi di
longitudine est. A questo punto della nostra storia il ministro Grechko cerca,
un’ultima volta, di ricondurre Sablin a più miti consigli, ma ottiene dallo
zampolit solo un elenco delle richieste dei ribelli tra cui spicca la già citata
richiesta di “dichiarare la nave territorio libero e indipendente dagli enti
statali e di partito per un periodo di un anno e di fornire alla nave tutti i
tipi di razioni”. Sablin, nel suo discorso, afferma di voler “il diritto di
parlare alla radio e alla televisione ogni giorno dopo Vremya (il notiziario
televisivo dell’era sovietica n.d.r.) per 30 minuti”, aspettandosi quindi di
ricevere “corrispondenza, supporto e incontri personali da esponenti di tutti i
ceti sociali”, pensando quindi di innescare una nuova ondata rivoluzionaria. Lo
zampolit chiede anche l’immunità per tutti i membri dell’equipaggio una volta
sbarcati, sottolineando che se verrà usata la forza contro i ribelli, ogni
responsabilità ricadrà sulle autorità statali. Lo Stato, però, è sordo, come
nella migliore tradizione sovietica. Il premier, Leonid Brezhnev, a questo punto
è sicuro che Sablin voglia disertare e ordina la distruzione della fregata con
ogni mezzo. Il 668esimo reggimento bombardieri, con base presso il campo
d’aviazione di Tukums, sempre in Lettonia, viene allertato e i piloti, già in
volo per una missione di addestramento, ricevono l’ordine di intercettare una
“nave da guerra ha invaso le acque territoriali dell’Urss”. I piloti però, anche
per via delle condizioni di scarsa visibilità dovute alla nebbia, non trovano la
fregata e solo uno sgancia i suoi ordigni su un’unità navale che però è una nave
da carico sovietica che aveva lasciato il porto di Ventspils poche ore prima. La
nave erroneamente attaccata comunica “un attacco di banditi nelle acque
territoriali dell’Unione Sovietica” e nel frattempo la nave ribelle continua la
sua rotta verso il mare aperto. Nella mattinata del 9 il quartier generale della
Flotta riceve un rapporto dai custodi del faro di Irbensky che scorgono la
fregata in navigazione con rotta 210 gradi e velocità di 18 nodi. La rotta per
Kronstadt è di 337 gradi ma i velivoli sovietici e la flottiglia uscita dal
porto di Riga non la stava cercando lì. Le acque territoriali della Svezia erano
distanti solo 43 miglia e 2 ore e mezza di navigazione, mentre e Kronstadt
distava 330 miglia e 18 ore. Ma tutti, dal comando della Flotta del Baltico sino
a Breznev, sono sicuri che la nave sarebbe andata in Svezia. Nel frattempo
quindi gli aerei da combattimento continuano a setacciare il golfo di Riga,
mentre la flottiglia di corvette missilistiche sotto il comando di Alexander
Bobrakov stava cercando disperatamente di intercettare la nave ribelle. Verso le
7 del mattino i marinai della Storozhevoy e i loro inseguitori entrano in
contatto visivo, e a bordo della fregata capiscono che i loro compagni sono
stati mandati a cercarli con l’ordine di ucciderli. Alle 8:10 un
bombardiere Tupolev Tu-16 Badger lancia un missile da addestramento che si
infila in acqua davanti alla prua della nave come ultimo avvertimento. A quel
punto Sablin ordina, ad un equipaggio sempre più spaventato e dubbioso sulla
giustezza della causa, di effettuare manovre evasive per evitare i velivoli, che
a loro volta si tengono a distanza temendo il fuoco del nuovo sistema
missilistico antiaereo 9K33 Osa installato sulla nave. Quando i piloti capiscono
che i marinai non li stanno puntando, attaccano. La prima bomba colpisce la
Storozhevoy proprio al centro del ponte sul cassero della nave, penetrando nei
locali sottostanti e bloccando il timone della nave nella posizione in cui si
trovava. Altre bombe cadono in acqua in prossimità dello scafo nella zona
poppiera danneggiarono ulteriormente il timone e le eliche. La fregata inizia a
descrivere un ampio cerchio sul mare per poi fermarsi. Nel frattempo i vascelli
inseguitori si fanno sotto con l’intenzione di affondarla, perché i comandanti
sono sicuri che la nave più recente della Flotta Rossa, con codici missilistici
segreti e altre preziose informazioni, sarebbe andata in Svezia. Rendendosi
conto di questo gli ammutinati ci ripensano, e a bordo scoppia una “rivolta
nella rivolta” che permette di liberare il comandante Anatoly Potulny, il quale,
salito in plancia, spara a una gamba a Sablin e comunica per radio che “l’ordine
è stato ripristinato sulla nave”. La ribellione era finita. Sablin viene
arrestato e processato per tradimento finendo fucilato il 3 agosto del 1976 a 37
anni. Gli altri membri dell’equipaggio subiscono un destino “più fortunato”:
tutti i colpevoli di ammutinamento vengono congedati con disonore, perdendo i
gradi e venendo espulsi dal partito, quindi condannati ad una vita di stenti non
potendo godere di pensione o sperare nella possibilità di avere un altro
impiego. La nave, come in un gesto scaramantico ma soprattutto per eliminare dal
Baltico e dal porto di Riga un simbolo di ribellione, viene trasferita
alla Flotta del Pacifico con un equipaggio totalmente nuovo. Finirà in disarmo
nel 2002 e venduta come rottame all’India poco dopo. Quell’episodio, che insieme
alla vicenda di Pleskis ha ispirato Tom Clancy per il suo romanzo “Caccia a
Ottobre Rosso” da cui hanno tratto un famoso film, rischiò anche di scatenare
una guerra. L’attività navale sovietica, ma soprattutto quella aerea, di quel
giorno di novembre mise infatti in allarme la Svezia che mobilitò i suoi caccia
e le sue navi militari, e a sua volta non passò inosservata alla Nato, che
temeva che quell’azione non comunicata fosse il preludio di una qualche
offensiva sul fianco orientale dell’Alleanza.
Nagorno
Karabakh: finisce la guerra, vince Putin.
Piccole note
10 novembre 2020 su Il Giornale. Finisce la guerra del Nagorno Karabakh che
infuria da un mese: l’accordo sottoscritto da Armenia e Azerbaigian sotto la
supervisione di Putin vede il passaggio di tre distretti della regione autonoma
sotto il controllo di Baku, mentre il resto rimane sotto il controllo di Erevan.
L’esercito russo andrà a interporsi, come forza di pace, tra i duellanti,
congelando la situazione per i prossimi cinque anni, durante i quali si spera di
sciogliere nodi rimasti tali dalla fine della guerra precedente (1991 – ’94).
I passi della
diplomazia. Finisce così una guerra sanguinosa che ha contrapposto Azerbaigian e
Armenia, ma soprattutto Turchia e Russia, la prima alleata di Baku, la seconda
di Erevan, con rischi di allargamento del conflitto nel Caucaso e oltre. Vince
la pace e vince Putin, che è riuscito a riportare ordine nel caos, con il mondo
a osservare da lontano, a parte il risuonare di blandi appelli alla pace.
Un’assenza interessata, dato che molti stavano tacitamente sperando che si
consumasse l’escalation, portando Ankara in aperto conflitto con Mosca, sviluppo
che avrebbe aperto le porte a un ritorno del figliol prodigo, Recep Erdogan, tra
le braccia della Nato. Da qui il blocco di quanti, interessati a riportare
l’ordine – anzitutto Macron -, si sono trovati soli nel rappresentare le
preoccupazioni dell’Occidente per il nuovo conflitto alle porte dell’Europa.
Invece Putin è riuscito laddove altri hanno latitato, con un’azione diplomatica
di alto livello. Anzitutto ha difeso le ragioni dell’Armenia, denunciando con
voce alta a forte l’attacco dell’Azerbaigian. Non un generico appello alla pace,
ma un puntuale richiamo all’aggressore. Ha però anche sostenuto che
l’Azerbaigian, pur errando, aveva delle pretese non del tutto indebite
sul Nagorno Karabakh, rimaste inevase dal congelamento del conflitto precedente.
Il lungo stallo aveva di fatto conferito la regione autonoma all’Armenia,
nonostante il fatto che essa, prima del collasso dell’Urss, era parte
dell’Azerbaigian e che gran parte della sua popolazione è musulmana sciita,
indistinguibile dal resto della popolazione azera. Putin aveva così rimproverato
a Baku non tanto le rivendicazioni, pur non sposandole in toto, ma l’uso della
forza, e chiedendo di aprire un dialogo tra le parti sulle controversie, invito
a lungo declinato da Baku. Stessa fermezza aveva usato con la Turchia e il suo
sultano, Erdogan, che inutilmente aveva provato a convincere lo zar delle sue
ragioni. Ma, pur condannando l’aggressione, non ha rotto né con l’Azerbaigian
(sempre identificato come partner paritario rispetto all’Armenia) né con
Erdogan, rimanendo in attesa di una ricomposizione e riuscendo nell’arduo
esercizio di tenere a freno gli ambiti dell’esercito e dell’élite russa
infuriati col sultano turco per il rilancio del sogno neo-ottomano nel Caucaso –
spazio ex sovietico e tutt’ora sotto la diretta influenza russa -, che rischiava
di destabilizzare l’intera regione. Allo stesso tempo, Putin aveva chiarito
all’Armenia che l’avrebbe difesa in caso di aggressione nel suo territorio,
lanciando così un monito parallelo a Baku, che aveva tentato alcune incursioni
contro Erevan. Ma aveva anche chiarito che non avrebbe inviato forze per
difendere il Nagorno Karabakh e che quindi lo sforzo bellico che Erevan stava
sostenendo per difendere la regione non riguardava Mosca. In tal modo ha evitato
di coinvolgere Mosca nella guerra, sviluppo ad alto rischio perché, seppure la
vittoria su Baku sarebbe stata di facile portata, il conflitto si sarebbe
trasformato inevitabilmente in un lungo scontro a bassa intensità, con un
dissanguamento progressivo delle risorse russe.
Il confronto
con la Turchia. Ma pur conservando il filo del dialogo, ha fatto sentire la
pressione russa su Erdogan, non solo con una inedita freddezza nei rapporti
diretti, preferendogli il dialogo con le autorità azere, ma anche con iniziative
belliche indirette, isolate, ma bastevoli a dare la misura della fermezza di
Mosca. In tal senso vanno interpretati i bombardamenti russi contro le milizie
terroriste di Idlib, in Siria, che Ankara ha usato per supportare lo sforzo
bellico azero. Insomma, una tessitura politica in cui Putin ha alternato
fermezza e dialogo, che alla fine ha prodotto i risultati sperati. A favorire
l’accordo, la constatazione di Erevan dell’impossibilità di difendere le sue
ragioni: l’esercito azero ha vinto la guerra, avendo preso il controllo di
Shushi, città chiave perché collega l’Armenia a Step’anakert, capitale del
Nagorno Karabakh. Eppure Step’anakert, come altri distretti, rimarrà sotto il
controllo di Erevan, conservando in parte lo status quo pregresso, e soprattutto
rassicurando la comunità armena della regione autonoma che temeva un revanscismo
islamico-azero. Allo stesso tempo, l’accordo, oltre a porre fine allo
spargimento di sangue, chiude le pretese azere sull’intera regione autonoma e
pone un freno alle pretese neo-ottomane sul Caucaso. A contribuire allo sviluppo
anche la vittoria di Biden alle elezioni Usa. Erdogan aveva in Obama un nemico
giurato. Col suo vice alla Casa Bianca, sempre se sarà ufficializzato, deve
guardarsi le spalle. E tenersi buona Mosca, almeno per ora. Ma poteva tirare la
corda ancora un po’. Putin non glielo ha permesso, chiudendo la partita e
lasciando a bocca asciutta quanti, in Occidente, speravano che finisse
invischiato nell’ennesima criticità geopolitica e che rompesse con la Turchia.
Il premier russo sul Monte Athos: missione o pellegrinaggio?
Emanuel Pietrobon il 21 settembre 2020 su Inside Over. Il 24 settembre il primo
ministro russo Mikhail Mishustin si recherà al monte Athos per un
soggiorno-lampo che terminerà il giorno successivo. Quello che in apparenza può
sembrare un ritiro spirituale, per nulla inusuale per i diplomatici russi,
potrebbe in realtà essere una missione in incognito tesa a riaprire l’annoso
fascicolo dello scisma ortodosso.
Pellegrinaggio o visita in incognito? Il primo ministro russo
arriverà sul Monte Athos, il cuore spirituale e politico dell’ortodossia greca,
nella giornata di giovedì 24 settembre e partirà il giorno successivo. Come
riporta il quotidiano greco Ekathimerini, Mishustin alloggerà e passerà la notte
nel monastero di san Pantaleone, un luogo che non è stato scelto a caso: si
tratta della “parte russa” del complesso monastico, essendo composto per la
stragrande maggioranza da monaci di origine russa. La due-giorni non è stata
pubblicizzata con vigore né dalle autorità russe né da quelle greche e ha
ricevuto una scarsa copertura mediatica, di gran lunga inferiore rispetto a
quella data alla visita di Vladimir Putin del 2018, e il motivo è il seguente:
non si tratterebbe di una visita ufficiale, Mishustin sarebbe in procinto di
recarsi nel luogo più santo dell’ortodossia greca in veste di pellegrino.
Essendo sacro e politica inestricabilmente legati nell’arena internazionale, e
questo è vero soprattutto per le grandi potenze, è difficile credere che la
due-giorni non verrà sfruttata anche per promuovere l’agenda geo-religiosa del
Cremlino e, in effetti, un indizio a sostegno di questa tesi è presente: nella
pausa tra la sessione di preghiere e l’incontro con i monaci russi, Mishustin si
recherà a Karyes, la sede dell’amministrazione monastica, dove incontrerà la
dirigenza del monte Athos. Lo scopo della due-giorni, a questo punto, potrebbe
essere più chiaro di quanto sembri: tentare di convincere le massime autorità
spirituali della chiesa ortodossa greca, che esercitano un astro incredibilmente
influente sulla politica e sulla società, a fare un passo indietro nella
questione dello scisma ortodosso, ovvero normalizzare i rapporti con il
patriarcato di Mosca e disconoscere la neonata chiesa ortodossa dell’Ucraina.
L’indipendenza di quest’ultima dalla giurisdizione del patriarcato di Mosca è
stata garantita dal patriarcato di Costantinopoli alla vigilia del Natale
ortodosso dello scorso anno per mezzo di un tomo di autocefalia molto dibattuto
e controverso, e la chiesa ortodossa greca si è infine unita al fronte che ha
riconosciuto la legittimità del decreto e la fondazione della nuova chiesa dopo
mesi di aspro dibattito, in ottobre.
Lo scisma, la situazione attuale. Dal 15 ottobre 2018 fra il
patriarcato di Mosca e il patriarcato di Costantinopoli è scisma: da allora i
due cuori della cristianità orientale hanno cessato ogni tipo di collaborazione,
rapporto e dialogo. La grave frattura intestina è stata provocata dal tomo di
autocefalia garantito da Bartolomeo I, il patriarca ecumenico di Costantinopoli,
alla chiesa ortodossa di Ucraina, nata su volontà di Petro Poroshenko con
l’obiettivo di limitare ulteriormente l’influenza russa nel Paese. Quattro
giorni prima che il patriarcato di Mosca decidesse di congelare le relazioni con
Costantinopoli, Bartolomeo aveva organizzato un Santo Sinodo per discutere la
questione del riconoscimento della neonata chiesa ortodossa ucraina,
raggiungendo un verdetto positivo: in virtù del ruolo rivestito di primus
inter pares, il patriarca ecumenico di Costantinopoli avrebbe concesso il tomo
di autocefalia all’entità, poi firmato il 5 gennaio successivo in tempo per la
celebrazione del Natale ortodosso. La decisione di Bartolomeo I, come
prevedibile, ha avuto un effetto domino, avendo costretto le chiese che
compongono la cristianità orientale a prendere una decisione, a fare una scelta
di campo: Costantinopoli, ossia l’Occidente, oppure Mosca, quindi la Russia. Ad
oggi, settembre 2020, la chiesa ortodossa autocefala d’Ucraina è stata
riconosciuta dall’omologa greca, dal patriarcato greco-ortodosso di Alessandria
e di tutta l’Africa, dalla chiesa ortodossa russa in America, e ha ricevuto
supporto non ufficiale dalle chiese ortodosse di Bulgaria e Romania. Inoltre,
con il passare dei mesi, la questione dell’autocefalia si è estesa ai Balcani
meridionali, minacciando direttamente l’integrità e l’autorità della chiesa
ortodossa serba, perché chierici con ambizioni scismatiche in Montenegro e
Macedonia del Nord hanno iniziato a strumentalizzare la vicenda per chiedere ai
rispettivi governi di adoperarsi per esercitare pressioni su Costantinopoli
affinché vengano prese in considerazione anche le loro richieste di autonomia da
Belgrado. Nel caso macedone, la chiesa ortodossa è già de facto autonoma, avendo
dichiarato la propria autocefalia in maniera unilaterale nel 1967, ma senza
ottenere riconoscimento alcuno da Costantinopoli. Nel caso montenegrino, invece,
esistono due chiese ortodosse in concorrenza tra loro. La prima, quella a cui
aderisce la stragrande maggioranza della popolazione e che risponde a Belgrado,
è stata recentemente protagonista di una lunga stagione di mobilitazione
popolare contro l’agenda anticlericale dell’autocrate Milo Dukanovic. La
seconda, non riconosciuta e con uno scarso seguito popolare, è nata nel 1993 ed
è stata storicamente filogovernativa e antiserba; è proprio quest’ultima che sta
tentando di approfittare dello scisma per ottenere riconoscimento da
Costantinopoli.
Dentro i misteri della Santa Madre Russia fra rose, cervelli,
vignettisti e Voltaire. Armando Torno svela molti
segreti del Paese di Stalin. Anche se non tutti...Luigi Mascheroni, Martedì
22/09/2020 su Il Giornale. Ci sono più cose sotto il cielo e sulla terra della
Grande Madre Russia di quante ne possiamo sognare nella nostra filosofia...
Misteri ed enigmi. Cosa accadde al tesoro di Priamo, scomparso da Berlino nel
'45 e riapparso dopo la guerra a Mosca? E dove sono finite le registrazioni
inedite di Furtwängler? Ed è un caso che Ian Fleming, il quale elaborò - in
piena Guerra fredda - la figura di James Bond passeggiando davanti alla
Lubjanka, regalò al suo agente segreto il prefisso telefonico di Mosca: 007?
Pochi Paesi sono capaci di tenere nascosti i propri segreti come la terra degli
Zar, e poi Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche. Ma pochi giornalisti
sono così addentro le sacre «cose russe» come Armando Torno, già fondatore del
«Domenicale» del Sole24ore, che per oltre dieci anni, fra il 2002 e il 2014,
come inviato speciale del Corriere della sera ha viaggiato fra Mosca, San
Pietroburgo, Odessa, Tula ed Ekaterinburg portando a casa una serie di reportage
eccezionali, una parte dei quali viene oggi pubblicata in volume sotto il titolo
Le rose di Stalin. La ballerina del Bolscioi e altre cronache dalla Russia
(Marietti 1820, pagg. 168, euro 14,50). Ed ecco i segreti di quel mondo che, dal
Principato di Moscovia a Putin, si estende lungo cinque secoli fra gli Urali e
la Siberia. Facendo le domande pertinenti e con i confidenti giusti, si possono
trovare storie straordinarie. Queste. Come quella della biblioteca di Voltaire,
oltre seimila libri, ricchi di note a margine, studiando i quali il filosofo
scrisse opere fondamentali per la cultura europea quali il Trattato sulla
tolleranza o il Dizionario filosofico, ma usati anche dagli Zar e oggi custoditi
in una sala blindata della Biblioteca nazionale russa di San Pietroburgo: e -
credeteci - rintracciarne il catalogo non è stato per nulla facile... O come la
storia di Boris Efimov, morto nel 2008 a 108 anni, ma intervistato da Torno
quando ne aveva 104, grandissimo caricaturista, amato da Trockij e utilizzato
per anni da Stalin: Boris disegnava le vignette per la prima pagina della Pravda
(mentre il Piccolo Padre scriveva di suo pugno le didascalie), sempre in bilico
tra un'approvazione e il gulag. «Credo che Stalin desiderasse essere padrone
della vita e della morte altrui, lasciando le situazioni in sospeso». O quella
di Ol'ga Ul'janova, la nipote di Lenin (la quale confessa che non fu suo zio a
dare l'ordine di fucilare lo zar e la sua famiglia, «anzi fermò molte esecuzioni
già decise dai rivoluzionari»). O di Nikita Krusciov, la cui figlia adottiva
smentisce una volta per tutte che il padre nel 1960 sbatté una scarpa sui banchi
dell'Onu (era un cinemontaggio): «Fu una montatura, nata da una foto
falsificata». O, ancora, quella della pipa che Stalin regalò nel '48 a Georges
Simenon (una cosa che li accomunava, peraltro, era un vago antisemitismo...): il
dittatore ammirava il «metodo investigativo» di Maigret e fu entusiasta del film
La tête d'un homme, quinto romanzo del celebre commissario, che vide in
proiezione privata il 7 novembre del '34...Potremmo parlare della modesta casa
del dottor Cechov. O dei 25mila volumi custoditi un tempo nella dacia di
Kuncevo, dove morì Stalin. O del baule su cui dormiva Dostoevskij. O del mistero
delle dodici stazioni della metropolitana di Mosca (ma perché si scelse quella
strana pianta zodiacale?). O dell'Istituto moscovita dove per anni furono
raccolti i cervelli dei più grandi scienziati, politici e scrittori russi. Ma,
forse, il pezzo più prezioso dei reportage di Armando Torno è l'incontro con
Ol'ga Lepesinskaja (morta nel 2008), prima ballerina del Bolscioi dal 1933, la
quale ogni sera veniva raggiunta a teatro da Stalin attraverso un corridoio
sotterraneo segreto. Cosa ricorda del suo «ammiratore»? Che era taciturno. Che
amava più di ogni altra cosa il film musicale Volga Volga. Che le portava sempre
delle rose. E che «era un uomo vendicativo e cattivo, come tutti gli orientali».
L’accusa di Mosca: “L’arresto dei mercenari un piano
ucraino-americano”. Emanuel Pietrobon il 28 agosto
2020 su Inside Over. La crisi fra Russia e Bielorussia è rientrata per via
dell’improvviso e inaspettato scoppio di una duratura insurrezione
post-elettorale che, in piedi dalla sera del 9 agosto, non mostra ancora segni
di declino e/o di interruzione. I disordini, sui quali sin da subito ha iniziato
a gravare l’ombra di un’interferenza straniera, per via degli arresti di
dimostranti provenienti da Polonia e Ucraina, poi confermata dal protagonismo
del duo Varsavia-Vilnius e dell’Unione Europea, hanno convinto Aleksandr
Lukashenko a sospendere la politica di avvicinamento all’Occidente, riportandolo
saldamente a riaffermare il posizionamento geopolitico di Minsk all’interno
della sfera d’influenza russa. L’episodio più eclatante della crisi, che sarebbe
culminata in una vera e propria rottura in assenza del maldestro tentativo di
cambio di regime, è stato indubbiamente l’arresto di trentatre mercenari
del gruppo Wagner, avvenuto il 29 luglio. L’operazione aveva avuto luogo grazie
alla soffiata ricevuta da alcuni servizi segreti esteri, secondo i quali i
militari privati si sarebbero trovati nel Paese con l’intento di attuare un
piano di destabilizzazione alla vigilia delle elezioni. A distanza di un mese da
quella controversa operazione, il Cremlino ne ha ricostruito i retroscena ed è
giunto ad una conclusione: l’intera vicenda sarebbe stata orchestrata da
Washington e Kiev con l’obiettivo di accelerare la spaccatura fra Minsk e Mosca.
L’accusa. Il 27 agosto il canale televisivo Rossia 24 ha
trasmesso un’intervista a Vladimir Putin durante la quale si è parlato, tra le
altre cose, degli eventi che stanno scuotendo la Bielorussia. Il presidente
russo si è concentrato, in particolare, sulla maxi-operazione del 29 luglio che
aveva condotto all’arresto di trentatre soldati del gruppo Wagner, lanciando
delle accuse all’indirizzo di Washington e Kiev. Secondo Putin, “questa
operazione è stata condotta congiuntamente dai servizi segreti statunitensi e
ucraini. […] Alcuni dei partecipanti nel processo – persone ben informate e
osservatori – non lo stanno neanche nascondendo”. Il gruppo avrebbe dovuto
recarsi in America Latina e Medio Oriente, ma sarebbe stato “trascinato in
territorio bielorusso e dipinto come una forza per destabilizzare la situazione
durante la campagna presidenziale, cosa assolutamente non vera”. Le
dichiarazioni di Putin hanno riportato alla luce una teoria circolata negli
ambienti mediatici russi sin dalle fasi immediatamente successive all’arresto
dei mercenari, condensata in un approfondimento del 6 agosto firmato dal
giornalista investigativo Aleksandr Kots per Komsomolskaya Pravda e in
seguito ripreso da Yuri Butusov, capo redattore del portale d’informazione
ucraino Censor.net. Secondo Kots, l’intera operazione sarebbe stata diretta dai
servizi segreti ucraini con lo scopo di deteriorare ulteriormente i rapporti fra
Minsk e Mosca, che all’epoca erano particolarmente fragili per via dell’agenda
filo-occidentale di Lukashenko. In breve, stando alle informazioni raccolte dal
giornalista, nei mesi precedenti all’inizio dell’estate alcuni agenti ucraini
sotto copertura avrebbero contattato dei reclutatori al servizio del gruppo
Wagner con la scusante di dover proteggere dei presunti siti petroliferi in
Siria e in Venezuela. La messinscena sarebbe stata organizzata in maniera
scrupolosa: costruzione di alias credibili, fornitura di dettagli sulle attività
da condurre una volta ingaggiati, origine di telefonate e messaggistica alterata
in maniera tale da essere ricondotta alla Siria in luogo che all’Ucraina.
L’intera operazione sarebbe stata supervisionata dai servizi segreti ucraini
dall’inizio alla fine, tappa per tappa. Kots ha scoperto, rivolgendosi alla
Turkish Airlines, che i biglietti aerei che avrebbero dovuto portare i mercenari
russi fra Damasco e Caracas erano stati acquistati da un’agenzia viaggi con sede
a Kiev e aperta di recente, a gennaio – prova, quest’ultima, di quanto fosse
stato studiato meticolosamente il piano. I mercenari, giunti a Minsk fra il 24 e
il 25 luglio, avrebbero dovuto prendere un volo per Istanbul il 25 pomeriggio,
da dove avrebbero poi dovuto raggiungere America Latina e Medio Oriente. Una
volta atterrato nella capitale bielorussa, il gruppo era stato informato
dell’improvvisa cancellazione del volo e invitato ad attenderne uno nuovo,
previsto entro una settimana, il 30. Come è noto, quel secondo volo era
un’invenzione, e alle prime luci dell’alba del 29 il gruppo era stato tratto in
arresto dalle forze di sicurezza bielorusse, avvertite da una soffiata della
presenza sospetta di turisti russi, vestiti in abiti militari, alloggiati in un
complesso turistico nei pressi di Minsk. Ad ogni modo, il governo ucraino ha
respinto le accuse provenienti dal Cremlino e dalle inchieste indipendenti di
Kots e Butusov, sostenendo la totale estraneità ai fatti dei propri servizi
segreti ucraini.
L’occasione mancata dell’Occidente. Lo scoppio dell’insurrezione
post-elettorale, che ha rapidamente assunto i caratteri di un tentativo di
rivoluzione colorata pilotato dall’esterno, ha convinto Lukashenko a ripiegare
su Mosca e ad assumere una postura difensiva nei confronti dei suoi presunti
registi, fra i quali Polonia, Lituania e Ucraina, mettendo da parte il proposito
del cambio di rotta geopolitico. In definitiva, si può sostenere che il tentato
cambio di regime si è rivelato controproducente, un’occasione mancata, perché
frutto di un grave errore di calcolo: Lukashenko era realmente intenzionato a
rompere con la Russia e ad inaugurare un nuovo corso diplomatico e geopolitico e
con molta probabilità avrebbe mantenuto le promesse fatte in sede elettorale. Il
presidente bielorusso aveva dato prova della serietà delle sue intenzioni ben
due volte: a giugno, dirigendo una campagna di arresti ai danni
della Belgazprombank, e a fine luglio, con l’operazione-farsa che aveva condotto
all’incarcerazione di trentatre soldati del gruppo Wagner, accusati di essere
entrati nel Paese “per destabilizzare la situazione in vista delle elezioni
presidenziali”. Ad ogni modo, quei mercenari di cui non è dato sapere se fossero
realmente coinvolti in un piano antigovernativo, se siano stati vittime di una
trama ucraino-americana o, più semplicemente, dell’ennesima provocazione di
Lukashenko per sfidare il Cremlino ed inviare un messaggio all’Occidente, sono
stati rimpatriati nel più totale silenzio il 14 agosto; proprio come loro, anche
il presidente bielorusso ha fatto ritorno a Mosca.
Macron a Putin: "Atto criminale".
Caso Navalny, la Russia accusa:
“Occidente oltre decenza, pretesto per ulteriori sanzioni contro Mosca”.
Redazione Il Riformista il 14 Settembre 2020. “I partner occidentali della
Russia, sul caso di Alexei Navalny, hanno superato ogni limite di decenza e buon
senso”. E’ con questa accusa che il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov,
ha cancellato la visita di domani a Berlino. Lavrov ha spiegato che la posizione
dell’Occidente sulla vicenda del dissidente russo, che per le autorità tedesche
è stato avvelenato con l’agente nervino Novichok, potrebbe causare “conseguenze
molto spiacevoli”. Infatti, il ministro russo ha detto che il caso Navalny è per
l’Occidente solo un pretesto per introdurre ulteriori sanzioni contro Mosca, e
ha avvertito che questo potrebbe causare dei risvolti incresciosi. In
un’intervista rilasciata a RTVI, il capo della diplomazia russa si è detto
“d’accordo con quanti ritengono che se non ci fosse stato nessun caso Navalny,
l’Occidente avrebbe escogitato qualcos’altro per introdurre ulteriori sanzioni”.
Lavrov ha osservato che nella situazione attuale “i partner occidentali guardano
Mosca con arroganza: abbiamo il diritto di dubitare della loro correttezza e
professionalità”. “L’arroganza e il senso della propria infallibilità sono già
stati osservati in Europa e hanno portato a conseguenze molto tristi”, ha
sottolineato il ministro russo. Intanto migliorano le condizioni del leader
dell’opposizione russa. L‘ospedale di Berlino dove è ricoverato a seguito di
avvelenamento con agente nervino Novichok ha fatto sapere che riesce ad alzarsi
per qualche minuto dal letto.
L’ATTACCO DI MACRON – Il presidente
francese Emmanuel Macron ha espresso la sua “profonda preoccupazione per l’atto
criminale” che ha preso di mira l’oppositore russo Alexei Navalny, nel corso di
un colloquio telefonico avuto con Vladimir Putin. A renderlo noto è l’Eliseo.
Macron ha confermato che la Francia ha raggiunto le stesse conclusioni dei suoi
partner europei sull’avvelenamento. “È necessario un chiarimento della Russia
nel quadro di un’indagine credibile e trasparente”, ha detto Macron. Dal canto
suo il presidente russo Vladimir Putin, ha sottolineato “l’inadeguatezza delle
accuse, infondate” rivolte a Mosca sul caso Navalny. Putin ha specificato che
“per scoprire le reali circostanze dell’incidente, è necessario trasferire i
materiali degli specialisti tedeschi in Russia”, “una conclusione ufficiale
basata sui risultati delle analisi di Navalny, nonché stabilire un lavoro
congiunto con i medici russi”.
Giuseppe Agliastro per “la Stampa” il 26 agosto 2020. Il Cremlino
non si smentisce. I medici tedeschi hanno annunciato che Aleksey Navalny è stato
quasi sicuramente avvelenato, eppure le autorità russe appaiono restie a
indagare sul grave malore che ha trascinato tra la vita e la morte l'avversario
di Putin. Alle pressioni internazionali per fare luce sulla vicenda, il Cremlino
risponde per ora facendo spallucce. Secondo il portavoce di Putin, Dmitry
Peskov, al momento non c'è neanche bisogno di un'inchiesta. Il sospetto che il
Cremlino sia coinvolto in un tentativo di uccidere Navalny? Solo «un vuoto
rumore» che non vale la pena «prendere sul serio», dice Peskov. Al massimo - è
l'uscita del presidente della Duma, Vyacheslav Volodin - delle potenze straniere
potrebbero aver messo a rischio la salute di Navalny «per alimentare le tensioni
all'interno della Russia». Il caso Navalny sta creando nuove tensioni tra la
Russia e l'Occidente. Incontrando a Mosca il ministro degli Esteri russo Lavrov,
il vice segretario di Stato americano Biegun avrebbe addirittura minacciato
«misure tali da far impallidire la reazione pubblica degli Usa all'ingerenza
russa nelle presidenziali del 2016». Questa almeno è la versione dei fatti che
arriva da Mosca. Lunedì Angela Merkel ha chiesto alla Russia un'indagine degna
di questo nome sul presunto avvelenamento del dissidente, ora ricoverato in coma
indotto all'ospedale Charité di Berlino ma non più in pericolo di vita. La
richiesta della cancelliera tedesca ha subito incassato il sostegno dell'Ue e
della Francia, che ha definito Navalny vittima di «un atto criminale». In
passato, diversi personaggi scomodi per Putin sono stati uccisi o sono stati
vittime di tentati omicidi. I killer a volte sparavano, altre volte usavano dei
veleni. Il Cremlino ha però sempre respinto ogni accusa e lo fa anche ora. I
medici tedeschi ritengono che Navalny sia stato avvelenato con «una sostanza del
gruppo degli inibitori della colinesterasi», di cui fanno parte gli agenti
nervini paralizzanti. Eppure per Peskov non ci sono i presupposti per indagare
sul caso finché non è certo che Navalny sia stato avvelenato. Anzi, a suo
avviso, gli specialisti tedeschi sono stati «affrettati» nel parlare di
avvelenamento. «Ci deve essere un motivo per un'indagine» e «al momento tutto
ciò che voi e io vediamo è che il paziente è in coma», ha detto il portavoce di
Putin. Una narrazione già intuibile nei giorni scorsi, quando i medici
dell'ospedale di Omsk, in Siberia, dove Navalny era ricoverato fino a venerdì,
hanno negato di aver trovato tracce di veleno. Solo in serata il ministero degli
Esteri di Mosca ha gettato un po' d'acqua sul fuoco assicurando che il governo
russo vuole un'indagine «minuziosa e obiettiva» sull'accaduto. Le parole di
Peskov sono state accolte con rabbia dagli alleati di Navalny, secondo cui il
dissidente potrebbe essere stato avvelenato con una tazza di tè all'aeroporto di
Tomsk. «Era ovvio che non sarebbe stata aperta una vera indagine e che il
colpevole non sarebbe stato trovato», ha dichiarato la portavoce di Navalny,
Kira Yarmish.
Igor Pellicciari per formiche.net il 29 agosto 2020. Chi ha
avvelenato Alexey Navanly? E perché? Il rischio è di drammatizzare l’avvenimento
e cadere in teoremi suggestivi ma frettolosi (avvelenamento + Russia = Putin); o
minimizzarlo negando evidenze di base (Navalny è in coma per cause “naturali”).
Dobbiamo basarci sui pochi elementi che abbiamo, per ora più dal versante russo
che da quello tedesco, e cercare di ipotizzare se quanto avvenuto abbia avuto un
mandante e movente politico-istituzionale o di altro tipo. Navalny è personaggio
divisivo in Russia, molto più fastidioso per gli scandali dell’establishment che
ha contribuito a scoprire che per il suo reale consenso politico, spesso
esagerato dai media occidentali. La lista dei suoi nemici è lunga sia
nell’enorme para-Stato russo che nel settore privato (i due contesti sono
osmotici). Fermo restando che è ancora difficile dire “chi-è-stato” ad ordire
l’avvelenamento, è più facile per l’analista ipotizzare “chi-non- è-stato”.
Difficile credere che l’azione sia partita da un ordine del Cremlino inteso, si
badi, come Vladimir Putin e il ristretto gruppo dei suoi più influenti
consiglieri. Per quanto a noi, comunque attratti dal carisma del Presidente,
faccia piacere (e comodo) pensare a una Russia verticista dove ogni decisione è
ricondotta a Putin in persona, ci sono tre elementi che mettono in secondo piano
l’ipotesi di un “avvelenamento di Stato”. Il primo è di ordine politico. È un
dato di fatto innegabile che ogni qualvolta avvenimenti del genere accadono, i
primi a rimetterci sono proprio il Cremlino e il presidente in persona. Il danno
di immagine è evidente sia all’estero (la narrativa di un Putin avvelenatore è
oramai tanto consolidata da essere penetrata anche nei nostri rotocalchi di
gossip), che all’ interno, dove, per inciso, il malcontento per l’emergenza del
Covid nel 2020 ha scalfito la popolarità del presidente. Difficile che un
Cremlino cauto a non bruciarsi l’immagine in Bielorussia (nonostante scomposti
richieste di Lukashenko ad usare la mano dura contro la piazza in protesta)
decida contestualmente di esporsi eliminando Navalny. Né convince l’ipotesi di
Mosca mossa dalla voglia di sbarazzarsi del “capo dell’opposizione”. In primo
luogo perché l’opposizione in Russia è molto più variegata di quanto noi
continuiamo a rappresentare e ha molte anime che si muovono autonomamente da
Navalny e che anzi si rafforzerebbero da una sua uscita di scena, come accadde a
suo tempo dopo l’arresto di Mikhail Khodorkovsky. In secondo luogo perché il
blogger è stato capace di mobilitare più dissenso verso l’establishment che
consenso per il suo movimento. In definitiva, pur essendo una spina nel fianco,
non rappresenta un rischio immediato e il rimuoverlo avrebbe dei costi molto più
alti che tollerarlo come avvenuto in tutti questi anni. Il secondo elemento che
induce a una certa cautela rispetto al movente istituzionale è di
intelligence-logistica. Colpisce l’analista la sopravvivenza di Navalny al
tentativo di avvelenamento, ma forse ancora più alle 44 ore di ricovero
nell’Ospedale di Omsk, dove i protocolli medici usati sono tutt’altro quelli di
chi ha l’occasione d’oro per dare il colpo di grazia alla vittima
miracolosamente scampata una prima volta all’attacco. Innanzitutto Navalny
arriva in ospedale con tempestività inusuale per la Russia, in tutto mezz’ora
dopo la richiesta di soccorso inviata dall’aereo in fase di atterraggio. Non si
gioca in sostanza sul ritardo dei soccorsi, uno degli aspetti logistici più
facili da usare in questi case per “aggravare” la posizione clinica del
paziente. Inoltre, durante il suo ricovero, a Navalny vengono eseguiti numerosi
test diagnostici che verranno passati integralmente (e accettati) al team medico
tedesco, permettendo loro di guadagnare tempo ed avere un’anamnesi completa del
paziente, tracciandone l’intera dinamica clinica. Si tratta di 8 esami del
sangue biochimici e 11 test di emogasanalisi, 6 esami del sangue generali, 5
elettrocardiogrammi, 25 test del glucosio; 4 test generali delle urine, nonché
di una risonanza magnetica. Ma, soprattutto, appena Navalny arriva in ospedale
viene subito trattato con iniezioni di atropina che ne stabilizzano la posizione
a tal punto che il team medico tedesco continuerà a usare lo stesso farmaco,
riconoscendone l’efficacia. È un trattamento che, anche per la tempistica, salva
la vita al paziente e viene deciso dal primario del pronto soccorso di Omsk,
Alexander Murakhovsky – dopo, a quanto pare, un consulto telematico con massimi
specialisti della sanità pubblica a Mosca. Di nuovo, un’efficienza e
disponibilità piuttosto strana da spiegare per chi avesse voluto fare aggravare
il paziente. L’ultimo elemento che va contro la narrativa del mandante-Putin è
di matrice storica. È credibile che il Paese che più viene ritratto in Occidente
come patria delle spie – spietate sì, ma anche efficienti – e che pochi giorni
fa ci ha comunicato che già nel 1961 aveva la “madre di tutte le bombe”,
fallisca cosi miseramente davanti all’obiettivo di eliminare un oppositore,
sbagliando la dose del veleno in una bevanda? Senza contare che, dovendo
scegliere, avrebbero probabilmente usato altri veleni più efficaci e invisibili
(tra le sostanze a disposizione dell’intelligence per questo tipo di operazioni
pare vi siano liquidi indolori e insapori che, se ingeriti, provocano un infarto
letale alla vittima, senza lasciare tracce in autopsie svolte dopo le 12 ore dal
decesso). E senza dimenticare che gli omicidi di Stato (non solo in Russia,
ahimè) prediligono da sempre l’incidente fatale ad altre tecniche come
l’avvelenamento, che lasciano troppe tracce e indizi. Riprendendo un post
apparso su Dagospia qualche giorno fa, se uno Stato vuole eliminare un
oppositore “non avvelena il thè che beve sull’aereo. Lo fa cadere direttamente
(Enrico Mattei docet)”.
Alexei Navalny avvelenato, ecco cosa non torna.
Emanuel Pietrobon il 20 agosto 2020 su Inside Over. La mattina
del 20 agosto, Alexei Navalny, uno dei più celebri detrattori del Cremlino, si è
sentito male poco dopo essersi imbarcato su un volo che lo avrebbe portato
da Tomsk a Mosca, costringendo l’aereo ad un atterraggio di emergenza poco dopo
il decollo. La situazione è parsa grave sin dai primi istanti e l’attivista
anti-corruzione si trova ricoverato in stato comatoso. Anche se l’ultimo
aggiornamento dall’ospedale di Omsk getta un’ombra su quanto affermato in queste
ore: “Nessuna traccia di avvelenamento”. Segno che se si è trattato di
avvelenamento, non c’è modo di trovarne traccia. La pista dell’avvelenamento
intenzionale da parte di agenti governativi è stata battuta sin da subito.
Navalny per molti è già considerato una delle vittime del sistema di potere
legato al Cremlino. Ipotesi possibile, certo, ma che in diversi punti non regge:
pur essendo vero che Navalny è il volto più noto dell’antiputinismo, una
conoscenza approfondita della realtà russa fa comprendere quanto sia falsato
ed esagerato il profilo politico solitamente descritto dall’informazione
occidentale. In breve, il Cremlino, da un punto di vista del rischio interno di
consensi e di crollo dell’immagine, non avrebbe ragioni evidenti e così
cristalline per eliminare lo scomodo oppositore per due ragioni: non rappresenta
una minaccia all’ordine putiniano tale da giustificare un ordine di esecuzione
in stile Litvinenko; la sua morte, in questo momento, non produrrebbe alcun
giovamento ma, anzi, sarebbe fonte di ulteriori problemi per Mosca, attualmente
sotto pressione per via di una crisi di legittimità interna e degli accadimenti
che stanno scuotendo il mondo russo, in primis la Bielorussia.
L’accaduto. Navalny era a bordo del volo Sibir 2614 che da Tomsk
lo avrebbe dovuto riportare a Mosca quando si è sentito male, perdendo i sensi,
costringendo l’equipaggio ad un atterraggio di emergenza a Omsk. L’attivista
rincasava dopo aver terminato un intenso tour per le città siberiane,
organizzato per promuovere i candidati indipendenti che concorreranno alle
elezioni locali del prossimo mese. I testimoni concordano: stamane, nell’attesa
dell’imbarco, Navalny non ha consumato alcun pasto nell’area ristorazione
dell’aeroporto, limitandosi ad ordinare e a bere una tazza di tè. La versione è
stata confermata anche dalla portavoce ufficiale dell’attivista, Kira Yarmish,
che ha scritto su Twitter: “Sospettiamo che Alexei sia stato avvelenato con
qualcosa mescolato nel suo tè. È l’unica cosa che ha bevuto questa mattina. […]
I dottori hanno detto che la tossina è stata assorbita più velocemente perché la
bevanda era calda”. Le condizioni di Navalny sono apparse gravi sin da subito:
ricoverato d’urgenza in terapia intensiva nell’ospedale, è stato comunicato che
l’uomo si trova attualmente in stato di coma ed è stato attaccato ad un
ventilatore. I medici stanno eseguendo tutti gli esami ordinari e straordinari
richiesti dal caso, precisando che, al momento, “non c’è nessuna certezza” a
sostegno della tesi dell’avvelenamento; sul posto, comunque, è immediatamente
giunta una squadra di investigatori per chiarire le dinamiche e seguire
l’evoluzione della vicenda.
Una morte che non gioverebbe al Cremlino. Quello di oggi, se
venisse confermato dagli accertamenti ospedalieri, sarebbe il secondo presunto
avvelenamento subito dall’attivista anti-corruzione dopo quello della scorsa
estate. Esattamente un anno fa, Navalny si trovava in stato di detenzione nel
carcere della capitale russa per trenta giorni per aver incitato la popolazione
a infrangere la legge e sfilare in una manifestazione non autorizzata dalle
autorità. Queste le motivazioni dell’arresto. Durante la breve incarcerazione,
l’uomo si era sentito male, manifestando segni di un’acuta reazione allergica;
sulla vicenda non è stata fatta completa chiarezza e soltanto un dottore ha
ritenuto plausibile la tesi del possibile avvelenamento. Il presunto tentativo
di eliminare l’attivista, che viene spesso rappresentato come il capofila
dell’opposizione antigovernativa, non sarebbe di alcun giovamento per il
Cremlino, soprattutto in un momento di alta tensione quale quello attuale. Per
quanto riguarda il fronte interno, il Paese sta venendo scosso periodicamente da
ondate di proteste, da quelle di Mosca ed Ekaterinburg dello scorso anno alla
recentissima mobilitazione di Khabarovsk, che sono indicative dell’esistenza
della crisi di legittimità attraversata dalle istituzioni – palesata dal crollo
di consensi e fiducia verso Vladimir Putin – minate dal serpeggiamento di un
innegabile malcontento popolare strumentalizzato da giocatori esterni. La morte
dell’attivista avrebbe ripercussioni negative sull’immagine delle istituzioni,
erodendo ulteriormente il consenso riscosso da Putin, e non è da sottovalutare
che possa fungere da fattore scatenante di una stagione di proteste tale da
costringere il Cremlino a deviare parte dell’attenzione dagli affari esteri a
quelli interni. I problemi sul fronte esterno sono altrettanto significativi: il
mondo russo è sotto pressione a causa di un accerchiamento poliedrico da parte
di Occidente, Turchia e Cina, e mentre le manovre delle ultime due potenze si
concentrano nello spazio postsovietico asiatico, il contenimento duro di Unione
Europea e Stati Uniti sta provocando effetti perniciosi in quello che rimane
della sfera d’influenza russa nell’Europa orientale,
ovvero Serbia, Moldavia e Bielorussia. Quest’ultima, inizialmente incamminatasi
autonomamente verso un percorso di allontanamento dal Cremlino su iniziativa di
Aleksandr Lukashenko, è stata infine travolta dai contraccolpi di quel cambio di
rotta geopolitico, perché la comunità euroamericana ha preferito condurre la
transizione con un personaggio più fidato, la liberale Svetlana Tikhanovskaya,
come palesato dalle recenti prese di posizione dell’Ue. La Russia, dapprima
forzatamente obbligata ad un basso profilo negli affari interni di Minsk per non
inimicare ulteriormente Lukashenko, si trova, adesso, costretta ad affrontare la
minaccia di un nuovo scenario Euromaidan lungo i propri confini, indecisa se
intervenire in difesa del presidente, rivelatosi inaffidabile oltre che
screditato agli occhi di larga parte della popolazione, o in supporto di
un’opposizione difficilmente penetrabile, poiché già avvicinata dall’Ue. La
morte di Navalny potrebbe fungere da miccia per l’esplosione della polveriera,
spingendo una parte della società russa a protestare in segno di solidarietà con
l’attivista che, trasformatosi post-mortem in un martire, sarebbe realmente in
grado di portare in strada un numero tale di persone da obbligare il Cremlino a
spostare l’attenzione da Minsk a Mosca, a San Pietroburgo, a Ekaterinburg, a
Khabarovsk, e in tutte quelle città che negli anni recenti hanno manifestato
insofferenza, attraversate da un importante fermento popolare.
Navalny non è una minaccia. Abbiamo raggiunto Ivan Timofeev, il
direttore dei programmi del prestigioso Russian International Affairs Council,
per capire quanto è realmente importante la figura di Navalny in Russia e quali
potrebbero essere le conseguenza della sua morte. Secondo Timofeev, “Navalny non
è una minaccia fondamentale per il governo”, perciò il Cremlino non avrebbe
alcun interesse nella sua eliminazione. L’eventuale decesso non favorirebbe
l’agenda del Cremlino, anzi getterebbe nuove ombre sulle istituzioni: in breve,
“la sua morte sarà un problema”. Tuttavia, secondo Timofeev è improbabile che
l’evento “avrà alcuna risonanza” e che i suoi seguaci possano riuscire a
collegarlo in qualche modo a quanto sta accadendo in Bielorussia; e il motivo è
semplice: contrariamente a quanto descritto dai media occidentali, Navalny
è politicamente irrilevante. Alla domanda se Navalny sia realmente influente, un
“game-changer“, all’interno del mondo politico russo, Timofeev risponde che “no,
non lo è; è una figura, anzi, piuttosto marginale”. L’opinione di Timofeev è
corroborata dai numeri, il vero strumento capace di confutare l’immagine
dell’attivista cristallizzatasi nell’immaginario collettivo euroamericano:
secondo un sondaggio d’opinione del Centro Levada del 2017, all’epoca il 48% dei
russi non era a conoscenza di chi fosse e i rispondenti positivi erano
polarizzati sul tema, il 31% credeva che fosse un politico come gli altri mentre
il 28% credeva che fosse un agente dell’Occidente.
Lucrezia Clemente per LaPresse il 21 agosto 2020. Le condizioni
di salute dell'oppositore russo Alexei Navalny si sono stabilizzate e il blogger
sarà trasferito in Germania, dall'ospedale siberiano di Omsk, per ricevere le
cure. Dai medici è arrivato il via libera al trasporto dopo un lungo braccio di
ferro con i familiari e i collaboratori dell'attivista. Lo staff di Navalny ha
accusato i sanitari di aver ritardato le procedure, su ordine del Cremlino, per
far scomparire ogni traccia del veleno contenuto nel té bevuto dall'uomo in
aeroporto, prima del malore. I medici dell'ospedale di Omsk hanno smentito la
tesi dell'avvelenamento e hanno riferito come principale diagnosi quella di un
disturbo metabolico che avrebbe causato a Navalny un calo di zuccheri con la
conseguente perdita dei sensi. Le notizie arrivate dai medici sono state
fortemente contestate dai collaboratori dell'oppositore. Se si fosse trattato di
un semplice calo di zuccheri, perché, per ore, è stato impedito il trasferimento
di Navalny in Germania? E' la domanda posta dalla portavoce del blogger, Kira
Yarmysh. Nella notte un'aeroambulanza, con attrezzature mediche e specialisti a
bordo, è decollata da Norimberga, diretta in Siberia per raggiungere Navalny e
portarlo a Berlino, dove le autorità si sono dichiarate pronte ad accoglierlo. I
medici tedeschi, dopo ore di attesa, hanno potuto visitarlo, e hanno riferito
che sarebbe stato in grado di viaggiare. Ma i medici dell'ospedale di Omsk erano
di tutt'altro avviso. Il Cremlino ha messo subito le mani avanti e ha negato di
aver posto ostacoli al trasferimento dell'uomo all'estero. Il portavoce Dmitry
Peskov ha sottolineato che la decisione aveva motivi sanitari e non politici.
Nel pomeriggio la moglie di Navalny, Yulia, ha inviato un appello al presidente
Vladimir Putin chiedendo al Cremlino il permesso per portare suo marito in
Germania. Dopo poche ore i medici russi hanno annunciato che le condizioni di
salute dell'uomo si erano stabilizzate e hanno dato il via libera all'espatrio.
La vicenda è stata seguita da vicino dall'Europa. L'Ue ha chiesto "un'indagine
rapida, indipendente e trasparente" sul malore dell'oppositore e ha esortato le
autorità russe a rispettare i voleri dei familiari sulla modalità delle cure. Il
governo tedesco, tramite il portavoce Steffen Seibert, ha invitato le autorità a
fare chiarezza in modo "completo e trasparente". Appello rilanciato anche dal
ministro degli esteri Luigi Di Maio. Quello di Navalny non sarebbe il primo caso
di avvelenamento e di scomparsa di personaggi scomodi a Mosca. Tra i precedenti,
la giornalista investigativa Anna Politkovskaja che nel 2004 si ammalò
gravemente e perse conoscenza dopo aver bevuto una tazza di té, e due anni dopo
venne uccisa a Mosca. Il giornalista e associato del leader dell'opposizione
russa Boris Nemtsov, fu ucciso nel 2015 mentre attraversava un ponte vicino al
Cremlino. E, più recentemente, nel 2018 la spia russa, diventata un doppio
agente per la Gran Bretagna, Sergei Skripal, e la figlia, sono stati avvelenati.
Navalny da tempo è una spina nel fianco per Putin, ma ora la sua pericolosità è
aumentata con le elezioni alle porte e la popolarità del presidente scesa ai
minimi storici.
Da "Ansa" il 21 agosto 2020. L'oppositore russo Alexei Navalny,
posto in terapia intensiva per sospetto avvelenamento, non verrà più trasferito
all'estero a causa del suo stato di salute "instabile". Lo ha detto oggi la sua
portavoce, denunciando una decisione che "minaccia la sua vita". "Il medico capo
ha annunciato che Navalny non è trasportabile. Le sue condizioni sono
instabili", ha scritto detto Kira Iarmych su Twitter, stimando che sarebbe
"fatalmente pericoloso lasciarlo nell'ospedale non attrezzato di Omsk" in
Siberia. Un aereo-ambulanza è decollato stanotte da Norimberga in Germania per
andare a prelevare l'oppositore russo e portarlo in un ospedale di Berlino.
Polonio, nervino, fosforo La «soluzione tranquilla» che Mosca
può negare. Guido Olimpo per il "Corriere della Sera"
il 21 agosto 2020. Una soluzione «tranquilla». Il killer silenzioso. Un metodo -
in teoria - più «pulito» del sicario con la pistola. Anche se spesso gli agenti
con licenza d'uccidere si sono fatti beccare. Certo, resta sempre un alone di
opacità, a volte manca la prova incriminante e questo basta ad un governo per
negare. Il giallo di Aleksej Navalny ne ricorda altri che hanno coinvolto la
Russia, i suoi collaboratori indicano una pista. Si basano sulla Storia, senza
che però tutto questo si trasformi immediatamente nell'evidenza del
coinvolgimento di Mosca. Riappare il fumo che nasconde le responsabilità, ci
sono sempre le condizioni per dirottare i sospetti su altri. In qualche modo i
russi sono tirati dentro dalla loro stessa propensione nel maneggiare tossine,
spesso mescolate ad una bevanda calda. Quelli del mestiere segnalano che fin
dagli anni Venti i sovietici hanno creato il famoso Dipartimento 12, detto anche
Kamera, con il compito di preparare sostanze letali. «Lavori» passati, nel
tempo, a nuove sezioni, come «Vympel», attiva durante la guerra fredda,
smantellata nel 1993 e rimessa in piedi all'interno del Dipartimento S. Un ex
funzionario dell'apparato ha ricordato che di solito c'erano 10 giorni per
preparare una missione ed altri 5 per correggere gli eventuali errori. Erano
meticolosi, con maggiore professionalità rispetto ai loro colleghi attuali, resi
vulnerabili dalle nuove condizioni esterne. Una volta alcuni fatti restavano
segreti, oggi esce tanto. All'epoca, se era necessario, l'Urss passava le sue
esperienze al Patto di Varsavia. Nel 1978 viene assassinato a Londra Georgi
Markov, un esule bulgaro. Lo colpiscono in strada usando un ombrello che spara
una minuscola sfera alla ricina. Racconteranno che sono stati i sovietici ad
assistere i fedeli alleati. Una ricostruzione di un transfuga svelerà che il
piano originale prevedeva il suo omicidio su una spiaggia in Italia, durante una
vacanza. L'esecutore avrebbe dovuto lanciargli sul corpo una miscela mentre era
al mare. Un modus operandi che ricorda quanto è avvenuto nel febbraio 2017 a
Kuala Lumpur, con il fratellastro del leader nordcoreano avvelenato con il VX
spalmato sul suo volto da due ragazze. Azione alla fine riuscita senza alcuna
conseguenza pesante per il Maresciallo. Dunque un invito a proseguire su una
tattica già attuata dal Mossad nella caccia ai palestinesi, con errori e
successi, e racchiusa negli infiniti progetti della Cia per mettere a punto armi
invisibili. Gli archivi sono pieni di casi. Nel 2002 il comandante ceceno
Khattab fa una brutta fine dopo aver aperto una lettera che era stata
contaminata. L'anno dopo è il giornalista Yury Shchekochikhin a morire per
un'emorragia celebrale, per gli amici non di origine naturale. Poi altri due
separatisti del Caucaso intossicati da qualcosa «al fosforo» in Georgia.
Settembre 2004: il politico ucraino Viktor Yushchenko è sfigurato da un attacco
con la diossina, nello stesso mese la giornalista Anna Politkovskaya si sente
male dopo aver bevuto un tè in aereo, era stato «corretto» con un prodotto mai
identificato. Verrà freddata due anni dopo. Novembre 2006: l'ex membro
dell'intelligence Alexander Litvinenko è vittima del polonio, somministrato in
un locale pubblico londinese. Gli untori usano - ancora una volta - una teiera.
È un colpo clamoroso che scatena una tempesta diplomatica non minore di quella
del 2018, con la vicenda di Sergei Skripal, agente doppio russo che provano ad
ammazzare a Salisbury, sempre in Gran Bretagna, ricorrendo al nervino Novichok.
Due dei presunti colpevoli finiscono in un'indagine aperta in Bulgaria per il
tentato omicidio - nel 2015 - di un mercante d'armi. Le telecamere di sicurezza
mostrano gli aggressori cospargere la maniglia della portiera dell'auto. Il
Cremlino ha sempre respinto le accuse bollando le rivelazioni come atti di una
campagna strumentale, ipotizzando provocazioni. Gli addebiti vanno dimostrati,
la difesa è legittima. Se non fosse per tutte quelle tazze di tè.
Inchieste sul web e piazze piene L'uomo che fa tremare Putin.
Da "La Stampa" il 21 agosto 2020. «Ciao, sono
Navalny». Ogni giovedì sul canale YouTube di Aleksey Navalny inizia un
telegiornale che racconta tutto quello che la tv di Stato non mostra. Ieri non è
andato in onda, mentre il leader dell'opposizione russa era tra la vita e la
morte in un pronto soccorso siberiano. L'edizione della settimana precedente nel
frattempo ha raggiunto quasi due milioni di visualizzazioni. Ma non è un record
(detenuto dal film-inchiesta sulla corruzione dell'ex presidente e premier
Dmitry Medvedev, con 36 milioni di visualizzazioni in tre anni), è ordinaria
amministrazione. Giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, i like, e i
crowdfunding delle rivelazioni delle inchieste di Navalny sono aumentati sempre
di più, e chiamarlo «blogger» oggi, più di dieci anni dopo il suo esordio nella
grande politica russa, è una definizione come minimo riduttiva: non è soltanto
il volto, la voce e la mente della protesta russa, è una star. È anche l'uomo
che Vladimir Putin teme di più, al punto da non pronunciare mai il suo nome, in
un rifiuto quasi scaramantico di ammettere che il suo potere viene insidiato da
un 44enne partito all'attacco del Cremlino armato soltanto di un telefonino con
account Twitter. Oggi, Navalny è un brand e un microimpero mediatico: oscurato
dalla censura, regna in Rete, e sotto l'ombrello della sua Fondazione per la
lotta alla corruzione lavorano centinaia di consulenti, attivisti e tecnici.
Navalny non è un oppositore elitista che si chiude in una cerchia di
intellettuali: è l'unico in Russia a portare in piazza decine di migliaia di
persone, non solo nelle capitali, nonostante le manganellate e gli arresti, e la
protesta di Khabarovsk, che da due mesi ormai chiede le dimissioni di Putin,
segue i codici, le parole d'ordine e le linee guida dell'oppositore. Perfino
Alexandr Lukashenko lo ha accusato di essere il burattinaio della protesta di
Minsk, e per quanto la rivolta popolare bielorussa sia molto autoctona, si è in
parte ispirata ai metodi di Navalny, rimasto compiaciuto del potere che gli ha
attribuito il dittatore bielorusso. Un potere che passa dai like e che diventa
voti: dopo essere riuscito a far prendere ai putiniani di Russia Unita il minimo
storico con il meme «partito dei ladri e dei farabutti», Navalny ha rovinato la
vita e la reputazione a decine di politici e funzionari, denunciando i loro
privilegi e le ruberie che diventano ville a Como e le dacie formato Versailles
vicino a Mosca. Tutte indagini in fonti aperte, sostengono nel team di Navalny,
che in Russia ha occupato gli spazi che nelle democrazie spettano alle
magistrature e ai giornalisti d'inchiesta. La chiave del successo è innanzitutto
il genio mediatico di Navalny, la sua capacità di spiegarsi in modo semplice (ma
non semplicistico) e di padroneggiare le tecniche dei social. Ma dietro c'è
anche un talento di organizzatore, che coordina la divulgazione politica con la
mobilitazione degli attivisti e l'iniziativa giuridica. È stata questa triade,
per citare un esempio recente, a permettere di inviare aiuti ai sindacati dei
medici russi lasciati senza protezioni a combattere il Covid-19, o a costringere
lo stesso Cremlino a seguire almeno in parte le proposte di Navalny per gli
aiuti alle famiglie durante il lockdown. O a perdere per un solo seggio la
maggioranza nel consiglio municipale di Mosca con il cosiddetto «voto
intelligente», che sostanzialmente convoglia tutto lo scontento sul candidato
non putiniano favorito, un trucco che Navalny si apprestava a ripetere in parte
delle trenta regioni russe che andranno alle urne il 13 settembre. Un secolo
dopo che Lenin aveva inventato un nuovo modello di rivoluzione con i Soviet e il
partito combattente, Navalny ha brevettato l'opposizione 2.0 all'autoritarismo
postcomunista. Il suo successo crescente si poteva misurare dagli arresti sempre
più frequenti, da sempre nuove incriminazioni e da pressioni sempre più pesanti
ai suoi collaboratori e familiari. Il nemico numero uno di Putin era protetto
dalla sua fama: quando il Cremlino decise, nel 2013, di incarcerarlo per 5 anni,
dovette cambiare idea dopo che decine di migliaia di suoi fan scesero in piazza.
Ma ora, che i suoi seguaci sono molto più numerosi, qualcuno ha deciso che i
rischi reputazionali di una sua morte violenta erano inferiori al vantaggio di
eliminare il leader di uno scontento sempre più diffuso.
Il veleno nelle mutande di Alexei Navalny:
ecco la Russia di Vladimir Putin.
Il leader dell'opposizione allo "zar" Vladimir ha pubblicato il
video di una telefonata con un agente dei servizi. Che rivela di essere stato
incaricato di far sparire le prove del suo tentato omicidio. Un episodio che
spiega bene cosa sta succedendo a Mosca. Svetlana Murzà su L'Espresso il 22
dicembre 2020. Alexei Navalny, il leader dell'opposizione russa, si sta
riprendendo da un misterioso avvelenamento. Oggi ha pubblicato, su YouTube, la
registrazione video di una telefonata. Durante la chiamata, Navalny parla
con Konstantin Kudrjavtsev, chimico militare del Servizio Federale per la
Sicurezza-FSB. Nel video Navalny si presenta come l’assistente di Nikolai
Patrushev (Capo assoluto del FSB). Kudrjavtsev racconta che il suo compito era
di “ripulire” i vestiti dal veleno quando, subito dopo l’avvelenamento, Navalny
era ricoverato presso l’ospedale in Omsk. Dalla conversazione di circa 50 minuti
diventa chiaro che il veleno era stato applicato sulle mutande del signor
Navalny.
Perché Navalny spaventa Putin. Alexey Navalny
è la spina nel fianco di Vladimir Putin già da molti anni. Tanto che, sempre
grazie a scuse burocratiche, Navalny non è stato registrato per diverse campagne
elettorali, da quelle per il sindaco di Mosca a quelle per la presidenza nel
2018. Ciononostante ha continuamente fatto inchieste su politici e oligarchi
russi, svelando i piani di corruzione e le strutture criminali ben inserite
nelle élite politiche e economiche russe, facendo venire il mal di testa a tutti
loro. Il 20 agosto 2020, durante un volo da Tomsk a Mosca, Navalny si è sentito
male ed è stato ricoverato d’urgenza presso l'ospedale di una città ai piedi
degli urali, Omsk (Siberia). Ed è stato tenuto nell’Ospedale di Omsk per circa 2
giorni, nonostante un aereo dalla Germania fosse pronto per trasportarlo subito
al Charité Hospital di Berlino. All’Ospedale di Omsk hanno a lungo
temporeggiato, dicendo che Navalny non era trasportabile e, solo dopo alcuni
giorni, hanno dato il permesso per il trasferimento in Germania, dove hanno
dichiarato che Navalny era stato avvelenato con l’agente nervino Novichok. Nella
conversazione telefonica con il chimico militare Konstantin Kudrjavtsev, diventa
subito chiaro perché avevano bisogno di questo tempo all'ospedale di Omsk.
Cosa ha detto il chimico nella telefonata. Il
21 Dicembre, alle 7 del mattino, Alexei Navalny chiama diverse persone del FSB
che ritiene membri del gruppo scelto per il suo avvelenamento. Per fare la
chiamata Navalny usa un programma semplice, che si può scaricare da
internet; quando chiami una persona, il programma fa vedere al ricevente un
numero diverso dal tuo. Navalny ha usato il numero di un collega di Kudrjavtsev.
La strategia era semplice: se alle 7 di mattina ricevi una chiamata da un numero
che conosci bene, non riesci reagire velocemente. Con le prime due o tre persone
che Navalny ha chiamato il piano non ha funzionato – hanno subito chiuso la
chiamata. Invece il chimico militare Konstantin Kudrjavtsev è stato meno
attento, ha abboccato. All’inizio non voleva parlare ma poi si è lasciato andare
e, nella conversazione di circa 50 minuti, ha rivelato tante cose
importanti. Navalny si è presentato come assistente di Patrushev, capo assoluto
del FSB, e ha detto che di dover preparare d’urgenza un rapporto di due pagine
per il Consiglio di Sicurezza (coordinato personalmente da Valdimir Putin).
Navalny chiede a Kudrjavtsev perché l’operazione-avvelenamento è «andata male e
cosa bisogna fare per far andare le cose bene». «Capisci benissimo – continua
Navalny - a chi sto facendo un rapporto su due fogli» minacciando che il suo
rapporto sarà discusso ad altissimo livello, e si riferisce al fatto che i
rapporti di due pagine sono per Putin in persona. Questo è il riassunto di
quello che ha rivelato il chimico militare Konstantin Kudrjavtsev: “Io sono solo
una parte del gruppo e non ho tutte le informazioni complete”. Kudrjavtsev
continuamente rimanda per maggiori informazioni al suo capo nel FSB. Durante la
conversazione rivela, che il suo compito era di andare a Omsk dopo
l’avvelenamento, il 25 Agosto 2020; ricevere una scatola con i vestiti dalla
Polizia di Trasporto di Omsk; “pulire” i vestiti di Alexei Navalny dalle tracce
di veleno, e riconsegnare questa scatola alla Polizia di Omsk. Il suo capo
Bogdanov, chiede in questa procedura di concentrarsi particolarmente sulle
cuciture anteriori delle mutande, in russo: “golfik”; e sulle cuciture anteriori
dei pantaloni. Questo mette in evidenza che il veleno era messo su questa parte
dei vestiti, e doveva essere assorbito dalla pelle. Kudrjavtsev rivela che
hanno seguito Navalny per diversi anni anche nei suoi viaggi, prendendo aerei
diversi da lui, e che Navalny non poteva quindi mai vedere i funzionari del
Servizio federale di sicurezza. Konstantin Kurjavtsev, non dice chi e quando ha
messo il veleno sui vestiti di Navalny, ma si riferisce diverse volte ai suoi
capi e collegi medici, che invece sanno tutto su questo: la maggior parte di
loro sono medici e scienziati. Konstantin Kurjavtsev, ha detto
che l’operazione-avvelenamento è andata male principalmente per tre motivi:
perché l’aereo è atterrato troppo presto; perché l’ambulanza dei soccorsi è
arrivata troppo velocemente; e perché i dottori dell’ambulanza avevano una
specie di antidoto che ha rallentato l’effetto del veleno. Konstantin
Kurjavtsev, alla fine della conversazione chiede: «Non è un problema che abbiamo
parlato di tutto questo al telefono normale?». Navalny risponde che il suo capo
ha approvato questa conversazione, e la situazione è di emergenza, quindi non
deve preoccuparsi di questo.
Che cosa esattamente ci racconta questa
conversazione tra Navalny e Kudrjavtsev? Prima di tutto, l’evidente degradazione
del sistema di sicurezza russo. I lavoratori dell’ Agenzia più importante per la
sicurezza sono impegnati in atti criminali contro i cittadini russi. E non si
tratta solo di poliziotti e militari, ma anche di scienziati, medici e
ricercatori. Sono tutti consapevoli di questi atti criminali, terroristici,
amorali e tuttavia continuano a farli. In questo caso andando anche contro la
Convenzione sulle armi chimiche (CAC), firmata il 13 gennaio 1993 anche dalla
Russia. Ma questa è solo la punta dell’ iceberg – la realtà è ancora più grave.
Secondo Navalny, la pubblicazione di questa telefonata con Kurjavtzev ha fornito
prove evidentissime della natura criminale del governo russo, il presidente
Putin non fa eccezione. È bene ricordare che questa situazione di Navalny e la
pubblicazione della telefonata con Kurjavtzev rende questo caso criminale
diverso da tanti altri: come, ad esempio, l’omicidio di Boris Nemtsov, un altro
oppositore Russo nel 2015; l’avvelenamento di Sergei e Yulia Skripali, in
Inghilterra nel 2018; l’avvelenamento di Aleksandr Litvinenko nel 2006;
l’omicidio di Anna Politkovskaja, giornalista russa, nel 2006; e tanti altri.
Per due motivi connessi tra di loro: primo, secondo Navalny, ci sono le prove
che la operazione è stata effettuata da funzionari FSB, e non da un gruppo
criminale esterno al governo. Secondo, i funzionari FSB non possono effettuare
operazioni importanti come l’avvelenamento di Navalny senza un ufficiale
permesso o comando di Putin, perché questo servizio dipende direttamente da lui.
Putin supervisiona personalmente le strutture militari e i servizi segreti.
Gennady Gudkov, politico ed ex-funzionario del servizio segreto russo, conosce
il sistema molto bene dall’interno; e conferma che non è possibile immaginare
una situazione in cui i funzionari FSB facciano operazioni così importanti senza
il permesso o il comando di Putin in persona. Se per i precedenti omicidi di
politici, giornalisti, ex-agenti segreti, c’era un minimo dubbio che ci
potessero essere delle strutture criminali sfuggite al controllo di Putin, dopo
la pubblicazione della telefonata Navalny-Kurjavtzev, questo dubbio non c’è più.
Secondo Gudkov, questo non è solo il fallimento del sistema; tutto ciò, rivela
anche che “Putin è il capo di un gruppo criminale che ha preso il potere in
Russia”. Nell’ambito delle scienze politiche questo fenomeno spesso viene
riferito in termini di state capture, che è un “tipo di corruzione politica
sistemica in cui gli interessi privati influenzano in modo significativo i
processi decisionali di uno stato a proprio vantaggio”. Questi termini sono
stati definiti dalla Banca Mondiale nel 2000, per descrivere la situazione nei
paesi post-Sovietici dell’ Asia Centrale. Ma nella Russia di oggi la situazione
attuale è ancora peggiore, perché non solo gli interessi privati influenzano
le decisioni del governo, ma i primi funzionari del governo pensano solo ai loro
interessi privati, effettuando operazioni criminali per mantenere la loro
posizione.
P.S. Il 21 Decembre 1991 stato firmato il
documento che ha messo la parola fine sul collasso dell’Unione Sovietica. Sembra
che il 21 Dicembre di 2020 possa essere la fine della Russia di Putin. Dimitri
Peskov, press secretary di Putin, ha detto oggi che non hanno visto il video
pubblicato da Navalny: non hanno tempo per questo.
Fabrizio Dragosei per il “Corriere della Sera” il 23 dicembre
2020. Negli ambienti dello spionaggio russo, dal palazzo della Lubianka dove
hanno la sede dal 1919 ai corridoi del Cremlino occupato dall'ex agente Vladimir
Putin, c'è grande agitazione per gli ultimi sviluppi dell'affaire Navalny. Quasi
15 milioni di persone hanno già visto il video nel quale il principale
oppositore del presidente russo parla al telefono con uno dei suoi avvelenatori
spacciandosi per un alto funzionario governativo. E gli fa raccontare tutti i
dettagli dell'operazione Novichok svoltasi in Siberia. Non potendo negare che
Konstantin Kudryavtsev, 40 anni, esperto di sostanze chimiche e batteriologiche,
esista e sia un agente, gli alti vertici russi hanno reagito finora in maniera
abbastanza scomposta. La prima risposta è venuta dal ministero degli Esteri che
ha convocato gli ambasciatori di Francia, Germania e Svezia per annunciare nuove
sanzioni contro funzionari dei Paesi europei che hanno appurato le cause
dell'avvelenamento di Navalny, oltre all'Organizzazione internazionale per la
proibizione delle armi chimiche (in risposta alle misure Ue di ottobre). Fatto
curioso ma che si spiega con l'insistenza del Cremlino nel rimanere fedele alla
sua linea, per quanto poco plausibile questa possa apparire: è tutto falso. Il
20 agosto Navalny si è sentito male dopo essere salito a Tomsk sull'aereo per
Mosca. Per sua fortuna il pilota ha fatto scendere il jet a Omsk dove il pronto
intervento dei sanitari gli ha salvato la vita, come avrebbe confermato nella
telefonata resa nota lunedì l'agente Kudryavtsev che era stato poi mandato
proprio a Omsk a cancellare le tracce del veleno dalle mutande contaminate del
blogger. Dopo pochi giorni, la moglie di Navalny è riuscita a ottenere da Putin
il permesso di portarlo in Germania per ulteriori cure. E questo è già un fatto
per noi incomprensibile, visto che nella maggior parte dei Paesi un paziente è
libero di farsi curare dove vuole. A Berlino gli esperti hanno determinato
l'avvelenamento con una variante del Novichok, sostanza chimica inventata dagli
scienziati dell'Urss. Cosa confermata da altri laboratori in Francia e Svezia.
L'Organizzazione internazionale ha anche determinato che si tratta di una nuova
variante. Il che fa sospettare fortemente che i russi abbiano continuato a
sviluppare armi chimiche in violazione al trattato solennemente firmato nel
1993. Mosca, da subito, ha adottato la linea del negare e ridicolizzare. A Omsk,
le autorità locali hanno detto di non aver trovato alcuna traccia di Novichok,
anche se ora sappiamo dalla «confessione» di Kudryavtsev che solo diversi giorni
dopo il suo team ha ripulito la biancheria di Navalny. Ora l'Fsb sostiene che la
telefonata messa in piazza dal blogger è fasulla, una creazione dei servizi
occidentali. Mentre il portavoce di Putin si è spinto a dire che Navalny soffre
di «mania di persecuzione e per alcuni si paragona a Gesù». L'intera vicenda è
un brutto colpo anche alla credibilità e al mito dei famigerati «organi». Come
minimo, visto che lo stesso Putin ha ammesso che seguivano da tempo Navalny, non
si sarebbero accorti che qualcun altro avvelenava il politico sotto i loro
occhi. Sul web fioccano lazzi su spie e mutande. Un noto cineasta, Vitalij
Manskij, è stato fermato (e poi rilasciato) davanti alla Lubianka mentre agitava
un paio di boxer: «Ero venuto a chiedere se me li potevano ripulire». Un altro
attivista innalzava un cartello con un'originale spiegazione della sigla Fsb:
«Pulizia federale della biancheria».
Mosca: "Navalny mitomane". Richiamati gli
ambasciatori. La
telefonata-denuncia colpisce nel segno. Il portavoce di Putin: "Soffre di manie
persecutorie e si crede Gesù". Luigi Guelpa, Mercoledì 23/12/2020 su Il
Giornale. Alexey Navalny continua a sostenere di aver incastrato i servizi
segreti, per tutta risposta i vertici dell'Fsb, i servizi segreti, parlano di
«montatura», mentre il Cremlino non esclude la linea dura verso tutti i Paesi
dell'Ue, in primis la Germania, che hanno aiutato in questi mesi il leader
anti-Putin. Il caso Navalny sta assumendo una dimensione sempre più
internazionale dopo che il dissidente ha pubblicato l'altro giorno una presunta
telefonata con un supposto agente segreto che avrebbe ammesso le responsabilità
dei servizi russi nel suo avvelenamento. Putin non si è ancora espresso
personalmente sugli ultimi sviluppi (dopo aver negato venerdì scorso qualsiasi
coinvolgimento), ma si è affidato al suo portavoce Dmitri Peskov che ha accusato
Navalny di soffrire di «manie di persecuzione. Il mio è un commento a titolo
personale, ma credo che quell'uomo sia convinto di essere Gesù Cristo in terra e
non perda occasione per trovare qualsiasi appiglio pur di apparire al centro
dell'attenzione». Più drastica la posizione del ministro degli Esteri Sergey
Lavrov che, in risposta alle sanzioni dell'Ue imposte a ottobre a Mosca dopo
l'avvelenamento di Navalny, ha deciso di ampliare l'elenco dei divieti di
ingresso dei rappresentanti di Bruxelles sul territorio russo. Lavrov ha
notificato ufficialmente l'azione reciproca della Russia ai capi delle missioni
diplomatiche di Germania, Francia e Svezia a Mosca, nonché alla delegazione
dell'Ue. Contestualmente ieri pomeriggio ha convocato l'ambasciatore francese in
Russia Pierre Levy, un rappresentante dell'ambasciata svedese e vice
ambasciatore permanente della Germania per ulteriori chiarimenti. Per Lavrov
«Bruxelles ha agito in maniera frettolosa e segreta. Ha preso una decisione
politica conflittuale che va contro le prerogative legali internazionali,
snobbando il trattato di Helsinki di non intervento negli affari interni». Dal
canto suo Navalny si dice convinto di aver smascherato i suoi aguzzini, e da
Berlino, dove si trova in convalescenza, continua a rilasciare nuove
dichiarazioni. «Sto notando un certo nervosismo da parte del Cremlino e non sono
sorpreso. Ho fornito prove inconfutabili e non sanno più che cosa inventarsi per
difendersi». Ricordiamo che a fornirgli la chiave del misterioso avvelenamento
sarebbe stato proprio un ufficiale dell'Fsb, Konstantin Kudryavtsev, cadendo in
pieno nel tranello telefonico tesogli dall'avversario numero uno di Putin.
Kudryavtsev non solo avrebbe confessato l'operazione ordita dall'intelligence
per far fuori il dissidente, ma rivelato che la tossina sarebbe stata spruzzata
sui boxer dell'oppositore. Il capo dell'Fsb, Aleksandr Bortnikov, ha però
bollato la telefonata di Navalny come «un falso» e l'inchiesta come «una
provocazione pianificata non avrebbe potuto aver luogo senza il supporto
organizzativo e tecnico di intelligence straniere». Eppure il video postato da
Navalny della famigerata telefonata sta facendo il giro del globo, e ha ottenuto
fino a ieri qualcosa come 15 milioni di visualizzazioni. Nelle immagini si vede
Navalny presentarsi a Kudryavtsev come Maxim Sergeevich Ustinov, presunto
assistente del segretario del Consiglio di sicurezza Nikolai Patrushev, un
fedelissimo di Putin e di certo tra le persone più potenti della Russia. La
vicenda viene seguita con grande attenzione dalla cancelliera tedesca Angela
Merkel, che potrebbe concedere a Navalny asilo politico (se rientrasse in patria
verrebbe arrestato per alto tradimento). Una mossa che porterebbe però a un
tracollo del rapporto economico tra Berlino e Mosca. In questi anni Gazprom,
E.ON e Basf hanno portato avanti non solo una proficua collaborazione, ma stanno
perfezionando la realizzazione dell'ultimo tratto del gasdotto baltico nell'area
delle acque territoriali tedesche. La Merkel, attraverso una nota del suo
ufficio stampa, non ha escluso di voler incontrare Putin in Russia entro
febbraio.
Le ultime ore
del sottomarino Kursk: venti anni fa la tragedia che sconvolse la Russia. Il
Dubbio il 15 agosto 2020. Per esibire preparazione degli equipaggi e qualità dei
mezzi navali, il 12 agosto del 2000, vent’anni fa, era stata organizzata
un’esercitazione in mare alla quale prendeva parte, con un ruolo di primo piano,
il gioiello della nuova flotta russa, il sommergibile d’attacco a propulsione
atomica Kursk. Vladimir Putin era fresco di nomina nell’agosto del 2000, aveva
vinto le sue prime elezioni presidenziali il 26 marzo e giurato il 7 maggio. Si
era in piena crisi cecena. Per non essere marginalizzata al momento della
divisione del budget della difesa, la marina russa intendeva dimostrare la
propria rinnovata capacità nautica e bellica, dopo il disastro conseguente alla
scomparsa dell’URSS, quando decine di navi erano rimaste ad arrugginire nei
porti. Allora si era rivelato un problema, risolto da tecnici francesi, anche lo
smaltimento dei noccioli radioattivi dei motori nucleari dei sottomarini
balistici da trentamila tonnellate. Per esibire preparazione degli equipaggi e
qualità dei mezzi navali, il 12 agosto del 2000, vent’anni fa, era stata
organizzata un’esercitazione in mare alla quale prendeva parte, con un ruolo di
primo piano, il gioiello della nuova flotta russa, il sommergibile d’attacco a
propulsione atomica Kursk, della classe Oscar I/ II secondo la classificazione
NATO, di 13.500 tonnellate di dislocamento in immersione. Entrato in servizio
nel 1995, aveva un equipaggio di 107 uomini, anche se per l’occasione si
trovavano a bordo tecnici e osservatori, che portavano il totale delle persone
imbarcate a 118. Le manovre della flotta russa si svolgevano nel Mar di Barens,
a nord della Norvegia, in una giornata di tempo buono e mare calmo. Prevedevano
che il Kursk effettuasse il lancio di un siluro a salve contro un incrociatore
per poi far perdere le proprie tracce alle unità di scorta che si sarebbero
messe in caccia dell’attaccante. Qualcosa non funzionò, ma in mare, mentre si
simulano le condizioni di guerra e si attende che qualcosa di bellico succeda è
difficile rendersi conto di quello che accade, nello stretto corridoio tra
realtà e finzione.
Alle 08: 51
locali il Kursk richiese il permesso, che venne accordato, di procedere nella
manovra come previsto.
Alle 11: 28
gli idrofoni di alcune unità della flotta russa rilevarono i rumori
caratteristici di un lancio di siluri, seguito quasi subito da uno scoppio di
notevole intensità.
Trascorsero
ancora circa due minuti e venne udita un’esplosione molto più violenta,
proveniente dalla medesima direzione. A questo punto la vicenda diviene
controversa. Chi rilevò che cosa, e chi era in grado di comprendere il
significato dei suoni ascoltati e registrati?
Chi conosceva
i dettagli degli ordini impartiti ed era in grado di valutare quanto gli
accadimenti si discostavano dal loro sviluppo normale?
L’esercitazione prevedeva che si udissero delle esplosioni e i sottomarini sono
progettati per attaccare e poi far perdere le proprie tracce, scomparire
silenziosi nell’immensità dei mari. Questo anche se la profondità delle acque
nella zona scelta per le manovre della flotta russa raramente supera le poche
centinai di metri. Le ragioni per quello che accadde sono molteplici, mentre il
corso degli eventi è univoco: per alcune ore nessuno si preoccupa dell’assenza
di notizie relative al Kursk. È solo a sera, alle 18.00, ora prevista per un
contatto radio fra tutte le unità impegnate nella manovra, che ci si rende conto
che il sottomarino è scomparso. Un aereo da ricognizione Ilyushin anti sub si
leva in volo per ricercarlo, ma inutilmente.
Alle 22: 30 la
gravità della situazione si fa evidente e l’esercitazione viene sospesa. Una
ventina di navi, molti aerei e 3000 uomini iniziano una sistematica esplorazione
dell’area nella quale la flotta era stata impegnata. A mezzanotte e mezzo prende
il mare da Murmasnk la Mikhail Rudnitsky, la nave appoggio sottomarini della
marina russa. In agosto nel Mare di Barens è sempre giorno e questo sembra
rendere più agevole l’avvistamento e l’eventuale soccorso dell’unità scomparsa.
Gli
osservatori occidentali che seguono le manovre rilevano ricerche frenetiche,
messe in atto da un vasto apparato, e comprendono che si tratta di tentativi di
individuare la posizione di un sottomarino del quale si sono perse le tracce e
che con molte probabilità si trova in grave avaria. Nei decenni della guerra
fredda avvenimenti simili si erano verificati più volte, per entrambe le flotte
in competizione. I governi occidentali offrono a quello russo la loro
collaborazione nella ricerca, ma la proposta viene rifiutata, non è ben chiaro
se per volere di Putin o su pressione degli ammiragli russi. Il Kursk è il
prodotto della più avanzata ingegneria navale russa, consentire agli occidentali
si avvicinarsi o di salire a bordo significherebbe metterli a parte di ogni
segreto costruttivo. Solo nella notte tra il 13 e il 14 si individua infine la
probabile posizione del Kurst, adagiato su di un fondo sabbioso a circa cento
metri di profondità. Qualcuno commenta che il sottomarino è lungo più di 150
metri: se fosse messo in verticale le eliche uscirebbero dall’acqua insieme a
tutta la poppa. La mattina successiva arriva sul posto il rimorchiatore d’altura
Nikolay Chiker, che dispone di una fotocamera da immersione con la quale si
ottengono le prime immagini dello scafo. Iniziano i tentativi di mettersi in
contatto con eventuali superstiti per effettuarne il salvataggio. Intanto a
Vidyayevo, il paesino nei pressi di Murmansk dove vivono le famiglie dei
sommergibilisti russi, si svolgono manifestazioni di protesta: i parenti degli
uomini imbarcati sul Kurst chiedono di essere informati sui termini reali della
situazione. La perestroika e la glasnost sono penetrate anche nei gangli più
nascosti e protetti del sistema militare russo. Numerose missioni di soccorso
tentate con i mezzi subacquei a disposizione della Mikhail Rudnitsky falliscono
nei giorni successivi. La tecnologia della nuova Confederazione Russa non si
dimostra più avanzata ed efficiente di quella sovietica. Intanto la bonaccia
termina e il mare comincia ad agitarsi, i limiti operativi degli apparati
impiegati mostrano tutti i loro limiti. Il 17 agosto, cinque giorni dopo il
disastro, Putin decide di accettare le offerte di collaborazione alle operazioni
di salvataggio avanzate dalle marine inglese e norvegese. Non quella
statunitense, non gradita dagli ammiragli russi dopo quasi un cinquantennio di
confronto in tutti i mari del mondo. Gli statunitensi rimangono pur sempre il
nemico, rivolgersi a loro per un aiuto sarebbe umiliante. Anche con i quasi
neutrali inglesi e norvegesi sorgono problemi. Per intervenire i tecnici
occidentali hanno bisogno di informazioni sull’architettura del Kursk e sui
sistemi di emergenza di cui dispone, in particolare dei portelli e di ogni altro
possibile accesso allo scafo. Superate molte diffidenze, alla fine ci si risolse
ad autorizzare una visita dei responsabili inglesi e norvegesi all’Oryol, unità
gemella del Kursk e dotata degli stessi sistemi per affrontare situazioni
critiche. In quell’occasione si scoprì che gli alberi delle eliche non erano a
tenuta stagna in condizioni di arresto e che l’acqua imbarcata penetrava proprio
nel compartimento poppiero, il nove, dove era prevista la riunione
dell’equipaggio in caso di pericolo. Il 21 agosto i sommozzatori anglo norvegesi
riescono a introdurre una telecamera nel compartimento interessato del Kurst,
che sembra il meno danneggiato e presso in quale si trova la camera stagna
destinata alle uscite d’emergenza. In un contesto di distruzione con evidenti
tracce di incendio vengono individuati i corpi ustionati e senza vita di
numerosi marinai russi. Ogni speranza di trovare dei superstiti scompare. Una
successiva ispezione del relitto conferma che alle esplosioni che hanno
squarciato lo scavo del sottomarino sono sopravvissuti 23 membri
dell’equipaggio, ma solo per poche ore. Martedì 22 agosto Putin, nonostante sia
stato sconsigliato di farlo per tema delle contestazioni cui rischia di andare
incontro, si reca a Vidyayevo e incontra le famiglie dei defunti nei locali del
centro culturale della base. Alle circa cinquecento persone riunite il neo
presidente russo dà numerose assicurazioni, di natura economica e previdenziale,
e fa alcune promesse, tutte mantenute, di carattere umanitario, tra di esse ci
sono quelle di recuperare il relitto, dare sepoltura ai defunti e scoprire le
vere cause dell’incidente. Il Kursk fu riportato in superficie l’ 8 ottobre
2001, al termine di un’operazione di sollevamento svolta da una società olandese
e costata circa 65 milioni di dollari. L’analisi dello scafo e dei danni che
presentava ha permesso di ricostruire con buona approssimazione la dinamica
degli eventi. Tutto cominciò con il malfunzionamento del sistema di propulsione
del siluro da esercitazione che doveva essere lanciato. Una perdita di perossido
di idrogeno dovuta a cattiva manutenzione causò una prima esplosione, che
devastò la plancia del Kurst, lo fece affondare e innescò un secondo scoppio,
molto più violento, delle testate da guerra imbarcate sul sottomarino e stoccate
in prossimità dei tubi lanciasiluri. I pochi superstiti si rifugiarono,
rispettando le istruzioni in caso di emergenza, nel compartimento nove, dal
quale non riuscirono a uscire abbandonando l’unità per il danneggiamento della
camera stagna a seguito delle esplosioni avvenute. Presto l’acqua cominciò ad
allagare anche il compartimento nove, mentre l’ossigeno diminuiva. Venne allora
accesa una candela per la produzione di ossigeno il cui innesco provocò però
l’incendio dei fumi di carburante presenti nell’aria e la combustione
dell’ossigeno rimanente. Così persero la vita gli ultimi superstiti del Kurst.
Dalla prima esplosione erano trascorse circa sei ore. Ai parenti rimase la
consolazione di sapere che la morte fu repentina, forse alcuni di loro non si
accorsero degli ultimi istanti. Non dovettero sopportare una lunga agonia mentre
le possibilità di salvarsi scomparvero presto. Neppure un tentativo di soccorso
tempestivo avrebbe avuto successo. Particolarmente commovente fu il ritrovamento
degli appunti scritti da Dmitrij Kolesnikov, il più alto in grado dei 23
superstiti, che assunse il comando del gruppetto chiuso nel compartimento nove,
registrò quello che accadeva e continuò a tracciare le ultime incerte parole
rivolte ai familiari anche dopo che l’ambiente era precipitato nel buio. Il
testo di Kolesnikov si conclude con «Saluto tutti, non dovete disperarvi».
La tragedia del Kursk, un mistero ancora irrisolto.
Paolo Mauri il 12 agosto 2020 su Inside Over. Latitudine
69°36’59” Nord, longitudine 37°34’26” Est. Mar di Barents, non lontano da
Poljarnyj, una delle tane dei sottomarini russi in quel lungo fiordo che prende
il nome di Baia di Kola. Queste sono le coordinate geografiche in cui il Kursk,
un sottomarino a propulsione nucleare lanciamissili da crociera (Ssgn), è
affondato portando con sé le vite di 118 uomini. È il 12 agosto del 2000, un
sabato, e la Flotta Russa del Nord ha preso il mare per la più grande
esercitazione navale dai tempi della Guerra Fredda: 30 navi di superficie, tra
cui l’incrociatore classe Kirov Piotr Velikij accompagnato dall’ammiraglia della
flotta, la portaerei Admiral Kuznetsov, e quattro sottomarini. Sono tempi
difficili per la Flotta Russa: i ripetuti tagli di bilancio degli anni
precedenti, causati dalla dissoluzione dell’Unione Sovietica, ne hanno menomato
fortemente le capacità operative. Nel 2000 la condizione delle infrastrutture di
supporto era atroce: i moli dei sottomarini, il caricamento dei siluri le gru,
le officine di riparazione, le attrezzature di soccorso, i centri di
addestramento e gli alloggi versano tutti in pessime condizioni. Nel 1995, il
bilancio annuale della flotta viene speso interamente nella prima metà dell’anno
così il pagamento degli stipendi per il personale viene sospeso per diversi
mesi, generando malcontento e soprattutto vergogna: quella che un tempo era una
delle più potenti flotte del mondo, la seconda per numero dopo quelle
statunitense, stava arrugginendo nei porti. Il neoeletto presidente della
Russia, Vladimir Putin, promise di aumentare il prestigio delle Forze Armate
ridando dignità ai militari vilipesi da un decennio di tagli e incuria. Per
impressionarlo gli ammiragli della Flotta del Nord decisero di tenere, pertanto,
la solita esercitazione estiva annuale su una scala mai vista dopo il crollo
dell’Unione Sovietica. Un’occasione per ridare prestigio alla Russia agli occhi
del mondo. Un’occasione per impressionare alleati – erano presenti osservatori
militari cinesi – e avversari – i Paesi occidentali – che allora non erano così
tanto avversari. Il Kursk era il sottomarino simbolo della rinascita della
Russia. Impostato nel 1990, varato nel 1994 ed entrato in servizio un anno dopo,
rappresentava il moto di orgoglio della Federazione Russa che voleva dimostrare
al mondo che il Cremlino era ancora un attore di cui tener conto sul
palcoscenico della politica internazionale. Il Kursk (codice identificativo
K-141), apparteneva alla classe Antey, o project 949A (Oscar II in codice Nato),
che rappresentava, a quel tempo, il non plus ultra della tecnologia in fatto di
costruzioni navali sottomarine russe. Il fiore all’occhiello della Flotta
quindi, e la prima unità di questo tipo ad entrare in servizio dalla
dissoluzione dell’Unione Sovietica. Comandato da Gennady Lyachin, un ufficiale
esperto e veterano dei sottomarini, sin dal 1996, il Kursk, prima
dell’esercitazione in cui affondò, partecipò solo ad una missione nel Mar
Mediterraneo: un pattugliamento di sei mesi a cavallo dell’estate del 1999 per
monitorare l’attività della Sesta Flotta Usa. Le unità della classe Antey sono
tra le più grandi esistenti al mondo: concepiti come piattaforme di lancio per
missili da crociera in grado di colpire i gruppi di portaerei americane, sono
armati di 24 missili P-700 Granit (SS-N-19 Shipwreck in codice Nato) che vengono
lanciati da canister annegati nella struttura del sottomarino ai lati della
falsatorre. Inoltre, come tutti i sottomarini, dispongono di tubi lanciasiluri
da 533 e 650 millimetri che, nel caso del Kursk, sono in grado di utilizzare
anche missili antisom tipo Rpk-7 Veter (SS-N-16 Stallion). Gli Antey, come
detto, sono di notevoli dimensioni: il Kursk era lungo 154 metri per 18,2 di
larghezza con un dislocamento, in immersione, di circa 19mila tonnellate (a
pieno carico). Le sue due eliche a sette pale ciascuna erano spinte dalla
potenza generata da due reattori nucleari Ok-650b in grado di erogare
complessivamente 98mila cavalli per poter spingere l’unità alla velocità massima
di 32 nodi in immersione. Un killer veloce, potente, e sfuggente. Erano passati
pochi giorni dalla Festa della Marina, quando il Kursk, nel porto
di Severomorsk, inalberava fieramente il gran pavese con l’equipaggio schierato
sulla tolda rendendo gli onori alle autorità della Flotta Russa presenti:
possiamo provare a immaginare il sentimento di orgoglio che accomunava quegli
uomini, consci anche dell’importante missione che avrebbero svolto a breve. Ora,
in quel mattino d’agosto, il sottomarino prendeva il mare per un’esercitazione
che avrebbe finalmente dimostrato al mondo che la Russia era ancora una potenza
navale da rispettare e temere. Compito del sottomarino era avvicinarsi
furtivamente al gruppo navale di superficie e simulare il lancio di siluri di
nuova fabbricazione proprio contro una delle più grandi unità della flotta:
l’incrociatore Piotr Velikij. A bordo, infatti, sembra che ci fossero, oltre
alle normali dotazioni, anche i Va-111 Shkval, un siluro “razzo” che grazie al
fenomeno fisico della supercavitazione può raggiungere velocità elevatissime in
immersione (si stima intorno ai 370 km/h). Tutto sembra andare per il meglio, e
forse il comandante Lyachin assaporava già gli allori del suo ritorno trionfale
in porto. Alle 11:28 locali (7:28 Utc) fu dato l’ordine di lanciare dei siluri
da esercitazione, ma qualcosa andò storto: vi fu un’esplosione a bordo che
liberò una potenza compresa tra i 100 e i 250 chilogrammi di Tnt producendo
un’onda sismica di magnitudo 2,2 , in conseguenza della quale il sottomarino si
adagiò sul fondo a 108 metri di profondità nel Mar di Barents al largo della
penisola di Kola. Una seconda esplosione avvenne 135 secondi dopo la prima con
un’intensità compresa tra magnitudo 3,4 e 4,4 quindi con una potenza compresa
tra le 3 e le 7 tonnellate di Tnt. L’esplosione sommerse il sottomarino con
molti detriti condannandolo insieme all’equipaggio, almeno alla maggior parte di
esso. L’onda d’urto della seconda deflagrazione, infatti, uccise sul colpo la
maggior parte degli uomini a bordo tranne 23, che trovarono rifugio nei
compartimenti poppieri del sottomarino. Qui comincia quella che è, forse, la
vera tragedia del Kursk. Quei 23 superstiti, bloccati dentro il sottomarino,
ancora non sapevano che si sarebbe trasformato in una bara d’acciaio: dopotutto
erano a soli 100 metri di profondità e forse confidavano di poter cercare di
uscirne con le dotazioni di salvataggio, oppure speravano che la Flotta Russa,
la potente Flotta del Nord, corresse in loro aiuto, ma così non fu. Tra quei 23
uomini c’era Dimitry Kolesnikov, un tenente-capitano (il nostro tenente di
vascello) di soli 27 anni, l’ufficiale più alto in grado rimasto vivo a bordo
del Kursk. Come lo sappiamo? Perché, in quelle terribili ore, ci ha lasciato la
sua testimonianza scritta. Scrive così Kolesnikov su un appunto trovato sul suo
cadavere: “ore 13:15. Tutto il personale dai compartimenti sei, sette e otto è
stato spostato nel nono. Qui siamo in 23. Abbiamo preso questa decisione in
seguito all’incidente. Nessuno di noi può uscire” ed ancora “ore 15:45. Qui è
troppo buio per scrivere, ma ci proverò a tentoni. A quanto pare non ci sono
possibilità di salvarsi. Forse solo dal 10 al 20%. Speriamo che almeno qualcuno
leggerà queste parole. Qui ci sono gli elenchi degli effettivi che adesso si
trovano nella nona sezione e tenteranno di uscire. Saluto tutti, non dovete
disperarvi”. Nessuno uscì vivo. Quei 23 marinai, quei 23 ragazzi poco più che
ventenni, perirono probabilmente qualche ora dopo che il sottomarino perse la
capacità di generare energia, al buio, al freddo di quel mare artico, ma
dopo giorni di tentativi di recupero falliti. Ipotermia, asfissia, annegamento.
Queste le cause di morte di quegli uomini, stabilite quando il relitto è stato
recuperato. Una morte orrenda, una morte che poteva essere, forse, evitata. Il
relitto fu localizzato solo alle 23:30 del 12 ed un primo tentativo di aggancio
da parte del Priz, un batiscafo di recupero in servizio nella Flotta, fallì.
Lunedì 14 agosto i governi di Regno Unito e Norvegia offrirono il loro aiuto per
cercare di salvare l’equipaggio, che allora dava ancora segni di vita, ma il
Cremlino rifiutò. Il giorno successivo, mentre, a fronte del maltempo che
imperversa sulla zona, i tentativi di salvataggio vennero sospesi, a Mosca si
dibatté sulla possibilità di accettare l’aiuto occidentale. Il 16 l’ammiraglio
Popov, comandante in capo della Flotta Nord, ebbe il via libera dal Cremlino per
accettare l’intervento dei mezzi di recupero norvegesi, ma dal Kursk, nessun
segnale di vita. Un silenzio che perdurerà anche quando venne accettato l’aiuto
inglese, ma ormai non c’era più speranza di recuperare i superstiti a bordo.
Mosca ammetterà che non c’era più possibilità di ritrovare in vita i 23 membri
dell’equipaggio solo il 19, generando un’onda di commozione e rabbia tra i
famigliari che mise in difficoltà sia i vertici della Flotta sia la stessa
presidenza: la Russia non è più sovietica e, sebbene i metodi di comunicazione e
insabbiamento siano rimasti gli stessi, la popolazione non era più disposta a
sopportarli. Un fatto inaudito che fece traballare i vertici dello Stato e della
Marina. L’accusa era quella di essersi mossi lentamente e in modo del tutto
inadeguato: del resto i mezzi di soccorso occidentali furono tenuti lontano del
relitto sino al 20 quando alla Seaway Eagle, nave di recupero e ricerca inglese,
venne permesso di avvicinarsi al relitto, un relitto che era ormai diventato una
gigantesca bara di acciaio. Il 21 la Normand Pioneer, vascello battente bandiera
norvegese, riuscì finalmente ad avere il permesso di inviare il
batiscafo LR5 sul Kursk solo per certificare, se non ve ne fosse stata già
certezza, che il sottomarino era completamente allagato e che non vi erano
sopravvissuti. Ma cosa ha determinato l’affondamento del sottomarino vanto della
Flotta Russa? La versione ufficiale riporta che una perdita di combustibile da
uno dei siluri tipo 65-76A ha innescato un’esplosione primaria ed un relativo
incendio che ha innescato la successiva deflagrazione contemporanea di tutti i
siluri presenti a bordo. Però questa spiegazione non convince del tutto, e a
sollevare ipotesi diverse c’è proprio l’alone di mistero e segretezza alzato
intorno al relitto reso ancora più evidente dall’attività russa nei suoi pressi
durante le fasi di recupero messe in atto l’anno successivo al disastro:
sappiamo infatti che la Marina Russa ha ammesso di aver lanciato oltre 50 bombe
di profondità contro presunti intrusi occidentali: un gesto che del tutto poco
ortodosso e che può anche essere considerato come un atto di guerra date le
circostanze. Ma nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita sul perché di
tanti sforzi e di tanti rischi. Quale potrebbe essere la spiegazione di un tale
comportamento e perché la parte prodiera del sottomarino è stata abbandonata sul
fondo e distrutta con cariche di profondità? Proviamo a fare delle ipotesi:
durante l’esercitazione del 12 agosto i sottomarini russi non erano gli unici
presenti in quelle acque. Sappiamo infatti che due sottomarini statunitensi,
l’Uss Memphis e l’Uss Toledo, della ben nota classe di unità da assalto
(Ssn) Los Angeles, erano presenti per osservare le manovre della Flotta Russa.
In particolare il Memphis avrebbe dovuto osservare lo svolgimento
dell’esercitazione tenendosi a distanza, mentre il Toledo avrebbe invece avuto
ordini di tallonare il Kursk come nella più classica tradizione della Guerra
Fredda, in cui i sottomarini di entrambe le parti si inseguivano reciprocamente
nelle profondità oceaniche. Qualcosa però sarebbe andato storto ed il Toledo
avrebbe urtato il sottomarino russo, senza tuttavia causargli gravi danni.
L’unità americana, danneggiata, avrebbe tentato di allontanarsi aiutata dal
Memphis che rilevando che il Kursk stava attivando i suoi sistemi d’arma,
avrebbe lanciato un siluro di tipo Mark 48, colpendolo in pieno nella sezione di
prua, ovvero all’altezza della camera di lancio siluri. Questo quindi avrebbe
comportato la reazione a catena che abbiamo descritto e causato la perdita del
sottomarino e del suo equipaggio. Gli Stati Uniti hanno sempre smentito questa
versione, sebbene abbiano confermato la presenza delle proprie unità in quelle
acque, ma a sollevare il sospetto che possa esserci stata una battaglia navale
sottomarina è una fotografia che ritrae, sulla fiancata dello scafo del Kursk,
un foro circolare con le lamiere piegate verso l’interno, proprio come se avesse
subito un colpo di siluro. Ulteriore sospetto è dato dalla decisione di
Washington, qualche tempo dopo il disastro, di cancellare un debito della Russia
del valore di 10 miliardi di dollari, ma questo provvedimento potrebbe trovare
spiegazione anche nell’arresto di una spia americana, Edmond Pope, che stava
cercando di appropriarsi dei segreti del siluro Shkval. Pope, agente della Dia
(Defenese Intelligence Agency), venne arrestato nei primi mesi del 2000 e a
dicembre dello stesso anno il presidente Putin gli concesse la grazia,
ufficialmente perché malato di cancro alle ossa, ma la tempistica è più che
sospetta. Una tragedia avvolta quindi nel mistero, dove si rincorrono segreti
militari, presunte battaglie navali e la volontà di Mosca di tenere nascosto
l’incidente; una volontà che, peraltro, potrebbe anche essere stata dettata
dalla necessità di insabbiare un possibile malfunzionamento dei siluri Shkval,
di cui un primo lotto era stato venduto proprio alla Cina che aveva inviato,
forse non a caso, i propri osservatori durante l’esercitazione navale. La
verità, è proprio il caso di dire, è rimasta sepolta sul fondo, distrutta
insieme alla parte prodiera del Kursk, che è stato recuperato e frettolosamente
smantellato, ma questa è un’altra storia.
Walter Rauhe
per “la Stampa” il 14 maggio 2020. «Si tratta di attacchi scandalosi,
inaccettabili e oltraggiosi». La cancelliera è visibilmente seccata quando, di
fronte ai deputati del Bundestag a Berlino, prende posizione sui casi di
hackeraggio ai danni della Germania orchestrati e organizzati da parte della
Russia. Non semplici sospetti ma accuse concrete. Così concrete dallo spingere
il Procuratore generale tedesco ad emettere un mandato di cattura internazionale
nei confronti di Dmitriy Badin, un cittadino di 29 anni di nazionalità russa che
lavora per conto dei servizi segreti militari di Mosca. Secondo gli
investigatori tedeschi si tratterebbe del principale responsabile della
massiccia azione di hackeraggio avvenuta nel 2015 ai danni del sistema
informatico del parlamento tedesco, di alcuni ministeri e della stessa
cancelliera. «Ormai è cosa provata che dietro all' attacco ci sia la Russia. Ma
devo dire onestamente che un simile comportamento mi ha profondamente addolorato
ed anche offeso. Da anni mi sforzo anche personalmente per migliorare i rapporti
fra i nostri Paesi. E adesso devo prendere atto che Mosca non compie certo gli
stessi sforzi, ma li rende invece vani», ha dichiarato ieri Angela Merkel
rispondendo alla domanda di un deputato. Secondo la cancelliera l' inchiesta
della Procura generale tedesca ha rilevato «prove schiaccianti» del
coinvolgimento dei servizi segreti russi. Con ogni probabilità anche il Cremlino
e lo stesso Presidente Vladimir Putin erano al corrente dell' operazione di
spionaggio. Nella peggiore delle ipotesi erano addirittura i loro mandanti.
Angela Merkel parla di una strategia da «guerra ibrida» portata avanti ormai da
anni dall' intelligence russa con l' obiettivo di destabilizzare l' intero
Occidente in generale e la Germania in particolare. Una guerra fatta di attacchi
hacker come quello contro il Bundestag nel 2015 o contro il sistema informatico
della principale società telefonica del Paese Telekom due anni più tardi, ma
anche con i tanti sostegni alle forze politiche populiste di destra o ai
movimenti di protesta contro le politiche del governo di grande coalizione.
Siano queste quelle del movimento anti islamico di Pegida a Dresda o quelle
delle nuove proteste contro le misure restrittive introdotte due mesi fa per
contenere la diffusione del coronavirus inscenate a Berlino, Monaco di Baviera o
Stoccarda da un gruppo molto eterogeneo di attivisti. Seguaci di sette
religiose, militanti vegani, hooligan, neonazisti, predicatori di teorie
cospirative. Quasi sempre c' è dietro lo zampino di Mosca che finanzia i gruppi
d' opposizione più svariati, finanzia le forze politiche populiste, coordina
campagne diffamatorie su internet, diffonde sui social network fake news. «È una
strategia pericolosa e dobbiamo prestare la massima attenzione e investire il
nostro massimo impegno per respingerla», sostiene Merkel. «Berlino continuerà a
fare ogni sforzo per migliorare i rapporti diplomatici con la Federazione
russa», ha aggiunto la cancelliera, «ma questi sforzi e questi rapporti vengono
a quanto pare disturbati. E questo è irritante». Secondo quanto riportato dal
settimanale tedesco Der Spiegel i servizi di spionaggio militare russi del GRU
avrebbero messo a punto una complessa campagna di cyber attacchi ai danni non
solo delle istituzioni pubbliche tedesche e delle più alte cariche dello stato,
ma anche di imprese private, università, aziende informatiche e della
telecomunicazione, centri di ricerca scientifica. Azioni spionistiche e di
sabotaggio che continuano ad avvenire ancora oggi nonostante le ripetute
smentite e promesse espresse dal Cremlino. Ma la Germania e soprattutto Angela
Merkel con il suo duro atteggiamento in difesa delle sanzioni contro la Russia
per l' annessione della Crimea, restano un nemico privilegiato di Mosca.
Jacopo
Iacoboni per “la Stampa” il 14 maggio 2020. Ricordatevi questo nome: Dmitry
Badin. Quando infine sarà scritta una storia degli hackeraggi compiuti in questi
anni dai servizi segreti militari russi (GRU) contro le democrazie occidentali -
a partire da quello più celebre, le mail di Hillary Clinton e del DNC, i
democratici Usa, durante la campagna presidenziale del 2016 - Badin avrà un
posto. E non sarà una nota a piè di pagina. Secondo Thomas Rid, professore di
cybersecurity alla Johns Hopkins University, il mandato di arresto emesso dal
procuratore generale tedesco per il trentenne ufficiale del GRU, coinvolto nel
maggio 2015 nell' hackeraggio del Bundestag e di almeno due delle caselle mail
di Angela Merkel, rimarrà «una pietra miliare nella storia europea dell'
attribuzione di intrusioni nelle reti informatiche». Alcune foto stupefacenti -
che furono scattate dall' intelligence olandese a inizio 2018, durante un'
operazione che bloccò l' hackeraggio del GRU contro l' OPCW (l' Organizzazione
per la prevenzione delle armi chimiche) a L' Aia - «alla fine hanno aiutato i
tedeschi a identificare Badin», spiega Rid. Ma chi è questo giovane uomo che è
forse, a questo punto, l' hacker politico più ricercato del mondo? Innanzitutto,
con pochi dubbi, è un militare: Badin per i tedeschi appartiene all' unità di
élite del GRU 26165, nota anche, tra gli analisti di sicurezza, come Apt28. Il
suo nome figurava già tra i super ricercati dell' FBI per l' hackeraggio ai
danni dei democratici alla viglia delle elezioni presidenziali americane del
2016, e per l' intrusione russa nei sistemi dell' organizzazione antidoping
WADA. Insomma, attraverso le incredibili azioni di quest' uomo ci corre davanti
la storia delle più ambiziose operazioni di hacking condotte dai russi in questi
anni. Una sequenza che incrocia una carriera già formidabile, nel suo genere.
Dalla foto del suo passaporto, pubblicata nei documenti americani da "wanted",
sappiamo che Badin è nato a Kursk, nella Russia europea, non distante dall'
Ucraina, il 15 novembre 1990. Ma è a San Pietroburgo la sua formazione (come
tanti altri hacker russi, molti dei quali escono dalle facoltà di computer
science di quella città, dove il KGB del giovane Putin era uno stato nello
stato, e tale è rimasto nelle sue metamorfosi). Una ricerca di open source
intelligence ha consentito a Bellingcat di stabilire che nel giugno 2018 Badin
comprò un' auto Kia Ps, registrandola col suo passaporto (luogo di rilascio San
Pietroburgo, appunto) e un indirizzo: Komsomolsky Prospect 20, Mosca. E' la sede
dell' unità militare del GRU 26165, nota anche come 85° direttorato, al quale
risultano registrate altre 305 auto di ufficiali russi, esposti in questi anni a
un leak fondamentale per gli analisti della materia. Quell' indirizzo è
importante perché - ed è un' altra storia chiave di questi anni - anche nei
leaks di cui fu vittima Emmanuel Macron due giorni prima del ballottaggio delle
elezioni presidenziali francesi del 2017, un ufficiale russo lascia il medesimo
indirizzo fisico di questa unità del GRU. Una sorta di impronta forense. Come
fosse fatto quasi apposta, se non per sciatteria. È come se questi hackeraggi
di stato non avessero mai perso l' antico sapore da gang del porto di San
Pietroburgo, sfacciati e nutriti da un senso di impunità così prepotente che né
Badin (che usava un account gmail, massimamente insicuro, e come password
"badin1990"), né il GRU in generale, sono parsi mai preoccuparsi tanto di
occultare le tracce informatiche. Anzi, tutto il contrario: da far ipotizzare
che le ostentino. Ha mai preso di mira l' Italia, il GRU? Nel 2017 il Guardian,
mai smentito, rivelò di un attacco hacker alla Farnesina da parte di attori
statuali russi, durato quattro mesi. C' entrava anche lì l' 85° direttorato del
GRU? Non lo sappiamo. Badin ama l' Italia: ha usato ripetutamente (su
V-Kontakte, il social russo) un nickname italiano, che ha origine nella commedia
dell' arte italiana, Scaramouche, scaramuccia. E un altro nick: Nicola Tesla, il
genio dell' elettricità, pioniere dell' elettromagnetismo, ma anche del
nomadismo e dei senza patria.
Russia, Putin rinvia voto su riforma Costituzione per restare
al potere. (LaPresse/AP il 25 marzo 2020) - Il
presidente russo, Vladimir Putin, ha rinviato il voto sui proposti emendamenti
alla Costituzione, tra cui la modifica che gli consentirebbe di ricandidarsi
alla presidenza. Il voto si sarebbe dovuto tenere il 22 aprile e Putin non ha
annunciato una nuova data. In un discorso televisivo, ha detto che dipenderà da
come si svilupperà la pandemia da coronavirus.
Giuseppe Agliastro per “la Stampa” il 26 marzo 2020. La narrativa
del Cremlino sull'epidemia di coronavirus è passata dal «tutto sotto controllo»
allo «stiamo all' erta». Vladimir Putin ieri si è presentato davanti alle
telecamere per un raro discorso alla nazione tutto dedicato all' emergenza
Covid-19 e ha ordinato «una settimana di stop» alle attività produttive «non
essenziali» a partire dal 28 marzo. «State a casa per evitare la diffusione
della malattia», ha consigliato il leader russo annunciando persino il rinvio
del voto sulla riforma costituzionale che con ogni probabilità sancirà la sua
ascesa di fatto a presidente a vita. Il voto per legittimare la sua
«incoronazione» era previsto per il 22 aprile ma, vista la gravità della
situazione, dovrà attendere. Putin ha chiarito che i lavoratori costretti a casa
«saranno pagati a stipendio pieno» e ha poi presentato una serie di misure a
sostegno dell' economia russa, messa all' angolo dal coronavirus e dal crollo
del prezzo del petrolio: una moratoria di sei mesi nel pagamento delle imposte
per le piccole e medie imprese, l' aumento delle indennità di disoccupazione
fino al pur basso livello del reddito minimo (143 euro al mese) e altri 60 euro
alle famiglie per ogni bambino sotto i tre anni. Ma anche una tassa per gli
oligarchi, che dovranno pagare il 15% sui capitali portati all' estero, e un'
altra che di fatto colpisce pure la classe media, con un ritenuta del 13% sui
redditi derivanti dai depositi bancari e dalle obbligazioni a lungo termine se
il capitale investito supera i 12.000 euro. Ieri la Russia ha annunciato altri
163 casi accertati di Covid-19 nelle ultime 24 ore, quasi il triplo rispetto al
giorno precedente, per un totale di 658 contagiati. Ma soprattutto ha confermato
i primi due decessi provocati dal virus nel Paese: due anziani di 73 e 88 anni
morti a Mosca, la città più colpita. Per fortuna quelli russi sono numeri ancora
relativamente bassi, ma si teme che i dati reali siano in realtà ben superiori.
Che la posizione delle autorità russe fosse cambiata lo si era capito già
martedì, quando Putin ha indossato una tuta protettiva gialla e un respiratore
per visitare il reparto malattie infettive dell' ospedale Kommunarka di Mosca,
dove sono curati i malati di Covid-19. Non si è trattato ovviamente di una
visita istituzionale come tante, ma di un messaggio alla Russia: prepariamoci al
peggio. «È molto importante prepararsi allo scenario italiano», ha spiegato a
Putin il direttore sanitario della Kommunarka, Denis Protsenko. La Russia ha
chiuso scuole, cinema e palestre, e ha imposto 14 giorni di isolamento a chi
arriva dall' estero. Eppure il leader del Cremlino non ha ordinato ai cittadini
russi di rimanere a casa e questa scelta è stata criticata da alcuni
osservatori. «L' effetto sarà il contrario di quello voluto», ha dichiarato l'
oppositore Aleksey Navalny, temendo che molti sfrutteranno la settimana senza
lavoro per viaggiare. A Mosca però sono attese restrizioni ulteriori, con la
chiusura di parchi, bar e ristoranti. Putin è consapevole che il nuovo virus
«può colpire chiunque». «Quello che oggi sta avvenendo in molti Paesi
occidentali - ha detto - può diventare il nostro prossimo futuro».
Marta Allevato per agi.it il 2 luglio 2020. Tra proteste
accennate, contagi poco inferiori alla soglia dei 7 mila casi al giorno e la
preoccupazione per le condizioni economiche del Paese quando si faranno sentire
i contraccolpi della crisi causata dal Covid-19, i russi hanno votato per la
riforma della Costituzione con cui si consolida il putinismo, il sistema di
potere fortemente centralizzato nelle mani del presidente e con alla base
un'ideologia ispirata al patriottismo e ai valori conservatori. I risultati
preliminari della sette giorni di votazioni - tenutesi online, a casa,
all'aperto e in seggi tradizionali e mobili per evitare assembramenti ma anche
per incoraggiare l'affluenza - fissano al 73,5% il sì col 26,5% delle schede
scrutinate. Il voto, che doveva tenersi lo scorso 22 aprile, è stato posticipato
per via della pandemia, ma il Cremlino non poteva aspettare oltre: troppo alto
il rischio che in autunno le conseguenze della crisi potessero erodere
ulteriormente il consenso di Putin, già in calo per una serie di motivi tra cui
anche la gestione della crisi sanitaria. Cuore del pacchetto di emendamenti è
l'azzeramento dei mandati presidenziali di Putin, che formalmente risolve - ma
solo rimandandolo - il dilemma della successione, su cui si arrovellava il Paese
in vista del 2024, quando il vincolo costituzionale dei due mandati consecutivi
non avrebbe più permesso all'ex agente del Kgb di candidarsi al Cremlino. Le
altre modifiche politiche conferiscono al presidente un maggiore controllo
sull'esecutivo, riaffermano la preminenza della legge russa sul diritto
internazionale, rendono irreversibile l'annessione della Crimea e trasformano il
Consiglio di Stato in un organo costituzionale. Sono mimetizzate da una cornice
di emendamenti 'populisti' come l'indicizzazione delle pensioni almeno una volta
l'anno, il salario minimo al pari o al di sopra del costo della vita,
l'introduzione della "fede in Dio" come fondamento dello Stato e la definizione
del matrimonio come unione tra uomo e donna. Per incentivare i russi a recarsi a
votare, seguendo una pratica di stampo sovietico, il Comune di Mosca ha lanciato
un programma di 'premi' con due milioni di voucher da regalare agli elettori per
l'acquisto di beni e servizi fino alla fine del 2020, spiegandola come
un'iniziativa per "stimolare i consumi". Stessa cosa anche in altre regioni,
dove i governatori locali hanno messo in palio auto o sconti al ristorante.
Numerose le segnalazioni, come peraltro succede in tutte le consultazioni in
Russia, di pressioni sui dipendenti della pubblica amministrazione e delle
grandi holding di Stato perché si esprimessero per il sì. L'oppositore Aleksei
Navalny aveva invitato al boicottaggio del voto e diversi osservatori
indipendenti hanno denunciato violazioni e brogli, liquidate dal Cremlino come
"fake news". Non sono mancate le proteste, nonostante i divieti di
assembramento: circa 300 persone si sono radunate a Mosca in Piazza Pushkin
sotto lo slogan "No a Putin eterno". Altra forma di dissenso, sui social, è
stata quella di postare le foto della propria scheda con barrata la casella no.
In mattinata, invece, la polizia aveva fermato sulla Piazza Rossa otto attivisti
che avevano disegnato a terra coi propri corpi il numero 2036, il termine ultimo
a cui arriverà ora la possibilità di Vladimir Vladimirovich di rimanere al
Cremlino.
Da ilmessaggero.it il 27 marzo 2020. Le farmacie che hanno
aumentato i prezzi dei farmaci antivirali e delle mascherine usa e getta
dovrebbero avere la licenza annullata. Le parole pronunciate dal presidente
russo Vladimir Putin, nel corso della riunione governativa sul coronavirus del 5
febbraio scorso, sono diventate virali. Soprattutto il video condiviso da
tantissime persone in questi giorni sui social. «Bisogna ritirare le loro
licenze, dato che hanno deciso di fare soldi sulla situazione, tutto qui», aveva
detto Putin. «Tanto di farmacie ce ne sono in abbondanza, se ne chiudono due o
tre non ci saranno conseguenze negative, almeno imparano per la prossima volta»,
ha aggiunto. Nel corso della riunione era emerso che alcune farmacie avevano
alzato i prezzi per le mascherine usa e getta a 70-100 rubli (1-1,50 euro)
sebbene prima di capodanno costassero 1-1,5 rubli l'una.
DAGONEWS il 17 aprile 2020. Se c’è un solo motivo al mondo per
farsi piacere il coronavirus è che è riuscito a bloccare il referendum nazionale
per prolungare la permanenza in carica di Vladimir Putin. La proposta di
continuare per altri due anni dopo la fine del suo mandato nel 2024 doveva
essere presentata alle persone mercoledì prossimo. Ma grazie al Covid-19 il voto
è stato rinviato. Visto il controllo che detiene sul potere e un'opposizione
silenziosa, non c’erano dubbi sul modo in cui sarebbe andata: il risultato
sarebbe stato che la Russia si sarebbe ritrovato Putin presidente a vita. Ma ora
c'è una pausa, seppur breve, alla sua incessante marcia verso la supremazia
autocratica incontrastata. Anche il duro Vlad deve inchinarsi al virus ed è
quasi un sollievo. Perché nei 20 anni trascorsi da quando ha preso la
presidenza, nessuno in casa è riuscito a ostacolarlo senza essere rimosso,
imprigionato, ucciso, intimidito o corrotto. Vlad ha trasformato una nazione
post-comunista che arrancava in una nazione temuta e aggressiva. La Russia di
Putin ora può ficcare le dita nella politica, nella diplomazia, nel campo
militare e finanziario di tutto il mondo con implicazioni preoccupanti per tutti
noi. Come questo uomo nato apparentemente dal nulla sia stato capace di questa
ascesa napoleonica da consigliere del sindaco di San Pietroburgo a uomo dal
potere assoluto è probabilmente la più grande storia del 21° secolo. La
giornalista Catherine Belton, ex corrispondente di Mosca del Financial Times, ha
scritto un libro, “Putin’s People: How the KGB Took Back Russia and Then Took on
the West”, che gli esperti occidentali della Russia moderna considerano vitale
per la nostra comprensione del fenomeno Putin. La sua tesi è davvero
agghiacciante. Quando l'Unione Sovietica si è disintegrata nel 1991 e il
comunismo ha lasciato il posto a una forma improvvisata di democrazia, il KGB,
l'esercito di spie, truffatori e poliziotti segreti di Mosca, è scomparso dai
radar. Ma non erano andati via per sempre, non erano stati sconfitti,
aspettavano solo il momento giusto. Il loro momento è arrivato quando gli
oligarchi, che gestivano la Russia dopo aver fatto enormi fortune nel petrolio,
nel gas e nei minerali nel caos economico e politico degli anni di Eltsin, hanno
catapultato alla presidenza l’apparentemente malleabile Putin. Lo hanno promosso
come loro uomo per risollevare il Paese e portarlo a una parvenza di democrazia
liberale. Non si aspettavano che il suo mandato sarebbe durato più di quattro
anni e soprattutto non prevedevano che Putin fosse la quintessenza del KGB. Lui,
che aveva spiato l'Occidente ai vecchi tempi comunisti, ribaltato le sorti di
uomini d'affari occidentali, rubando segreti industriali, contrabbando, aveva
giurato fedeltà ai suoi vecchi amici e non i sarebbe tirato indietro. Con Putin
al posto di guida, sostiene Belton, il KGB è tornato al controllo della Russia e
la sua presa sul paese è più forte che mai. La sua agenda - presa avidamente dal
cosiddetto siloviki (la parola significa "uomini forti") che reclutava dai
vecchi ranghi - era di rendere di nuovo la nazione potente sia in casa che
all’estero. Una scalata che passava attraverso il riciclaggio di denaro sporco,
la corruzione, la frode, i rake-off, i fondi neri e il furto. La Russia di Putin
sarebbe diventata non solo un'autocrazia ma una cleptocrazia. Ribaltò il
rapporto di potere con gli oligarchi che lo avevano sponsorizzato, facendoli
lavorare per lui. Il risultato, scrive Belton, è stato "un sistema in cui tutte
le imprese di qualsiasi dimensione dipendevano dal Cremlino. I magnati dovevano
servire lo stato per preservare la loro posizione e ricchezza". Coloro che
facevano resistenza hanno scoperto che la polizia bussava alle loro porte con
mandati di arresto per evasione fiscale, frode o altri crimini. Alcuni
scapparono, come il magnate dei media Boris Berezovsky, ritrovato morto nella
sua vasca da bagno in Inghilterra. Alcuni andarono in prigione. Fu il caso
dell'uomo più ricco della Russia, il magnate del petrolio Mikhail Khodorkovsky
che mentre stava salendo sul suo jet privato in Siberia, è stato raggiunto da un
commando che lo ha arrestato. Gli altri hanno ceduto e hanno fatto quello che
gli era stato chiesto. Roman Abramovich, secondo Belton, ha acquistato il
Chelsea FC su istruzione di Putin, come modo per rafforzare il prestigio russo
in Occidente. Ma anche quelli più vicini a lui non sono mai stati al sicuro,
soprattutto se diventavano troppo potenti. Belton descrive un percorso negli
anni fatto di manovre finanziarie losche, di giochi di prestigio, di trattative
dietro le quinte, di "prestiti" dalle banche statali, di contraccolpi sui
contratti che Putin e i suoi cortigiani hanno messo in moto per attirare la
ricchezza. Con queste manovre sono riusciti a fare soldi in nero all’estero per
un valore che si stima di 640 miliardi di dollari, mentre nel loro paese
ostentavano le ricchezze, con yacht e aerei privati e vasti palazzi. Uno di loro
aveva un garage per 15 auto e una box per le pellicce. Nel frattempo, i diritti
umani, la libertà e lo stato di diritto venivano annientati. I governatori
locali sono stati privati della loro autorità. Il dissenso è stato soppresso. I
tribunali hanno agito come un braccio del Cremlino. I giudici hanno seguito la
linea. Sebbene la Russia fosse apparentemente una democrazia, la realtà era che
Putin si comportava come monarca feudale, un tiranno, uno zar come Pietro il
Grande, circondato dai suoi scagnozzi, i suoi boiardi, che dovevano la loro
fedeltà e la loro vasta ricchezza a lui. Belton trova vergognoso che
l'Occidente, che aveva lavorato e poi accolto con favore la fine del comunismo
in Russia, abbia accettato questo ritorno all'autocrazia. Non solo. I banchieri
e i broker a Londra, in particolare, sono caduti loro stessi ai piedi dello zar,
felici di girare la testa e non vedere mentre le loro fortune erano nascoste nei
paradisi offshore. Il denaro russo che ha girato negli anni a Londra ha fatto
guadagnare alla capitale il soprannome di "Londongrad" o Moskva-na-Thames,
Mosca-sul-Tamigi. Negli Stati Uniti, Donald Trump, prima di diventare
presidente, fece affari con i russi per salvare ed espandere il suo impero
immobiliare. L'avidità ha trionfato sui principi, con il risultato che
l'Occidente, seguendo scrupolosamente il proprio istinto di fare soldi, si è
lasciato infiltrare. Belton avverte: «La debolezza del sistema capitalista
occidentale, in cui il denaro alla fine supera tutte le altre considerazioni,
l'ha lasciato completamente aperto alla manipolazione del Cremlino». A
peggiorare le cose è che i siloviki sono sempre in missione, non solo per
diventare molto ricchi, ma per usare quella ricchezza per minare l'Occidente.
Sotto il comunismo, il KGB aveva visto l'Occidente come suo nemico. I suoi
successori, guidati da Putin, si sentono dei pari. Sotto di lui, la Russia, che
un tempo era stata adombrata sulla scena mondiale, è tornata potente. Nella sua
nuova veste, la FSB ha adottato i trucchi del vecchio KGB, causando disagi in
Occidente. I suoi soldi sostengono gli estremisti politici, di destra o di
sinistra: non importa la causa, l'obiettivo è creare scompiglio. Agli occhi di
Putin e dei suoi compari, la guerra fredda non è mai finita, è appena entrata in
una nuova fase. Siamo stati avvertiti.
Angelo Allegri
per “il Giornale” il 14 aprile 2020. Era il giugno dell' anno scorso e per
sancire l' accordo si mossero i due leader: furono il presidente russo Vladimir
Putin e quello cinese Xi Jinping a benedire personalmente l' alleanza per il 5G
tra Mts, uno dei maggiori gruppi telecom dell' ex Unione Sovietica, e Huawei, il
colosso con sede a Shenzen. Da allora l' intesa ha dato i suoi primi frutti:
nella zona di Mosca le sperimentazioni sono già iniziate. Da qualche anno i
rapporti tecnologici tra i due Paesi nel campo del ciberspazio sono sempre più
stretti e con la recente legge sulla regolamentazione di Internet, entrata in
vigore nel novembre dell' anno, la Russia sembra aver individuato nella Cina
anche un modello. I provvedimenti adottati a Mosca hanno come obbiettivo la
creazione di una «frontiera digitale», in grado di separare il web in cirillico
da quello del resto del mondo. Le nuove norme creano un meccanismo di
sorveglianza sul trasferimento dei dati via Internet e un controllo
centralizzato sull' infrastruttura fisica su cui essi viaggiano (reti e apparati
tecnici). All' autorità per le telecomunicazioni, Roskomnadzor, diventata sempre
più potente negli ultimi anni, vengono affidati ampi poteri per la
disattivazione del Web in caso di emergenza. Sempre in caso di emergenza la Rete
potrà essere di fatto staccata da quella internazionale, visto che i «service
provider» avranno l' obbligo di evitare l' instradamento dei messaggi attraverso
network situati al di fuori del territorio russo. I service provider infine
dovranno installare «apparati tecnici per contrastare le minacce alla stabilità,
alla sicurezza e all' integrità funzionale di Internet sul territorio della
Federazione russa». La formulazione è abbastanza vaga e non si sa bene di che
tipo di apparecchiature si tratta, ha commentato Alena Epifanova, analista del
German Council on Foreign Relations, ente di ricerca non-profit con sede a
Berlino, ma dalla legge si sa che sarà la stessa autorità a fornirle. L' ipotesi
è che si tratti di strumenti utilizzabili per controllare il contenuto delle
comunicazioni Internet, già previsti in un' altra parte delle nuove norme. La
Russia tenta poi, con la nuova legislazione, un esperimento mai riuscito fino ad
ora ad altri: la creazione di un sistema di denominazione dei siti (in termini
tecnici Dns, Domain Name System) del tutto indipendente da quello attualmente in
uso a livello internazionale. La spiegazione ufficiale è il tentativo di
sfuggire all' aggressività americana, che attraverso l' Icann (per altro
indipendente dal governo Usa) gestisce l' organizzazione attuale. Al di là delle
dichiarazioni di principio contro il colonialismo a stelle e strisce, l'
innovazione ha però senso, dice Alana Epifanova, «solo se il Paese opta per un
isolamento completo e a lungo termine del proprio web», visto che i siti russi
diventerebbero indisponibili negli altri Paesi e viceversa. La strada, comunque,
sembra tracciata, dice Alana Epifanova: «Nel prossimo futuro la Russia dovrà
cooperare ancora più strettamente con la Cina per sviluppare tecnologie che le
consentano di raggiungere i suoi obiettivi. Dovrà anche coordinare con il Paese
asiatico la sua politica di Internet a livello internazionale». Il tema
sollevato dai cinesi all' Itu di Ginevra, quello di un nuovo protocollo Internet
che sostituisca quello utilizzato negli ultimi decenni (vedi l' articolo a
fianco), sembra provare la tesi dell' analista del German Council of Foreign
Relation. Tra le adesioni subito raccolte da Pechino c' è anche quella russa.
Le fake news di Putin? No è lui vittima delle bufale.
Riccardo Amati de il Riformista il 12 Aprile 2020. Vladimir
Putin ha firmato una legge che prevede pene severe – fino a cinque anni di
galera – per chi diffonde false notizie sul Covid-19. Sembra paradossale, visto
che la Russia è stata appena accusata di utilizzare la pandemia per riempire il
mondo di fake news e condurre attività di spionaggio mascherate da aiuti
internazionali. In realtà, almeno in questo caso, i responsabili
della “disinformazia” non abitano al Cremlino. Ci sono pochi dubbi che Mosca sia
da tempo impegnata in una guerra politica – o “ibrida”, se preferite – con
l’Occidente, combattuta a colpi di propaganda, false notizie e azioni talvolta
criminali dei suoi servizi di sicurezza: i casi Skripal e Litvinenko sono solo i
più eclatanti. Appare però eccessivo identificare oggi un «piano coordinato» da
parte di Mosca «per aggravare la crisi sanitaria nei paesi occidentali durante
la pandemia» – come ha fatto la task force anti-disinformazione EUvsDisinfo
dell’Unione Europea. Anche perché l’ecosistema di troll che il Cremlino ha
contribuito a stabilire non riesce poi a controllarlo del tutto: è in mano a
“imprenditori politici” più realisti del re. In Russia «agiscono 10mila piccoli
Putin», secondo il politologo Andrei Kolesnikov del think tank moscovita
Carnegie. Si tratta di «conformisti aggressivi» che puntano al vantaggio
personale cercando di compiacere il capo. Con effetti che possono rivelarsi
controproducenti per il capo stesso. «Mentre le informazioni che i maggiori
media russi stanno fornendo sull’epidemia sono adeguate, ci sono all’opera anche
i prezzolati predatori della propaganda», spiega al Riformista Kolesnikov. «La
guerra politica con cui la Russia cerca di dividere, distrarre e demoralizzare
l’Occidente non è combattuta da un singolo e disciplinato “esercito della
disinformazione”», ha notato in un articolo sul Moscow Times l’esperto di
servizi di sicurezza russi Mark Galeotti, autore di Russian Political War
(Routledge, 2019): «È un ecosistema di entusiasti e mercenari, composto da
rumorosi presentatori di talk-show, commentatori, pseudo-esperti, magliari,
ciarlatani e complottisti». Ed è su questo “ecosistema” che gli investigatori
della task force EUvsDisinfo hanno indagato, rilevando una vera e propria
campagna anti-occidentale sui temi legati al Coronavirus. Le conclusioni sono
state riprese dalle maggiori testate giornalistiche del continente. «La task
force nata per combattere la disinformazione da parte della Russia rischia di
diventare essa stessa fonte di disinformazione», notano Stephen Hutchings e Vera
Tolz, professori di Studi sulla Russia all’Università di Manchester e
responsabili di un progetto accademico che analizza la copertura giornalistica
dei media di Stato di Mosca. Contestando il metodo con cui è stato elaborato il
rapporto europeo, e stigmatizzando «una profonda incomprensione di come
funzionino i media nei sistemi neo-autoritari come quello russo», Huthcings e
Tolz parlano di «palesi distorsioni». Ciò che la EUvsDisinfo non ha capito, o
non ha voluto capire, è che i “conformisti aggressivi” dell’informazione sono
spesso utili al regime di Putin ma non sono direttamente coordinati dal
Cremlino. Se ne utilizza il potere di fuoco quando serve per questioni
strettamente legate alla politica estera. Non è il caso del Covid-19. Piuttosto,
è probabile che ai vertici dell’amministrazione presidenziale ci si sia
parecchio arrabbiati, a sentire qualche strampalato cantore del putinismo dar la
colpa al Regno Unito per la creazione del virus – una delle fake news
individuate dalla task force di Bruxelles. Perché in realtà Mosca ha sì tentato
di sfruttare la crisi globale generata dalla pandemia, ma solo lanciando una
campagna d’immagine finalizzata a creare una breccia nell’isolamento in cui la
Russia è stata relegata dopo l’annessione della Crimea nel 2014. In particolare,
si sta cercando di far passare il messaggio secondo cui in questo momento le
nazioni devono agire insieme, e che le sanzioni devono finire. Come ha
esplicitamente chiesto Putin al G20 virtuale di fine marzo. È un’offensiva
all’insegna del soft-power. L’operazione “Dalla Russia con amore” per l’aiuto
sanitario all’Italia, con tutti i suoi limiti, ne è parte. Perché mai
il Cremlino dovrebbe lanciare una parallela offensiva di disinformazione proprio
in questo momento? Alimentando la percezione della Russia come gangster delle
relazioni internazionali, i “piccoli Putin” della propaganda che il regime ha
lasciato crescere e prosperare allo zar fanno solo un danno. Anzi, più di uno.
Perché le fake news individuate dalla task force europea circolano più in Russia
che all’estero. E rischiano di minare la credibilità delle informazioni che
Stato e amministrazioni locali stanno fornendo sull’epidemia, e l’efficacia dei
provvedimenti decisi per tentare di contenerla. Per ora stanno meglio di noi:
meno di dodicimila contagiati e meno di cento morti, secondo i dati del 10
aprile. Ma la “curva” sta impennandosi. E solo questa, a Mosca come dappertutto,
è oggi la priorità.
Giuseppe Agliastro per “la Stampa” il 4 marzo 2020. C'era una
volta l'atea Unione Sovietica. Atea per imposizione del regime comunista, che
abbatteva chiese e perseguitava i credenti. Da allora le cose in Russia sono
molto cambiate. Adesso che al Cremlino regna Vladimir Putin, la Chiesa ortodossa
è diventata un'alleata tanto stretta del governo autoritario di Mosca che il
presidente russo ha addirittura deciso di inserire nella Costituzione un
riferimento alla «fede in Dio». Una scelta paradossale per un ex ufficiale del
Kgb? Solo apparentemente. Secondo molti osservatori, il vero obiettivo della
nuova riforma costituzionale è mantenere Putin al potere. Le 24 pagine di
emendamenti presentate da Putin al Parlamento rispecchiano però anche i valori
conservatori che il Cremlino promuove usando il Patriarcato di Mosca come
strumento di propaganda. La Russia si contrappone così all' Occidente e ai
valori liberali, già definiti «obsoleti» da Putin. La nuova bozza della
Costituzione prevede per esempio che il matrimonio sia un' unione tra un uomo e
una donna. In pratica in questo modo le unioni omosessuali saranno vietate dalla
legge fondamentale della Russia, dove le minoranze sessuali sono già
discriminate dalla famigerata «legge anti-gay», che ufficialmente punisce la
promozione tra i minori delle «relazioni non tradizionali» ma di fatto impedisce
ogni manifestazione in difesa dei diritti Lgbt. Era stata la stessa Chiesa
ortodossa russa a chiedere di inserire Dio nella Costituzione. «La maggioranza
dei russi crede in Dio, non solo gli ortodossi ma anche i musulmani e molti
altri», aveva spiegato il Patriarca di Mosca Kirill. Nessun riferimento
ovviamente ai Testimoni di Geova, che in Russia continuano a finire dietro le
sbarre solo perché professano pacificamente il loro credo. Kirill è sospettato
di essere stato un informatore del Kgb in un' epoca in cui le chiese erano piene
di infiltrati dell' intelligence sovietica e i genitori battezzavano di nascosto
i propri figli. Ora appoggia apertamente Putin, che di aver lavorato nel Kgb non
fa certo mistero. Appena un mese prima delle elezioni del 2011, Kirill arrivò a
definire il governo di Putin «un miracolo di Dio». L' anno scorso ha invece
ringraziato Dio e Putin «per questo dialogo tra la Chiesa e lo Stato» che, a suo
dire, non era così intenso «neanche ai tempi dell' Impero Russo». Non poteva poi
mancare nella Costituzione il lato patriottico. Innanzitutto sarà vietato cedere
porzioni di territorio russo. Mosca sottolinea così di non voler mollare la
Crimea che ha strappato all' Ucraina nel 2014. La Russia sarà inoltre
riconosciuta dalla Costituzione come l' erede dell' Urss, legittimando le
proprie mire da grande potenza. Ma non è tutto. Putin ha confezionato un
articolo per vietare di sminuire il contributo sovietico nella vittoria sul
nazismo, di cui il 9 maggio la Russia celebrerà in pompa magna i 75 anni. L'Urss
ha avuto un ruolo importantissimo nella lotta al nazismo, ma quella veicolata
dal Cremlino è una versione idealizzata della storia russa e Putin giustifica
persino il patto Ribbentrop-Molotov con cui Stalin e Hitler si spartirono l'
Europa dell' Est e diedero inizio all' invasione della Polonia. Gli emendamenti
alla Costituzione saranno presto approvati dalla Duma e il 22 aprile saranno
sottoposti a un controverso voto della popolazione. Due russi su tre ammettono
di non capire il significato della riforma. Gli esperti invece hanno pochi
dubbi: serve a garantire a Putin una poltrona dalla quale guidare la Russia
anche dopo il 2024, quando per legge non potrà ricandidarsi alla presidenza.
Gaia Cesare
per “il Giornale” il 20 febbraio 2020. Dalle elezioni americane che hanno
portato Trump alla Casa Bianca alla Brexit. Dall' avvelenamento dell' ex spia
russa Sergej Skripal, in Gran Bretagna, alle dimissioni dell' ex vicecancelliere
del governo austriaco Heinz Christian Strache. Dalla trasferta in Russia di
Matteo Salvini, passando per le rivolte dei gilet gialli, fino alle recenti
dimissioni del candidato a sindaco di Parigi, Benjamin Griveaux. Tutte le strade
portano a Mosca. Da qualche tempo a questa parte non c' è scandalo che non passi
per il sospetto che i russi ci abbiano messo lo zampino. L' ultimo si sta
consumando in Francia, dopo la diffusione, da parte dell' artista russo Piotr
Pavlenski, di un video di natura sessuale che ha stroncato la carriera politica
del candidato sindaco del presidente Emmanuel Macron. Proprio un anno fa, era
stato Macron in persona a denunciare la presunta ingerenza russa nella crisi di
protesta dei «gilet gialli», con atti di propaganda da parte dei media di Mosca,
consulenze dall' estero e una campagna sui social network per rilanciare video e
messaggi del movimento, anche falsi. Secondo il presidente francese, l' ala
«radicale» dei gilet è stata «manipolata con il concorso di una potenza
straniera». È anche per questa ragione che a Parigi gli occhi sono ora puntati
su Juan Branco, avvocato autore di un pamphlet anti-Macron, consulente di Julian
Assange e di alcuni gilet gialli, che appena scoppiato lo scandalo Griveaux si è
offerto di difendere l' artista russo coinvolto (ma la difesa gli è stata
negata). Appena pochi mesi dopo la denuncia del leader francese - è il maggio
2019 - un altro scandalo, anche stavolta di natura politico-sessuale e
immortalato in un video, travolge il governo di Vienna di Sebastian Kurz, fino
alla sua caduta e a nuove elezioni. Stavolta di mezzo c' è la finta nipote di un
oligarca russo, cioè una giovane avvenente che si spaccia per tale, segno che la
carta dei miliardari vicini al regime funziona anche quando la loro influenza
non esiste e viene solo millantata. A cadere nella rete finto-russa è il
vice-cancelliere Strache, fino a quel momento presidente del partito di estrema
destra Fpö, che in un video girato a Ibiza nel 2017 offre e chiede favori alla
signora. Il filmato lo costringe in poche settimane all' addio al governo, suo e
del partito, e al ritiro definitivo dalla politica. Passano appena poche
settimane e a finire sulla graticola per le connessioni russe è il leader della
Lega Matteo Salvini. Di mezzo ci sono due visite a Mosca, nel 2014 e nel 2018,
ma soprattutto la trattativa che Gianluca Savoini, ex portavoce di Salvini,
avrebbe portato avanti con tre cittadini russi all' hotel Metropol di Mosca
nell' ottobre 2018 per far arrivare alla Lega finanziamenti per 65 milioni.
Tutto ciò mentre un rapporto dei democratici al Congresso americano accusa anche
i network collegati al Movimento Cinque Stelle di essere influenzati dalla
Russia in chiave anti europea. E mentre il Regno Unito punta il dito contro due
cittadini russi considerati gli autori dell' attacco al gas nervino, in
territorio britannico, contro l' ex spia Skripal. E a proposito di spie e
omicidi sul territorio europeo, proprio in queste ore sembra emergere in maniera
inequivocabile - secondo il tedesco Spiegel - il «ruolo centrale» del servizio
segreto interno russo nell' uccisione di un ex comandante dei separatisti
ceceni, il georgaino Zelimkhan Khangoshvili, in un parco di Berlino lo scorso
agosto. Ma sono le ombre russe sulla politica del vecchio continente e dei Paesi
occidentali che ormai non stupiscono più, anzi rischiano di essere tirate fuori
a ogni occasione, non necessariamente con prove alla mano. Secondo un rapporto
parlamentare inglese, in occasione del referendum sulla Brexit del 2016, ci
furono interferenze russe, messaggi favorevoli all' addio alla Ue, disseminati
sul web dai media vicini al Cremlino, ma il loro effetto concreto «non è
quantificabile». Il contrario di quello che il procuratore Mueller ha riferito
sul Russiagate, sostenendo che nel 2016 «c' è stata una grande e sistematica
interferenza del governo russo nelle nostre elezioni». Secondo un documento
dell' intelligence americana, pubblicato da Buzzfeed, il Cremlino avrebbe in
mano video compromettenti «sulle ossessioni e perversioni sessuali di Trump».
Sesso, politica e l' ombra di Mosca sugli scandali occidentali.
Rosalba
Castelletti per repubblica.it il 28 febbraio 2020. «Siete il vero Putin?»,
chiede il giornalista dell’agenzia di stampa Tass . «Sì», risponde il presidente
russo. «Ho rifiutato di avere un sosia. È stato durante gli anni più duri della
lotta al terrorismo». Così, nel corso di un’intervista sui suoi 20 anni al
potere, il leader del Cremlino Vladimir Putin ha rivelato l’esistenza di un
piano segreto per usare controfigure che lo impersonassero in pubblico, ma ha
anche aggiunto di essersi opposto. «Il vostro sosia sarebbe andato nei posti
pericolosi?», ha incalzato il giornalista della Tass. «Sì, sarebbe andato e si
sarebbe mostrato in pubblico», ha confermato Putin. Accadde, ha poi precisato,
all’inizio degli anni 2000 quando la Russia era in guerra contro
l’indipendentismo islamista nel Caucaso. Nominato premier e poi presidente ad
interim nel 1999, Putin guidò la seconda guerra cecena che portò alla
riconquista dei territori occupati dai separatisti ceceni. Una vittoria che
scatenò un’ondata di attentati suicidi e di prese di ostaggi. In Russia circola
da tempo la teoria - priva di fondamento - che Putin usi un sosia, o più d’uno,
durante alcuni eventi pubblici. C’è chi ha confrontato le foto negli anni e chi
è arrivato addirittura a ipotizzare che Putin sia morto e sia stato rimpiazzato
da una controfigura. In particolare dopo una sua assenza dalla scena pubblica
per 10 giorni nel 2015. «Ci si annoia senza pettegolezzi», commentò allora lo
stesso Putin riapparendo in pubblico. Stavolta il giornalista gli ha mostrato
una lista delle ricerche su Internet più popolari associate al suo nome. Una
era: «Prove del sosia di Putin». Nella stessa intervista Putin ha poi confermato
che continua a non avere un cellulare.
Russia, la figlia «nascosta» di Putin guida (a 33 anni) la
ricerca sui robot. Pubblicato sabato, 29 febbraio 2020
su Corriere.it da Fabrizio Dragosei. Mosca Tirato per i capelli dai giornalisti
che sempre più spesso vogliono sapere delle sue figlie, Vladimir Putin si era
limitato a lodare la conoscenza linguistica delle due ragazze: «Parlano tre
lingue straniere. Non solo, ma le usano anche nel loro lavoro». Adesso, senza
che sia il padre orgoglioso a raccontarcelo, scopriamo che almeno una, la
minore, sarebbe una specie di genio della matematica e della fisica: a soli 33
anni è stata messa a capo di un nuovo istituto per la ricerca nel campo
dell’intelligenza artificiale dell’Università di Mosca, con un budget che
dovrebbe sfiorare solo per quest’anno il miliardo di rubli, circa 13,7 milioni
di euro. Per essere precisi, la giovanissima ricercatrice che già prima di
compiere trent’anni era prorettore dell’Università, fa Tikhonova di cognome e
non Putina. Ma tutti sanno ormai da molto tempo che Katerina Tikhonova è un
alias assunto dalla figlia minore poco dopo l’insediamento al Cremlino di
Vladimir Putin. Per difendere la sua privacy e per la sua sicurezza. Così come
la figlia maggiore Maria, 35 anni, ha preso il cognome Vorontsova.Le ragioni, le
ha spiegate lo stesso presidente russo che ha sempre insistito nel tenere la
famiglia al riparo dall’attenzione dell’opinione pubblica. Putin si è rifiutato,
anche nel dicembre scorso, di dire esplicitamente chi siano le figlie e che
lavoro facciano. «Non l’ho mai fatto e non lo farò adesso», ha precisato. «In
generale credo che ognuno abbia il diritto di avere un proprio destino. Loro non
sono mai state ragazze-star e non hanno mai amato essere alla ribalta. Vivono le
loro vite e lo fanno in maniera del tutto adeguata». In un’altra occasione,
Putin aveva detto chiaro e tondo: «Non voglio che crescano come principesse!».In
realtà, negli ultimi tempi Maria e Katerina sono comparse in pubblico,
rilasciando interviste e parlando del loro lavoro. Naturalmente sempre con i
«nuovi» cognomi e senza mai fare riferimento al presidente. Poco più di un anno
fa era stata proprio Katerina Tikhonova ad apparire in tv per parlare del suo
ruolo come direttore di un istituto scientifico, l’Innopraktika che oggi
collabora con l’Università per il nuovo centro sull’intelligenza artificiale. La
Tikhonova aveva già diretto (a che età, ci si chiede a questo punto) l’istituto
universitario di studi matematici dei sistemi complessi dell’Università statale
di Mosca. Sarebbe stata sposata e si sarebbe poi separata da Kirill Shamalov, un
investitore in parte proprietario di una compagnia petrolchimica, la Sibur, che
secondo i media russi avrebbe ricevuto un prestito di 1,75 miliardi di dollari
da un fondo pensionistico statale. Il prestito avrebbe avuto un interesse più
basso di quelli di mercato. La cosa aveva fatto parlare all’epoca di un
possibile conflitto di interessi.Nel giugno del 2018 il canale 1 della tv russa
aveva invece intervistato l’altra figlia di Putin, Maria Vorontsova,
endocrinologa infantile. Lei è azionista della società medica Nomeko che
starebbe costruendo un grande centro sanitario nella regione di San Pietroburgo.
I finanziamenti verrebbero dalla Sogaz, compagnia assicuratrice di proprietà del
colosso statale del gas Gazprom (guidato dal fedelissimo di Putin Aleksej
Miller). Anche Maria è sposata. Con un manager olandese che lavorava in Gazprom.
Una delle poche cose che il presidente ha rivelato pubblicamente con orgoglio è
di essere già due volte nonno. Da piccole le due figlie di Putin frequentavano
la scuola tedesca di Mosca. Poi, già dopo la nomina a primo ministro nel 1999,
vennero fatte studiare a casa con istitutori privati. All’università sono andate
con le false identità che hanno tuttora.
Michela Iaccarino per “Il Fatto Quotidiano” l'1 marzo 2020. Sta
per essere inaugurato l' Istituto di Intelligenza artificiale dell' Università
di Mosca (Mgu) e al suo vertice ci sarà una potente, misteriosa direttrice
bionda: una cittadina russa nata a Dresda nel 1986, dove era di stanza suo
padre, all' epoca funzionario del Kgb. Katerina Tikhonova è la figlia - o meglio
la donna che in Russia tutti sanno essere la figlia - di Vladimir Putin. Già
vicerettore, Katerina, 33 anni, farà capolino alla punta della piramide del
nuovo dipartimento dell' imponente Università della Capitale, dove già dirige la
fondazione Innopraktika, organo con un budget che supera il miliardo di dollari
e al cui tavolo della dirigenza siedono i signori dell' industria energetica
della Federazione russa: Aleksey Likhachev , capo del gigante Rosatom, e Igor
Sechin , amministratore di Rosneft. Adesso la Tikhonova gestirà un programma
condiviso da nove dipartimenti di prossima apertura che hanno già ricevuto 4
miliardi di rubli, quasi 60 milioni di euro, in fondi statali. Il piano di
ricerca è stato definito da Putin "uno degli strumenti più essenziali per la
strategia nazionale", come riporta il quotidiano Vedomosti. Le due colonne su
cui il Cremlino ha deciso di investire sono tecnologia dell' informazione e
intelligenza artificiale, al centro di un progetto di legge sulla
sperimentazione che presto finirà in visione alla Duma. "La Russia deve
assicurarsi sovranità nel settore, chi lo domina sarà signore del mondo". Con
queste parole Putin, parlando dello sviluppo dell' AI , promise agli studenti
nel 2018 cascate di finanziamenti per le ricerche di strumentazioni
potenzialmente letali nella guerra digitale delle fake news. Un esempio
concreto: l' interferenza nelle elezioni 2016 - e in quelle previste quest' anno
- di cui gli Stati Uniti accusano Mosca. Il fine dello sviluppo dell'
intelligenza artificiale è la vittoria nelle guerre asimmetriche, operazioni di
intelligence o cyberconflitti. Il Rdif, Fondo federale russo di investimenti
diretti, che collabora con l' ateneo moscovita, è già stato impinguato da
investitori di Asia, Medio Oriente ed Emirati. A capo di questo braccio
tecnologico dello Stato, che fornirà nuovi dispositivi ai dipartimenti militari
e dei servizi segreti, c' è la finora misteriosa figlia di Putin. Sciorinando
algoritmi dei sistemi complessi della matematica applicata, la Tikhonova si era
mostrata ai russi, truccatissima e paciosa, per la prima volta solo nel 2018 sul
canale Rossija 1. È certo che si è sposata nel 2013 con Kirill Shamalov , figlio
dell' oligarca Nikolay e amico di suo padre; non è certo se ha divorziato nel
2018. Chi l' ha ascoltata parlare con voce flemmatica nelle poche dichiarazioni
rilasciate, dubita che Katerina sia capace di fare salti mortali abbracciata a
un ballerino pallido come lei. Eppure la giovane donna in passato è stata
ballerina acrobatica e ha partecipato a una competizione della World Rock and
Roll Federation. Katerina Assomiglia a sua sorella maggiore, Maria Vorontsova,
nata a Leningrado nel 1985. Entrambe hanno frequentato il liceo tedesco di
Mosca, dove tutta la famiglia si trasferì nel 1996. Quando pochi anni dopo la
spia di Dresda diventò presidente della Russia, le sorelle finirono in un cono
d' ombra e discrezione. Ricorsero a false identità per iscriversi all'
università: Maria scelse biologia, Katerina fisica e matematica. Poi acquisirono
nomi di copertura come fanno le spie, ma cambiarono solo il cognome. Dopo
apparizioni sporadiche nel periodo studentesco, le due si sono inabissate per
sparire completamente dalla scena pubblica. La minore è tornata a galla prima
dell' altra, ma anche Maria si è mostrata ai giornalisti l' estate scorsa. Ha
parlato ai microfoni della tv Rossija 24, quando è divenuta socia di un' azienda
medica da 634 milioni di dollari a San Pietroburgo: la Nomeko, abbreviazione di
New Medical Company. Ricerca avanzata: quella artificiale, ma anche genetica.
Sono state amatissime dal loro padre "che le viziava". A dirlo è stata anni fa
Lyudmila Shkrebneva , ex moglie di Putin, da cui ha divorziato dopo 30 anni di
matrimonio nel 2013. Amatissime ma non identificate: le figlie non sono mai
state ufficialmente riconosciute dal presidente. Vere, ma mai confermate: in
nessuna occasione Putin ha pronunciato i nomi di Katerina e Maria e ha smentito
invece pubblicamente di avere avuto due figli con la ginnasta Alina Kabaeva ,
medagliata di ori olimpici e numerosi articoli di gossip. È la fidanzata di
Putin, anche lei solo nelle supposizioni dei rotocalchi; ma in Russia una cosa
diventa vera solo se la conferma ufficialmente il Cremlino.
Fabrizio Dragosei per "corriere.it" l'1 marzo 2020. Tirato per i
capelli dai giornalisti che sempre più spesso vogliono sapere delle sue
figlie, Vladimir Putin si era limitato a lodare la conoscenza linguistica delle
due ragazze: «Parlano tre lingue straniere. Non solo, ma le usano anche nel loro
lavoro». Adesso, senza che sia il padre orgoglioso a raccontarcelo, scopriamo
che almeno una, la minore, sarebbe una specie di genio della matematica e della
fisica: a soli 33 anni è stata messa a capo di un nuovo istituto per la ricerca
nel campo dell’intelligenza artificiale dell’Università di Mosca, con un budget
che dovrebbe sfiorare solo per quest’anno il miliardo di rubli, circa 13,7
milioni di euro. Per essere precisi, la giovanissima ricercatrice che già prima
di compiere trent’anni era prorettore dell’Università, fa Tikhonova di cognome e
non Putina. Ma tutti sanno ormai da molto tempo che Katerina Tikhonova è un
alias assunto dalla figlia minore poco dopo l’insediamento al Cremlino di
Vladimir Putin. Per difendere la sua privacy e per la sua sicurezza. Così come
la figlia maggiore Maria, 35 anni, ha preso il cognome Vorontsova. Le ragioni,
le ha spiegate lo stesso presidente russo che ha sempre insistito nel tenere la
famiglia al riparo dall’attenzione dell’opinione pubblica. Putin si è rifiutato,
anche nel dicembre scorso, di dire esplicitamente chi siano le figlie e che
lavoro facciano. «Non l’ho mai fatto e non lo farò adesso», ha precisato. «In
generale credo che ognuno abbia il diritto di avere un proprio destino. Loro non
sono mai state ragazze-star e non hanno mai amato essere alla ribalta. Vivono le
loro vite e lo fanno in maniera del tutto adeguata». In un’altra occasione,
Putin aveva detto chiaro e tondo: «Non voglio che crescano come principesse!».
In realtà, negli ultimi tempi Maria e Katerina sono comparse in pubblico,
rilasciando interviste e parlando del loro lavoro. Naturalmente sempre con i
«nuovi» cognomi e senza mai fare riferimento al presidente. Poco più di un anno
fa era stata proprio Katerina Tikhonova ad apparire in tv per parlare del suo
ruolo come direttore di un istituto scientifico, l’Innopraktika che oggi
collabora con l’Università per il nuovo centro sull’intelligenza artificiale. La
Tikhonova aveva già diretto (a che età, ci si chiede a questo punto) l’istituto
universitario di studi matematici dei sistemi complessi dell’Università statale
di Mosca. Sarebbe stata sposata e si sarebbe poi separata da Kirill Shamalov, un
investitore in parte proprietario di una compagnia petrolchimica, la Sibur, che
secondo i media russi avrebbe ricevuto un prestito di 1,75 miliardi di dollari
da un fondo pensionistico statale. Il prestito avrebbe avuto un interesse più
basso di quelli di mercato. La cosa aveva fatto parlare all’epoca di un
possibile conflitto di interessi. Nel giugno del 2018 il canale 1 della tv russa
aveva invece intervistato l’altra figlia di Putin, Maria Vorontsova,
endocrinologa infantile. Lei è azionista della società medica Nomeko che
starebbe costruendo un grande centro sanitario nella regione di San Pietroburgo.
I finanziamenti verrebbero dalla Sogaz, compagnia assicuratrice di proprietà del
colosso statale del gas Gazprom (guidato dal fedelissimo di Putin Aleksej
Miller). Anche Maria è sposata. Con un manager olandese che lavorava in Gazprom.
Una delle poche cose che il presidente ha rivelato pubblicamente con orgoglio è
di essere già due volte nonno. Da piccole le due figlie di Putin frequentavano
la scuola tedesca di Mosca. Poi, già dopo la nomina a primo ministro nel
1999, vennero fatte studiare a casa con istitutori privati. All’università sono
andate con le false identità che hanno tuttora.
Michela AG Iaccarino per il “Fatto quotidiano” il 2 marzo 2020.
Sotto i cieli nuvolosi che ricoprono la terra russa, all' aeroporto di Mosca, al
trentaquattrenne Michail Galin, in partenza per la Siberia, l' hostess della
compagnia Aeroflot ha chiesto di pesare il bagaglio a mano, per riferirgli
subito dopo che eccedeva di due chili e sarebbe finito in stiva. Ma nella borsa
c' era il suo fedele e obeso gatto Viktor e Michail non avrebbe mai abbandonato
il suo amico al destino da deposito bagagli che lo attendeva. Così il
proprietario del felino ha deciso di perdere il volo, prenotare il successivo,
rifare i controlli con una controfigura, un doppelganger, un sosia smilzo: il
magro gatto Phebe, prestatogli rocambolescamente da un' amica. Poi ha lasciato
Phebe alla legittima proprietaria, ha sostituito Viktor nella borsa e ha
imbarcato il suo animale, buggerando le regole della compagnia Aeroflot. La
storia sarebbe finita lì se Michail non fosse vissuto nell' era di Instagram.
Uno scatto mostrava al mondo Viktor mentre guardava le nuvole fuori dal
finestrino in aereo e centinaia di persone hanno letto di come era riuscito
furbescamente ad imbarcarsi. Tra loro anche gli impiegati dell' Aeroflot, che
presto hanno sanzionato il proprietario, sottraendogli le sue trentasettemila
miglia di bonus accumulati per sconti aerei. Milioni di click dopo, è stata
questa la mossa che ha dato inizio alla saga del felino virale. Qui segue la
storia (vera) del tentato dirottamento di un gatto volante, grosso e grasso, e
forse dell' anima della Federazione che abita. Sul web è stato subito un non
complesso schierarsi di fazioni: supporto e solidarietà al proprietario punito
dall' Aeroflot e anatemi contro la compagnia di bandiera, già fiore all'
occhiello dei sovietici, gestita dal suocero dell' ex presidente Boris Yeltsin
fino al 2009 e ora nelle mani di Vitaly Savelyev, amico del presidente Vladimir
Putin. Veloce come il boeing dove gli volevano impedire di viaggiare, il gatto è
diventato meme condiviso, soggetto adamantino da social media, protagonista di
commenti in sequenza chilometrica, fonte d' ispirazione di aforismi profondi
degli utenti: "Il grasso non è un crimine". Icona anomala contro l' ingiustizia
da milioni di fan: "Siamo tutti Viktor". "Viktor Vola". "Aerogatto". È la
vittoria di Viktor il grasso contro il colosso aereo per la santa alleanza
trasversale tra felini e umani nel Paese dove nel 60% delle case c' è un gatto.
La Russia è la nazione con più felini domestici al mondo, riferiscono
statistiche di oscure fondazioni capaci in maniera misteriosa di contare i gatti
pro capite. Inammissibile quanto imprevedibile, la controversia è diventa
centrale per settimane nel dibattito dell' opinione pubblica slava. Uno stormo
di penne della stampa cirillica si è occupata dei branchi di felini presenti
nella storia della nazione, sono state rispolverate pagine maestose della
letteratura russa del Novecento. Nei talk show: "Perché i russi amano i gatti?".
Rispondono esperti: "Perché incarnano tradizione e saggezza del nostro popolo".
Sono utili: i gatti proteggono il prestigioso museo dell' Hermitage a
Pietroburgo. È uno sciorinare di certezze chiave: "I gatti sono amici degli
umani". Si cercano risposte definitive nella scienza, in un proliferare propizio
di opinioni sui benefici della vita domestica condivisa con la presenza pelosa.
Viktor, il gatto, diventa l' eroe nazionalpopolare a quattro, molli zampe che
tutti vorrebbero tirare per il cicciuto collo. Omaggi alla sua bellezza
sovrappeso: sul quotidiano Izvestia cominciano a scrivere che "grasso è bello".
Ripreso in ogni posizione per mostrare alle telecamere la sua maestosità
adiposa, una sagoma di pelo grigio e lardo, il gatto è finito su quasi ogni
canale russo. Lunghi minuti di inchieste ai microfoni dei giornalisti: Signor
Galin, cosa mangia Viktor? È un gatto pulito, si lava? Dorme bene "dopo tutto
quello che è successo"? Viktor è felice? Mentre il proprietario parlava a reti
unificate, il micio Viktor per tutto il tempo è rimasto muto e probabilmente
incosciente della sua fama non richiesta in inspiegabile espansione. Per un'
indignazione collettiva palesata in dimensione minore contro le istituzioni per
sanzioni economiche, scandali, corruzione, Viktor ha ottenuto regali da aziende
private, come cibo gratis a vita. Al suo proprietario sono stati regalati gli
stessi chilometri che la compagnia aerea gli aveva sottratto da una società
privata di taxi. Un trattamento da star è stato promesso dal dipartimento
turistico della Repubblica del Tatarstan, che in via ufficiale ha invitato la
coppia a visitare la capitale Kazan. Viktor contro Aeroflot. "Il governo si
rifiuta di reagire alla situazione!". Il portavoce del presidente Putin, Dimitry
Peskov, interpellato per sciogliere il veemente dilemma animalesco, assaltato da
interrogativi di giornalisti impavidi in conferenza stampa ufficiale, ha dovuto
rispondere: "Io non credo che il Cremlino debba o possa in qualche modo
commentare la situazione del gatto in aereo", ammettendo infine che "il Cremlino
non si occupa di gatti". La ballata di Viktor è proseguita oltre confine. "I
grassi hanno diritto di volare": c' è stato anche lo sberleffo delle compagnie
aeree straniere, dall' Air France all' Egypt Air, con foto annesse dei loro
gatti viaggianti in costume nazionale, adagiati comodi nelle poltrone. Tentando
di ignorare la notizia, per cedere poi alla calamita degli hashtag, del grassume
del quadrupede hanno scritto Bbc, Washington Post, New York Times, Cnn, The
Guardian. È una "cat-catastrofe" sul Daily Mail. Dell' insostenibile pesantezza
di Viktor infine scriviamo anche noi. Il mogio felino pesante ha continuato ad
essere tema dell' annoso dibattito fino a che la ruggine del web non stava per
seppellire l' argomento. Il taciturno Viktor poteva finalmente riposare in un
meritato cono d' ombra. Quando si pensava che fosse iniziato il suo letargo
mediatico il silenzio sull' animale è stato rotto proprio da Ria Novosti,
agenzia stampa del Cremlino. Un dispaccio di fine gennaio annuncia che presto
sta per ricominciare tutto: "Viktor deve tornare a volare e si è messo a dieta".
Anna Lombardi per “la Repubblica” il 18 dicembre 2019. Al cigno
nero del balletto americano proprio non è andata giù. Quella foto di due
danzatrici del Bolshoj con il corpo dipinto di scuro, durante le prove de La
Bayadère, «è razzista». Misty Copeland, 37 anni, prima ballerina dell' American
Ballet Theatre di New York, ma soprattutto prima afroamericana a diventare
étoile di una compagnia così importante, ha puntato il dito contro il teatro
russo, accusandolo su Twitter di essere insensibile ai temi razziali: «È
doloroso che importanti compagnie non assumano ballerini di colore, optando per
il trucco blackface ». Il suo post, che ha già 60mila like, ha indignato gli
americani. Sensibili al tema: visto che la blackface - che affonda le sue radici
in quell' abitudine iniziata negli anni '30 di far camuffare da neri gli attori
bianchi pensando che chi aveva la pelle scura fosse incapace di rappresentare in
scena perfino se stesso - è ormai simbolo di discriminazione e appropriazione
culturale. Vladimir Urin, direttore del Bolshoj, ha risposto sdegnato: «Questa
Bayadère è già andata in scena migliaia di volte. Non ci lasceremo coinvolgere
in una inutile polemica». Difeso sui social da molti esperti di teatro russi, ha
spiegato che il trucco serve perché in quella parte di mondo i danzatori neri
scarseggiano. «Chiamarci razzisti è ridicolo» ha insistito Urin. Ma i tempi,
almeno in America, sono cambiati: lo dimostra la difficile parabola artistica di
Copeland in un mondo dominato dalla visione del grande coreografo Balanchine
secondo cui «le ballerine devono avere la carnagione pallida di una mela
sbucciata ». Nata povera a Kansas City, è arrivata alla danza tardi, a 13 anni,
per sfuggire ai vagabondaggi di una madre che alla fine di ogni relazione
cambiava città, costringendo i sei figli ad ammucchiarsi nei motel. È Cynthia
Bradley a cambiarle la vita, insegnandole quella disciplina che la imporrà in
ruoli bianchi: Odette ne Il lago dei cigni e perfino Giulietta, con Roberto
Bolle come Romeo. Nel 2015, anno in cui l' American Ballet la sceglie come
stella, Time la inserisce tra le 100 persone più influenti del mondo. Non a caso
quello stesso anno debutta a Broadway Hamilton , il musical amatissimo da Obama,
dedicato alla vita del primo ministro delle Finanze, con i padri fondatori
interpretati da artisti di colore. Da allora non è inusuale vedere sui
palcoscenici neri o asiatici in panni tradizionalmente da bianchi. Come nella
Bohème ora in scena al Metropolitan: col coreano Jongmin Park come Colline e il
nero Arthur Woodley a interpretare Benoit. Cigni neri crescono. E un domani,
chissà, conquisteranno anche Mosca.
Mosca, le spie della porta accanto: svelati i nomi degli
infiltrati del Kgb.
Pubblicato domenica, 02 febbraio 2020 su Corriere.it da Guido Olimpio. Per la
prima volta il governo russo rende noti i nomi delle spie illegali che adoperava
il servizio segreto sovietico: alcuni sono morti, altri oggi si godono la
pensione. Abitudini normali, occupazioni normali. Per vivere come noi e tra di
noi. Capaci di ingannare il vicino, a volte la famiglia. In grado di condurre
un’esistenza senza sussulti, quasi anonima, per poter raccogliere informazioni
sotto gli occhi di tutti. Indisturbati. Questo raccontano le storie di alcuni
«illegali», agenti dei servizi russi mandati all’estero dopo essere stati
preparati a somigliare ad americani, giapponesi, sudamericani, europei. Nella
valigia identità spesso rubate ai morti. I dettagli scarni delle loro missioni
sono stati svelati di recente dall’SVR, l’intelligence esterna della Russia, in
un’operazione di trasparenza, dal valore storico e propagandistico, iniziata con
la diffusione delle prime schede. Alcuni si godono la pensione, altri sono
morti, accomunati dal riconoscimento postumo nella forma di medaglie e titoli da
parte di Vladimir Putin, uno di loro. Anatolyevich Shevchenko, figlio di
impiegati, architetto, entra nel Kgb nel 1963. Per due anni lo «costruiscono»,
gli insegnano trucchi e metodi di comunicazione. Nel 1969 inizia a viaggiare
all’estero, dove aggancia informatori e rastrella dati top secret di massimo
livello. Nel 2001 è «terminato», lo richiamano in patria e resta nell’apparato
fino al congedo. Non un ritiro completo, visto che continuerà a insegnare ai
futuri «illegali». Un peccato sprecare la sua «arte». Ivanovich Kim, origini
coreane, genitori contadini, fluente in spagnolo, si trasferirà «in uno Stato
con una complessa situazione operativa» dimostrando «audacia e coraggio».
Gestirà una «residenza» clandestina attraverso la quale coltiverà fonti
primarie. Muore in un incidente stradale nel 1998. La coppia incredibile.
Meglio, credibile.
Anatoly Vasenkov è arruolato nel 1996, «onesto, modesto, laborioso». Certamente
scaltro. Lo sappiamo non dalla versione ufficiale ma da quanto è emerso nel 2010
dopo essere stato smascherato dall’Fbi grazie alla soffiata di un transfugo.
Vasenkov assume l’identità di Juan Lazaro, di professione fotografo, nato «in
Uruguay» e residente in Perù. Qui conosce la moglie, la combattiva reporter
Vicky Pelaez, castrista accesa. Dal Sud America si trasferiranno al numero 17 di
Clifton Avenue, Yonkers, stato di New York. Un amico non era mai stato troppo
convinto di quell’accento con inflessione tedesca, però non aveva fatto domande.
E poi Vasenkov-Lazaro era stimato quanto impegnato. Trasmetterà le «info» usando
una radio a onde corte, senza lasciare tracce e suscitare sospetti neppure in
Vicky che, dopo l’arresto, giurerà di non aver saputo nulla. Anche se
un’intercettazione parrebbe dire il contrario. I due torneranno in Russia grazie
ad uno scambio, lasciando in America i figli, Waldo e Juan jr, pianista di
talento. I legami affettivi possono attendere.
La seconda coppia. Tamara e Vitaly Netyksa, entrambi bravi con lo spagnolo. Lui
ha seguito una formazione speciale — sostiene l’SVR – dal 1972 al 1978. Un
periodo piuttosto lungo chiusosi con il trasferimento, insieme alla
consorte-collega, in un paese ad alto rischio. La Russia li ha premiati con una
sfilza di onorificenze, lei con il grado di colonnello. Identico percorso per
Vladimir Lokhov, impiegato dagli anni ’60 in Asia e in Europa. Quindi la nomina
a istruttore nel 1973 e una successiva promozione. A chiudere il colonnello
Aleksevich Nuikin. Ha agito fino all’86 in 18 paesi, avendo come principale
sponda la moglie Lyudmila, parte del servizio. Saranno traditi da un alto
funzionario del Kgb scappato in Occidente. La bella serie tv The Americans ne ha
offerto una ricostruzione romanzata, i dossier dell’SVR e le testimonianze dei
protagonisti li hanno resi più terreni, meno mondani. Restano le domande sui
successi e sul dopo, con alcuni partiti quando c’era l’Urss e tornati in una
realtà profondamente mutata.
·
Quei razzisti come
i venezuelani.
Venezuela, l'accusa dell'Onu: Maduro responsabile di crimini
contro l'umanità. Pubblicato mercoledì, 16 settembre
2020 Daniele Mastrogiacomo su La Repubblica.it. Nel rapporto degli investigatori
delle Nazioni Unite si afferma che le forze di sicurezza e i gruppi loro alleati
hanno commesso "violazioni sistematiche dei diritti umani, compresi omicidi e
torture". L'Onu accusa Nicolás Maduro di crimini contro l'umanità e chiede che
venga processato dalla Corte internazionale dell'Aja. Con un comunicato che
esprime la sintesi di un duro e dettagliato rapporto steso da un gruppo di
investigatori al termine di una lunga indagine nel Paese sudamericano, le
Nazioni Unite affermano che le forze di sicurezza e i gruppi loro alleati hanno
commesso "violazioni sistematiche dei diritti umani, compresi omicidi e torture
che equivalgono a crimini contro l'umanità". Lo scrive Reuters che assieme
alla Bbc riporta ampi brani del rapporto che inchioda il presidente del
Venezuela e i suoi ministri della Difesa e dell'Interno, Néstor Reverol e
Vladimiro Padrino López, a pesanti responsabilità. La maggioranza delle
esecuzioni illegali da parte di agenti statali", sottolinea il dossier, "non
sono state oggetto di indagine e sottoposte a giudizio in Venezuela, un paese
dove lo Stato di Diritto e le istituzioni democratiche hanno fallito". La
missione degli investigatori dell'Onu ritiene che la Corte Penale
Internazionale, assieme ad altre istituzioni giuridiche nazionali, che avviarono
uno studio preliminare in Venezuela nel 2018, dovrebbero processare i personaggi
coinvolti. Gli esperti sono pronti a consegnare i dati che contengono i nomi
degli ufficiali identificati dalle vittime. "Il gruppo", spiega ancora il
rapporto, "ha raggiunto motivi ragionevoli per credere che le autorità
venezuelane e le forze di sicurezza abbiano pianificato e portato a termine
violazioni dei diritti umani sin dal 2014". Tra queste gli assassinii e l'uso
sistematico della tortura che, rileva la presidente del gruppo di investigatori
Onu, Marta Valinas, "sono crimini contro l'umanità". Maduro e il suo governo non
hanno risposto alla diffusione del rapporto. Ma è probabile che lo faranno nelle
prossime ore. Un'accusa così pesante, sollevata da un organismo internazionale
che il presidente stesso aveva invitato in Venezuela per dimostrare che tutto
andava bene e che le accuse dell'opposizione e degli espatriati erano solo
calunnie, non può lasciarlo indifferente. Soprattutto ora che ha assunto un
atteggiamento molto più disponibile ad un negoziato che porti a una
pacificazione, ha rilasciato duecento prigionieri politici, ha ottenuto la
partecipazione alle elezioni legislative fissate a dicembre di Henrique
Capriles, esponente di spicco del dissenso, già due volte candidato alle
presidenziali, sconfitto per un pugno di voti prima da Hugo Chávez e poi dallo
stesso Maduro. Il nuovo rapporto segue quello altrettanto critico, ma con
diverse sfumature, realizzato dall'Alta Commissaria per i Diritti Umani dell'Onu
Michelle Bachelet. L'ambasciatore venezuelano presso le Nazioni Unite Jorge
Valero si è mostrato sorpreso dalle conclusioni della missione. "Avevamo ripreso
i rapporti con la Bachelet e avviato un programma di visite nelle carceri", ha
ricordato. "La relazione nuoce al dialogo in corso e va a sommarsi alle pesanti
sanzioni imposte dal presidente Trump che stanno provocando sofferenza e morte
al popolo venezuelano".
Maduro annuncia l’arresto di un agente della Cia (ma qualcosa
non quadra). Giovanni Giacalone il 16 settembre 2020
su Inside Over. Il regime di Nicolas Maduro ha reso noto lunedì 14 settembre di
aver arrestato un agente della Central intelligence agency (Cia), in compagnia
di tre cittadini venezuelani, che stavano pianificando attentati contro le
installazioni petrolifere nell’ovest del Paese. Secondo quanto riferito dal
procuratore generale, Tarek William Saab, i quattro sono stati identificati come
Daeven Enrique Rodriguez Argueta, Marco Antonio Garces Carapaica, Darwin Adreizo
Urdaneta Pardo (ufficiale della Guardia nazionale bolivariana) e John Matthew
Heath, quest’ultimo indicato come ex marine che avrebbe prestato servizio in
Iraq. Le autorità di Caracas hanno inoltre riferito che i quattro sono stati
sorpresi a bordo di un’auto all’interno della quale è stato trovato un
armamentario che include un lanciagranate AT4 calibro 84, una mitraglietta UZI
9mm, quattro pezzi di esplosivo C4, un telefono satellitare, tre cellulari,
denaro in valuta estera e un cappello con un non meglio specificato stemma
governativo.
I presunti agenti della Cia. Il regime di Maduro è da tempo che
ostenta arresti di presunti agenti della Cia; lo si è visto la scorsa primavera
in seguito a una rocambolesca azione armata andata in malora ancor prima di
iniziare, per mano di un gruppo di oppositori del regime affiancati da due ex
militari statunitensi in veste di contractors e il tutto sotto la regia di
Jordan Goudreau, ex Berretto Verde reinventatosi contractor. Nonostante Goudreau
abbia vantato rapporti con l’amministrazione Trump, Washington ha ampiamente
smentito qualsiasi legame con la disastrosa iniziativa e lo stesso presidente ha
affermato “se fossimo stati noi, le cose sarebbero andate diversamente”. Fatto
sta che i due ex militari Luke Alexander Denman e Airan Berry sono ancora
detenuti in un carcere venezuelano e il regime Maduro ha suonato le trombe
propagandistiche spacciando i due per agenti della Cia e l’azione come un enorme
fallimento di Washington. Del resto il regime di Caracas ha sempre avuto il
vizio di accusare cittadini statunitensi arrestati nel Paese di far parte della
Cia e di voler destabilizzare il Paese. Nell’aprile del 2013 toccò a Timothy
Hallet Tracy, un 35enne reporter indipendente arrestato all’aeroporto di Caracas
mentre era in procinto di lasciare il Paese e accusato di “aver scattato foto e
registrato filmati con l’obiettivo di documentare situazioni per fini
sovversivi”; Tracy venne poi espulso dal Paese. Accuse simili vennero poi mosse
nei confronti del missionario mormone Joshua Holt, originario dello Utah,
sposato con una donna ecuadoriana con cittadinanza venezuelana e arrestato nel
2016 con l’accusa di “possesso di arma da guerra”. Holt veniva rilasciato due
anni dopo assieme alla moglie e ricevuto dal presidente, Donald Trump.
Tutto quello che non torna. Sul caso dell’arresto del presunto
agente della Cia, John Michael Heath, le informazioni disponibili sono ancora
insufficienti per poter inquadrare adeguatamente la situazione, ma è bene fare
alcune riflessioni sugli elementi presentati fin’ora dal regime. Secondo i
dettagli attualmente disponibili, i quattro individui erano a bordo di una Chery
modello Aruaca targata AH642ZA e risultante di proprietà di Ivonne Coromoto
Barrios Finol (moglie di Daeven Enrique Rodriguez Argueta, uno dei quattro
occupanti del mezzo). Heath avrebbe varcato il confine tra Colombia e Venezuela
nei pressi della frontiera di Paraguachon e si trovava sul mezzo per essere
accompagnato a Punto Fijo, dove si trovano le raffinerie di Amuay e Cardon,
forse per scattare foto o addirittura per sabotare l’impianto, magari con il
lanciagranate trovato a bordo o con il C4. A bordo era presente anche il già
citato ufficiale della GNB, Urdaneta Pardo, plausibilmente per aiutare Heath a
superare eventuali controlli, ma i quattro sarebbero stati scoperti a un posto
di blocco e tratti in arresto mentre viaggiavano sulla Troncal 3 all’altezza di
Los Pedros. Il primo elemento che desta perplessità riguarda quanto dichiarato
dal Procuratore Generale della Repubblica, Tarek Saab, secondo cui Heath sarebbe
un ex marine e contractor della società MVM che ha compiuto missioni in Iraq dal
2006 al 2016 per tre mesi all’anno, dove avrebbe lavorato come operatore di
comunicazione presso una base segreta della Cia. Saab ha poi aggiunto: “Sappiamo
che l’impresa MVM è utilizzata dal governo Usa per appaltare piani di
destabilizzazione nei confronti di altri Paesi”. Saab sembra però non essere al
corrente del fatto che la MVM perse il contratto con la Cia nel 2008, come già
riportato a suo tempo dal Wall Street Journal. In aggiunta, emersero problemi
anche in relazione a un accordo fatto tra MVM ed NSA. Va inoltre sottolineato
che la suddetta società non forniva personale alla Cia, ma si occupava di
proteggere il personale dell’intelligence militare, cosa che avrebbe cessato di
fare nel 2008. Non risulta dunque chiaro come Heath, ammesso che avesse
realmente operato per la MVM, avrebbe potuto continuare a lavorare per altri
otto anni. Sempre secondo quanto riferito dalla Procura Generale venezuelana,
Heath sarebbe stato in possesso della fotocopia del passaporto, nascosta
all’interno della propria scarpa e di una moneta che lo ricollegava alla Cia. In
poche parole, Heath viaggiava su una delle strade più controllate del Venezuela
(proprio perché a ridosso del confine con la Colombia e in direzione dei due
principali stabilimenti petroliferi del Paese), pochi giorni dopo che le
autorità di Caracas avevano scoperto un presunto sabotaggio nei confronti dello
stabilimento PDVSA di El Palito, con la fotocopia del passaporto nella scarpa,
senza ingresso ufficiale nel Paese, con un elemento identificativo che lo
ricollegava alla Cia e come se non bastasse a bordo dell’auto il gruppo
trasportava armi, denaro contante in gran quantità e un telefono satellitare.
Insomma, un’operazione che non avrebbe nulla da invidiare allo sgangherato
assalto dello scorso maggio da parte dei contractor di Goudreau. La presenza in
auto dell’ufficiale della Guardia Nazionale Bolivariana suona altrettanto
strana, non solo per il fatto che non è certo garanzia di libero passaggio ad
eventuali controlli, visto che i servizi segreti di Maduro diffidano di tutti,
GNB inclusa, ma non si capisce nemmeno come un ufficiale di tale corpo possa
aver voglia di infilarsi in un’auto carica di prove compromettenti assieme a un
presunto agente statunitense (dal nome chiaramente anglosassone, cosa curiosa
considerata l’ampia scelta di agenti dai nomi ispanici di cui l’Agenzia dispone)
che gira con la fotocopia del passaporto nella scarpa e una medaglia (o moneta
che sia) ricollegabile alla CIA. Perchè entrare poi per la frontiera di
Paraguachon e rischiare di essere scoperti percorrendo la “Troncal” per più di
400 chilometri fino a Punto Fiijo quando sarebbe stato sufficiente imbarcarsi
dalla penisola colombiana di La Guajira e navigare per poco più di 50 km e
raggiungere la penisola di Punto Fijo? Difficile credere che la Cia non disponga
dei mezzi per un’azione così basilare. Insomma, l’arresto del presunto agente
statunitense e dei suoi collaboratori suona molto come l’ennesima azione
propagandistica di un regime sempre più allo sbando, al punto che nonostante il
Venezuela sia uno dei principali Paesi produttori di petrolio, il regime di
Maduro è costretto a fare affidamento sulle importazioni di greggio dall’Iran e
sarebbe arrivato addirittura al punto di smembrare oleodotti per rivenderne il
metallo. Come se non bastasse, la Corte Suprema di Capo Verde
ha autorizzato l’estradizione negli Usa del businessman e faccendiere del regime
venezuelano, Alex Saab Moran, arrestato a inizio estate mentre era in volo verso
l’Iran. Il 14 settembre è inoltre stato reso noto che Washington
ha congelato 700 milioni di proprietà di Saab Moran presenti su dei conti
correnti in banche del Liechtenstein. Una volta estradato, il soggetto in
questione potrebbe riferire agli USA informazioni di vitale importanza che
potrebbero seriamente inguaiare il regime Maduro, gli alti apparati militari e
il cosiddetto Cartel de los Soles.
·
Quei razzisti come
gli Argentini.
Argentina, trova lista di 12mila nazisti tra le carte di una
banca in disuso: dentro, il tesoro sottratto a milioni di ebrei.
Il documento con la lista dei 12mila nazisti e relativi conti correnti (Centro
Simon Wiesenthal). A fare la scoperta l'investigatore privato Pedro Filippuzzi.
Un lista nota che si pensava distrutta: indicava le ingenti somme che i nazisti
si erano portati dietro fuggendo a Buenos Aires dopo la caduta del Terzo Reich e
che furono il capitale iniziale del Credit Suisse. Daniele Mastrogiacomo il 04
marzo 2020 su La Repubblica. L'HA scoperto per caso. In mezzo alle cartacce
ammassate alla rinfusa in un sotterraneo di una vecchia banca ormai in disuso.
Rovistando si è soffermato su documento dal titolo anomalo, almeno arcaico:
"Congresso della Nazione Argentina". Si è incuriosito e ha iniziato a
sfogliarlo. Pedro Filippuzzi, investigatore privato, ha capito subito che era
qualcosa di grosso: si era imbattuto sulla rete di 12mila nazisti che tra il
1941 e il 1943, prima della caduta del Terzo Reich, avevano preso il largo e si
erano rifugiati in Argentina. La lunga lista di nomi indicava anche le somme che
si erano portati dietro e che erano il bottino sottratto ai milioni di ebrei
saccheggiati dei loro averi. La lista era nota. Ma nel 1944 il governo del
dittatore filo tedesco Edelmiro Farrel aveva disciolto la Commissione incaricata
di analizzarla e ordinato la distruzione del documento. Tutti pensavano che la
questione si fosse chiusa e con il macero anche questa importante prova fosse
sparita dalla circolazione. Non sapevano che qualcuno ne aveva fatto una copia
rimasta poi per 80 anni seppellita nei sotterranei del vecchio
istituto. Filippuzzi ha contattato il Centro Simon Wiesenthal, famoso per la sua
caccia ai nazisti sopravvissuti al dissesto del regime di Hitler, che a sua
volta si è rivolto al Credit Suisse reclamando la restituzione dei beni
trafugati. Il Centro ha potuto anche ricostruire la rotta seguita da questo
tesoro che secondo diverse ipotesi è servito a finanziare le attività legali
messe in piedi in Argentina dai nazisti fuggiaschi. Parte di questi soldi
sarebbero poi rientrati in Europa tramite la banca svizzera Schweizerische
Kreditanstalt, oggi diventato appunto Credit Suisse. "Questi conti",
osserva Shimon Samuels, direttore delle Relazioni internazionali del Centro
Simon Wiesenthal, "includevano diverse imprese tedesche come la IG Farben,
fornitore del gas Zyklon-B, utilizzato nelle camere di sterminio, e organismi
finanziari come il Banco Tedesco Transatlantico e il Banco Tedesco dell'America
del Sud. Banche che, apparentemente, servirono per realizzare delle transazioni
naziste in Svizzera". La presenza di una folta comunità nazista a Buenos Aires
era cosa nota negli anni successivi alla fine della Seconda guerra mondiale. Si
calcolava che fosse formata da 1.400 persone, sostenute da 12mila simpatizzanti
e da altri 8mila militanti di diverse organizzazioni locali. I governi
dell'epoca facevano finta di niente e lasciavano agire i nuovi arrivati come
parte della massa di immigrati già giunti, per sfuggire al conflitto e al
terrore hitleriano, anni prima. Ma una retata della polizia nella sede
dell'Unione tedesca delle corporazioni, una facciata per le migliaia di
immigrati nazisti del Terzo Reich, portò al sequestro della lista che fu
consegnata al Parlamento argentino. "Non tutti i 12mila indicati nel documento",
precisa Ariel Gelblung, direttore per l'America Latina del Wiesenthal, "erano
persone che usarono la triangolazione per portare via il denaro rubato dai
nazisti. Ma all'interno della lista c'è sicuramente chi la utilizzò". Far
sparire quel denaro era vitale per Hitler. Non c'era la possibilità di cambiare
la moneta tedesca con i dollari. Trasferirla in Argentina consentiva di farlo.
Veniva scambiata con il foglio verde e da qui rientrava in Europa. Secondo
Gelblung è impossibile stabilire l'ammontare del tesoro depositato nei conti
sospetti. Ma è certo che quella ingente somma fu usata come capitale iniziale
dal Credit Suisse sorto sulle ceneri del Schweizerische Kreditanstalt.
Argentina, Kirchner attacca gli italiani: "Mafiosi per
genetica". La vicepresidente argentina Cristina
Kirchner ha detto che gli italiani sono “mafiosi per genetica”. Scoppia la
polemica. Federico Giuliani, Mercoledì 12/02/2020 su Il Giornale. Parlando alla
Fiera del Libro all'Avana, la vicepresidente argentina Cristina Kirchner ha
attaccato il popolo italiano definendolo mafioso “per genetica”. Partendo
dall'utilizzo del sistema giudiziario per screditare un avversario politico,
Kirchner ha detto che “in Argentina il lawfare ha avuto una componente
mafiosa che ha provocato la persecuzione dei miei figli”. A proposito della
componente mafiosa citata, questa, secondo la vicepresidente, “deve essere
probabilmente causata dagli antenati di chi è stato presidente proprio come ha
denunciato un noto giornalista del giornale Pagina 12 quando ha parlato della
'ndrangheta. Devono essere quegli antenati". Chiaro il riferimento a Mauricio
Macri, avversario di Kirchner nonché ex presidente dell'Argentina di origini
italiane. La dichiarazione non è certo passata inosservata; ha scatenato
polemiche immediate e suscitato una immediata presa di distanza del presidente
in carica, Alberto Fernandez, che si è dissociato da Kirchner, sottolineando che
“i valori dell'Italia sono fondamentali in Argentina”.
Il presidente Fernandez prova a ricucire lo strappo. Il
presidente Fernandez ha poi postato su Twitter una foto del suo incontro con
l'ambasciatore d'Italia a Buenos Aires, Giuseppe Manzo. La didascalia
all'immagine è emblematica di un tentativo di ricucire lo strappo provocato da
Kirchner: “Con l'ambasciatore italiano @beppemanzo condividiamo i risultati
della visita a Roma. Abbiamo parlato di investimenti produttivi e di
cooperazione scientifica e tecnologica. Abbiamo anche evidenziato il contributo
della comunità italiana e dei suoi valori allo sviluppo dell'Argentina". In ogni
caso, tornando alle parole usate da Kirchner, la Fondazione Apollo ha denunciato
la vicepresidente per manifestazioni "italofobiche": “Le espressioni usate dalla
vicepresidente della Nazione presentano un carattere discriminatorio, in quanto
attribuiscono una sospetta condotta mafiosa di una persona ai suoi “antenati”,
come se i comportamenti etici o contrari all'etica non dipendessero dalla libera
determinazione degli esseri umani, ma dalla loro discendenza, dalla loro origine
etnica". La Fondazione Apollo ha concluso così la sua replica a Kirchner:
"Contrariamente alla tesi italofobica dell'ex presidente, due dei nostri più
grandi leader, che incarnano onestà, distacco personale, protezione del
patrimonio dello Stato e disinteresse per il patrimonio straniero e proprio,
sono Manuel Belgrano e Arturo Illia, entrambi discendenti di italiani".
«Gli
italiani sono mafiosi per genetica»: polemiche per le parole di Kirchner.
Pubblicato mercoledì, 12 febbraio 2020 su Corriere.it. Stanno facendo molto
discutere le parole usate dalla vicepresidente argentina Cristina Kirchner che,
parlando dell’ex presidente Mauricio Macri, ha definito gli italiani «mafiosi
per genetica». La dichiarazione è stata fatta durante la Fiera del Libro
organizzata a l’Havana. La vicepresidente — classe 1953 — ha collegato, seppure
implicitamente, gli «antenati» di Macri alla ‘ndrangheta. Kirchner ha citato
alcuni articoli del quotidiano Pagina 12 che hanno riferito di possibili
connessioni tra la famiglia Macri e la mafia. Due consiglieri della coalizione
politica «Insieme per il Cambiamento» della città di Rosario hanno chiesto
all’Istituto nazionale contro la discriminazione argentina di indagare sulle
parole della vicepresidente, «allo scopo di punirla»: «Le parole dell’ex
presidente costituiscono un’offesa inutile e gratuita a gran parte della società
argentina, perché gran parte di noi proviene da famiglie di origine italiana»,
hanno detto i consiglieri. Il vicesegretario per l’America Latina del Consiglio
Generale degli Italiani all’estero, Mariano Gasola, ha dichiarato di essere
«triste perché questo ci ridicolizza e ci danneggia». Dall’Italia è intervenuto
sul caso il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra, che ha definito
«inaccettabile» la dichiarazione di Kirchner. «Se ci sono politici argentini
coinvolti con la mafia, devono essere arrestati. Ma attaccare in modo razzista
tutti gli italiani, generalizzando in questo modo, è vergognoso. In qualità di
presidente della commissione Antimafia italiana esprimo dura condanna verso le
parole della vicepresidente argentina e chiedo formalmente le sue scuse». Nei
social network argentini, le parole hanno suscitato indignazione di numerosi
discendenti di italiani in Argentina, che con l’hashtag #CFKdiscrimina hanno
chiesto di punire la vicepresidente. C’è chi la accusa di essere «xenofoba», chi
ricorda la fatica dei suoi nonni arrivati in Argentina «in terza classe» e che
hanno lavorato sodo per tutta la loro vita. Chi si sente umiliato dalle sue
offese e chi chiede di essere risarcito.
Maurizio
Stefanini per “Libero quotidiano” il 12 febbraio 2020. Secondo la
vice-presidente argentina, la peronista di sinistra Cristina Kirchner, «gli
italiani sono mafiosi per eredità genetica». Cioè, non è che la ex-presidente -
ora tornata alla vicepresidenza assieme a quell' Alberto Fernandez che secondo
molti non sarebbe che un paravento - ha detto esattamente così. Lo ha detto in
modo abbastanza più volgare. «El lawfare (en la Argentina tuvo) un componente
mafioso, debe ser por los ancestros de quien fuera..., la bragueta italiana...».
Alla lettera: «la guerra giudiziaria in Argentina ha avuto una componente
mafiosa deve essere per gli antenati di chi sa chi, la mutanda italiana». L'
ultima locuzione si potrebbe rendere con un: «la trasmettono ai discendenti
attraverso i testicoli». Ma data la raffinatezza del ragionamento forse ancora
più rispondente sarebbe un «attraverso i coglioni». Lo ha detto sabato a Cuba,
dove si trovava per una Fiera del Libro. Che già sarebbe quasi come parlare da
un convegno sul pluralismo religioso organizzato in Arabia Saudita o da un
seminario sul diritto penale fatto a Teheran: ma tant' è. Presentava il suo
libro, che si intitola Sinceramente. Con "lawfare" si riferiva alla sequela di
11 processi in cui è coinvolta, con ben 5 mandati di arresto preventivo non
eseguiti per l' immunità parlamentare che ha ricercato apposta, facendosi prima
eleggere come senatrice e poi come vicepresidente, che appunto come presidente
del Senato in Argentina ha pure questa protezione. Il presidente della
repubblica invece no: i maligni dicono che è per questo che avrebbe lasciato la
carica a Fernandez. Per via di questa immunità lunedì la Cassazione argentina ha
fatto cadere l' ultimo dei mandato di arresto ancora in piedi. Motivazione: è
inutile, visto che è protetta dall' immunità. Come mai tutte queste cause?
Secondo gli antipatizzanti, semplicemente perché avrebbe rubato a tutto spiano,
configurando un arricchimento illecito secondo alcuni stimato in ben 30 miliardi
di dollari. Lei dice invece che è una persecuzione voluta dal suo predecessore
Mauricio Macri. Che è appunto di origine italiana: da cui l' insinuazione. Il
bello è che Papa Bergoglio, a sua volta di origine italiana, ha attivamente
operato per consentire la vittoria elettorale della coalizione di Cristina. Pure
quello un complotto mafioso? Comunque di fronte all' insurrezione indignata
degli italo-argentini il presidente Fernandez, che peraltro è appena stato in
Italia, è andato subito dall' ambasciatore Manzo, twittando poi una foto
abbracciato con lui assieme a una loda per l' apporto storico degli italiani
alla crescita dell' Argentina.
Cara Kirchner,
le scrivo da italiano offeso. Roberto Pellegrino su Il Giornale il 15 febbraio
2020. Gentile Signora Cristina Elisabet Fernandez Wilhelm Kirchner, Vice
presidente dell’Argentina, da italiano molto offeso e sorpreso, le scrivo perché
lei qualche giorno fa, attaccando un suo avversario politico d’origini italiane,
ha definito tutti gli italiani “geneticamente mafiosi”. Stava parlando con i
giornalisti della gestione dell’ex presidente argentino, Mauricio Macri, ma ha
voluto tiare in ballo un Paese intero, l’Italia che, forse dimentica, ha un
notevole e importante peso nelle nascita della sua nazione. Lei era all’Avana,
alla Fiera del Libro, quando l’è venuta in mente l’idea poco geniale di
collegare i parenti di Macri alla ‘ndrangheta, citando il quotidiano Pagina 12,
suo giornale amico, che ha riferito di possibili connessioni tra la famiglia
dell’ex presidente italo-argentino e la criminalità organizzata. Ha detto: “In
Argentina il lawfare (l’uso del sistema giudiziario per screditare un avversario
politico, ndr) ha avuto una componente mafiosa che ha portato alla persecuzione
dei miei figli”. E poi ha aggiunto: “Deve essere quella componente mafiosa, gli
antenati di chi è stato… come ha denunciato un noto giornalista del
giornale Pagina 12 quando ha parlato della ‘ndrangheta. Devono essere quegli
antenati”. Vede, signora Kirchner, attaccare in modo razzista tutti gli
italiani, generalizzando in questo modo, è semplicemente un comportamento
vergognoso che non mi aspetterei da una persona che, non solo ricopre una carica
così importante, ma che è vice presidente di un Paese di cui oltre il 70 per
cento della popolazione ha origini italiane. Forse, lei che ha un padre spagnolo
e una madre tedesca, non conosce la storia dell’Argentina, il Paese che lei dice
di amare. Una nazione che esiste grazie agli immigrati europei e, soprattutto,
italiani. Non solo per i Conquistadores che decimarono la popolazione indigena
schiavizzandola o uccidendola con le loro malattie importate dall’Europa.
Cristina Kirchner (1953), dal 10 dicembre 2019 è vicepresidente dell’Argentina.
Già senatrice dal 1995 al 2005, è stata in seguito presidente della Repubblica
argentina dal 2007 al 2015. Si è accorta che molto parole in argentine sono
mutuate dall’italiano o dal dialetto veneto e siciliano? Non sa che nel 1895,
dopo la prima grande ondata di migranti dall’Europa che era iniziata
cinquant’anni prima, a Buenos Aires su 663.864 abitanti, 181.361 erano italiani.
Il quartiere centrale di la Boca, dove oggi si balla il Tango in raffinatissimi
ristoranti e bar, fu costruito dagli italiani provenienti dalla Liguria: erano
per lo più pescatori di tonni e dipinsero le loro case con colori vivaci, in
modo che da lontano, guardando dai loro pescherecci, quelle macchie rosse,
gialle, azzurre, verdi e arancioni, ricordassero loro Portofino e le Cinque
Terre. Gli italiani erano gente povera, ma buona, ottimi lavoratori che nel giro
di pochi decenni, proprio per il loro sacrificio, arrivarono a occupare le
posizioni migliori come commercianti, imprenditori e proprietari terrieri.
Sempre nel 1895, in tutta l’Argentina su 143 pubblicazioni periodiche, 13 erano
scritte in italiano. Gli italiani in pochi anni sono, faticosamente, diventati
un’élite che, per necessità o per ambizione, affrontava unita ogni difficoltà,
riuscendo sempre a farsi strada. Lei dimentica che se non fosse stato per i
contadini italiani emigrati da Piemonte, Veneto, Campania e Sicilia la politica
fondiaria governativa, con le tecniche di coltivazione italiane, non si sarebbe
sviluppata nella Pampa. Secondo il censimento del 1895 su un totale di 407.503
proprietari agricoli, più di un quarto erano di nazionalità straniera e fra essi
62.975, – più della metà -, erano italiani. Gentile signora Kirchner, ora, mi
saprebbe dire chi era Manuel Belgrano? Glielo dico io: nato a Buenos Aires nel
1770 da Domenico Belgrano Peri, un ligure di Capo d’Oneglia (oggi Imperia),
Manuel Belgrano è considerato con José de San Martin e Simon Bolivar uno dei
padri dell’indipendenza dei paesi sudamericani dalla Spagna. Belgrano ha
inventato e disegnato nel 1812 la bandiera argentina bianca e azzurra. Il giorno
della sua nascita in Argentina è festa nazionale, in particolare è la Giornata
dell’Emigrante Italiano. La famiglia di Pedro Vasena in una foto dei primi del
Novecento nella loro casa di Buenos Aires. Vasena creò l’industria siderurgica
in Argentina. Lei dimentica, signora vice presidente, la lunga lista di nostri
connazionali che hanno avuto un ruolo di spicco nel suo Paese. E questa non è la
solita retorica riscaldata, è storia: dal presidente Carlos Pellegrini a
scrittori come Ernesto Sabato, da grandi musicisti del tango come Astor
Piazzolla a calciatori come Antonio Valentin Angelillo, da mitici piloti
automobilisti come Juan Manuel Fangio a industriali come Agostino Rocca. Magari
si sta chiedendo: che cosa erano andati a fare tanti italiani a Buenos Aires?
Gli italiani che scelsero di vivere nella città del rio Plata, partendo da
Napoli, Roma, Trieste, Verona, Genova, Bari e Palermo, dopo settimane di
navigazione, stremati dalla stanchezza e dalle malattie, arrivati a Buenos
Aires, da zero crearono aziende d’abbigliamento, fabbriche di mobili e imprese
edili che tutt’ora esistono e producono Pil nel suo Paese. Gli italiani, non
solo hanno portato le braccia, m anche il cervello: le loro conoscenze, la loro
tecnica, il loro talento, la loro indiscussa capacità di creare e inventare.
Ricorda un tale Pietro “Pedro” Vasena? Era nato a Lecco e raggiunge Buenos Aires
a tredici anni, orfano, senza conoscere nessuno. Da zero gettò le basi del
nascente settore siderurgico argentino. A trent’anni, Vasena dirigeva tre
stabilimenti siderurgici di 15 mila, 10 mila 9 mila mq: produceva l’acciaio per
la costruzione delle ferrovie e delle navi, delle strutture dei palazzi, dei
ponti e delle strade. La nascita e l’espansione della fiorente industria
siderurgica argentina la si deve soltanto a lui. Non a uno spagnolo e a un
francese. O a un tedesco. Ma a un italiano semianalfabeta. Il mercato della
Repubblica, l’azienda della New Gaz Company e l’armatura del gran ponte di
Catamarca sono opera sua, perché Pedro Vasena oltre a produrre acciaio e leghe,
progettava con la precisione di un ingegnere del MIT di Harvard. Forse, ora,
gentile signora Kirchner che gentile con gli italiani non è stata, ora inizia a
capire quanta importanza hanno avuto i nostri avi, i nostri bisnonni, i nostri
nonni italiani per far nascere l’Argentina, come nazione, come repubblica, come
solida economia e come cultura dominante. Vogliamo parlare delle innumerevoli
aziende italiane che tra gli anni Cinquanta e Ottanta hanno aperto in Argentina
producendo milioni di posti di lavoro? Hanno portato ricchezza nel tessuto
economico del suo Paese. Nessuno lo può negare. Poi sono stati i cattivi
amministratori, come lei e i suoi amici, che hanno mandato in bancarotta un
Paese che era forte e produttivo come la California. Per tale motivo le sue
affermazioni, che poggiano sul solito immeritato stereotipo dell’italiano
mafioso, anche se è Cristoforo Colombo o Michelangelo, sono frutto di ignoranza
e razzismo. E paura. Per questo dovrebbe scusarsi con tutti gli italiani,
italo-argentini inclusi. Che cosa proverebbe se dicessimo che, essendo sua madre
tedesca, lei è geneticamente una nazista sanguinaria, razzista colpevole della
Shoah? Ci porremmo al suo livello, e non lo facciamo, non lo diciamo, né per
nostra voce né per quella di un nostro politico. Signora Kirchner si scusi con
l’Italia e colmi le sue immense lacune sulla storia del suo Paese. Roberto
Pellegrino
Un archivio
dei desaparecidos italiani in America Latina: "Perché la memoria non si
disperda".
Tanti immigrati furono sterminati in Argentina, Messico, Ecuador,
Uruguay. Il progetto di un collettivo di giovani giornalisti che ha lanciato
anche una raccolta di fondi. Lucio Luca il 24 febbraio 2020 su La Repubblica.
Rastrellamenti, processi sommari, stupri e violenze di ogni tipo, bambini
strappati alle madri. Ottantamila oppositori politici inghiottiti nei lager.
Almeno 30 mila scomparsi dopo torture e sevizie nei Centri clandestini di
detenzione. Dal 1964, la data del golpe della giunta militare in Brasile, al
1990, la fine del regime di Augusto Pinochet in Cile, le dittature
latinoamericane hanno scritto le pagine più nere della loro storia. Argentina in
testa, ma anche Ecuador, Messico, Uruguay: mezza America Latina nella quale chi
non si piegava al regime veniva sterminato. E molto spesso alle famiglie non
rimaneva nemmeno un corpo da seppellire. Molte di queste sono famiglie italiane,
magari tornate a casa dopo decenni di emigrazione: ma nessuna di loro si è
arresa nella ricerca della verità, anche se ormai sono passati più di
cinquant’anni. Il fenomeno dei desaparecidos in America Latina è stato
riconosciuto come crimine contro l’umanità dalle Nazioni Unite soltanto negli
anni ’90. Fra questi quanti sono gli italiani, che fine hanno fatto, quali sono
le loro storie? Se ne sta occupando da un anno un progetto del Centro di
giornalismo permanente, un collettivo di giornalisti indipendente attivo su
Roma, che dopo aver presentato il progetto durante un evento al Nuovo Cinema
Palazzo, in queste ore ha deciso di promuovere una raccolta fondi sul
sito Produzionidalbasso.it per iniziare a diffondere le storie che ha raccolto
finora e proseguire con le altre. Il progetto si chiama Archivio desaparecido ed
è condotto da Alfredo Sprovieri, Elena Basso e Marco Mastrandrea. Punta,
attraverso un lavoro d’inchiesta giornalistica, a creare un archivio digitale e
multimediale fatto di documenti e testimonianze, per mantenere la memoria su una
delle pagine più drammatiche della storia del secolo scorso. “Una campagna che
passi anche dai social media, che sia capace di ricostruire, e tramandare alle
nuove generazioni la dura e decennale lotta di queste famiglie per ottenere
dignità, memoria e giustizia”, raccontano gli autori. Punto focale della vicenda
è il Processo Condor di Roma che in secondo grado ha visto comminare 24
ergastoli per il sequestro e l’omicidio di 23 cittadini italiani e di origine
italiana residenti in Bolivia, Cile, Uruguay e Perù all’epoca delle dittature
militari. Ma le storie che l’archivio vuole ricostruire e raccontare sono molte
di più. Sono quelle di immigrati italiani che nel dopoguerra sono partite per la
ricerca di una vita migliore e che dopo aver dovuto lottare per l’integrazione,
sono stati chiamati a fare i conti con regimi sanguinari che hanno ordinato la
scomparsa delle tracce di chi ha tentato di opporsi. Militanti dei partiti e
delle organizzazioni che si erano opposte ai tiranni, ma anche sindacalisti,
sacerdoti, studenti e semplici cittadini. Quello degli italiani è stato un
contributo numeroso e qualitativamente importante, visto che nelle storie
ricostruite dall’Archivio desaparecido si trovano anche quelle di uomini e donne
che hanno avuto anche ruoli apicali prima accanto a protagonisti come Guevara e
Allende e poi fra i movimenti storici che hanno lottato per il “Nunca mas”, come
le Madres de Plaza de Mayo. Insomma, “non sono solo un catalogo di orrori
perpetrati e di eroismi dimenticati, ma una vera e propria finestra aperta sul
presente”, per usare le parole del compianto Alessandro Leogrande, al cui
impegno il progetto dell’Archivio desaparecido è ispirato.
ITALIANI. MAFIOSI PER SEMPRE. Mafia, un brand di successo,
scrive il 4 agosto 2017 Attilio Bolzoni su "La Repubblica". E' la parola
italiana più conosciuta al mondo. Più di pizza, più di spaghetti. La troviamo in
tutti i dizionari e in tutte le enciclopedie di ogni Paese, dal Magreb
all'Australia, dall'America Latina al Giappone. Ha la sua etimologia
probabilmente nell'espressione araba "maha fat”, che pressappoco vuol dire
protezione o immunità. Quando un italiano - e soprattutto un siciliano - va
all'estero, la battuta è sempre una, immancabile: «Italia? Mafia. Italiano?
Mafioso». E poi giù una risata. Come se l'argomento fosse divertente. La parola
mafia non ha sempre avuto lo stesso significato. Un secolo fa rappresentava una
cosa, un'altra negli Anni Cinquanta e Sessanta, un'altra ancora dopo le
uccisioni di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ogni epoca ha avuto la sua
mafia. Ufficialmente esiste dal 25 aprile del 1865 - quando il termine "Maffia",
scritto con due effe, apparve per la prima volta in un rapporto ufficiale
inviato dal prefetto Filippo Antonio Gualterio al ministro dell'Interno del
tempo - ma ha avuto la sua incubazione almeno un secolo prima. Nel Regno delle
Due Sicilie c'erano sette e unioni e "fratellanze" con a capo un possidente, un
notabile e spesso anche un arciprete. Fenomeno tipico della Sicilia e delle
regioni meridionali - in Campania è camorra e in Calabria 'ndrangheta - secondo
i funzionari governativi di quegli anni «era incarnata nei costumi ed ereditata
col sangue». Per letterati e studiosi delle tradizioni popolari come Giuseppe
Pitrè «il mafioso non è un ladro, non è un assassino ma un uomo coraggioso...e
la mafia è la coscienza del proprio essere, l'esagerato concetto della propria
forza individuale». Dal 9 settembre del 1982 essere mafioso in Italia è reato.
Dal 30 gennaio del 1992 - sentenza della Corte di Cassazione sul maxi processo a
Cosa Nostra - la mafia è considerata un'associazione criminale e segreta. Ma
nonostante ciò la parola mafia è diventata un "marchio" di qualità, un brand di
successo. Nel febbraio del 2014 sono andato in Spagna per realizzare un
reportage su una catena di 34 ristoranti che si chiamano "La Mafia se sienta a
la mesa", la mafia si siede a tavola. Ai loro clienti offrono una carta fedeltà
e una "zona infantil" riservata ai bambini con speciali menu. Per fortuna la
presidente della commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi ha portato avanti
una battaglia attraverso il ministero degli Esteri e, dopo un paio d'anni,
l'Ufficio Marchi e Disegni dell'Unione Europea ha censurato i proprietari della
catena di ristoranti spagnoli accogliendo un ricorso dell'Italia «per
l'invalidità del marchio». In Austria hanno pubblicizzato un "panino Falcone",
nome del giudice grande nemico dei boss ma che «purtroppo sarà grigliato come un
salsicciotto». In Sicilia si vendono da sempre gadget inneggianti ai mafiosi,
pupi con la lupara, tazze con il profilo del Padrino-Marlon Brando, magliette e
adesivi che fanno il verso a Cosa Nostra. In Germania ha grande mercato da
qualche anno la musica della mafia, spacciata anche da alcuni miei colleghi
tedeschi come «autentica cultura calabrese». Ho ascoltato una canzone "dedicata"
all'uccisione del prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa. Comincia così: «Hanno
ammazzato il generale/non ha avuto neanche il tempo di pregare...». Oscenità
smerciate come tradizione popolare.
MERIDIONALI: MAFIOSI PER SEMPRE.
Ravetto vs Aprile: "Sembra l'avvocato dei mafiosi", su Tagadà de La7 l'8 giugno
2018. Scontro in studio tra Laura Ravetto (FI) ed il giornalista Pino Aprile
sulle frasi razziste della prima su dove e come opera la mafia in Italia.
Laura Ravetto: E’ inutile raccontarci favole. Il Sud lo liberi e
liberi le risorse, perché non è non potrebbero vivere meglio ed essere più
produttivi con il turismo, se lo liberi dalla criminalità organizzata…
Pino Aprile: …la mafia…
Laura Ravetto: scusi, cominciamo da dire la verità, guardi. Il
Sud lo conosco bene anch’io. Quante volte mi son sentita dire, andando anche
soltanto su una spiaggia del sud “perché non fate quello perché non fate
l’altro?" “Perché purtroppo abbiamo dei limiti; purtroppo vengono a dirci,
purtroppo vengono a chiederci". Scusate. Cominciamo a dire la verità. Il, la
sfida che lancerei a Salvini, oltre naturalmente la sfida dell’immigrazione, è
veramente quella: liberiamo il Sud. La vera infrastruttura per il Sud è
liberarla dalla criminalità organizzata. Che soffoca la loro economia; che
soffoca le loro imprese. Le soffoca con il pizzo, le soffoca con il controllo
sugli imprenditori. Quanti imprenditori del Sud mi hanno raccontato di capannoni
bruciati, perché erano sotto ricatto. Facciamo questa cosa seriamente e poi
vediamo. Perché non è che a Sud sono meno bravi a lavorare o hanno meno
possibilità di lavorare, considerato che il nostro paese è a vocazione
turistica. Cominciamo a dire la verità. Io personalmente credo che Salvini, se
vuol passare alla storia, questo deve portare a casa.
Tiziana Panella: anche perché sarebbe una cosa che tutti i
Governi precedenti non hanno fatto.
Pino Aprile: quei dati sono frutto di scelte politiche,
esattamente come diceva prima Cottarelli. Perché se dalla spesa pubblica,
quella, diciamo, che dovrebbe essere uguale per tutti, tu sottrai ogni anno per
ogni cittadino del Sud 4340 euro, che fa 85 miliardi all’anno, e monitorati gli
ultimi 10 anni, fanno 850 miliardi. Se sottrai 6,5 miliardi all’anno di
investimenti pubblici al sud rispetto all’uguale per tutti, ecc, i risultati
sono quelli. Quanto alla mafia al Sud versa il sangue, al Nord porta i soldi.
Non a letto (rivolto alla Ravetto) l’ultimo rapporto di Scarpinato….
Laura Ravetto: scusi sta dicendo che ho detto sbagliato? Perdoni,
ma sta dicendo che non c’è la mafia al Sud?
Pino Aprile: sto dicendo che la mafia opera al Nord ed ammazza al
sud...
Laura Ravetto: e vabbè, liberiamola dal Nord e da Sud, scusi
(come se il pericolo fosse il Nord ed il Sud ndr)...
Pino Aprile: Lei ha detto che il Sud deve essere liberato…
Laura Ravetto: e vabbè perché si offende? Guardi che lo dico per
il Sud eh. Non è un’offesa. Ma liberiamola anche dal Nord (?)...
Pino Aprile: lei ha parlato della mafia al Sud...
Laura Ravetto: ma è la realtà. Si offende…
Pino Aprile: posso dire due dati? Non mi sto offendendo…
Laura Ravetto: scusi eh…si offende…sembra l’avvocato dei mafiosi!
Sa così sembra che difende i mafiosi…
Pino Aprile: …sto portando dei dati...
Laura Ravetto: non sono contraddittoria…
Pino Aprile: signora mi fa parlare?
Laura Ravetto: sì, sì, ma non mi venga addosso perché dico che va
liberato il sud dalla criminalità organizzata, se non mi preoccupo.
Pino Aprile: lei non ha letto l’ultimo rapporto. Uno studio fatto
a Bologna…
Laura Ravetto:..ma lei non lo sa se non l’ho letto. Perché da
quello che ho detto da cosa evince che non l’ho letto.
Pino Aprile:…il 20% delle aziende del Nord hanno contatti con la
mafia…
Laura Ravetto: ..ma che centra, benissimo, andiamo a beccarli
anche lì.
Pino Aprile: Liberate il Nord. Liberate l’economia del Nord dalla
mafia….
Poi finisce in gazzarra ad opera della Ravetto che non accetta la
critica su quello che ha detto a sfondo razzista.
Mafia, quei padrini nella nebbia della Padania.
Per anni ho raccontato come giornalista l’invasione delle cosche
al nord. Ora la giustizia conferma una verità che nessuno voleva vedere, scrive
Giovanni Tizian il 6 marzo 2017 su "L'Espresso". La nebbia della pianura padana
è un mantello naturale sotto il quale nascondere intrallazzi e imbrogli. Alibi
perfetto per chi vuole fingersi cieco. «Ciechi che pur vedendo non vedono»,
rifletteva così il protagonista di “Cecità”, capolavoro del premio Nobel José
Saramago. Benché il romanzo si riferisse all’indifferenza di cui è intrisa la
nostra società, il concetto si adatta benissimo ai tanti seguaci della filosofia
del “non vedo, non sento, non parlo”. Le tre scimmiette dell’omertà mafiosa
hanno risalito la penisola. Hanno seguito la linea della palma. Come aveva
profetizzato Leonardo Sciascia quando paragonava l’avanzata culturale e
finanziaria della mafia verso i ricchi territori del Nord al fenomeno climatico
propizio alla coltivazione della palma che, secondo gli scienziati, saliva verso
nord di 500 metri ogni anno. Una voce rimasta inascoltata, quella dello
scrittore siciliano, da alcuni giudicata fin troppo allarmistica. Lo stesso
giudizio guardingo e superficiale riservato ai cronisti che hanno raccontato i
focolai mafiosi sparsi lungo la penisola. Chi scrive e parla di mafie conosce
bene questi silenzi istituzionali. Ostacoli insidiosi. Generano confusione,
disorientano i cittadini e isolano i giornalisti, colpiti sempre più spesso da
querele temerarie, che sanno di messaggio minatorio. Fin dai primi articoli che
ho scritto sulla Gazzetta di Modena ho provato, insieme ai colleghi, a
sbriciolare quel muro di reticenza e inconsapevolezza che circondava la
provincia. Dapprima nessuna reazione. Solo la curiosità di qualche cittadino e
l’attenzione delle associazioni antimafia. Poi arrivò l’ironia di alcuni
politici, in difesa del “buon nome” della regione. Il tribunale di Bologna ha
riconosciuto il metodo mafioso applicato da un'organizzazione che dal Ravennate
operava in tutta l'Emilia Romagna. E per questo motivo i giudici hanno
condannato gli imputati per associazione mafiosa. Una sentenza con pochissimi
precedenti nella Pianura Padana, soprattutto per il fatto che questo gruppo
finito alla sbarra non è collegato direttamente alla 'ndrangheta calabrese, ma
come tale si comporta. Questo è il metodo mafioso che il pm Francesco Caleca ha
sostenuto nel suo impianto accusatorio, riconosciuto in sentenza. E non ha
importanza se questo processo sia stato chiamato "Black Monkey" e non compaia la
parola mafia nella sua denominazione. Ciò che prevale è che per il tribunale
questa è associazione mafiosa. E come tale si è comportata anche quando uno
degli imputati ha minacciato di morte il nostro collega Giovanni Tizian che
sulle pagine della Gazzetta di Modena aveva denunciato questi affari mafiosi
intrecciati con il business delle slot machine. Oggi insieme alla giustizia ha
vinto anche la buona informazione. Ha vinto il coraggio di Giovanni. Il mio
giornale di allora, e così oggi L’Espresso, mi hanno sempre sostenuto. E siamo
andati avanti. Fino a quando due di quelle inchieste mi sono costate un pezzo di
libertà: inquietanti minacce di morte e l’assegnazione di una scorta. Sono
trascorsi quasi sei anni dall’intercettazione di quella telefonata, «gli
spariamo in bocca», che ha cambiato all’improvviso la mia vita e quella della
mia famiglia. Gli articoli che avevano disturbato il boss legato alla
’ndrangheta sono finiti agli atti del processo Black Monkey. Tre anni di
dibattimento in tribunale a Bologna per stabilire se l’organizzazione al cui
vertice stava Nicola “Rocco” Femia fosse associazione mafiosa. Tra le tante
parti civili, insieme all’Ordine dei giornalisti, c’ero anch’io. Il 22 febbraio
scorso la corte ha pronunciato il verdetto di primo grado: il gruppo Femia è
mafia e dovrà risarcire il giornalista, sia me sia l’Ordine. I giudici hanno
certificato, dunque, l’esistenza in Emilia Romagna di una cosca autonoma e
moderna. E non meno importante, hanno riconosciuto nell’informazione un valore
democratico da tutelare dalle ingerenze del potere criminale. A queste
latitudini, dove ormai la palma cresce rigogliosa, i padrini sono al vertice di
organizzazioni poco militari e molto imprenditoriali. Corrompono e solo se
strettamente necessario sparano. Spesso sono nuclei autonomi nelle decisioni e
nelle strategie. Condizionano la politica, l’economia, la pubblica
amministrazione, il mondo delle professioni, le forze dell’ordine e anche pezzi
di informazione. Per anni chi ha provato a denunciare la complessità di tale
groviglio di interessi è stato etichettato come un folle speculatore e, perché
no, pure incosciente. Intanto alcuni prefetti negavano, qualche sindaco riveriva
i capi ’ndrina e inveiva contro la stampa. Assessori, consiglieri e candidati
vari replicavano immagini note al Sud: in fila dai boss per elemosinare qualche
voto. Fino ad arrivare ai consigli comunali sciolti per mafia. Più noi cronisti
individuavamo le ferite sul corpo malandato della pianura padana, più le
risposte oscillavano tra l’indifferenza, lo scherno, la negazione e le querele.
Poi sono arrivate le intimidazioni. E qui qualcuno ha suggerito che sarebbe
stato forse necessario chiedere aiuto a un medico specialista per farsi
prescrivere una cura antibiotica. La speranza è che gli antibiotici facciano
effetto al più presto. Prima che sia troppo tardi. Per chiudere con la stagione
dello stupore e inaugurare il tempo della consapevolezza. Tra la nebbia cercano
riparo ancora troppi complici insospettabili. Stanare i mafiosi e i loro
manutengoli non può essere compito esclusivo dei magistrati o delle forze
dell’ordine. Né di qualche visionario giornalista.
"La mia vita a metà per aver denunciato la 'ndrangheta al
Nord". "Nel 2011 un boss intercettato al telefono
disse che voleva spararmi in bocca perché avevo scritto nei miei articoli dei
suoi affari. Ora il tribunale di Bologna gli ha dato 26 anni in primo grado. E
ha riconosciuto che nelle regioni settentrionali la mafia è ormai radicata".
Parla il nostro cronista, scrive Giovanni Tizian il 23 febbraio 2017. Oltre la
linea Gotica c'è una mafia silente. Per niente rumorosa, accorta a non apparire,
abile nel penetrare nei tessuti sani della società. E se invece questi tessuti
non fossero così sani? Il sospetto è che nei territori del Nord ci sia una forte
richiesta di mafia, dei suoi metodi e strumenti. La chiamano voglia di clan.
Imprenditori, professionisti, politici, servitori dello Stato, che nati e
cresciuti nelle regioni ricche hanno scelto di stare dalla parte del crimine.
Indizi e sentenze recenti, degli ultimi anni, hanno trasformato il dubbio in
certezza. Spesso anche nel minacciare l'accento è misto: nel mio caso quando
boss e faccendiere, progettavano di eliminarmi, il piemontese si mescolava
all'accento calabrese. La telefonata intercettata risale al 2011. E non smetterò
mai di ringraziare quegli uomini e quelle donne della guardia di finanza che
hanno ascoltato e segnalato d'urgenza il fatto alla procura antimafia di
Bologna. Da lì il procuratore dell'epoca Roberto Alfonso, insieme al pm
Francesco Caleca che seguiva l'inchiesta sul gruppo Femia, chiese alla
prefettura di Modena di mettermi sotto scorta. Così iniziò una vita diversamente
libera. Un'esistenza vissuta nell'equilibrio tra fragilità, insicurezze, paure,
ma anche tra l'amore di chi in questi quasi sei anni mi è stato vicino,
sopportando un vita di certo non facile. Poi, ieri, a distanza di così tanto
tempo, il tribunale di Bologna ha riconosciuto l’esistenza di un clan mafioso
che in Emilia aveva messo radici. L'esistenza di quella cosca che voleva
bloccare l'informazione locale immaginando persino di usare il piombo per
raggiungere l'obiettivo. Il tribunale di Bologna ha riconosciuto il metodo
mafioso applicato da un'organizzazione che dal Ravennate operava in tutta
l'Emilia Romagna. E per questo motivo i giudici hanno condannato gli imputati
per associazione mafiosa. Una sentenza con pochissimi precedenti nella Pianura
Padana, soprattutto per il fatto che questo gruppo finito alla sbarra non è
collegato direttamente alla 'ndrangheta calabrese, ma come tale si comporta.
Questo è il metodo mafioso che il pm Francesco Caleca ha sostenuto nel suo
impianto accusatorio, riconosciuto in sentenza. E non ha importanza se questo
processo sia stato chiamato "Black Monkey" e non compaia la parola mafia nella
sua denominazione. Ciò che prevale è che per il tribunale questa è associazione
mafiosa. E come tale si è comportata anche quando uno degli imputati ha
minacciato di morte il nostro collega Giovanni Tizian che sulle pagine della
Gazzetta di Modena aveva denunciato questi affari mafiosi intrecciati con il
business delle slot machine. Oggi insieme alla giustizia ha vinto anche la buona
informazione. Ha vinto il coraggio di Giovanni. Il capo Nicola Femia e i suoi
figli, Nicolas e Guendalina, sono stati condannati a pene pesanti: Nicola detto
"Rocco" a 26 anni, Nicolas a 15 e la figlia a 10. E per la prima volta viene
riconosciuta l’intimidazione all’informazione. Per questo i giudici hanno
stabilito che il clan Femia dovrà risarcire il giornalista che firma questo
articolo e l’Ordine dei giornalisti. Risarcimento per le minacce ricevute. «O la
smette o gli sparo in bocca», diceva il faccendiere Guido Torello (condannato a
9 anni) al boss Femia che si lamentava dei ripetuti articoli che avevo
pubblicato sulla Gazzetta di Modena. Risarcimento per aver minacciato la libertà
di stampa, non solo la mia vita. Anche per questo il verdetto di primo grado del
processo "Black Monkey" è un punto di rottura nella storia dell’antimafia del
Paese. Che serve a tutta la categoria. E spero possa far sentire meno soli quei
colleghi che senza scorta e in trincea scrivono dei poteri criminali nelle
province d'Italia. Lo spero, nonostante il dibattimento che si è concluso ieri a
Bologna si sia svolto nel silenzio. Sebbene la mafia come tema di dibattito
pubblico non abbia più l’appeal di un tempo. Alla fine questa sentenza
rappresenta uno spartiacque. Perché da ora in avanti le organizzazioni mafiose
che pensavano di farla franca nei territori del Centro-Nord dovranno rassegnarsi
a essere giudicate con la stessa severità che gli viene riservata dai tribunali
del Sud, allenati da decenni di violenza e lotta antimafia. In questi anni
vissuti sotto protezione ho maturato una convinzione: il mestiere di informare è
un servizio. Un servizio per i lettori, che sono cittadini. A loro proviamo a
dare gli strumenti per leggere ciò che accade nella comunità in cui vivono.
Un’informazione corretta, insomma, che sia un argine al veleno delle forze
criminali. Sono trascorsi cinque anni e mezzo dal 22 dicembre 2011, da quando,
cioè, la Questura di Modena mi comunicò che da quel giorno avrei vissuto sotto
scorta. Non avevo la minima idea di cosa significasse. Non sapevo esattamente
quali cambiamenti avrebbe portato nella mia vita. Avevo 29 anni. Le lacrime
della mia compagna, il divieto di informare persino i parenti stretti, i primi
due agenti che mi aspettavano sotto casa: mi istruirono in fretta su ciò che
potevo fare e soprattutto su cosa non avrei più potuto fare da quel momento in
poi. Ero come un bambino che imparava a muovere i primi passi in una nuova
vita. Una vita a metà. I momenti di intimità familiare sarebbero diventati una
rarità di cui godere appieno. Non posso però neanche scordare le voci di chi
bollava il tutto come una strumentalizzazione per procurarmi notorietà e
attenzione. Non ho mai risposto. Non mi ha mai appassionato la ferocia del
dibattito social. Preferisco scrivere, raccontare, indagare. Guardare negli
occhi, scrutare ciò che a prima vista non si vede, entrare nelle storie.
Prendermi il tempo per interpretare la verità. Che cammina sempre piano. C’è
voluto tempo anche per la sentenza del processo Black Monkey, ma è un verdetto
storico. Merito di una procura guidata all’epoca da Roberto Alfonso (oggi
procuratore generale di Milano) e di un pm, Francesco Caleca, che ha descritto
alla perfezione la mafia moderna senza alcun protagonismo. Ma un ringraziamento
speciale va a chi ogni settimana, sacrificando il proprio tempo, ha riempito
l’aula 11 del tribunale: studenti, tantissimi; ai loro docenti; agli amici; alle
associazioni che si sono costituite parte civile, da Libera a Sos Impresa; per
finire agli enti locali che hanno ottenuto il risarcimento per i danni di un
clan che ha ucciso un pezzo di economia. Perché questo fanno le mafie 2.0,
ammazzano imprese sane e uccidono la buona economia.
Nessuno ha il coraggio di dire a Bindi che è razzista?
Scrive Mimmo Gangemi il 22 Ottobre 2017 su "Il Dubbio". Per la presidente
dell’Antimafia è impossibile che in Valle d’Aosta non ci sia ’ndrangheta, stante
che il 30% della popolazione è di origine calabrese. La Presidente della
Commissione Parlamentare Antimafia, on. le Rosy Bindi, dichiara che è
impossibile che in Valle d’Aosta non ci sia ’ndrangheta – «che ha condizionato e
continua a condizionare l’economia» – stante che il 30% della popolazione è di
origine calabrese. Qua e là annota punti di vista di matrice abbastanza
lombrosiana, che criminalizzano molto oltre i demeriti reali, aggiungono
pregiudizio al pregiudizio, alimentano la fantasia assurda che quaggiù sia il
Far West e una terra irredimibile, allontanano l’idea di una patria comune,
distruggono i sogni dei nostri giovani su un futuro possibile. Io non sono in
grado di escludere la presenza della ’ndrangheta – essa va dove fiuta i soldi o
dove c’è, da parte di imprenditori locali, una richiesta sociale di ’ndrangheta,
delle prestazioni in cui è altamente specializzata: i subappalti da spremere, il
lavoro nero, la fornitura di inerti di dubbia provenienza, lo smaltimento dei
rifiuti di cantiere, di quelli tossici o peggio, l’abbattimento violento dei
costi, la pace sindacale per sì o per forza, la garanzia di controlli
addomesticabili, e non con il sorriso. Ma, dopo aver controllato la cronaca
delittuosa, non mi pare che compaia granché o che sia incisiva da dover indurre
a tali spietate esternazioni. E non mi piace che tra le righe si colga
l’insinuazione che il calabrese è, in diverse misure, colpevole di ’ ndrangheta
– o di calabresità, che è l’identica cosa. Alludervi è anche disprezzare il
bisogno che ha spinto tanto lontano i passi della speranza e gli immani
sacrifici sopportati per tirarsi su. L’emigrazione in Valle d’Aosta è stata tra
le più faticose e disperate. I primi giunsero nel 1924. E giunsero per fame.
Lavorarono alla Cogne, nelle miniere di magnetite. E quelli di seconda e terza
generazione hanno dimenticato le origini, sono ben inseriti e valdostani fino al
midollo, pochi quelli che ricompaiono per una visita a San Giorgio Morgeto, nel
Reggino, da dove partirono in massa. Più che ai “nostri” tanto discriminati,
forse si dovrebbe guardare alle storie di ordinaria corruzione, non calabrese e
non ’ ndranghetista, che nelle Procure di lì hanno fascicoli robusti. Detto
questo, la on. le Bindi Rosy da Sinalunga – civile Toscana, non l’abbrutita
Calabria – dovrebbe mettersi d’accordo con se stessa.
Chiarisco: alle ultime politiche, dopo che la sua candidatura
traballò da ottavo grado della scala Richter e non ci fu regione disposta ad
accoglierla, per sottrarsi alla rottamazione a costo zero ha dovuto riparare
nell’abbrutita Calabria, che sarà tutta mafiosa ma sa essere anche generosa e
salvatrice per chi, come lei, non intende rinunciare alla poltrona imbottita,
con le molle ormai sbrindellate stante i decenni che le stuzzica poggiando il
nobile deretano. È prona come si pretende da una colonia, la Calabria. In
quell’occasione elettorale lo fu due volte, con la on. le Bindi e con un altro
personaggio di cui l’Italia va fiera, tale Scilipoti Domenico, una bella
accoppiata, entrambi eletti. La on. le fu prima con migliaia di voti nelle
primarie PD del Reggino e, da capolista, ottenne l’entrata trionfale in
Parlamento. Assecondando la sua ipotesi sulla Valle d’Aosta e sulla presenza ’
ndranghetista, diventa legittimo estendere a lei il suo stesso convincimento
che, dove ci sono calabresi, per forza ci sono ’ndranghetisti. Quindi, essendo
la Calabria piena di calabresi – questa, una perla di saggezza alla Max
Catalano, in “Quelli della notte” – logica pretende che tra le sue migliaia di
voti ci siano stati quelli degli ’ ndranghetisti, non si scappa.
Ne tragga le conseguenze. Oppure per lei, e per le Santa Maria
Goretti in circolazione, l’equazione non vale e i voti ’ndranghetisti non
puzzano e non infettano? Eh no, troppo comodo. Qua da noi persino il vago
sospetto d’aver preso certi voti conduce a una incriminazione per 416 bis e
spesso al carcere duro del 41 bis. Questo è. Forse però si è trattato di parole
in libera uscita, di un blackout momentaneo del cervello. Se così, dovrebbe
battersi il petto con una mazza ferrata, chiedere scusa ai calabresi onesti, che
sono la stragrande maggioranza della popolazione, e fare penitenza magari
davanti alla Madonna dagli occhi incerti nel Santuario di Polsi oltraggiato come
ritrovo di ’ ndrangheta e invece da decenni diventato solo luogo di preghiera e
di devozione. Ora mi aspetto l’indignazione dei calabresi. Temo che non ci sarà,
a parte quella di qualche spirito libero – e incosciente, vista l’aria che tira.
E stavolta dovrebbero invece, di più i nostri politici che, ahinoi, tacciono
sempre, mai una voce che si alzi possente e riesca ad oltrepassare il Pollino.
Coraggio, uno scatto d’orgoglio, tirate fuori la rabbia e gli attributi. Se non
ci riuscite, almeno il mea culpa per aver miracolato una parlamentare che ripaga
con acredine la terra che l’ha eletta e a cui, nell’euforia della rielezione
piovuta dal cielo, aveva promesso attenzioni amorevoli.
Toscani shock: «Niente selfie, sei calabrese...»,
scrive Simona Musco il 21 ottobre 2016, su "Il Dubbio". Antonio Marziale,
Garante per l'infanzia e l'adolescenza: «Nel 2007 non ha avuto remore a
prendersi i soldi per la campagna pubblicitaria della regione». «Non vedo il
motivo per cui dovremmo farci una foto. Per quanto ne so, potresti essere un
mafioso». Sono queste le parole con le quali Oliviero Toscani ha negato una
fotografia a Vittorio Sibiriu. Lui ha solo 18 anni e una faccia pulita.
Un'intelligenza vivida e la passione per l'arte. Quella che lo ha spinto,
giovedì, al Valentianum di Vibo Valentia, per assistere alla lectio magistralis
del fotografo e alla sua mostra "Razza Umana". Una mostra, ha spiegato lo stesso
Toscani, che rappresenta uno studio antropologico sulla morfologia degli esseri
umani, «per vedere come siamo fatti, che faccia abbiamo, per capire le
differenze». Parole che associate alla storia di Vittorio riportano alla mente
il concetto di "razza maledetta" dal sapore lombrosiano. Toscani era «un mito»,
fino a due giorni fa, quando ha rifiutato l'invito del ragazzo. «Anche Matteo
Messina Denaro non ha la faccia da mafioso eppure lo è», avrebbe spiegato, come
se quelle parole fossero del tutto normali. A raccontarlo è lo stesso giovane,
studente della quinta classe del liceo scientifico di Vibo. «Ho seguito la
conferenza stampa e ho aspettato il mio turno per fare una foto - ci racconta -.
C'era una degustazione di vini e altra gente che si avvicinava a lui per qualche
scatto. Ho aspettato un po' per non disturbarlo, poi gli ho chiesto di poter
fare una foto. Al suo no stavo andando via, quando mi ha fermato per spiegarmi,
come se fosse del tutto normale, che potrei essere uno 'ndranghetista».
Vittorio, figlio di una poliziotta e di un carabiniere, non è riuscito ad avere
alcuna reazione. È andato via, portando con sé l'amica rimasta con il cellulare
in mano, pronta ad immortalare quel momento. «Lo consideravo uno dei più grandi
non solo come artista, ma anche come persona. Beh, ora so che di certo come
persona non lo è», aggiunge. Nessuno ha reagito alle parole di Toscani. Nessuno
è intervenuto in difesa di Vittorio, che solo il giorno dopo è riuscito a
metabolizzare la rabbia e l'indignazione, scrivendo un messaggio indirizzato al
famoso fotografo, colui che già nel 2007, ingaggiato dalla Regione Calabria per
una campagna promozionale, aveva partorito, alla modica cifra di 3,8 milioni la
frase - tra le altre - "Mafiosi? Sì, siamo calabresi". «Vorrei ricordare al
signor Toscani che la principale qualità di un artista dovrebbe essere l'umiltà,
cosa che a quanto pare non rientra tra i termini del suo vocabolario. E vorrei
dire che l'unica cosa che il suo atteggiamento provoca in me è lo sdegno -
scrive Vittorio -. Mi dispiace molto di averla conosciuta e di aver perso due
ore della mia vita ad ascoltare le sue parole definite "anticonformiste" e usate
"per lanciare messaggi contro i pregiudizi", ai miei occhi adesso appaiono
solamente come poco coerenti». Commenti al vetriolo sono arrivati da Antonio
Marziale, Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria. «Se le
cose stanno così - ha dichiarato -, Toscani farebbe bene a spiegarci se ha avuto
le stesse remore a prendersi i soldi per la campagna pubblicitaria del 2007.
Come si fa a fare una battuta del genere ad un ragazzo? La sua è la generazione
che più patisce il fatto di aver consentito alla 'ndrangheta di proliferare in
questo territorio. Lui senza provocazione sarebbe un fotografo qualunque, la sua
arte è opinabile, le sue provocazioni non portano nulla. Anche perché la
provocazione deve essere saggia e commisurata al soggetto che la riceve. Questa
storia, purtroppo, conferma il masochismo dei calabresi - conclude -.
Continuiamo ad acclamare gente che ci insulta, come Vasco Rossi o Antonello
Venditti. Dico una cosa a Vittorio: non sentirti offeso, Toscani è il vuoto».
Magalli:
“Mai insultato i calabresi”,
la replica del conduttore sulla polemica con un video del 18/11/2016 su "La
Stampa”. «Mi piacerebbe mettere la parola fine a questa polemica inutile che si
sta trascinando sulla Calabria indignata. A me dispiace moltissimo che i
calabresi si siano dispiaciuti per qualcosa che in realtà io non ho detto. Lo
voglio chiarire: i calabresi sono ottime persone, ho passato anni di vacanze in
Calabria, ho amici calabresi e conosco i loro innumerevoli pregi e conosco anche
il loro principale difetto che è quello di essere permalosi». Così Giancarlo
Magalli si difende dopo le accuse piovutegli addosso per la frase pronunciata il
15 novembre scorso durante I fatti vostri su Rai2, dopo la mancata risposta al
telefono del telespettatore estratto, di Casignana, in provincia di Reggio
Calabria. «Siete permalosi a torto perché avete giudicato qualcosa senza vederla
o sentirla - prosegue -. Tutti quelli che si sono indignati e sono tanti, si
sono indignati non per quello che hanno visto, ma per quello che hanno letto.
Quando uno legge robaccia tipo l’Huffington Post: Magalli virgolette «I
calabresi scippano le vecchiette», hanno ragione ad indignarsi. Solo che io non
ho mai detto nulla del genere. Un giornale ha scritto: Magalli offende i
meridionali. Io non ho mai parlato dei meridionali. Faccio questo lavoro da
trent’anni, se avessi qualcosa contro i meridionali sarebbe già venuto fuori,
no?» «Il problema - spiega ancora - è la cosa originaria che non era riferita a
Casignana, a niente, era solo una frase detta a cavolo, dicendo: vi lamentate
che non vi telefoniamo per il gioco e poi non ci siete quando vi telefoniamo, ma
dove andate? A scippare le vecchiette? Una battuta, certamente cretina, ma non
riferita né a Casignana, né alla Calabria, né al Meridione. Solo che chi l’ha
sentita l’ha capita, tanti non l’hanno sentita e commentano il commento di un
altro. Vorrei che questa cosa finisse, anche perché sta raggiungendo toni
inconsulti. Speriamo che si raggiunga questa tranquillità perché ci sono cose
più serie a cui pensare».
L'antimeridionalismo qualunquista di Vecchioni & company,
scrive "Infoaut Palermo" il 6 Dicembre 2015. Siamo chiaramente di parte; è
normale: lo siamo sempre stati. E anche meridionali - beh - come è ovvio, lo
siamo sempre stati: ci siamo nati al Sud. Ci siamo cresciuti in quest'isola
chiamata Sicilia; ci stiamo vivendo; ci stiamo lottando. E onestamente nella
merda, a volte, anche tutt'ora, un po' ci siamo sentiti. Nella merda non perché,
oggettivamente parlando, la Sicilia sia un'isola di merda; e neanche perché ogni
giorno ci troviamo a dover guardare orde barbare di “senzacasco” sfrecciare per
le nostre strade; o manipoli di “posteggiatori della sedicesima fila” aggravare
lo storico problema del traffico palermitano. Un po' nella merda ci troviamo a
sguazzare letteralmente per altri motivi. Ma su questo ritorneremo fra un
attimo. “Chi sa fa, chi non sa insegna” - ecco un vecchio detto (a dire il vero
forse un po' ingeneroso verso le professioni dell'insegnamento) a cui la mente
ci riporta leggendo le ultime dichiarazioni del professor Roberto Vecchioni.
Professore intellettuale (o almeno così considerato da molti) che, invitato
qualche giorno fa all'università di Palermo a parlare di rapporti
figli-genitori, ha brillantemente deciso di lasciarsi andare ad alcuni
spiacevoli commenti sulla terra in cui si trovava in visita: la Sicilia. Ecco,
il professore intellettuale pare abbia sentito il dovere morale di “provocare”
sostenendo la tesi secondo cui la Sicilia “è un'isola di merda” andando poi a
chiarire meglio il senso della provocazione: “una forzatura per smuovere le
coscienze di siciliani che si accontentano di vivere tra assenza di caschi,
macchine mal posteggiate, abusivismo edilizio etc.” Insomma, la Sicilia è
secondo il professore “una merda” perché “incivile”. Pare anche che Vecchioni si
sia lasciato andare ad un paragone non proprio di buon gusto tra una Palermo che
“col cazzo che avrebbe potuto...” ed una Milano che invece ha ospitato l'Expo e
i suoi 25 milioni di visitatori: e i soldi, secondo il professore, non
c'entrerebbero proprio nulla. Questione di inciviltà!!! La polemica è così
scatenata, il dibattito aperto. La rabbia si diffonde, ovviamente, tra la
maggioranza dei siciliani; ma non fra tutti. Un altro professore, per esempio,
seguito da una folta schiera di istruiti pensatori (spesso “di sinistra”),
Leoluca Orlando sindaco di Palermo, si schiera a difesa dell'intellettuale
milanese arrivando a sostenere che le parole di Vecchioni sarebbero “un atto di
amore verso la Sicilia” perché coraggiose e realistiche. Altri, nello stesso
fronte, si limitano ad apprezzare la denuncia della questione sollevata in quel
discusso intervento: l'inciviltà! Ecco un primo grosso (grossissimo) problema di
cui, forse, i meridionali dovrebbero assolutamente liberarsi: l'accusa di
inciviltà. Che poi è quella (anche se cambiano i toni) che ci sentiamo e
portiamo dietro dai tempi dell'unità italiana. Cerchiamo di valutare allora,
usufruendo dello stesso vocabolario di una certa retorica dominante, cosa sia
civile e cosa no. Se a Vecchioni le macchine in doppia fila e i motociclisti
senza casco appaiono come grande segno d’inciviltà, un tantino più incivili ci
sembrano la devastazione ambientale e umana nei nostri territori tramite
petrolchimici o basi militari; d'inciviltà ci parlano le statistiche su
disoccupazione giovanile e conseguente emigrazione a cui sono costretti i
siciliani, o quello che è uno dei tassi percentuale di morti sul lavoro più alti
d’Europa; oppure che i cittadini di Messina, Gela, Agrigento, etc, rimangano
senza acqua corrente per settimane. Ospedali che chiudono, cavalcavia
autostradali che crollano, collegamenti marittimi con le isole minori interrotti
per settimane, decine di migliaia di precari della pubblica amministrazione
continuamente a rischio reddito, insomma, “d’inciviltà” su cui il nostro
intellettuale dell’ultim’ora poteva concentrarsi ce n’è parecchia in Sicilia; e
ricondurre un sistema di estremo sfruttamento delle risorse umane e territoriali
(che ci racconta in due parole quella che è la storia dell’imposizione italiana
al meridione), a una semplice “questione culturale”, non fa di certo onore alla
sua nomea d’intellettuale(?). Quello che invece in maniera tutt’altro che
provocatoria, vogliamo e ci sentiamo di rintracciare anche nella
citata inciviltà vecchioniana, è un atteggiamento contro le regole e le
regolamentazioni che inconsciamente però, esprime un grado di rifiuto: ieri alla
costrizione a un determinato sistema economico e a certi modelli di vita e di
condotta sociale, oggi all’assenza totale di servizi, tutele, garanzie sociali,
e di una precarietà che si fa esistenziale, e di cui la nostra regione detiene
sicuramente il primato in Italia. Quindi ci chiediamo ancora: come si misura il
grado di civiltà di un popolo? Dal numero di caschi? O dal numero di gente che,
pur e soprattutto nei suoi tessuti più indigenti, conosce cooperazione e
solidarietà molto più che in tanti luoghi civili!? Dalle auto in doppia fila o
dal numero di persone che, senza casa, muoiono per le strade notturne di grandi
città del nord!? Cosa c'è poi di civile nell'avere come presidente della Regione
un razzista come Maroni!? O cosa ci sarà mai di civile in quel grande partito
del nord come la Lega, che fa di razzismo e xenofobia i suoi manifesti
politici!? A Vecchioni la parola (per la verità non ci interessa molto la sua
risposta…). A questo punto non possono che tornarci alla mente le recenti
polemiche televisive su altri due interventi molto discussi: quello di Massimo
Giletti sull' “indecenza” di Napoli; e sempre a proposito di Napoli, il
recentissimo dibattito scaturito dall'appellativo scelto da Enrico Mentana
(direttore del TgLa7) per richiamare in una trasmissione calcistica un collega
giornalista napoletano: “Pulcinella”. A occhi attenti,
l'antimeridionalismo paternalistico ha ormai pieno titolo su media e main
stream, soprattutto se sei considerato un intellettuale. Da quando poi Renzi
quest’estate ha nuovamente riportato in auge la “questione meridionale” (con la
solita narrazione del sottosviluppo per silenziare l’incapacità governativa di
porre rimedio alle problematiche sociali ed economiche dell’Isola), sembra che
chiunque (evidentemente confondendo “lo spettacolo” e l’opinionismo da tv con le
analisi e le valutazioni storiche e politiche) possa permettersi di dire
qualsiasi cretinata, basta che poi le facciano seguire un qualsiasi complimento
sulla storia e le grandi tradizioni di un popolo per pulirsi la faccia. Come del
resto Vecchioni ha già fatto con una lettera al Corriere della Sera, in cui il
professore però - oltre al pulirsi la faccia - si lascia nuovamente andare in
stereotipi stigmatizzanti e assai pregiudizievoli sulla “pigrizia dei
meridionali” e anche che quanti non lo hanno capito sono “pusillanimi e
mafiosi”. Finalmente! Ci chiedevamo come la parola mafiosi non fosse stata
pronunziata dal professore nel grande logos intellettuale dei luoghi comuni. Le
decine e decine di studenti e non solo che hanno abbandonato l'aula durante il
suo intervento... saranno mafiosi?! Cretinate e cretini a parte, quello a cui
assistiamo è il diffondersi di nuove (perchè mai abbandonate e tralasciate nelle
retoriche del sottosviluppo, o della mancata modernità del sud, etc) forme di
razzismo antimeridionale. Razzismo antimeridionale che tanto fa comodo
alle governance, locali e nazionali, perché utili a distrarre l’opinione
pubblica da quello che è il vero trattamento riservato al sud: un
neocolonialismo petrolifero e di estrazione e sfruttamento di risorse e materie
prime da far invidia a quello dell’epoca dell’unità d’Italia, a fronte di una
continua scarsità di accesso a reddito, servizi e diritti sempre più negatici e
sottrattici con commissariamenti e istituzionalizzazione dello stato
d’emergenza. Come dire, i siciliani sapranno pure quali sono i problemi della
loro quotidianità e della loro terra, in alternativa…possono chiedere a
Vecchioni. Sicuramente molti siciliani si sentono offesi dalle parole del caro
professore, ma non scriviamo queste righe per unirci al coro dell'indignazione:
speriamo soltanto di proporre l'individuazione di vecchie/nuove forme di
razzismo che finiscono per diventare anche forme di controllo delle condotte,
libertà di manovra capitalistica sui territori, commissariamenti politici e
repressione di classe. Perché i problemi veri non sono i “senzacasco” ma i
senzacasa; e non il modo di parcheggiare ma l'assenza di servizi sociali e come
detto, di accesso al reddito. E persino dell'acqua corrente!!!! e questo, a
nostro modo di vedere, è la vera inciviltà. A cui i siciliani dovrebbero
ribellarsi senza bisogno di professori che diano lezioni di dignità: non ne
abbiamo bisogno. Infoaut Palermo
Sei parente
di un mafioso? Sei un mafioso pure tu... Così chiudono le aziende,
scrive il 27 ottobre 2016 “Il Dubbio”. L'intervento di Carlo Giovanardi,
componente della Commissione Giustizia del Senato. Il codice antimafia
stabilisce che tentativi di infiltrazione mafiosa, che danno luogo all'adozione
dell'informazione antimafia interdittiva, possono essere concretamente desunti
da:
a)
Provvedimenti giudiziari che dispongono misure cautelari, rinvii a giudizio,
condanne, ecc.;
b) Proposta o
provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione ai sensi della legge
575 del 1967;
c) Degli
accertamenti disposti dal Prefetto.
Con alcune
piccole recenti modifiche che cambiano soltanto marginalmente la normativa. Il
punto c) come si vede dà ampi poteri discrezionali ai prefetti che in tutti i
provvedimenti assunti sul territorio nazionale motivano sempre l'interdittiva
con queste premesse: «Atteso che, come più volte riportato dalla dottrina e
dalla giurisprudenza, il concetto di "tentativo di infiltrazione mafiosa", in
quanto di matrice sociologica e non giuridica, si presenta estremamente sfumato
e differenziato rispetto all'accertamento operato dal giudice penale, "signore
del fatto" e che la norma non richiede che ci si trovi al cospetto di una
impresa "criminale", né si richiede la prova dell'intervenuta "occupazione"
mafiosa, né si presuppone l'accertamento di responsabilità penali in capo ai
titolari dell'impresa sospettata, essendo sufficiente che dalle informazioni
acquisite tramite gli organi di polizia si desuma un quadro indiziario che,
complessivamente inteso, ma comunque plausibile, sia sintomatico del pericolo di
un qualsivoglia collegamento tra l'impresa e la criminalità organizzata.
Considerato che, per costante giurisprudenza, la cautela antimafia non mira
all'accertamento di responsabilità, ma si colloca come la forma di massima
anticipazione dell'azione di prevenzione, inerente alla funzione di polizia di
sicurezza, rispetto a cui assumono rilievo, per legge, fatti e vicende anche
solo sintomatici e indiziari, al di là dell'individuazione di responsabilità
penali (T. A. R. Campania, Napoli, I, 12 giugno 2002 nr. 3403; Consiglio di
Stato, VI, 11 settembre 2001, nr. 4724), e che, di conseguenza, le informative
in materia di lotta antimafia possono essere fondate su fatti e vicende aventi
un valore sintomatico e indiziario, poiché mirano alla prevenzione di
infiltrazioni mafiose e criminali nel tessuto economico-imprenditoriale, anche a
prescindere dal concreto accertamento in sede penale di reati». Vediamo ora di
capire come la preoccupazione del legislatore di difendere le aziende dalle
infiltrazioni mafiose sia stata completamente stravolta dalle interpretazioni
giurisprudenziali e dalla prassi delle prefetture, andando ben al di là del
rispetto formale e sostanziale dei principi costituzionali e anche del buon
senso, con un meccanismo infernale che massacra le aziende, le fa fallire e
distrugge migliaia di posti di lavoro. Bisogna tener conto infatti che
all'impresa colpita da interdittiva antimafia vengono immediatamente risolti i
contratti in essere, bloccati i pagamenti, impedito di acquisire nuovi lavori,
ecc. a tempo indeterminato, fino a che cioè, non venga meno un plausibile,
sintomatico pericolo di un qualsivoglia collegamento tra l'impresa e la
criminalità organizzata. E da cosa si può dedurre questo pericolo che le forze
di polizia comunicano al Prefetto? Incredibilmente anche da semplici rapporti di
amicizia o di parentela o di affinità con i titolari o i dipendenti della
impresa ma anche con persone che con le imprese non c'entrano assolutamente
nulla. Due recenti casi modenesi spiegano la follia di questa procedure.
Un'impresa locale con titolare originario di Napoli, felicemente sposato con una
palermitana conosciuta mentre era militare in Sicilia nell'ambito
dell'operazione Vespri Siciliani, dalla quale ha avuto tre figli, assunse a suo
tempo, con l'autorizzazione del giudice tutelare e l'approvazione dei servizi
sociali, cognato e suocero usciti dal carcere a Palermo dopo aver scontato una
condanna per attività mafiosa. Sulla base di questa circostanza all'impresa è
stata negata l'iscrizione alla white list ed è scattata l'interdittiva
antimafia. L'imprenditore ha immediatamente licenziato cognato e suocero ma per
la Prefettura questo non era sufficiente e l'ha invitato a rivolgersi al Tar
dell'Emilia-Romagna che a sorpresa ha confermato l'interdittiva con la
stupefacente motivazione che malgrado il licenziamento permaneva il rapporto di
parentela (semmai affinità, sic. ndr). Soltanto recentemente, dopo questa
surreale decisione, il Consiglio di Stato ha finalmente riconosciuto le buone
ragioni dell'imprenditore escludendo che il semplice rapporto di affinità possa
essere sufficiente per mantenere una interdittiva. Nel frattempo sempre a Modena
un altro imprenditore di origine campana si è visto applicare l'interdittiva, in
base a precedenti penali del fratello, con il quale non ha rapporti di nessun
tipo da tantissimi anni, con inevitabile fallimento e rovina per moglie e figli,
decisione confermata dal Tar dell'Emilia-Romagna perché "non si esclude", pur
non essendoci attualità di una situazione di pericolo, che il passato oscuro del
fratello, comparso in una lista di componenti di un clan di casalesi, arrestati
per ordine della Procura, possa nascondere futuri tentativi di infiltrazione.
Bisogna aggiungere, per chiarezza espositiva, che diversamente dai procedimenti
penali dove c'è possibilità di difesa e contraddittorio, l'imprenditore a cui
viene rifiutata l'iscrizione alla white list non viene ascoltato dalla
Prefettura e neppure può prendere visione egli atti che lo riguardano, che sono
secretati. Di fronte a questa situazione, essendo in discussione in commissione
Giustizia del Senato la riforma del Codice Antimafia, sono stati sentiti in
audizione il prefetto Bruno Frattasi, attuale comandante dei Vigili del Fuoco,
per anni responsabile dell'Ufficio legislativo del Ministero degli Interni, i
Prefetti di Milano, Palermo, Napoli, Reggio Calabria, Modena, ecc., illustri
avvocati, docenti di diritto amministrativo e rappresentanti delle associazioni
imprenditoriali. Ad eccezione dei Prefetti sul territorio, che hanno sostenuto
di vivere nel migliore dei mondi possibile e non si sono accorti di nessuna
criticità, da Frattasi, i professori, gli avvocati e le associazioni degli
imprenditori sono state sottolineate le incongruenze e i limiti di questo
sistema ed indicate soluzioni come l'obbligo di sentire l'imprenditore, fare
verificare i provvedimenti interdittivi da un giudice terzo, accompagnare
l'azienda colpita da interdittiva a superare lo stato di pericolo prima che
possa giungere il fallimento. Con una consapevolezza che è emersa chiaramente:
la criminalità organizzata non viene minimamente scalfita da questi
provvedimenti che viceversa per la loro assoluta arbitrarietà e disprezzo per
l'economia reale non possono che creare disaffezione e rancore verso le
istituzioni.
Se non sai che il parente del tuo amico è mafioso sei mafioso
anche tu…, scrive Tiziana Maiolo il 21 gennaio 2017 su
"Il Dubbio". Il politico patrocinò la festa paesana dello stacco organizzata da
un parente di un presunto ndranghetista. Colpevole di “inconsapevolezza”,
l’assessore va rimosso. Ci mancava solo Rosy Bindi nel caravanserraglio di
quanti hanno preso di mira il Comune milanese di Corsico e il famoso (mancato)
“Festival dello stocco di Mammola”, per saldare vecchi e nuovi conti politici.
La Commissione bicamerale Antimafia è arrivata a Milano giovedì con un programma
ambizioso: audizioni dei massimi vertici della magistratura (il procuratore
generale Alfonso, il procuratore capo Greco e la responsabile della Dda
Boccassini) e discussione sulla presenza di spezzoni di ‘ ndrangheta al nord, e
in particolare nelle inchieste su Expo e il riciclaggio. Ma tutto è rimasto
sbiadito in un cono d’ombra illuminato prepotentemente dal caso del merluzzo, il
famoso stocco di Mammola, che viene festeggiato ogni anno da 38 anni in Calabria
con il patrocinio dell’ambasciata di Norvegia, ma che non si può evidentemente
esportare nel milanese. La Presidente Rosy Bindi è stata perentoria: l’assessore
alle politiche giovanili Maurizio Mannino, che nell’ottobre dell’anno scorso
aveva dato il patrocinio alla Festa dello stocco a Corsico senza rendersi conto
del fatto che il promotore dell’evento era il genero di una persona indagata per
appartenenza alla ‘ ndrangheta, deve essere subito rimosso. Altrimenti
verrebbero avviate, per iniziativa di una serie di zelanti parlamentari del Pd,
le procedure per arrivare al commissariamento del Comune di Corsico. Certo, dice
la stessa Presidente dell’Antimafia, il sindaco era inconsapevole, ma
“l’inconsapevolezza per essere innocente deve essere dimostrata”. Inversione
dell’onere della prova, al di là e al di fuori da qualunque iniziativa
giudiziaria, dunque. Il concetto è questo, in definitiva: se anche tu non sai
con chi hai a che fare (cioè uno colpevole di essere parente di un altro), sei a
tua volta colpevole a prescindere. E la cosa grave è che su questa vicenda di
Corsico si soni mossi parlamentari del Pd (la famosa nuova generazione dei
“garantisti”) come Claudio Fava e Franco Mirabelli e persino il mediatico
promotore di libri nonché procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri. Tutti
compatti contro il sindaco Filippo Errante, colpevole di “tradimento”, perché da
ex sindacalista e assessore di una giunta di sinistra, ha osato non solo
allearsi con il centrodestra, ma addirittura portarlo alla vittoria dopo
sessanta anni di governo ininterrotto di sinistra. Un capovolgimento politico
che brucia ancora, dopo oltre un anno. Il che è comprensibile, soprattutto per
la candidata sconfitta, l’ex sindaco Maria Ferrucci. La quale un risultato a
casa l’ha portato, quello di riuscire a fare annullare la festa dello stocco e
di conseguenza di indebolire la figura del neo- sindaco. Il quale sarà costretto
oggi anche a rinunciare a un suo assessore di punta. Indebolendosi sempre più.
Ma c’è da domandarsi se sia di grande soddisfazione politica per l’ex sindaco e
per il suo partito essere costretti a denunciare per simpatia con le mafie una
persona come il sindaco Errante che un tempo militava nelle loro fila. E cercare
di sconfiggere per via burocratica e tramite i prefetti e le commissioni
antimafia (neanche per via giudiziaria, non essendoci inchiesta alcuna
all’orizzonte) chi ha vinto le elezioni. Democraticamente e non con un colpo di
stato.
Storia di
Pino Maniaci su Cnn: «Ha perseguitato la mafia, ora è lui il bersaglio»,
scrive il 26/12/2016 “La Sicilia”. La celebre rete televisiva americana dedica
al direttore di Telejato, recentemente indagato per estorsione, un ampio
servizio sulle sue pagine on line. "Pino Maniaci è stato uno dei pochi ad avere
avuto il coraggio di denunciare la mafia in Sicilia". La Cnn dedica al direttore
di Telejato un lungo servizio pubblicato sulle sue pagine on line, un servizio
dove ricostruisce la vicenda di Maniaci finito sotto inchiesta a sua volta per
estorsione ai danni di un amministratore locale. "He goes after the mob; now
he’s the target", ha perseguitato la mafia, ora è lui il bersaglio, scrive il
reporter Joel Labi, in una lunga inchiesta nella quale compare anche una
intervista video intitolata "The Mafia Hunter", "Il Cacciatore di mafiosi". "Il
reporter Pino Maniaci - scrive la Cnn - è stato una delle poche persone a
denunciare pubblicamente la mafia in Sicilia". Maniaci, sottolinea l’influente
emittente televisiva statunitense, "ha usato la sua piccola televisione fatta in
casa per combattere il crimine organizzato" da allora "è diventato bersaglio a
sua volta".
Parola anche
ad Antonio Ingroia, legale di Maniaci: "non ho mai visto niente di simile nei
miei vent'anni come magistrato e avvocato", afferma l’ex pm. "Si sta utilizzando
un video (quello delle intercettazioni ambientali, ndr) per distruggere un uomo
di televisione...". Non è la prima volta che la storia di Maniaci finisce sulla
stampa internazionale. In passato anche The Guardian e l’Economist hanno
dedicato spazio al direttore di Telejato.
Caso
Maniaci, Ingroia: “Ci voleva la CNN per ricordare un processo surreale”,
scrive "Telejato" il 26 dicembre 2016. “C’è voluta la CNN per ricordare che in
Italia sta per cominciare un processo surreale come quello a carico di un
giornalista coraggioso come Pino Maniaci. Pur avendo milioni di notizie da dare,
la più grande tv del mondo ha deciso di raccontare con un lungo articolo sulla
homepage del suo sito internet la storia di un’indagine basata sul nulla,
costruita dalla Procura di Palermo su accuse infondate o su fatti per i quali
Maniaci ha fornito ampia e puntuale spiegazione”. Così l’avvocato Antonio
Ingroia, difensore con l’avvocato Bartolomeo Parrino di Pino Maniaci. “Dovrebbe
far riflettere – aggiunge – com’è stato trattato il caso in Italia, dove la gran
parte della stampa ha già processato e condannato mediaticamente Maniaci, con
superficialità e approssimazione, dando per certa la tesi della Procura. Una
dimostrazione di sconcertante conformismo, un conformismo confermato anche dalla
reazione di alcuni organi di stampa nazionali, subito pronti a criticare la CNN
con l’accusa di aver dimenticato di dare la notizia dell’uccisione dei cani di
Maniaci e della reazione che Maniaci ebbe. Una circostanza non rilevante ai fini
del processo e di cui comunque Maniaci ha ampiamente dato spiegazione nelle sedi
opportune. Ma tant’è – conclude Ingroia – c’è chi ha già emesso la sua sentenza
e non vuole sentirsi dire che forse si è sbagliato”.
Lettera
aperta di Pino Maniaci ai colleghi giornalisti,
scrive il 28 settembre 2016 "Telejato". «Cari colleghi, sin dal primo giorno in
cui vi è stata data la notizia, il video e le intercettazioni delle vicende in
cui la Procura di Palermo ha deciso di “impallinarmi”, assieme a nove mafiosi di
Borgetto che con me non c’entravano niente, a nessuno di voi è venuto il minimo
dubbio che ci fosse qualcosa che non quadrava. Conosco il vostro rapporto con i
magistrati: sono loro che vi passano le notizie e il materiale per integrarle,
quindi nessuno di voi oserebbe mettere in discussione l’operato di chi, alla
tirata delle somme, offre gli elementi per mandare avanti il proprio lavoro, di
chi vi fa campare. Tutti avete emesso, in partenza la sentenza di condanna, sia
perché quello che dice la Procura non si discute, sia perché rispetto a voi io
non sono un giornalista, non merito questa etichetta e, addirittura, diffamo la
vostra categoria. Ad alcuni non è parso vero di potere dilatare la macchina del
fango messa in moto nei miei confronti. Altri hanno sottilmente distinto
l’aspetto penale, per la verità molto fragile, da quello “morale” o etico,
arrivando alla conclusione che se i risvolti penali di ciò di cui ero accusato
erano irrilevanti, dal punto di vista morale io ero condannato e condannabile
perché le intercettazioni che abilmente erano state confezionate e vi erano
state date in pasto, mettevano in evidenza una persona senza scrupoli e senza
rispetto per i valori minimi della convivenza e della morale comune: come potevo
io fare la predica agli altri, quando non avevo rispetto per le istituzioni, per
la magistratura e la legalità da essa rappresentata, per i politici, per il
Presidente della Repubblica e persino per la mia famiglia? Anche adesso che,
dopo essere stato finalmente ascoltato, alcune cose sono state chiarite, molti
di voi sono rimasti fermi alla prima devastante impressione che vi è stata
offerta e che escludeva addirittura qualsiasi personale rivalsa da parte di quei
settori del tribunale di cui avevo messo in luce la vergognosa gestione. Sono
stati ignorati, da parte vostra, che pur li conoscevate bene, anni d’impegno, di
denunce, di servizi a rischio, di documentazione di attività sociali, culturali,
religiose. È stato ignorato il ruolo di una redazione in costante rinnovo,
ignorata la presenza di scolaresche, associazioni, volontariato, sincera
collaborazione, il tutto senza un minimo di risvolto o di vantaggio economico.
Cosa aggiungere? Che nessuno di voi, diversamente da quanto posso io fare, ha la
piena libertà di scrivere ed esprimere i propri giudizi, dal momento che questi
si uniformano a quelli di chi vi paga o vi dà le informazioni? La libertà di
stampa non è acqua fresca e lo si nota giornalmente dal modo in cui vengono
confezionati giornali e telegiornali e dalla scarsa capacità di chi vede e
ascolta, di maturare un proprio giudizio e di notare subito dove sta il trucco o
lo stravolgimento della notizia. Che aggiungere? Il regime non è finito, anzi
sta cercando di rafforzarsi sia con lo stravolgimento dei principi
costituzionali su cui andremo a votare, sia con le minacce di coloro che da
sempre hanno agito indisturbati, sia con gli avvertimenti mafiosi, sia con il
reato di diffamazione a mezzo stampa, che non si ha nessuna voglia di cambiare
per agevolare il nostro lavoro. La titolare della Distilleria Bertolino una
volta lo disse con chiarezza: “Una volta c’era la pistola, adesso basta la
denuncia”. Oppure un buon servizio giornalistico. Una volta che la pietra è
stata buttata ritirarla diventa difficile, anzi impossibile.»
Xylella, Trentino contro la Puglia: «Causa vostra, giù export
di mele», scrive Marco Mangano il 20 novembre 2016 su
“La Gazzetta del Mezzogiorno”. La Xylella Fastidiosa spacca l’Italia
ortofrutticola. Il batterio killer degli ulivi, oltre ad assestare colpi
violenti al paesaggio, al territorio, all’immagine della Puglia, arreca «danni
collaterali» (mutuando il titolo del famoso film interpretato da Arnold
Schwarzenegger) anche alla parte dell’economia agricola del tutto estranea alla
batteriosi. La Giordania esige dagli esportatori certificati in cui si assicuri
l’assenza della patologia. Ciò, oltre ad avvenire per l’uva pugliese, si
verifica per le mele trentine. Ed è qui che casca l’asino: i produttori della
Val di Non puntano l’indice contro la Puglia: sostengono che se non fosse stato
per loro non avrebbero subito alcun calo nell’export verso la Giordania. Un
danno riflesso alla zona delle mele d’eccellenza. «Stiamo incontrando problemi
di ordine burocratico poiché la Giordania chiede ai produttori pugliesi di
dichiarare sul certificato fitosanitario che i prodotti sono esenti da Xylella»,
afferma Giacomo Suglia, presidente pugliese dell’Apeo (associazione produttori
ed esportatori ortofrutticoli) nonché vicepresidente nazionale di FruitImprese.
«Ritengo - osserva - che il ministero delle Politiche agricole debba intervenire
per fare chiarezza: intendo dire che sarebbe opportuna una campagna attraverso
cui i Paesi importatori potessero essere rassicurati circa l’impossibilità che
prodotti come l’uva, le mele e molti altri possano essere colpiti dal batterio.
I frutti sono estranei alla patologia e, pertanto, non possono arrecare alcun
danno alla salute, né trasferire la patologia». Insomma, la Xylella diventa una
questione di politica agricola, per nulla trascurabile. La Puglia deve
difendersi non soltanto dagli attacchi della sputacchina, l’insetto vettore che
spadroneggia fra gli uliveti, assicurando notti insonni agli olivicoltori del
Barese (dove si produce l’altissima qualità), ma anche dalle accuse del
Nord. Diamo un’occhiata all’avanzata del batterio: dopo essere sbarcato a Ostuni
e a Martina Franca (come anticipato in entrambi i casi dalla Gazzetta), la
situazione pare incontrollabile. E non soltanto sul piano dell’espansione
batterica. I nervi vengono messi a dura prova: abbiamo già riferito del
conflitto fra Cia e Anas. Lo scorso 20 ottobre, in seguito all’individuazione di
un focolaio a Ostuni, in una stazione di servizio all’altezza dei villaggi
turistici «Monticelli» e «Rosa Marina», la Regione firmava un’ordinanza di
sradicamento non solo dell’ulivo colpito dalla batteriosi, ma anche delle piante
ospiti. Venivano, però, abbattuti l’albero ammalato e le piante che si trovavano
nel raggio di cento metri dall’ulivo, ma non quelle (oleandri) che - nello
stesso raggio di 100 metri - ricadevano e ricadono in aree di pertinenza
dell’Anas. La confederazione sostiene che queste piante siano pericolose e che
non abbia senso limitare lo sradicamento solo ad alcuni alberi. La Cia scrive
all’Anas, sollecitandola a procedere nel più breve tempo possibile allo
sradicamento.
La leggenda assurda della mafia che incendia i boschi e i
monti, scrive Alberto Cisterna il 27 Agosto 2017 su
"Il Dubbio". Sia chiaro uno può anche sbagliare. Ma ad occhio e croce saranno
vent’anni che circola la storia che ad incendiare i boschi ed a devastare le
colline della Calabria, della Sicilia o della Campania siano ndrangheta, mafia e
camorra. La leggenda assurda della mafia che incendia i boschi e i monti.
Tuttavia, a memoria, non ci si ricorda di uomini delle cosche che siano stati
arrestati e men che meno condannati per barbarie del genere. Non è un’esclusiva
della Calabria dove la tesi circola da maggiore tempo. In Sicilia e in Campania
si sentono le stesse cose da altrettanti anni. Tra squinternati, giovinastri,
villeggianti incauti, pastori in cerca di pascoli, vigili del fuoco esaltati, il
panorama (il bestiario) degli incendiari è composito e multiforme, ma di mafiosi
non si vede neanche l’ombra. La qualcosa, alla lunga, non può restare priva di
ricadute. O gli inquirenti sono degli inetti che non riescono a venire a capo
della questione oppure, in genere, le mafie non c’entrano nulla. E poiché
occorre scartare la prima ipotesi, tenuto conto del livello delle forze
antimafia nel paese, la seconda prospettiva comincia a prendere piede in modo
sostanziale. Non è una questione da poco. Un conto è teorizzare una strategia
mafiosa volta a depredare e deturpare il territorio, altro è dare la caccia ai
portatori di microinteressi e microbisogni, quando non a dei veri e propri
teppisti e mascalzoni. Si tratta di adottare strategie del tutto diverse,
ricorrere a strumenti investigativi completamente nuovi. Ad esempio qualche
drone gioverebbe più di cento intercettazioni. Nel frattempo, invece, è tutto un
teorizzare, ipotizzare, allarmare in vista di tenebrose trame mafiose che, alla
fine, è il caso di dire, risultano fumose e prive di riscontri. D’altronde
bruciano la California, la Spagna, la Francia, la Grecia, il Portogallo, ed in
modo anche più devastante che in Italia, e nessuno si azzarda a lanciare l’idea
che le mafie italiane, espandendosi per il mondo, si siano messe a dar fuoco
alle foreste di mezzo globo come se fossero in Aspromonte. E’ all’incirca una
sciocchezza e, come tutte, le superstizioni ha una matrice tutta italica. Il
sillogismo è semplice: la mafia controlla il territorio in modo capillare, il
territorio brucia, la mafia incendia il territorio. Naturalmente, come tutte le
aberrazioni logiche, anche questa parte da un postulato opinabile, anzi da due.
Non è più vero, e per fortuna da un paio di decenni, che le mafie controllino il
territorio in modo così asfissiante e meticoloso, come in passato. Hanno
strategie ed obiettivi diversi e il controllo è costoso e poco redditizio ormai.
In secondo luogo il fatto che i boschi brucino non realizza alcun evidente
interesse delle mafie che, difatti, nessuno indica con un minimo di precisione.
Piuttosto, per molti decenni, i più importanti esponenti della ndrangheta
amavano essere additati come i «re della montagna». Si facevano chiamare così i
più pericolosi ras della ndrangheta reggina, tutti direttamente impegnati
nell’industria boschiva che ha costituito, almeno nella Calabria aspromontana,
la prima forma di imprenditoria mafiosa. Dalla montagna e dal suo controllo la
ndrangheta ha ricavato vantaggi enormi, si pensi soltanto alla stagione dei
sequestri di persona e alle fasi iniziali dello stoccaggio della cocaina. In
montagna, in fosse scavate nel terreno, la ndrangheta ci nascondeva persino il
denaro. E poi è vero o no che i picciotti hanno invocato per decenni la
protezione della Madonna della Montagna a Polsi? Basterebbe rileggere con
attenzione il capolavoro di Gioacchino Criaco, Anime nere, per rendersi conto di
quale rapporto ancestrale, interiore, anzi intimo leghi la gente di ‘ndrangheta
(come tanti calabresi perbene) alla montagna e sbarazzarsi, così, di una certa
allure che nasconde, da qualche tempo, le proprie inefficienze dietro lo spettro
di una mafia purtroppo, a suo dire, imbattibile. Sia chiaro, non si sono mai
viste neppure coppole iscritte al WWF o versare contributi ad Italia Nostra, ma
qui parliamo di interessi, di denaro, di progetti di egemonia che dovrebbero
indurre i boss ad appiccare incendi qui e là in giro per il Mezzogiorno
d’Italia. Tra parecchie dozzine di pentiti e decine di migliaia di
intercettazioni, che nulla raccontano in proposito, gli unici a farsi beccare al
telefono a parlare di fuoco e fiamme sono stati i vigili volontari di Ragusa per
intascare dieci euro l’ora. Siccome la storia prosegue, come detto, da troppo
tempo è forse giunta l’ora di chiedere le prove a chi sostiene cose del genere.
La pubblica opinione è ormai alluvionata dai “ragionamenti” degli inquirenti,
avrebbe diritto anche alla dimostrazione di ciò che si sostiene. Se davvero ci
fossero le cosche dietro la distruzione piromane sarebbe un fatto gravissimo, un
vero e proprio attentato alla Repubblica. Un atto di guerra e, come ricordava
Georges Benjamin Clemenceau, «La guerra è una cosa troppo seria per lasciarla in
mano ai militari», figuriamoci ad altri.
·
Quei razzisti come
i Cubani.
Cuba: l'agonia più lunga. Paolo
Manzo su Panorama il 14 Novembre 2020. Con l'uscita di scena di Raúl Castro,
sull'«isola della rivoluzione» si sta compiendo un passaggio cruciale al
vertice. Ancora una volta è trascurata la popolazione, sempre più povera. Che
adesso però comincia a protestare. Raúl Castro, l'ultimo simbolo della
rivoluzione castrista, sta morendo, cancro in fase terminale. Notizie raccolte
da Panorama confermano ciò che da tempo si mormora all'Avana: ovvero che il
primo segretario del Partito comunista cubano, il vero capo che detta la linea
all'Avana tramite suo figlio Alejandro, è ricoverato da settimane in una
casa-ospedale per cure segrete, e al capezzale, sempre più sovente, c'è la glia
Mariela. La notizia naturalmente non è confermata dal regime di Cuba, ma gira
con sempre più insistenza tra chi segue con attenzione tanto il Venezuela quanto
Cuba, due Paesi che in realtà sono una sola cosa, soprattutto se si tratta di
gestire «notizie riservate» e «propaganda». «Le mie fonti cubane mi hanno
segnalato che c'è uno strettissimo riserbo sullo stato di salute di Raúl Castro,
che sarebbe molto grave a causa di un cancro in stadio avanzato» scriveva su
Twitter il 13 ottobre scorso Nelson Bocaranda, autorevole giornalista
venezuelano che già una decina di anni fa fu il primo a svelare al mondo un
analogo tumore che di lì a poco si sarebbe portato via l'allora presidente del
Venezuela Hugo Chávez, ricoverato in gran segreto proprio all'Avana. All'epoca
il suo fu uno scoop che fece il giro del mondo e Bocaranda ci scrisse il libro
Il potere dei segreti. Certo, ufficialmente il capo di Cuba è il presidente
Miguel DíazCanel, l'uomo che nel 2018 aveva firmato uno storico accordo con
Google simile a quello siglato con la Cina anni fa dal moloch del web, che
cancella i canali YouTube sgraditi a Pechino; ma di fronte all'agonia di Raúl, i
gruppi di potere della quinta dittatura più longeva del mondo da oltre un mese
stanno facendo di tutto per mantenere la «barra dritta» e salvare il potere
assoluto conquistato nel 1959. Solo Paesi come Arabia Saudita (1932), Corea del
Nord (1948), Cina (1949) e Vietnam (1954) governano con un partito unico i loro
abitanti/sudditi da più tempo del castrismo, che continua a detenere il potere
reale all'Avana. Fino a ieri con Raúl Castro, anche se Fidel è morto quattro
anni fa, proprio a novembre, in coincidenza con le elezioni statunitensi che nel
2016 portarono Donald Trump alla Casa Bianca. Ora (casualmente sempre in
coincidenza con le presidenziali Usa) il potere sull'isola dei Caraibi lo ha in
pugno la cosiddetta «triade» che copre con coriacea ostinazione le notizie sullo
stato di salute dell'89enne fratello minore di Fidel. A mantenere il segreto di
Stato più ferreo sull'agonia di Raúl è il vice ammiraglio Julio César Gandarilla
Bermejo, il primo esponente della triade, membro di quella potente leadership
militare che comanda davvero Cuba, e da ben prima del 2017, quando fu nominato
ministro degli Interni. È Gandarilla a dirigere il controspionaggio che in
questi giorni veglia su Raúl, supervisionato a sua volta dal figlio Alejandro
Castro Espín, il coordinatore dell'intelligence e del Paese. È lui il secondo
esponente della triade, la pedina più importante per organizzare le manovre dei
generali, decisive per il futuro della più antica dittatura delle Americhe, oggi
in difficoltà come non accadeva dal crollo dell'Unione Sovietica. Una crisi glia
della pandemia ma, soprattutto, delle politiche di Donald Trump che hanno
cancellato l'apertura voluta da Barack Obama nel 2015 con la mediazione di Papa
Francesco. Apertura definita dall'oppositore José Daniel Ferrer, «un disastro».
Due volte prigioniero politico della dittatura, l'ultima volta lo scorso aprile
(quando è stato incarcerato e torturato) Ferrer coordina l'Unione patriottica di
Cuba (Unpacu), il maggiore movimento sociale che si oppone alla dittatura con
migliaia di membri e decine di migliaia di simpatizzanti. Persone per la maggior
parte umili e di origini contadine ma stanche dei soprusi e che, sempre più
spesso, affrontano con coraggio i crimini dei servizi di intelligence guidati da
Alejandro Castro. «Per questo abbiamo lanciato la Rivoluzione dei Girasoli, che
sta raccogliendo sempre più appoggio da parte di una popolazione allo stremo
(95% di povertà tra la popolazione, stipendio medio 30 dollari al mese, ndr), e
stanca delle bugie del regime. Grazie a Trump la nostra lotta si è rafforzata -
Obama, invece, si era persino rifiutato di incontrarci - e il suo sostegno al
popolo cubano e la sua mano ferma contro la tirannia che ci opprime è stata
decisiva. Di questo l'ho ringraziato». Di certo c'è che le proteste pubbliche
sull'isola sono raddoppiate a ottobre, secondo il rapporto dell'Osservatorio
cubano sui conflitti (Occ). Un totale di 88 contestazioni, dovute alla fame e
alla bea della «dollarizzazione» praticata dalla dittatura con l'apertura di
decine di negozi di regime, dove non manca nulla ma si può pagare solo in valuta
statunitense. Un sogno per oltre il 90% dei cubani. In realtà, le agitazioni
sono molte di più di quelli denunciate dall'Occ. Come, per esempio, il caso
della famiglia di Fidel Batista Leyva, perseguitata solo per aver appoggiato la
Rivoluzione dei Girasoli con una foto online. «Hanno appiccato il fuoco alla
cucina, ci hanno distrutto porte e finestre. Con i nostri due bambini ci siamo
salvati fuggendo dal tetto mentre gli sgherri del regime, armati di machete e
sbarre di ferro, distruggevano ogni mobile e oggetto. Hanno spaccato tutto».
Tutto questo per una foto. «Personaggi del genere sono inltrati nei movimenti
antifascisti delle Americhe» denuncia Ferrer. E di infiltrazioni castriste
ovunque in America latina, e anche negli Stati Uniti, se ne intende la terza
gura importante della transizione che verrà dopo la morte di Raúl Castro, il
terzo membro della triade: il generale di brigata Luis Alberto Rodríguez
López-Calleja. Per anni marito della glia di Raul, Déborah, ma soprattutto lo
zar economico del castrismo degli ultimi 15 anni. Sanzionato lo scorso settembre
dagli Stati Uniti per «gravi violazioni dei diritti umani contro il popolo
cubano», LópezCalleja è il capo del consorzio cubano di proprietà militare Grupo
de administração empresarial SA (Gaesa), che gestisce di fatto tutta la
ricchezza economica del paese caraibico, a cominciare dai settori delle
comunicazioni, del turismo e del commercio. «Il reddito generato dalle attività
economiche di Gaesa è usato per opprimere il popolo cubano e finanziare il
dominio parassitario e coloniale di Cuba sul Venezuela», ha denunciato il
segretario di Stato americano Mike Pompeo, qualche settimana fa. E proprio
López-Calleja sarà decisivo nella transizione della Cuba che verrà, non
foss'altro perché fu lui ad accompagnare Miguel Díaz-Canel nel settembre 2018
nella sede di New York di Google, per incontrare le principali aziende di
tecnologia del globo, con in testa i «big boss» di Twitter e Facebook, su invito
diretto di Eric Schmidt, il presidente di Alphabet, la società che gestisce
Google. Come sempre, a seguire il percorso dei soldi si comprendono molte cose.
·
Quei razzisti come
gli Austriaci.
Paolo
Valentino per il “Corriere della Sera” il 7 dicembre 2020. All'inizio del
Millennio, quando in Austria il partito cristiano-democratico aprì le porte del
potere all'estrema destra radicale di Jörg Haider alleandosi con la sua Fpö,
Karl-Heinz Grasser fu il volto glamour e per bene di quella controversa
operazione politica, che costò a Vienna le prime sanzioni varate dall'Ue contro
un Paese membro. Ministro delle Finanze dal 2000 al 2007, elegante e belloccio,
sposato con Fiona Swarovski, ereditiera dell'omonimo impero dei brillanti, il
giovane Grasser dominava le copertine dei tabloid e il gossip nazionale. Sic
transit gloria mundi. Venerdì l'ex protégé di Haider, che ha da poco superato i
cinquanta, è stato condannato a otto anni di carcere, per il suo coinvolgimento
in uno dei più grandi scandali di corruzione della recente storia austriaca, il
cosiddetto Affare Buwog. La Corte penale di Vienna ha riconosciuto Grasser
colpevole di aver fornito informazioni riservate a un investitore privato, il
gruppo immobiliare Immofinanz AG, poco prima della vendita di 60 mila
appartamenti di proprietà della società pubblica Buwog. Secondo la motivazione
letta dal presidente del Tribunale, Grasser tramite due complici avrebbe
rivelato l'offerta massima dell'altro gruppo partecipante all'asta a Immofinanz,
che poi si aggiudicò le case offrendo 961 milioni di euro, cioè un milione in
più dei concorrenti. Anche i due compari sono stati condannati insieme all'ex
ministro. La tangente pagata da Immofinanz per l'informazione fu di 9,6 milioni
di euro, l'1% della somma di acquisto. Una parte di questo denaro finì poi su
tre conti segreti del Lichtenstein, su ognuno dei quali vennero accreditati 2,4
milioni di euro. L'accusa ha dimostrato che il beneficiario di uno dei conti era
proprio Karl-Heinz Grasser. A inchiodare l'ex ministro sono stati soprattutto i
500 mila euro in contanti che lui versò in una banca austriaca, spiegando di
aver avuto i soldi dalla suocera che viveva in Svizzera. Ma l'indagine
finanziaria ha rivelato che un'identica somma era uscita negli stessi giorni da
uno dei tre conti del Lichtenstein, legati all'affare Buwog. Grasser continua a
protestare la propria innocenza e ha annunciato di voler ricorrere in appello.
In tribunale ha dichiarato di vivere in affitto in una casa di campagna vicino
Kitzbühel, di non avere un lavoro e di non possedere né un'abitazione né
un'auto. Il processo è durato tre anni, ma ne sono passati più di dieci da
quando l'inchiesta aveva preso le mosse, innescata dalle procedure di fallimento
di Immunofinanz, che portarono alla luce tutti i vecchi loschi affari del
gruppo. Il caso getta nuova luce sui sei anni dei primi governi tra popolari e
nazionalisti, sotto la guida del cancelliere Wolfgang Schüssel, che costarono a
Vienna oltre sei mesi di isolamento totale nell'Unione Europea. Haider, l'uomo
nero che lodava le politiche del lavoro di Hitler e si circondava di uomini
giovani e attraenti, non faceva parte del governo. Ma aveva chiesto e ottenuto
per Grasser, simpatizzante ma non membro della Fpö, lo strategico ministero
delle Finanze. Nella narrazione dei media, KHG diventò subito il talento
politico che dava fascino alla coalizione, grazie anche al suo matrimonio con
l'ereditiera Swarovski. Ma, stando almeno alla prima sentenza, quello che si
voleva come il governo del «rinnovamento austriaco» in realtà proseguì un'antica
pratica, conosciuta a Vienna non come corruzione ma come «economia degli amici».
È la prima volta nella storia degli ultimi 70 anni in Austria, che un uomo
politico vene condannato per «arricchimento illegale a spese della Repubblica».
"Fumate per stare magri": l'Opera di Vienna nella bufera.
L'Opera di Vienna accusata di abusi fisici e mentali ai danni dei ballerini
picchiati, graffiati, trascinati per i capelli e umiliati sul proprio fisico.
Giorgia Baroncini, Mercoledì 18/12/2019, su Il Giornale. Abusi fisici e
pressioni psicologiche su i suoi giovani ballerini: è bufera sull'Opera di
Vienna. La prestigiosa accademia di balletto è finita al centro di un rapporto
commissionato dal governo austriaco e quanto è venuto alla luce fa rabbrividire.
Lo scandalo era scoppiato lo scorso aprile, quando il settimanale Falter aveva
accusato l'Opera di abusi fisici e mentali ai danni degli studenti. L'indagine
parlava di "metodi del Novecento" con giovani ballerini tra i 10 e i 18 anni che
venivano picchiati, graffiati fino a sanguinare, trascinati per i
capelli, umiliati sul proprio fisico, con alcuni di loro affetti da anoressia.
Accuse pesanti, ma che non finivano lì: per non far mangiare gli studenti,
veniva detto loro di fumare. Rivelazioni choc che hanno creato non poca
indignazione. E così del caso si è interessata una apposita commissione
governativa. Dopo 16 udienze e 24 testimonianze raccolte, il verdetto è
raccapricciante: l'Opera di Stato di Vienna mette in pericolo il benessere dei
suoi ballerini, colpiti da negligenze e discriminazioni, si legge
sull'agenzia Agi. Con il rapporto dell'autorità, l'accademia viene quindi
accusata di maltrattamenti, non solo psicologici, sugli studenti. "È chiaro che
bambini e adolescenti non sono stati sufficientemente protetti da
discriminazioni, negligenze e effetti negativi sulla propria salute. Gli
studenti venivano chiamati per nome e taglia di vestiti", ha dichiarato Susanne
Reindl-Krauskopf, a capo della commissione. "Abbiamo ricevuto segnalazioni in
merito al consiglio, dato agli allievi, di iniziare a fumare per essere
meno affamati", ha continuato la donna che ha accusato, insieme ai colleghi, il
direttore dell'Opera, il francese Dominique Meyer (che dal 2020 sarà il nuovo
sovrintendente della Scala). "Ha fallito nel pieno svolgimento delle sue
responsabilità di supervisione", hanno denunciato. A seguito di un'indagine
svolta dal settimanale Falter, un'insegnante dell'accademia è stata licenziata e
un altro sospeso dal suo incarico perché accusato di molestie sessuali. Nel
frattempo, l'Opera ha dichiarato di aver già attuato una serie di misure
a tutela degli allievi. In particolare, è stato introdotto un corso
sull'alimentazione e sull'immagine corporea e sono stati assunti alcuni
psicologi per sostenere i giovani ballerini. Piccoli passi avanti che però la
commissione ha giudicato come "insufficienti". Tra le scuole di ballo più
antiche al mondo (assieme a quelle di Parigi e di San Pietroburgo), l'Opera
richiama anche allievi da tutto il mondo. E ora la Balletakademie, fondata nel
1771, si trova al centro di uno scandalo senza precedenti.
Letizia
Tortello per “la Stampa” il 19 dicembre 2019. Quanto sacrificio è tollerato per
«Il lago dei cigni»? La domanda non vale, se le caratteristiche richieste per
danzare in uno dei balletti più famosi al mondo sono sopportazione delle
umiliazioni e silenzio di fronte a maltrattamenti e abusi. Come quelli che
accaduti per anni all' Opera di Vienna, ai danni di alcuni studenti che aspirano
a diventare étoile. Ad accertarlo è stata una commissione speciale nominata dal
governo, che aveva il compito di intervistare bambini e ragazzi per appurare se
davvero nelle sale e nei corridoi di una delle scuole più antiche al mondo
capitavano le scene descritte lo scorso aprile in uno scoop giornalistico del
settimanale austriaco Falter. Il Balletto dell' Opera di Vienna esiste dal 1771
e insieme a Parigi e San Pietroburgo è una delle più prestigiose accademie di
danza classica. Sforna talenti per i grandi teatri internazionali, i suoi
ballerini hanno tra i 10 e i 18 anni. Abusi e maltrattamenti I maltrattamenti,
secondo il report della commissione, andavano dal bullismo all' oltraggio, alle
molestie sessuali, con frasi del tipo «perché non c' è sangue sulla tua
scarpetta?», all' inadeguato supporto psicologico e alimentare offerto, per
ragazzi e ragazze che competono in un ambiente in cui anoressia e bulimia sono
diffusissime. In qualche modo, secondo le accuse, disturbi di questo tipo non
sarebbero stati neppure presi in considerazione. Anzi, talvolta la magrezza
sarebbe stata incentivata, con espressioni della serie «il fumo vi aiuta a non
prendere peso». Le umiliazioni maggiori sarebbero state rivolte ai ragazzi in
particolare da un' insegnante russa, Bella R. Ma c' è anche un giovane che
denuncia di essere stato molestato da un insegnante uomo, che poi è stato
licenziato. Vi è poi il caso di una giovanissima, graffiata fino a sanguinare, o
di un' altra che accusa di essere stata presa a calci sulle caviglie mentre era
sulle punte, o ancora il racconto di una studentessa giapponese, arrivata a
pesare solo 37 chili, additata come quella che «puzza di morte». Solo dopo
settimane, gli insegnanti avrebbero proposto per lei una degenza ospedaliera; i
genitori hanno rifiutato e la ballerina è stata «rimandata» in Giappone.
«Abbiamo reagito troppo tardi, abbiamo aspettato troppo», fa il mea culpa Simona
Noja, direttrice dell' Accademia. Per quelli che sono stati definiti «metodi
educativi del '900», l'ex ballerina dell' Opera di Stato ora capo della
struttura non è stata mai messa in discussione. Anche il direttore artistico,
Manuel Legris, lascerà l'anno prossimo, a fine mandato. Resteranno, invece, i
segni sui piccoli artisti in età fragile, chiamati con la taglia dei pantaloni
al posto del cognome, a cui qualcuno potrebbe aver insegnato che, per avere
successo nella vita, bisogna essere disposti a tutto.
Austria: «Io, Sebastian Kurz, un conservatore in verde».
Pubblicato venerdì, 24 gennaio 2020 su Corriere.it da
Paolo Valentino. È il più giovane capo di governo al mondo. L’alleanza dei
“suoi” popolari con gli ambientalisti potrebbe diventare un modello per l’Ue.
Lui, sui conti dell’Italia resta inflessibile. Sebastian Kurz, 33 anni,
cancelliere austriaco per la seconda volta. È il capo di governo più giovane del
mondo. Ha giurato all’inizio di gennaio. Questa è la sua prima intervista
italiana dopo la nomina (foto Gordon Welters/Laif/Contrasto)«Io sono una persona
molto normale», risponde Sebastian Kurz alla domanda su come viva l’essere
diventato nuovamente il più giovane capo di governo al mondo. Una normalità
piuttosto speciale, si potrebbe dire. Martedì 7 gennaio il ragazzo venuto dal
nulla ha giurato da cancelliere austriaco nelle mani del presidente Alexander
van der Bellen. Per la seconda volta in due anni, l’Austria mette il suo destino
nelle mani di un leader dal volto di porcellana, nato nella periferia viennese
nel 1986 da un ingegnere e da un’insegnante, capace di impossessarsi
trasfigurandola di una forza veneranda come la OeVP, il Partito Popolare, cui ha
cambiato perfino il colore da nero a turchese. Maestro nell’arte della seduzione
retorica, flessibile e vago quanto basta per non doversi mai legare a posizioni
definitive, Sebastian “il normale” ha offerto a un Paese ricco, sazio e
sonnolento il brivido del cambiamento, del nuovo inizio e di una nuova frontiera
politica. Nella sua prima esperienza da Bundeskanzler, tra settembre 2017 e
maggio 2019, Kurz aveva sposato una linea molto dura su migranti e sicurezza e
aveva incarnato ancora più dei tedeschi il rigore sui conti in Europa, senza
riguardi in particolare per l’Italia. «Sanzioni chiare verso chi crea debito»,
era ed è il suo motto. «Regole non aggirabili per impedire che l’Italia diventi
una seconda Grecia con una politica debitoria irresponsabile», era ed è la sua
ricetta per l’Eurozona. Ma soprattutto aveva sdoganato un’estrema destra fra le
meno presentabili d’Europa. L’esito gli ha dato ragione, perché oggi la FPOe si
ritrova in macerie, travolta dagli scandali, sconfitta nelle urne e a rischio di
scissione. Questa volta è diverso. Perché stravinte le elezioni di settembre con
oltre il 37% dei voti, di tutte le opzioni di governo a sua disposizione Kurz ha
scelto quella più affascinante, ma anche più rischiosa in quanto terra incognita
non solo in Austria ma nell’intera Europa. Egli guida infatti la prima
coalizione tra popolari e Verdi, due forze politiche agli antipodi o quasi, mai
realizzata nell’Unione europea. Il grande scrittore e polemista Karl Kraus
definì l’Austria all’inizio del Novecento, «il luogo di sperimentazione della
fine del mondo». Venti anni e un secolo dopo, con una maggior dose di ottimismo,
Vienna diventa il laboratorio politico di un’Europa futura. Prossima stazione
potrebbe essere la Germania, dove l’alleanza tra Cdu e Verdi appare sempre più
come soluzione obbligata per il dopo Angela Merkel. Saranno “il normale”
Sebastian Kurz e la sua inedita maggioranza a fornire i parametri di
riferimento? «Non lo so, può succedere», dice il cancelliere nella prima
intervista a una testata italiana a pochi giorni dal suo ritorno al potere. «Io
posso parlare per l’Austria e le dico che abbiamo fatto bene ad allearci con i
Verdi». Kurz spiega che il vero fatto nuovo è che «non abbiamo raggiunto un
compromesso sul più basso denominatore comune, ma abbiamo messo insieme il
meglio dei due mondi, che permetterà a entrambi di mantenere le più importanti
rispettive promesse elettorali». Così, «noi popolari ridurremo le tasse e
continueremo la battaglia contro l’immigrazione illegale, mentre i Verdi
potranno intensificare la lotta contro i cambiamenti climatici, rendere più
trasparente l’amministrazione e varare una nuova legge sulla libertà di stampa».
Il momento giusto Kurz è normalmente pragmatico. Il problema se si tratti di un
matrimonio d’interessi o di una scelta strategica non sembra toccarlo: «È la
coalizione giusta al momento giusto». Allo stesso modo non lo tocca l’accusa di
essere un uomo per tutte le stagioni: in soli tre anni è passato da ministro
degli Esteri della Grosse Koalition tra socialisti e popolari, a capo del
governo con l’estrema destra e ora a cancelliere con i Verdi austriaci, da
sempre molto a sinistra. C’è un problema di credibilità? «Viviamo in una
democrazia e questo significa che se non hai una maggioranza in Parlamento devi
trovare un partner. Io ho posto fine alla grande coalizione con la SPOe perché
non aveva più le risposte, litigava ed era paralizzata. All’epoca, nel 2017,
l’unica opzione alternativa era la FPOe, l’estrema destra con cui avevamo
posizioni simili su sicurezza, migrazioni e tagli fiscali. E insieme abbiamo
fatto cose importanti. Ma poi ho chiuso quell’esperienza a causa degli scandali
in cui era coinvolta. Abbiamo vinto le elezioni, c’era una nuova opzione con i
Verdi e l’abbiamo esplorata con successo. Noi però come popolari difendiamo e ci
battiamo per gli stessi contenuti di prima». Visione ambiziosa L’accordo di
governo sul clima è molto ambizioso: l’obiettivo è di rendere l’Austria del
tutto libera da emissioni di CO2 entro il 2050, riducendole del 50% entro il
2030. «Ce la possiamo fare», assicura Kurz a chi critica l’assenza di dettagli
«se combiniamo crescita economica e misure pratiche. Siamo sulla buona strada
per contare solo sulle energie rinnovabili ed essere denuclearizzati entro dieci
anni. Ma intanto aumenteremo le tasse sui voli commerciali e inizieremo a
riformare in senso ecologico il sistema fiscale, per poter misurare i costi
reali delle emissioni nocive». Pure, il cancelliere non è un fan di Greta
Thunberg: «Non condivido molte delle sue posizioni». Entrato adolescente nella
vita pubblica, egli considera tuttavia «positivo che i giovani si impegnino nei
processi politici» e «importante che Greta abbia successo nel portare questo
tema all’attenzione del mondo». Quanto a lui personalmente, il suo ecologismo si
ferma davanti a una cotoletta viennese: «Con tutto l’amore per il clima, non
rinuncerò mai a una Schnitzel (ispirata a quella alla milanese, ndr) o a
mangiare quello che mi piace». Il nuovo governo austriaco ha una altra,
importante qualità: è composto più da donne che da uomini. È un caso o una
scelta? «Non sono un feticista delle quote. Ritengo importante che in un governo
ci siano uomini e donne, giovani e più anziani, ministri delle città e dei
centri rurali. La politica deve rappresentare un ampio spettro della società, ma
non sto lì a contare. Ho scelto una squadra di persone competenti, che hanno
anche passione e volontà di servire con dedizione il nostro Paese e di
cambiarlo». In Europa, Sebastian Kurz non si considera inferiore a nessuno:
«Siamo un piccolo Paese ma con una grande Storia e abbiamo il dovere di far
sentire forte la nostra voce nell’Unione e sul palcoscenico internazionale».
Anche a costo di qualche contraddizione. Il Green Deal, progetto esistenziale
della Commissione di Ursula von der Leyen, ha bisogno di un bilancio europeo più
robusto? Si può fare, ma a condizione che l’Austria, già contribuente netto, non
debba versare ancora di più: «La nostra posizione, come di altri Paesi
contributori netti, è che non si vada oltre l’1% delle risorse proprie. Si può
investire di più nel clima e nella protezione delle frontiere, ma riducendo i
costi ovunque sia possibile». «Good governance nella distribuzione dei fondi di
coesione», la chiama il cancelliere. E fa un esempio non casuale: «Negli ultimi
6 anni il Sud Italia ha ricevuto circa 22 miliardi di euro eppure ci sono ancora
grossi problemi strutturali. In Sicilia e Campania la disoccupazione giovanile
sfiora il 50%: dobbiamo verificare dove il denaro dei contribuenti europei è
investito bene e dove no e chiederci il perché». La difesa delle frontiere è il
suo vero mantra. Tolleranza zero sugli arrivi, via terra e soprattutto via mare:
«Le persone che vengono salvate nel Mediterraneo non devono essere portate sul
territorio della Ue ma rimandate indietro verso i Paesi di origine, transito o i
primi Paesi sicuri». Anche in Libia? «Dobbiamo lavorare con le organizzazioni
internazionali e costruire centri di raccolta decenti e umani, rendere la vita
impossibile ai trafficanti impedendo loro di partire, in Egitto ha funzionato».
Ma al Cairo c’è un governo, a Tripoli c’è violenza e caos politico: «Bisogna
cooperare con i Paesi sub-sahariani per fermare lì chi vuole andarsene e
naturalmente dobbiamo lavorare per una tregua sostenibile in modo da favorire
l’apertura di un processo di riconciliazione nazionale!». Ma sulla
redistribuzione dei profughi che comunque riescono ad arrivare, Kurz non cede.
L’Austria ha già dato e non intende prenderne altri: «Non funziona. Negli ultimi
4 anni, più di 150 mila persone hanno chiesto asilo da noi, in proporzione molto
più di ogni altro Paese della Ue. La verità è che ci sono Paesi nei quali i
rifugiati semplicemente non vogliono vivere. E comunque fino a quando avremo un
sistema il cui messaggio implicito è “se riuscite in qualche modo ad arrivare in
Europa vi redistribuiremo tra Germania, Francia, Austria, Svezia”, sempre più
persone continueranno a mettersi in mare cercando di venire. Questo è il
problema con le Ong: con le migliori intenzioni, le loro azioni fanno aumentare
il numero dei morti». Sulla crisi tra Iran e Stati Uniti, il cancelliere
sostiene che «l’Europa deve fare di tutto per riportarli al tavolo negoziale» e
che «bisogna evitare un’escalation nella regione». Dice che bisogna usare i
meccanismi previsti dall’accordo nucleare e offre di nuovo Vienna come luogo
della mediazione: «La nostra capitale è pronta a ospitare nuovamente colloqui ed
eventuali trattative». Sto per lasciarlo. Gli chiedo ancora dove abbiamo
sbagliato se 30 anni dopo la fine della Guerra Fredda, il divario economico tra
Europa dell’Est e dell’Ovest si è ridotto, ma quello mentale e culturale si è
ampliato. «I Paesi dell’Europa centrale non hanno l’impressione di essere
trattati da eguali tra eguali. Non ci possono essere compromessi su temi come lo
Stato di diritto, i diritti civili, la libertà dei media. Ma su temi come la
sicurezza e le migrazioni, alcuni Paesi dell’Europa occidentale ostentano una
superiorità morale inaccettabile per nazioni come la Polonia o l’Ungheria.
L’Austria, in ragione della sua storia e della sua posizione, vuole agire da
ponte. Nessuno ha interesse che il divario si approfondisca». Sorride, Sebastian
Kurz “il normale” mentre accenna un inchino e mi stringe la mano. Ma lei si
diverte in questo lavoro? «Sì. Ma sento anche una grande responsabilità. Bisogna
prenderlo sul serio, molto sul serio».
La vita — Nato a Vienna il 27 agosto 1986, Sebastian Kurz è
figlio di un ingegnere e di una insegnante. Dopo il servizio militare
obbligatorio, si iscrive alla facoltà di Giurisprudenza a Vienna, che poi
abbandona per dedicarsi a tempo pieno all’attività politica. È fidanzato da
quando aveva 18 anni con Susanne Thier, impiegata al Ministero delle Finanze.
La politica — Inizia la carriera politica a 16 anni, a 18 è
presidente dei giovani del Partito Popolare. Nel 2011 viene nominato
sottosegretario agli Interni, nel 2013 ministro degli Esteri. Dal 15 maggio 2017
è leader dei Popolari. Il 18 dicembre 2017 diventa cancelliere, il 27 maggio
2019 viene sfiduciato dopo lo scandalo “Ibizagate” che travolge i suoi alleati
di governo. Poi la rielezione e l’insediamento il 7 gennaio.
·
Quei razzisti come
i Turchi.
Avvocati, intellettuali, giudici. Ecco tutti i nemici di
Erdogan. Simona Musco su Il Dubbio il 29 agosto 2020.
Non c’è spazio per i dissidenti nella Turchia di Erdogan, dove le carceri
ingoiano coloro che protestano per i diritti civili sputandoli fuori, molto
spesso, soltanto da morti. Giornalisti, professori, artisti, intellettuali. E,
soprattutto, avvocati. Non c’è spazio per i dissidenti nella Turchia di Recep
Tayyip Erdogan, dove le carceri ingoiano coloro che protestano per i diritti
civili sputandoli fuori, molto spesso, soltanto da morti. E la repressione
continua, nonostante lo stato d’emergenza, durato due anni e proclamato a luglio
2018, sia ufficialmente finito. Ebru Timtik è solo l’ultima vittima: Helin
Bölek, solista del gruppo musicale Grup Yorum, è morta il 3 aprile dopo essersi
rifiutata di mangiare per 288 giorni in segno di protesta contro
l’imprigionamento di altri membri del gruppo, al quale erano stati vietati i
Abdullah Öcalan, leader dell’ala armata del Partito dei lavoratori del Kurdistan
(Pkk), al quale è stata vietata ogni visita con familiari e avvocati. Molti, tra
coloro che hanno preso parte allo sciopero, sono stati accusati di terrorismo.
Sono 101 i giornalisti attualmente in carcere e 1546 gli avvocati perseguitati
dal 2016, 605 quelli arrestati e 345 quelli condannati arbitrariamente, per un
totale di 2145 anni di prigione. Uomini e donne diventati il simbolo della
repressione dell’opposizione politica al regime di Erdogan, che il giorno dopo
il fallito golpe del 16 luglio 2016 ha licenziato 2.745 giudici, un terzo del
totale. Ma non solo: 182.247 funzionari, insegnanti e accademici statali hanno
perso il lavoro, 59.987 di loro sono stati arrestati e condotti in carceri dove
il diritto alla difesa è una chimera. Una situazione semplificata concerti. Dopo
di lei, il 7 maggio, è morto il bassista della band, Ibrahim Gökçek, anche lui
stroncato da uno sciopero della fame durato 323 giorni. E prima di loro la
stessa sorte era toccata al prigioniero politico Mustafa Koçak, morto il 24
aprile dopo un digiuno di 296 giorni. Sono migliaia, stando al rapporto di
Amnesty international, le persone rimaste in custodia cautelare per tempi
lunghissimi, senza che a loro carico vi fossero prove di un qualche reato
riconosciuto dal diritto internazionale, in carceri dove non di rado è praticata
la tortura. Tra gennaio e maggio, migliaia di prigionieri hanno avviato uno
sciopero della fame, seguendo l’esempio di Leyla Güven, parlamentare dell’Hdp di
Hakkari, che chiede la fine dell’isolamento totale di dal caso dei 20 legali
dell’associazione degli avvocati progressisti – della quale faceva parte Timtik
– arrestati nel 2017 e condannati il 20 marzo 2019 in violazione di qualsiasi
elemento costitutivo del giusto processo: dal diritto alla difesa, a quello al
contraddittorio, passando per il diritto ad essere giudicati da un tribunale
indipendente. Colpa degli avvocati quella di aver difeso gli oppositori politici
di Erdogan, ma non solo: tra loro ci sono anche i difensori delle famiglie
espropriate delle loro case a Istanbul, abbattute per far posto ai grattacieli,
o di donne che sono state picchiate dai mariti perché rifiutavano di portare il
velo. Tra le persone finite in carcere anche il presidente dell’associazione
degli avvocati progressisti, Selçuk Kozagaçli, condannato a 19 anni per aver
fondato e gestito un’organizzazione internazionale di matrice terroristica,
mentre gli altri per averne fatto parte, con pene dai tre anni e un mese in su.
Il capo di imputazione si regge sull’aver suggerito ai propri clienti di
avvalersi della facoltà di non rispondere, con una percentuale statistica
considerata superiore al dato nazionale, ma anche a colloqui con le famiglie
troppo lunghi e frequenti. La storia è iniziata con le purghe contro gli
accademici, messa in atto da Erdogan dopo il mancato golpe, tra i quali Nuriye
Gulmen e Semih Ozakca, imputati per “terrorismo” per presunti legami con il
gruppo di estrema sinistra Dhkp. L’arresto di tutti e venti gli avvocati del
collegio difensivo è avvenuto due giorni prima dell’inizio del processo a loro
carico, diventato di colpo un processo politico per contrastare l’opposizione.
Solo sei mesi dopo l’arresto, a marzo 2018, agli avvocati è stato concesso di
prendere visione dei capi d’imputazione, secondo i quali l’associazione degli
avvocati progressisti costituirebbe una branca del partito rivoluzionario messo
fuori legge da Erdogan. La riforma costituzionale ha poi segnato in via
ufficiale una vera e propria fusione tra potere governativo e sistema
giudiziario: con la legge antiterrorismo del 25 luglio 2018 è stata infatti
istituita una costola del potere che monitora gli istituti pubblici e che ha
pieno e completo accesso a tutti gli elementi sensibili di tutti gli ordini
degli avvocati della Turchia.
Turchia, l’avvocata Ebru Timtik muore dopo 238 giorni di
digiuno. Simona Musco su Il Dubbio il 28 agosto 2020.
La professionista, assieme al collega Aytaç Ünsal, aveva trasformato lo sciopero
della fame in digiuno mortale, chiedendo un processo equo. Dopo 238 giorni di
sciopero della fame, è morta l’avvocata turca Ebru Timtik. Era stata arrestata
insieme a altri 18 colleghi per il suo impegno nella difesa dei diritti civili
in Turchia. Il 14 agosto, la Corte costituzionale turca aveva respinto la
richiesta di rilascio a scopo precauzionale sia per lei sia per il collega Aytaç
Ünsal, entrambi in sciopero della fame, nonostante le loro condizioni di salute
fossero già molto critiche. Per la Corte non ci sarebbero state «informazioni o
reperti disponibili in merito all’emergere di un pericolo critico per la loro
vita o la loro integrità morale e materiale con il rigetto della richiesta per
il loro rilascio». Il People’s Legal Bureau (Halkın Hukuk Bürosu, Hkk) ha
annunciato giovedì su Twitter che Timtik era stata sottoposta a massaggio
cardiaco dopo un arresto cardiocircolatorio, chiedendo a tutti i colleghi e al
personale di riunirsi davanti al Bakırköy Dr. Sadi Konuk Hospital. Ma poco dopo
l’Hkk ha annunciato la morte di Timtik. Ünsal è attualmente detenuto presso il
Kanunu Sultan Süleyman Training and Research Hospital di Istanbul. Ebru Timtik e
Aytaç Ünsal avevano avviato lo sciopero della fame a febbraio e non sono stati
rilasciati nonostante siano stati dichiarati non idonei alla reclusione
dall’Istituto di medicina legale. Nemmeno una denuncia alla Corte costituzionale
turca di Ankara ha avuto successo. I due avvocati, trasferiti sotto osservazione
contro la loro volontà in diversi ospedali di Istanbul, avevano deciso di
trasformare lo sciopero in un “digiuno mortale” il 5 aprile – la “Giornata degli
avvocati”. Nel complesso dei procedimenti contro presunti membri del Dhkp-C, gli
avvocati sono stati condannati a lunghe pene detentive in base alle leggi sul
terrorismo, a causa delle dichiarazioni contraddittorie di un testimone chiave.
Con la loro protesta, i due avvocati invocavano un processo equo. Timtik è la
quarta vittima del processo Dhkp-C: Helin Bölek, solista del gruppo musicale
Grup Yorum, è morta il 3 aprile. Si era rifiutata di mangiare per 288 giorni in
segno di protesta contro l’imprigionamento di altri membri della band e il
divieto di concerti per i Grup Yorum. Il 7 maggio, il bassista della band,
Ibrahim Gökçek, è morto dopo uno sciopero della fame durato 323 giorni. In
precedenza, il prigioniero politico Mustafa Koçak era morto il 24 aprile a causa
di un digiuno di 296 giorni. Sezgin Tanrıkulu, il principale deputato
all’opposizione del Partito popolare repubblicano (Chp), ha criticato la
magistratura per non aver rilasciato Timtik. «È impossibile non ribellarsi a
questo. Fino a quando assisteremo a queste morti? Avevamo implorato la Corte
costituzionale di occuparci di questo fascicolo», ha detto Tanrıkulu in un
programma in onda su Halk Tv. I presidenti di diversi ordini degli avvocati
hanno criticato le autorità statali per aver ignorato il caso di Timtik e Ünsal.
«Non l’hanno sentita gridare per mesi chiedendo un processo equo. Coloro che
hanno fatto orecchie da mercante e hanno voltato le spalle hanno massacrato la
giustizia e la coscienza», ha detto il presidente dell’Associazione degli
avvocati di Ankara, Erinç Sağkan. Il presidente dell’Ordine degli avvocati di
Antalya, Polat Balkan, ha descritto la morte di Timtik come un «omicidio
giudiziario», mentre il presidente dell’Associazione degli avvocati di Mersin,
Bilgin Yeşilboğaz, ha sottolineato che «l’ingiustizia uccide».
Da repubblica.it il 29 agosto 2020. Ebru Timtik era un'avvocata,
aveva 42 anni e voleva processi equi. A febbraio ha iniziato uno sciopero della
fame e ieri è morta, dopo 238 giorni, in un carcere di Istanbul. È stata
arrestata 18 mesi fa con l'accusa di legami con il Fronte Rivoluzionario della
liberazione popolare (Dhkp), un gruppo considerato terroristico da Ankara. Il
suo corpo è stato sepolto oggi nel cimitero di Gaz. Sulla sua bara, una bandiera
rossa, un abito da avvocato e dei garofani. La polizia turca ha tentato di
impedire ai sostenitori dell'avvocata di partecipare a un memoriale davanti
all'Associazione avvocati di Istanbul. Secondo il quotidiano Evrensel, gli
agenti in assetto antisommossa hanno sparato gas lacrimogeni e proiettili di
gomma contro la marcia di protesta contro il trattamento dell'avvocata per i
diritti umani e altri colleghi, incarcerati e condannati secondo quelli che le
organizzazioni per i diritti umani ritengono processi né giusti né imparziali.
Almeno un avvocato è stato fermato, ha aggiunto il quotidiano. "Ebru Timtik è
immortale" e Aytac Unsal, attualmente in condizioni critiche per uno sciopero
della fame in carcere, "il nostro onore", scandivano i dimostranti. A febbraio
aveva avviato il digiuno per protestare contro i processi non giusti, assieme al
collega Aytac Unsal, che sarebbe in condizioni critiche. I gruppi per i diritti
umani e d'opposizione da lungo tempo contestano la mancanza di imparzialità e
indipendenza dei tribunali sotto il presidente Recep Tayyip Erdogan. La morte di
Timtik arriva mesi dopo che due membri del gruppo musicale Grup Yorum, Helin
Bolek e Mustafa Kocak, erano morti per lo sciopero della fame. Anche loro erano
accusati di legami con il gruppo definito terrorista. "Quando muore un avvocato,
muoiono i diritti dei cittadini. Gli avvocati romani piangono la collega turca
ebru timtik, martire dei diritti umani e dell'avvocatura, che quei diritti ha
difeso con la la vita". Lo scrive su Facebook il consiglio dell'ordine degli
avvocati di Roma, che ha voluto così ricordare Timtik. "Ebru Timtik, membro del
nostro studio, è caduta martire", ha scritto su Twitter, Halkin Hukuk Burosu.
Condannata lo scorso anno a più di 13 anni di carcere per "appartenenza a
un'organizzazione terroristica", Timtik era membro dell'Associazione degli
avvocati contemporanei, specializzata nella difesa di casi politicamente
sensibili. Le autorità turche accusano l'associazione di essere legata
all'organizzazione marxista-leninista radicale Dhkp. L'avvocata aveva difeso in
particolare la famiglia di Berkin Elvan, un adolescente morto nel 2014 per le
ferite riportate durante le proteste antigovernative a Gezi nel 2013. Il mese
scorso, un tribunale di Istanbul aveva rifiutato di rilasciare Ebru Timtik,
nonostante un referto medico indicasse che il suo stato di salute non le
permetteva più di restare in carcere. Analoga richiesta era stata presentata in
agosto alla Corte costituzionale, senza successo. Invece di essere rilasciati,
Timtik e Unsal sono stati trasferiti in due diversi ospedali a luglio. Ebru
Timtik, che consumava solo acqua zuccherata, infusi e vitamine durante il suo
sciopero della fame, pesava 30 chili al momento della sua morte, secondo i suoi
parenti.
La morte di Ebru è stata dunque una morte voluta. Voluta da
Erdogan. Ezio Menzione, Osservatore Internazionale per
l’UCPI, su Il Dubbio il 28 agosto 2020. L’avvocata Ebru Timtik è morta ieri dopo
238 giorni di sciopero della fame, e fin dall’inizio dell’aprile scorso senza
assumere neppure gli integratori alimentari: uno sciopero della fame che andava
dritto verso la morte. Ebru Timtik è morta ieri dopo 238 giorni di sciopero
della fame, e fin dall’inizio dell’aprile scorso senza assumere neppure gli
integratori alimentari: uno sciopero della fame che andava dritto verso la
morte. Sta condividendo con lei questo drammatico percorso il collega Aytac
Unsal, con soli 30 giorni di meno di sciopero sulle spalle. Ebru pesava ormai 33
kili e aveva perso ben più di quel 25% del peso iniziale che da tutti è
considerato un punto di non ritorno. Non si reggeva più in piedi e la sua bocca
era piagata al punto che anche ingerire acqua le era diventato quasi
impossibile; l’acqua la assumeva ormai solo da una siringa. Una morte
annunciata, verrebbe da dire. Ma sarebbe troppo sbrigativo.Dal primo di agosto
sia lei che Aytac erano stati trasferiti dalla cella in carcere ad una cella in
un centro clinico detentivo, rifiutando loro la rimessione in libertà,
nonostante che una perizia dell’Istituto Medico Legale avesse dichiarato la loro
incompatibilità col regime carcerario. Ed in questa nuova situazione le
condizioni di Ebru erano addirittura peggiorate: luce accesa giorno e notte,
nessuna finestra e altre torture analoghe.La collega era stata condannata a più
di 13 anni di carcere assieme ad altri 15 colleghi della sua stessa
associazione, la CHD, che avevano il solo torto di difendere, e bene, i
lavoratori, le donne, gli oppositori del regime, e perciò erano stati denunciati
e imprigionati e condannati per terrorismo, per un totale di 159 anni. Per la
verità nel novembre 2018 erano stati anche rimessi in libertà, ma poche ore dopo
di nuovo catturati. Il processo di primo grado si era caratterizzato per
macroscopiche violazioni del diritto di difesa, ampiamente denunciate da molti
Osservatori Internazionali. La Corte Regionale d’Appello aveva confermato la
sentenza con poche righe che denunciavano come non avesse preso nemmeno in
considerazione i motivi dell’impugnazione. Ricorso in Cassazione: questa da più
di un anno non decide ed è andata in vacanza il 20 luglio (fino al 10 settembre)
lasciando in sospeso la questione, quasi ad aspettare che i due colleghi in
sciopero della fame nel frattempo morissero. Ed Ebru, purtroppo, è morta, senza
avere non dicasi giustizia, ma nemmeno una decisione, favorevole o meno che
fosse.Più volte è stato fatto ricorso in queste settimane sia alla Cassazione
che al giudice locale affinché fosse rimessa in libertà a causa delle condizioni
di salute, ottenendo sempre decisioni negative. Molti si sono mobilitati, anche
a livello internazionale, compreso il CNF e la nostra UCPI, con lettere e
appelli indirizzati a tutti i giudici possibili e a tutte le autorità
competenti, perché questo scempio non si compisse. Ed invece si è compiuto.
Aggiungiamo – perché occorre farlo, anche se non si dovrebbe – che era stato
presentato anche un ricorso urgente alla CEDU, la quale aveva dato tre giorni di
tempo al governo turco per presentare le sue difese, fino al 27 agosto. Questo
aveva chiesto una proroga e gli era stato concesso fino alle 8 di sera del 27.
Proprio l’ora in cui Ebru è morta. Ma almeno la CEDU ha capito l’urgenza della
questione.La morte di Ebru è stata dunque una morte voluta. Voluta da Erdogan e
dal suo governo secondo una linea autoritaria che non esita a mostrare i muscoli
nemmeno di fronte alla morte di cittadini inermi. Voluta da una magistratura
ormai asservita quasi totalmente (solo la Corte Costituzionale mostra ancora di
tanto in tanto qualche barlume di equità). Voluta anche da chi non ha ascoltato
gli appelli per la liberazione di Ebru e Aitac e non ha inteso intervenire: la
Farnesina e l’ambasciata italiana ad Ankara, per esempio. Non parliamo della
stampa e dell’informazione che, chiusura dopo chiusura imposta dal governo
turco, giornalista dopo giornalista arrestato e incriminato, è ormai ridotta
quasi solo ad una schiera di servi che chinano il capo.Rimane da salvare il
collega Aytac Unsal, ma ci sono rimasti pochi giorni.Vogliamo qui, in chiusura,
ricordare Ebru Timtik come l’abbiamo conosciuta incontrandola in carcere il
Natale scorso: bella, sorridente, con due occhi che parevano due stelle, vivace
nonostante gli anni di detenzione già sofferti, chiusa nel supercarcere di
Silivri, ma perfettamente informata di ogni avvenimento, di ogni cambiamento
politico e sociale. Fiduciosa, ancora e nonostante tutto, che la lotta sua e
degli altri colleghi potesse contribuire a ripristinare un minimo di legalità
nel paese e nelle aule di tribunale. Il nome di Ebru Timtik rimarrà per sempre
legato a questa speranza di un futuro di legalità. Oggi la piangiamo, ma ancor
più la rimpiangeremo quando, in un domani non troppo lontano, verrà ripristinata
in Turchia la democrazia ed il suo contributo avrebbe potuto essere enorme.
L’urlo di Nihat Ünsal: «Non lasciate che mio figlio muoia».
Il Dubbio il 30 agosto 2020. Il padre di Aytac,
collega di Ebru Timtik a digiuno da 209 giorni: «La sua amica è morta di
indifferenza, prendetevi cura di mio figlio». Anche le condizioni di Aytaç
Ünsal, l’avvocato in digiuno per protesta assieme alla collega Ebru Timtik,
morta giovedì sera dopo 238 giorni senza cibo, sono diventate critiche. A
confermarlo Nihat Ünsal, padre di Aytaç Ünsal, che con un post su twitter ha
denunciato che suo figlio viene curato in cattive condizioni. «Mio figlio Aytaç
si sta sciogliendo davanti ai nostri occhi in un digiuno da 209 giorni. È stato
detenuto per 31 giorni in condizioni peggiori del carcere. Inoltre non è
previsto alcun trattamento. Il suo amico avvocato è morto per indifferenza.
Anche la situazione di Aytaç è diventata molto critica. Invito tutti coloro che
hanno coscienza a prendersi cura di mio figlio. Non lasciate che mio figlio
muoia». Davanti all’ospedale Kanuni Sultan Süleyman, dove Aytaç Ünsal è
detenuto con la forza, Didem Baydar Ünsal, moglie di Aytac, ha rilasciato una
dichiarazione: «Adempiremo alla volontà di Ebru, manterremo in vita Aytaç Ünsal.
Un avvocato ha dato la vita per la giustizia». Timtik e Ünsal erano accusati di
«appartenere all’organizzazione terroristica Dhkp-c» e sono stati perciò
condannati rispettivamente a 13 anni e 6 mesi e a 10 anni e 6 mesi. Una condanna
frutto di un processo farsa contro il quale i due hanno avviato lo sciopero
della fame che ha tolto la vita a Timtik. «Durante le udienze era il procuratore
a ricordare al testimone certe sue dichiarazioni. Inoltre si tratta di una
persona che è stata utilizzata in circa 100 processi tra cui anche il maxi
processo che riguarda la rivolta popolare del Parco Gezi del 2013. Questo fatto
non ha nessuna base giuridica», ha sottolineato il presidente dell’Ordine degli
avvocati di Istanbul, Mehmet Durakoglu.
«Erdogan ha paura degli avvocati perché smascherano la
dittatura». Simona Musco su Il Dubbio il 30 agosto
2020. Intervista a Günay Dag, dell’ufficio legale turco People’s law office, del
quale faceva parte anche Ebru Timtik. «Se non sono al sicuro gli avvocati non
può essere al sicuro nessuno. In Turchia non esiste una magistratura
indipendente e il governo vuole controllare gli avvocati per poter governare in
maniera arbitraria senza essere disturbato». A parlare al Dubbio è l’avvocato
turco Günay Dag, dell’associazione “People’s Law Office- International Office”,
che da 30 anni si batte per la legge e la giustizia in Turchia e della quale
faceva parte anche Ebru Timtik, morta ieri dopo un lungo sciopero della fame».
Cosa rappresenta la morte di Timtik per la Turchia?
«Ebru Timtik è deceduta nel 238esimo
giorno della sua resistenza, iniziata con la richiesta di un processo equo. E il
suo non lo è stato affatto: è stato celebrato in un tribunale appositamente
istituito, sotto il comando del governo. Un processo politico che in realtà non
poteva nemmeno essere considerato davvero un processo. Ebru e gli altri avvocati
avrebbero voluto esercitare efficacemente il loro diritto alla difesa, con
giudici indipendenti e imparziali. Naturalmente la situazione non riguarda solo
loro, ma tutto il popolo. Perché se i giudici e i pubblici ministeri non sono
imparziali e lavorano a comando del governo, allora non potranno mai prendere
una decisione che non sia improntata alla volontà di Stato. Tutti sono in
pericolo».
A quali condizioni carcerarie sono stati sottoposti Ebru
Timtik e gli altri prigionieri?
«Gli avvocati imprigionati sono
stati detenuti in otto carceri diverse, lontani l’uno dall’altro e in isolamento
all’inizio del processo. È stata una strategia consapevole. Volevano isolarli.
Ebru e Aytaç sono stati tenuti illegalmente in isolamento per un anno. Nella
loro prima udienza, un anno dopo l’arresto, tutti gli avvocati detenuti sono
stati rilasciati, ma a seguito delle pressioni politiche sui giudici e sui
pubblici ministeri, è stato emesso un mandato di arresto per 12 avvocati dopo
appena 10 ore. In altre parole, sono stati rilasciati con una decisione
giudiziaria e nuovamente arrestati con una decisione politica. Sappiamo che è
così, perché i giudici che hanno firmato l’ordine di rilascio e quelli che hanno
emesso nuovamente il mandato di arresto sono gli stessi, salvo poi essere
licenziati e spediti in altri tribunali. Al loro posto sono stati nominati
giudici speciali».
Che clima c’è per l’avvocatura in Turchia?
«C’è un attacco molto grave contro
gli avvocati. Il governo dell’Akp li vede come nemici, perché potrebbero
impedire al governo di attuare le proprie politiche come preferisce. E questo
perché l’Akp infrange la legge, anche la propria, governando in maniera
arbitraria. Oggi gli avvocati svolgono un ruolo importante nello smascherare
l’illegalità delle politiche del governo, la loro ingiustizia, la loro
arbitrarietà e nel raccontare la Turchia e il mondo all’opinione pubblica. E
così l’Akp li prende di mira. Questo è lo scopo principale della riforma multi-
ordine entrata in vigore il mese scorso. Attaccano gli avvocati per controllarli
e piazzare i propri uomini negli ordini».
Qual è lo status dei diritti fondamentali nel paese?
«Non vi è alcuna garanzia dei
diritti fondamentali nel paese. Non sono garantiti la libertà di espressione,
quella di stampa, di riunione, né altri diritti e libertà. Perché non esiste un
meccanismo di garanzia. La separazione dei poteri, che esisteva da tempo
immemorabile, tra gli organi legislativo, esecutivo e giudiziario è scomparsa.
Ora sono tutti formalmente collegati a un unico potere. Non esiste una
giurisdizione indipendente per sorvegliare le pratiche del governo che limitano
o distruggono questi diritti e per dire ‘ questa pratica è contro la legge’. Non
si può parlare dell’esistenza di diritti fondamentali in un luogo in cui la
magistratura è completamente sotto il controllo dell’esecutivo, dove non c’è
indipendenza giudiziaria».
Qual è la situazione nelle carceri?
«Le carceri turche sono sempre state
problematiche. Tuttavia, i problemi sono aumentati esponenzialmente di recente,
soprattutto dopo il tentativo di colpo di Stato. Oggi nelle carceri esiste una
pratica severa di isolamento. A causa di pratiche arbitrarie e divieti, le
relazioni dei prigionieri con il mondo esterno vengono interrotte. I diritti di
comunicazione vengono annullati. Questa situazione si è ulteriormente aggravata
con la scusa dell’epidemia. Ci sono molti casi di violenza fisica e psicologica
e tortura. Esiste una pratica di isolamento molto, molto severa per i
prigionieri politici condannati all’ergastolo aggravato. Non hanno quasi diritti
fondamentali e sono detenuti in condizioni molto dure».
Crede che ci saranno altre morti come quella di Timtik?
«Ovviamente. Attualmente, il nostro
collega, il nostro amico Aytaç Unsal, sta digiunando fino alla morte con le
stesse richieste di Ebru. Anche la sua salute peggiora ogni giorno. Se la Corte
Suprema non esamina il caso il prima possibile e non prende una decisione in
conformità con la legge, potremmo perdere Aytac come Ebru».
Cosa si aspetta dalla comunità internazionale?
«Che non sia insensibile
all’illegalità e alle ingiustizie subite in Turchia da Ebru e Aytaç. Il potere
politico non si sente vincolato da nessuna legge, non segue nessuna regola.
Perché non esiste alcun meccanismo nel paese per controllarlo. L’unico
meccanismo che può controllare il potere è l’opinione pubblica nazionale e
internazionale. Ci aspettiamo che qualcuno agisca per porre fine a pratiche
antidemocratiche e politiche repressive, facendo pressione politica sullo stato
turco e sul governo dell’Akp».
·
Quei razzisti come
gli Israeliani.
Il paradosso. Il paradosso dell’antirazzismo antisemita,
perché tanto odio verso Israele? Valentino Baldacci su
Il Riformista il 13 Dicembre 2020. Israele ha, in Italia e nel mondo, molti
buoni amici le cui ragioni sono basate sulla conoscenza della realtà, in
particolare della realtà del conflitto arabo-israeliano. Ma non ci si può
nascondere che è diffuso, in Italia e nel mondo, un atteggiamento di ostilità
verso lo Stato ebraico, che assume spesso la forma di un vero e proprio odio. È
un odio difficile da contrastare perché basato in larga parte su elementi
irrazionali che non hanno a che fare con la causa apparente di questo
atteggiamento, di solito individuata con la posizione dello Stato ebraico nel
conflitto con i palestinesi. Ma anche le posizioni apparentemente irrazionali
hanno le loro radici. Individuare queste radici significa fare un grosso passo
avanti per combattere l’ostilità contro Israele. Per quanto riguarda l’Italia, è
relativamente agevole individuare queste radici sia a sinistra come a destra. A
sinistra, con la svolta politica del 1992-94, le forze politiche e culturali di
indirizzo laico e democratico sono state spazzate e via e oggi ne restano solo
il ricordo e la presenza in gruppi relativamente ristretti. Lo spazio
politico-culturale a sinistra è stato occupato pressoché interamente dagli eredi
della cultura del PCI e della sinistra cattolica che avevano costantemente
mantenuto, a partire dagli anni ’50, una posizione di ostilità verso lo Stato
ebraico. Tali posizioni non si identificano meccanicamente con quelle di un
partito, in particolare il Pd. Si tratta in realtà di un’area molto più vasta,
che si può definire di sinistra diffusa, che trova, per esempio, nell’Arci e
nell’Anpi le sue punte di diamante, e la cui presenza è significativa nella
stampa, nelle televisioni, nelle Università, nella scuola, in altre forme di
aggregazione anche informali, in particolare giovanili, nelle quali l’ostilità
verso Israele è un dato di fatto non suscettibile di essere messo in
discussione. È quindi di un’ostilità di tipo ideologico e l’ideologia è
difficile da sradicare, se si riflette sul fatto che per decenni decine di
milioni di persone hanno creduto, in buona fede, che l’Unione Sovietica e gli
altri Paesi socialisti fossero il regno del benessere e della giustizia e solo
vicende traumatiche come quelle che si sono verificate tra il 1989 e il 1991
hanno potuto, e forse solo in parte, scardinare certezze consolidate. Ma anche a
destra ci sono certezze ideologiche difficili da superare. Qui continuano a
giocare un forte ruolo – nonostante i mutamenti intervenuti nelle posizioni
ufficiali dei partiti rappresentativi di questa area – i tradizionali pregiudizi
antisemiti che, se apparentemente sono esibiti solo da gruppuscoli di estrema
destra, continuano in realtà ad agire in profondità in una parte cospicua
dell’opinione pubblica di destra e non solo, sotto forma di sotterranea
accettazione di complottismi e di negazionismi di varia natura. Accanto a questi
pregiudizi antisemiti, questa parte dell’opinione pubblica continua a essere
influenzata dalle tradizionali posizioni della Chiesa cattolica. Il Concilio
Vaticano II con la dichiarazione “Nostra Aetate” ha avuto un’influenza sul piano
religioso ma non su quello politico-culturale. La Chiesa ha assunto una
posizione simile a quella che si ritrova nell’art. 20 della Carta dell’Olp: gli
ebrei costituiscono una religione, non un popolo, e quindi non hanno diritto ad
avere uno Stato. Non a caso la Santa Sede ha riconosciuto diplomaticamente lo
Stato d’Israele solo nel 1993, dopo che con gli accordi di Oslo sembrava aprirsi
una nuova fase e una posizione intransigente appariva insostenibile. Ma da
allora e fino ad oggi sull’Osservatore Romano e sull’Avvenire, organo dei
vescovi italiani, non viene quasi mai usata l’espressione “Stato d’Israele” e si
parla invece di “Terrasanta”, per esprimere una perdurante riserva sulla liceità
stessa dell’esistenza dello Stato ebraico. Se in Italia le radici
politico-culturali dell’ostilità contro Israele sono abbastanza chiare, esse
possono essere individuate anche a livello europeo. Alcune delle cause presenti
in Italia sono le stesse che agiscono negli altri Paesi dell’Europa
occidentale. Anche se la sinistra come rappresentanza politica si è indebolita,
tuttavia il suo sistema ideologico continua ad avere una forte presa per lo meno
in alcuni Paesi, come la Spagna e la Francia. I pregiudizi antisemiti che sono
presenti nella cultura di destra continuano ad agire in tutta Europa e anche
l’influenza delle Chiese non può essere trascurata. Ma a livello europeo – anzi
mondiale – va soprattutto tenuto conto dell’affermarsi della cultura
del “politicamente corretto” che ha in larga misura sostituito quella che era la
vecchia egemonia culturale del marxismo. Il “politicamente corretto” agisce
quasi spontaneamente in senso antiisraeliano dando vita a forma di antirazzismo
antisemita, che sembrerebbe una contraddizione in termini e che è invece una
realtà ampiamente diffusa. Se queste sono le radici dell’ostilità contro
Israele, appare difficile combattere con efficacia convinzioni così
capillarmente diffuse. E tuttavia, come è stato in passato nei casi del nazismo
e del comunismo, non si deve mai disperare nelle risorse della ragione e della
conoscenza. È una battaglia dura ma che non può essere abbandonata. Non ci si
deve mai stancare di far conoscere la realtà del conflitto arabo-israeliano, il
costante rifiuto palestinese di giungere a una pace di compromesso, che consenta
la realizzazione dell’obiettivo due popoli – due Stati. I recenti Accordi di
Abramo hanno aperto prospettive che modificano profondamente un quadro che
sembrava immutabile. Può sembrare un eccesso di enfasi retorica e tuttavia credo
che si possa dire che gli Accordi di Abramo possono rappresentare per il Medio
Oriente quello che per l’Europa rappresentò il collo del muro di Berlino. Ci
vorrà tempo, naturalmente, perché tutte le conseguenze degli Accordi si facciano
sentire e soprattutto sta agli amici di Israele farne comprendere appieno il
significato. Ma la strada è stata aperta è appare possibile percorrerla fino a
risultati che fino a ieri sembravano impossibili.
Ombre cinesi su Israele. Lorenzo
Vita su Inside Over il 18 maggio 2020. La Via della Seta passa anche per
Israele. E per gli strateghi americani è un problema talmente serio che lo
stesso segretario di Stato, Mike Pompeo, si è dovuto recare in visita a
Gerusalemme per ribadire alle controparti dello Stato ebraico il netto rifiuto
di Washington alla penetrazione di Pechino. Una visita particolarmente intensa
visto che si è parlato di Cina, di piano di annessione della Cisgiordania, di
nuovo governo di coalizione e di strategie regionali, ma che si è conclusa anche
con un evidente scontro politico tra i due giganti del mondo – Pechino e
Washington – che adesso vedono in Israele una delle trincee della loro nuova
Guerra fredda. Una trincea che è destinata a essere anche una delle più
pericolose e complesse data anche la faglia strategica su cui sorge Israele,
avamposto dell’Occidente nel mondo mediorientale e che da qualche tempo ha
deciso di aprirsi anche alle sirene orientali. Nonostante la preoccupazione e i
continui avvertimenti delle amministrazioni americane. In questo contesto di
tensione, rafforzato con l’arrivo di Pompeo e con una serie di articoli e
comunicati usciti da una parte all’altra della barricata su prospettive e rischi
della partnership tra Israele e Cina, è piombata l’improvvisa morte di Du Wei,
ambasciatore cinese da poco insediatosi a Tel Aviv. Una morte per cause naturali
che però non poteva non gettare più di un’ombra di sospetto e di mistero vista
la tempistiche del decesso, praticamente a poche ore dal giuramento del nuovo
governo e dalla visita del potente segretario di Stato americano ed ex direttore
della Cia. Le indagini della polizia israeliana hanno accertato in maniera
definitiva le cause “naturali” della morte. Il diplomatico, 57 anni, trovato
senza vita nel letto della sua Herzliya, sarebbe stato colpito da un infarto.
Una conclusione a cui è giunto anche il governo di Pechino, che dopo una prima
possibilità di inviare una squadra investigativa a Tel Aviv per indagare sulla
morte dell’ambasciatore, ha scelto di non mandare nessuno confermando i
risultati delle indagini della polizia israeliana. La possibilità dell’invio di
una squadra investigativa cinesi non è stata soltanto frutto delle indiscrezioni
di stampa (in particolare del South China Morning Post e di Haaretz): lo stesso
portavoce del ministero degli Esteri, Lior Haiat, aveva dichiarato all’agenzia
di stampa Dpa che la Cina aveva deciso di inviare un team di esperti. Ma in
serata è arrivata la retromarcia del governo cinese, che ha invece confermato
quanto appreso dalla polizia israeliana ribadendo che la morte di Du Wei sarebbe
avvenuto per un malore. Come già anticipato dall’organo internazionale del
Partito, il Global Times. Una retromarcia particolarmente interessante. Da una
parte è chiaro che difficilmente Israele avrebbe avallato un’investigazione
straniera sul proprio territorio; dall’altro lato, inviare un team di
esperti non fidandosi delle affermazioni degli investigatori israeliani avrebbe
di fatto svelato tutti i sospetti di parte cinese oltre che creare un pericoloso
precedente nei rapporti tra i due Paesi. In ogni caso, l’annuncio e la
successiva smentita hanno fatto comprendere che più di qualcuno, nelle stanze
del Partito a Pechino, ha pensato che la morte di Du Wei non sia stata un caso.
Difficile (se non impossibile) fare ipotesi. Le speculazioni in questo caso sono
potenzialmente infinite ed è sempre pericoloso pensare alla risposta più facile.
È chiaro che una morte del genere, improvvisa e così importante, e il solo fatto
che la polizia israeliana abbia indagato su una morte già all’apparenza
naturale, siano questioni foriere di dubbi e sospetti. Ma la scelta di Pechino
di non inviare il team così come la netta presa di posizione delle autorità
dello Stato ebraico inducono a credere che dalle parti di Tel Aviv e di Pechino
si voglia mettere un freno al giallo. Freno che però non può essere messo al
tema cruciale dello scontro su Israele tra Cina e Stati Uniti e su cui ora si
gioca parte della sopravvivenza internazionale del governo Netanyahu-Gantz. E
non a caso tre giorni fa era stata proprio l’ambasciata cinese a Tel Aviv a
protestare per le parole di Pompeo sulla minaccia legata alla penetrazione
asiatica nel Paese ebraico. Israele interessa alla Cina ed è allo stesso tempo
considerato fondamentale per gli Stati Uniti. Benjamin Netanyahu, pur legato a
doppio filo all’attuale amministrazione americana, non ha mai disdegnato gli
interessi cinesi, specialmente con un’Unione europea molto poco incline ad
accettare le scelte dei governi guidati dal Likud e con gli Stati Uniti che,
sotto l’era Obama, avevano firmato quell’accordo con l’Iran che Bibi aveva
sempre condannato. Scelta che ha provocato una frattura non ancora del tutto
sanata tra i due alleati. La Cina, grazie anche alle posizioni di Netanyahu, si
è mossa per cercare di colmare i primi vuoti lasciato dagli Stati Uniti. E sono
anni che i servizi segreti israeliani, storicamente saldati con l’America,
avvertono le autorità sugli investimenti di Pechino. Lo hanno fatto per le
vendite di aziende israeliane a grandi marchi cinesi, ma lo hanno fatto
soprattutto per l’interesse del gigante asiatico nel porto di Haifa e nel più
grande impianto di desalinizzazione del mondo, Israele starebbe rivalutando
l’offerta di una società legata alla Cina, la Hutchison, per la costruzione di
un impianto di dissalazione, il Sorek 2, nel kibbutz Palmachim, poco lontano da
Tel Aviv. Sul porto di Haifa i problemi sono legati soprattutto ai rischi del
doppio uso civile e militare dei possibili investimenti cinesi. Motivo per cui
gli Stati Uniti da tempo chiedono ai partner europei di evitare (con scarso
successo) il coinvolgimento di Pechino nelle grandi infrastrutture portuali. Il
rischio, per l’intelligence e militari americani e israeliani, è che la Cina
possa sfruttare queste opere civili per mettere più di un piede nelle strutture
strategiche legate direttamente alla sfera di influenza americana. Diverso il
tema del Sorek 2, che è di natura prettamente politica ed economica: il
negoziato con la Hutchinson, azienda di Hong Kong, non è mai piaciuto agli Stati
Uniti, tanto che le pressioni nei confronti del governo israeliano sono state
tantissime . E non a caso in concomitanza con la visita di Pompeo e l’avvio del
nuovo governo, da Israele è arrivata la notizia di un “ripensamento”. Un segnale
di dubbi politici prima ancora che economici seguito, a stretto giro di posta,
dalla tragica morte di Du Wei.
Le molte vite di Bibi Netanyahu perché da 25 anni il popolo lo
sceglie? Pubblicato martedì, 03 marzo 2020
su Corriere.it da Aldo Cazzullo. Nec tecum nec sine te vivere possum, Israele
non riesce a vivere né con né senza Benjamin Netanyahu. Quando divenne premier
nel 1996 in America c’era Clinton, in Germania Kohl, in Francia Chirac, in
Russia Eltsin, in Egitto Mubarak. I suoi colleghi sono quasi tutti morti. Lui
nel ’99 perse le elezioni contro Ehud Barak, l’ultimo premier laburista, capo di
un partito che aveva fondato lo Stato ebraico e ora in pratica non esiste più.
Con Barak è morto il sogno della pace: Israele la considera impossibile; e
l’unico leader cui la maggioranza relativa dell’unica democrazia del Medio
Oriente è disposta ad affidare la propria protezione resta il fratello di Yoni
Netanyahu, l’eroe di Entebbe. Meno di un anno fa Bibi, come lo chiamano tutti,
chiese al popolo un ultimo mandato. La sua coalizione ottenne più seggi di
quella del rivale, l’ex capo di Stato maggiore Benny Gantz, però Netanyahu non
riuscì a formare un governo per l’opposizione di Avidgor Lieberman, conservatore
ma a lui avverso. Le elezioni anticipate del 17 settembre scorso hanno
confermato lo stallo: Lieberman ha bloccato anche l’investitura di Gantz,
rifiutando di votare insieme con i partiti arabi. L’altro ieri Netanyahu ha
colto quella che definisce «la vittoria più importante della mia vita», anche se
gli manca ancora un fatidico seggio. Non dovrebbe essere impossibile trovarlo.
Più difficile sarà affrontare i magistrati che lo aspettano tra due settimane
per giudicarlo su accuse gravissime. Ma una volta riconfermato al potere
Netanyahu sarebbe capace di tutto, anche di regalarsi un’amnistia. L’alternativa
è un patto per una grande coalizione o per una staffetta, sul modello di quella
che vide alternarsi Yitzhak Shamir del Likud e il laburista Shimon Peres. Ieri
l’editorialista principe del quotidiano Haaretz, Anshel Pfeffer, ha confrontato
i volti dei due Benjamin nella notte elettorale: «Sono esausti. Ma Bibi è più
abituato. Quindi sembra un po’ meno esausto». Gantz fa a Israele la promessa più
rivoluzionaria: la normalità. Ma se ancora una volta Israele ha dato fiducia a
Netanyahu – sia pure non del tutto -, è perché non pensa e non sente di vivere
tempi ordinari. Il premier in questi anni ha stretto la mano praticamente a
tutti i suoi compatrioti. Ha seppellito politicamente l’ostile Obama e ora
flirta con Trump, che dopo aver portato l’ambasciata a Gerusalemme ha
predisposto un piano di pace – soldi ai palestinesi in cambio di territori —
apparso più che altro uno spot elettorale per il Likud. È amico di Putin con cui
parla in russo. Dialoga con Al Sisi. Si confronta con Erdogan e con la dinastia
saudita. È rispettato dai cinesi, temuto dagli ayatollah, detestato da gran
parte della stampa del suo Paese. Non è un uomo di pace, ogni volta che oscilla
nei sondaggi rilancia assicurando che con lui non ci sarà mai uno Stato
palestinese e che presto annetterà almeno un terzo della Cisgiordania; ma non ha
mai scatenato una guerra (l’ultima, l’invasione del Libano in cui morì il figlio
di David Grossman, fu decisa da Ariel Sharon). Netanyahu, cresciuto negli Stati
Uniti, è percepito come un leader adatto al mondo globale, e nello stesso tempo
come il più affidabile difensore della terra, dell’identità, degli interessi del
popolo di Israele. E questo induce ancora molti a perdonargli l’uso
spregiudicato del potere, della propaganda, financo del nemico alle porte. Più
che da quello palestinese, Israele è accerchiata dal nemico iraniano, che
prepara l’atomica e nel frattempo arma, addestra, finanzia Jihad e Hamas a sud,
Hezbollah a nord, il regime di Assad a est. Ma – nonostante questo, o proprio
per questo - metà Israele non si è mai sentita così al sicuro come con
Netanyahu.
·
Quei razzisti come
i Libanesi.
Esplosione a Beirut, più di 100 morti. Preoccupazione per le
tossine nell’aria. Pubblicato il 5 agosto 2020 da Il
Corriere della Sera. È salito a più di 100 morti e circa 4 mila feriti il
bilancio delle due esplosioni che hanno devastato Beirut nel pomeriggio di
martedì 4 agosto, secondo quanto riportato dalla Croce Rossa libanese. I
soccorritori hanno lavorato per tutta la notte. Le esplosioni, udite anche a
Nicosia (Cipro), a 240 chilometri (150 miglia) di distanza, sono state
registrate dai sismologi come l’equivalente di un terremoto di magnitudo 3,3. A
provocare le esplosioni sarebbe stato un carico di nitrato di ammonio di oltre
2.700 tonnellate che era conservato in un magazzino nei pressi del porto dopo
esser stato confiscato sei anni fa. Testimoni hanno riferito di aver visto una
nuvola arancione come quella che appare quando viene rilasciato gas tossico di
biossido di azoto dopo un’esplosione che coinvolge nitrati e nel Paese è forte
la preoccupazione anche per le tossine presenti ora nell’aria. Non ci sono
ancora certezze sulle cause dell’accaduto (qui l’articolo di Lorenzo Cremonesi:
«Incidente o attentato?»). I sospetti che si tratti di un attentato erano stati
avanzati inizialmente a causa delle prime notizie circa una seconda esplosione
nei pressi della residenza dell’ex premier sunnita Hariri. Tuttavia, la tesi
dell’incidente appare via via più probabile e le autorità restano caute. Nella
notte Donald Trump ha rilanciato l’ipotesi-bomba, affermando durante una
conferenza stampa di aver parlano con alcuni generali americani, i quali pensano
si sia trattato di «una bomba di qualche tipo».
Libano, enorme esplosione a Beirut. Almeno 73 morti e 3.700
feriti: «Una catastrofe, i responsabili pagheranno» di Lorenzo Cremonesi.
Pubblicato il 5 agosto 2020 da Il Corriere della Sera. Sale
il bilancio delle devastanti esplosioni. Trump: alcuni generali Usa pensano si
sia trattato di «una bomba di qualche tipo». Le tensioni internazionali e il
processo per l'omicidio di Hariri. Il terribile scoppio al porto è avvenuto
mentre il Libano attraversa una delle più gravi crisi economiche e finanziarie
degli ultimi anni, e mentre si alzano le tensioni tra Israele e il gruppo
sciita Hezbollah. Poco dopo l'esplosione, le autorità israeliane hanno precisato
di «non avere nulla a che vedere» con quanto avvenuto. Il ministro degli Esteri
israeliano Gabi Ashkenazi ha detto alla tv israeliana N12 che l'esplosione
sarebbe stata «un incidente», causata da «un incendio». Diversi Paesi — dalla
Francia alla Gran Bretagna, dagli Usa all'Iran, a Israele — hanno offerto aiuti.
Il premier italiano Giuseppe Conte ha detto che l'Italia «farà tutto quel che le
è possibile per sostenere» il popolo libanese; il ministro degli Esteri Luigi Di
Maio ha espresso «il nostro profondo cordoglio» per quanto accaduto. Dirigenti
militari Usa pensano che l’esplosione a Beirut sia stata un attacco, una bomba
di qualche tipo: lo ha detto Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa
Bianca. Un’enorme esplosione, avvenuta nella zona del porto, ha devastato nel
pomeriggio di martedì 4 agosto la capitale del Libano, Beirut. I feriti, secondo
il ministro della Salute Hamad Hassan, sono almeno 3.700, ma il numero è
probabilmente destinato ad aumentare. Gli ospedali della capitale — già sotto
pressione per l'epidemia di Covid-19 — sono colmi di feriti, molti dei quali
bisognosi di interventi di emergenza. Secondo quanto si apprende, tra le persone
coinvolte c'è anche un militare italiano, seppur in modo leggero. I morti,
sempre secondo il ministro della Salute, sono 73: ma si tratta di un bilancio
provvisorio. La Croce Rossa libanese ha riferito di un numero imprecisato di
persone ancora sepolte sotto le macerie e intrappolate nelle loro case. Il
premier Hassan Diab ha deciso che quella di mercoledì sarà, in Libano, una
giornata di lutto nazionale. Diab ha parlato di una «catastrofe», i
«responsabili» della quale saranno chiamati a «rendere conto». Il presidente
libanese, Michel Aoun, ha convocato per una riunione urgente il Consiglio
supremo di difesa. «Ciò che è successo a Beirut ricorda Hiroshima e Nagasaki,
nulla di simile era mai accaduto in passato in Libano», ha detto in lacrime il
governatore della capitale libanese, Marwan Abboud. Nelle immagini diffuse sulle
tv locali e sui social si vede prima una densa colonna di fumo bianca — il
risultato, secondo quanto riportato dal New York Times, di un primo scoppio, o
di un incendio —, alla base della quale si vedono esplosioni secondarie, minori
e colorate. Pochi istanti dopo, si vede una gigantesca onda d’urto, a forma
di fungo, che colpisce via via diversi edifici, facendoli collassare. Svanito il
vapore del fungo, resta una altissima colonna di denso fumo rosso-arancione.
Vaste zone del porto sono state rase al suolo, e balconi e finestre sono
collassati a chilometri dal luogo dell'esplosione. Danneggiati centinaia di
edifici, tra i quali anche il Palazzo Baabda, residenza del presidente. Il
fragore dell'esplosione, secondo quanto riferito dall'agenzia Reuters, è stato
sentito anche a Nicosia, Cipro, quasi 200 chilometri a nord-ovest della capitale
libanese.
Le cause dell'esplosione e i materiali «altamente esplosivi». Non
ci sono ancora certezze sulle cause dell’esplosione. Il primo scoppio sarebbe
avvenuto, secondo notizie inizialmente riportate dalle tv locali, in un deposito
di fuochi d’artificio. La seconda, devastante, esplosione è invece originata da
un magazzino poco distante. Il ministro dell'Interno ha spiegato che a
deflagrare, in questo secondo magazzino, sono stati materiali «altamente
esplosivi» — «2.750 tonnellate di nitrato di ammonio sequestrate diversi anni fa
da una nave», ha detto il presidente Michel Aoun, citato dalla Bbc online, dopo
la riunione d’emergenza del Supremo consiglio della Difesa nel palazzo
presidenziale di Baabda. È «inaccettabile», ha scritto Aoun in un tweet, che
2.750 tonnellate di nitrato di ammonio fossero tenute immagazzinate in
condizioni non sicure. Un’inchiesta è in corso per appurare cosa abbia provocato
l’esplosione. Secondo quanto riportato dall'agenzia Ap, le esplosioni di nitrati
causano abitualmente colonne di fumi tossici di colore rosso-arancio, come
quello visto al porto di Beirut. Non è noto perché quel materiale fosse
conservato così vicino al porto, né che cosa fosse esattamente il deposito o per
che cosa fosse usato, né infine come mai fosse così vulnerabile. Il premier ha
detto in tv che quel «pericoloso magazzino» era utilizzato «dal 2014». «Ho visto
una palla di fuoco e una colonna di fumo che si alzava sopra Beirut. C'erano
persone che correvano e urlavano ovunque, con il volto insanguinato», ha detto
alla Reuters un testimone. Un altro testimone, citato dalla stessa agenzia, ha
parlato di «una situazione di caos totale». Un passante citato dall'agenzia Ap
ha detto: «Questo Paese è maledetto».
Incidente o attentato? Le ipotesi. E le parole di Trump: «I
nostri generali pensano a un attacco». (qui l'articolo
di Lorenzo Cremonesi: «Incidente o attentato?»). Pubblicato il 5 agosto 2020 su
Il Corriere della Sera. Incidente o attentato? È la domanda che sorge nel
guardare le immagini della gigantesca esplosione che ha sconvolto martedì
pomeriggio il cuore di Beirut. Un enorme fungo rossastro di fuoco e detriti ha
investito l’area del porto, non distante dal centro storico ricostruito dopo la
guerra degli anni Settanta e Ottanta, che aveva ridotto in macerie larga parte
della capitale libanese. Decine le abitazioni distrutte o danneggiate. Tra i
feriti leggeri un militare italiano. I danni sono così ingenti che l’intero
porto è stato bloccato. Il presidente Michel Aoun chiede due settimane di stato
di emergenza. Il ministro della Sanità Hamad Hassan invita chi può a lasciare la
città, mentre l’ambasciata americana consiglia di «rimanere al chiuso e
indossare maschere» per evitare di inalare gas tossici.
Il premier Hassan Diab giura: «I responsabili pagheranno». I
sospetti che si tratti di un attentato erano stati avanzati inizialmente a causa
delle prime notizie circa una seconda esplosione nei pressi della residenza
dell’ex premier sunnita Hariri. A ciò si aggiunge la gravissima situazione di
crisi economica, politica e sociale interna che causa pericolose tensioni e
rigurgiti di violenza. Tuttavia, la tesi dell’incidente appare via via più
probabile, alcuni video mostrano un grande fumo in tutta la zona dei capannoni.
E le autorità restano caute sulle cause. Pare che prima della deflagrazione
maggiore l’area fosse già in fiamme. Anche se nella notte Donald Trump ha
rilanciato l’ipotesi-bomba, affermando durante una conferenza stampa di aver
parlano con alcuni generali americani, i quali pensano si sia trattato di «una
bomba di qualche tipo».
Ancora incerto il numero delle vittime. Il primo bilancio è di
decine di morti e 3.700 feriti. I testimoni parlano di auto in fiamme, urla di
civili intrappolati sotto le macerie e crolli di balconi a causa dell’enorme
onda d’urto: «Automobili sollevate come foglie. Ho visto persone coperte di
sangue correre terrorizzate». La terra ha tremato sino a Tripoli, 200 chilometri
più a est. «Non si era mai vista un’esplosione tanto grave, neppure durante la
guerra civile», sostengono in tanti. Tra i feriti vi sono anche tra gli 8 e i 10
soldati bengalesi del contingente Unifil che dal 1978 ha il compito di
controllare il cessate il fuoco al confine con Israele. «Si trovavano al porto
per ritirare alcuni container». Il contingente è diretto dal comando italiano.
Il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha specificato che il militare
italiano si trovava in un edificio con altri 11 commilitoni (ora trasferiti da
Beirut a Shama) ed è rimasto leggermente ferito a un braccio. Sembra che il
capannone dove è avvenuta la conflagrazione contenesse esplosivi, in particolare
2750 tonnellate di nitrato d’ammonio. Una prima versione parlava anche di
«fuochi d’artificio». Sia Israele che Hezbollah hanno negato qualsiasi
coinvolgimento: il primo si è offerto di mandare aiuti, il movimento filo
iraniano ha fatto un appello all’unità.
La lunga notte di Beirut: 135 le vittime accertate, 5mila i
feriti e 300mila gli sfollati. Francesca Spasiano su
Il Dubbio il 4 agosto 2020. Il governo libanese chiede che «vengano arrestati
tutti i responsabili dello stoccaggio della sostanza che ha provocato la
tragedia». La lunga notte di Beirut ha restituito all’alba di oggi una città di
morte e macerie. Della violenta devastazione che ha colpito la capitale del
Libano resterà l’immagine di un’apocalisse: un boato che ha raggiunto l’isola di
Cipro, distante più di 200 chilometri, un urto pari a quello di un terremoto di
magnitudo 4.5, mentre una gigantesca nube rossastra conquista il cielo e le
strade. La prima esplosione alle 18 del 4 agosto, ora locale, poi subito
un’altra: la deflagrazione colpisce la zona del porto e vaste aree del centro.
Le finestre delle case non reggono all’urto, mentre gli edifici, ancora
danneggiati dalla guerra civile che ha insanguinato il paese tra il 1975 e il
1990, cadono in pezzi uno dopo l’altro. «Sembra di attraversare un fiume di
vetro», racconta Margherita, una cooperante italiana che vive in un quartiere
nei pressi del porto, all’indomani dell’esplosione. «Ero in casa quando ho
sentito il boato, che mi ha letteralmente buttato a terra – spiega ancora la
ragazza. Eravamo tutti certi di morire». Tra le rovine si contano ancora i
numeri della strage: almeno 135 le vittime, oltre 5mila i feriti e 80 i
dispersi, secondo le ultime stime riportate dai media locali. Circa 300mila le
persone rimaste senza casa. A causare le esplosioni sarebbe stato un incendio
all’interno di un deposito del porto che conteneva 2.750 tonnellate di nitrato
di ammonio, un composto chimico utilizzato come fertilizzante e per fabbricare
esplosivi. Ma la dinamica resta ancora incerta: se per il presidente Usa, Donald
Trump, le esplosioni sarebbero causate da una bomba – una tesi però contraddetta
da tre fonti anonime della Difesa Usa citate dalla Cnn, secondo le quali non ci
sono indicazioni di attacchi – sia Israele che Hezbollah hanno negato qualsiasi
coinvolgimento.
Il primo si è offerto di inviare aiuti, mentre il movimento filo
iraniano ha fatto un appello all’unità del Paese. «Affinché i libanesi possano
arrivare a un’indagine trasparente è necessaria una partecipazione
internazionale e di esperti in grado di scoprire la verità e rendere giustizia a
Beirut e ai suoi cittadini», scrive invece in una nota il partito sunnita
dell’ex premier Saad Hariri. La deflagrazione arriva proprio a pochi giorni dal
verdetto del Tribunale speciale dell’Onu sull’assassinio dell’ex premier Rafik
Hariri, morto nell’esplosione di una bomba a Beirut nel 2005. La sentenza,
attesa per il 7 agosto, è stata posticipata al 18 in seguito all’accaduto:
«Questa decisione – fa sapere in un nota il tribunale dell’Onu – è stata presa
per rispetto delle innumerevoli vittime e dei tre giorni di lutto in Libano». I
quattro imputati, in contumacia, sono membri delle milizie sciite filo iraniane
di Hezbollah, che hanno sempre negato di avere avuto un ruolo nell’attentato.
Intanto, la ministra per i Rifugiati, Ghada Shreim, ha riferito che saranno
messi agli arresti domiciliari «tutti i dirigenti del porto responsabili della
gestione, della protezione e dell’ispezione dei materiali esplosivi» dal 2014,
anno in cui venne sequestrato il carico di nitrato d’ammonio conservato nel
deposito esploso. La misura – precisa il ministro dell’Interno Mohamed Fahmy
prevede un divieto di viaggi «per chiunque abbia un tipo di legame con quanto
successo» e ha rivolto un appello «all’unità» ai politici libanesi, invitandoli
a «mettere da parte le dispute per salvare il Paese». Da mesi, infatti, il
Libano soffre di una gravissima crisi economica e politica, aggravata dalla
pandemia di coronavirus che ha portato al collasso il sistema sanitario: dopo la
guerra civile gli ospedali sono stati quasi tutti privatizzati, e quelli
pubblici sono a corto di finanziamenti dopo che il governo ha dichiarato
bancarotta. La situazione è precipitata rapidamente a partire dalla rivoluzione
di ottobre: da allora una parte della popolazione – di cui almeno il 25% tra
rifugiati palestinesi e siriani che vivono in condizioni umanitarie estreme –
muore letteralmente di fame. La tragedia delle ultime ore non potrà che
aggravare la situazione: il Libano, infatti, importa la maggior parte del suo
cibo dall’esterno, ma con la distruzione dello snodo portuale il transito di
scorte potrebbe essere compromesso.
Tra i feriti un militare italiano: non è grave. Tra le migliaia
di feriti, anche un militare italiano della forza internazionale Unifil. Sta
bene, è stato lui stesso a informare i suoi familiari. Il ministro della Sanità
libanese, Hamad Hasan, ha invitato tutti i cittadini di Beirut che ne hanno la
possibilità di lasciare la città: i materiali pericolosi sprigionati nell’aria
dalle due esplosioni sono potenzialmente tossici se respirati a lungo. Secondo
le prime ricostruzioni, infatti, le esplosioni avrebbero diffuso nell’aria
biossido di azoto, un gas tossico rilasciato da del nitrato di ammonio che
sarebbe stato sequestrato nel 2014 da una nave mercantile e a quanto pare
stoccato nel magazzino di petardi e materiale esplosivo. Dopo la riunione del
Consiglio supremo di difesa, a Beirut è stato dichiarato lo stato d’emergenza
per due settimane.
Ferite moglie e figlia del primo ministro libanese. Il primo
ministro libanese, Hassan Diab, ha dichiarato per domani una Giornata di lutto
nazionale per le vittime. Secondo l’emittente «Al Arabiya», tra i feriti vi
sarebbero anche la figlia e la moglie del primo ministro e di alcuni suoi
consiglieri. Le esplosioni avrebbero danneggiato anche il palazzo di Baabda,
sede della presidenza della Repubblica. Il ministro della Salute, Hamad Hassan,
ha predisposto l’accoglienza di tutti i feriti negli ospedali a spese del
dicastero. Finora sono poco chiari i contorni di quanto è accaduto. Intanto sono
in corso le operazione di spegnimento dell’incendio divampato in seguito
all’esplosione da parte di canadeir e dei corpi dei vigili del fuoco. Un
cittadino intervistato dall’emittente «Al Arabiya» ha detto di aver udito due
esplosioni, una più contenuta e l’altra più forte. Sembra che l’esplosione sia
avvenuta all’interno del settore 12 del porto di Beirut, in un silos di grano,
secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa «Nna».
In coma il segretario generale del partito falangista. Il capo
del partito socialista progressista, Walid Joumblatt, si è recato in visita alla
Casa del centro (Bayt al Wast) per sincerarsi della condizione di salute dell’ex
premier Saad Hariri, secondo quanto riferito da quest’ultimo su Twitter.
Intanto, fonti arabe citate da «Al Arabiya» riferiscono del dispiegamento di
membri del movimento sciita Hezbollah nell’area del porto di Beirut. Fonti
vicine allo stesso Hezbollah citate dal sito «Otv» affermano che non vi è nulla
di vero sulle notizie circolate in merito a un presunto raid israeliano contro
depositi di armi del movimento filo-iraniano nel porto. In passato, Israele ha
denunciato la presenza di armi e materiale esplosivo di Hezbollah sia nel porto
di Beirut, sia a ridosso di siti civili. Fonti israeliane citate oggi dal
quotidiano «The Times of Israel» che citano anonimi funzionari dello Stato
ebraico negano qualsiasi coinvolgimento nell’accaduto.
Il messaggio del premier Conte. Ieri sera il presidente del
Consiglio, Giuseppe Conte, in un tweet ha affermato che «le terribili immagini
che arrivano da Beirut descrivono solo in parte il dolore che sta vivendo il
popolo libanese. L’Italia farà tutto quel che le è possibile per sostenerlo. Con
i ministeri degli Esteri e della Difesa stiamo monitorando la situazione dei
nostri connazionali». Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha dichiarato che
l’Italia è vicina agli «amici libanesi in questo momento tragico». «I nostri
pensieri vanno alle famiglie delle vittime, a cui esprimiamo il nostro profondo
cordoglio, e alle persone ferite, a cui auguriamo una pronta guarigione»,
aggiunge Di Maio sui propri canali social. Anche il titolare del dicastero della
Difesa, Lorenzo Guerini, ha espresso il suo messaggio di cordoglio e vicinanza.
«Appena ho appreso della tremenda esplosione a Beirut ho voluto subito
sincerarmi delle condizioni del nostro contingente in Libano. Un nostro militare
è rimasto lievemente ferito: la mia vicinanza a lui, alla sua famiglia, a tutti
i militari italiani e grande solidarietà al popolo libanese così duramente
colpito», ha scritto Guerini che ha aggiunto di aver parlato telefonicamente con
il comandante Stefano Del Col, che guida la missione Unifil in Libano. «C’è la
disponibilità di tutta la Difesa italiana a fornire aiuto e supporto», ha
affermato il ministro.
Esplosione a Beirut, il militare italiano ferito è di Bitonto. Il
sindaco: "A lui l'abbraccio di tutta la comunità". Pubblicato mercoledì, 05
agosto 2020 da La Repubblica.it. "A Roberto e alla sua famiglia vada l'abbraccio
di tutta la comunità bitontina e pugliese". È quanto scrive in un post
pubblicato su facebook Michele Abbaticchio, sindaco di Bitonto (Bari) paese in
cui risiede il Roberto Caldarulo, il militare italiano rimasto ferito a Beirut,
capitale del Libano, dove ci sono state due violente esplosioni che hanno
causato più di 100 morti e 4mila feriti. "Non riesco neanche a immaginare cosa
abbiano provato e quali devastanti ricordi resteranno nella memoria di questo
terribile evento", aggiunge il primo cittadino e conclude: "vi siamo vicini".
Caldarulo che ha 40 anni e vive nella frazione bitontina di Palombaio con la sua
famiglia, è un caporal maggiore e ha una lunga esperienza in aree di crisi. Le
sue condizioni non sono gravi.
(ANSAmed il 6 agosto 2020) - Una cittadina italiana di 92 anni è
morta nell'esplosione di Beirut e almeno dieci sono rimasti lievemente feriti.
Lo confermano fonti della Farnesina, che stanno monitorando in tempo reale la
situazione insieme all'ambasciata d'Italia a Beirut. Si tratta, secondo quanto
si apprende, di Maria Pia Livadiotti, nata a Beirut nel 1928 e moglie di
Lutfallah Abi Sleiman, già medico di fiducia dell'ambasciata d'Italia in Libano.
Esplosione a Beirut, almeno 135 morti. Tutti i dubbi
sull'incidente. Le Iene News il 05 agosto 2020. Il
giorno dopo la gigantesca esplosione (ma sarebbero state in realtà almeno due)
la capitale del Libano si presenta come uno scenario di guerra. A Beirut si
cercano ancora vittime e dispersi, i feriti sono oltre 5.000 e il bilancio si
aggrava. Mentre le cause sono ancora da chiarire. Almeno 135 morti, 100
dispersi, oltre 5.000 feriti e 300mila sfollati rimasti senza casa. Ma il
bilancio è destinato purtroppo a salire. Il giorno dopo lo scenario a Beirut è
quello di un’apocalisse. Come ha detto a caldo in lacrime il governatore della
capitale del Libano, Marwan Aboud: "Sembra quello che è successo a Hiroshima e
Nagasaki”.
LE ESPLOSIONI. Ieri, 4 agosto, attorno alle 17, una o due enormi
esplosioni hanno devastato, come vedete cliccando qui e nel video sopra, la zona
del porto con un inquietante fungo, che ricordava appunto quelli atomici, che si
è alzato sulla città dove l'onda d’urto ha colpito per almeno tre chilometri
sventrando gli edifici e danneggiando anche il palazzo presidenziale e molte
ambasciate (non quella italiana). Le esplosioni hanno spaccato vetri di case e
macchine e sparso polvere e detriti per un’area molto più ampia. Il boato è
stato sentito fino a Cipro, a oltre 240 chilometri di distanza. Una nuvola
gigantesca rossa e arancione ha avvolto Beirut, dove è stato proclamato lo stato
d’emergenza per due settimane. Tra i feriti c’è anche un militare italiano del
contingente di pace internazionale Unifil che è comunque in buone condizioni,
ferito lievemente ma rimasto sotto choc. Sembra rientrato intanto l'allarme
sugli inquinanti nell’aria dove non sarebbero presenti ancora tossine chimiche
nocive dopo che le polveri si sono depositate. Le autorità libanesi avevano
invitato in precedenza chi poteva a lasciare la città, quelle statunitensi a
“stare al chiuso”. A esplodere sarebbero state soprattutto 2.750 tonnellate di
nitrato di ammonio, confiscate al porto nel 2013 da una nave russa battente
bandiera moldava, lasciate in un container e tenute da allora lì per sei anni
non in condizioni di sicurezza. Parliamo di una sostanza usata per i
fertilizzanti, ma anche per i fuochi d’artificio, come propellente per i razzi e
come esplosivo, per esempio dai suprematisti bianchi americani nel 1995
nell’attentato di Oklahoma City, che ha provocato 168 morti, o in moltissimi
casi nelle recenti guerre in Siria, Afghanistan e Iraq. Tutti i funzionari del
porto di Beirut che dal 2014 sono stati responsabili dello stoccaggio di nitrato
di ammonio e della sua sicurezza sono stati ora arrestati e messi ai
domiciliari.
INCIDENTE O ATTENTATO? Sulle cause resta ancora il mistero e
restano aperte molte domande. A partire da due principali: cosa ha innescato
l’esplosione del nitrato di ammonio? Si è parlato di una prima esplosione in una
vicina fabbrica di fuochi d’artificio, di una nave che trasportava fuochi
d’artificio e addirittura di scintille provocate da operazioni di saldatura in
un magazzino. Sembra comunque certo che una prima altra esplosione, che avrebbe
innescato l’altra, ci sia stata. Il premier Hassan Diab promette: “I
responsabili pagheranno”. Anche sulla seconda domanda si dibatte in tutto il
mondo: si tratta davvero di un incidente o di un attentato? Nessuna ipotesi
viene per ora esclusa, le autorità resto prudenti ma sembrano puntare sul
tragico incidente. Per il presidente Usa, Donald Trump, che cita il parere si
alcuni generali, l’esplosione sarebbe stata causata da “una bomba di qualche
tipo”: “Sembra un terribile attacco”. Due circostanze l’avevano fatto pensare
all’inizio: nella zona si sarebbe trovato l'ex premier Saad Hariri, rimasto
illeso. Le esplosioni arrivavano inoltre alla vigilia della sentenza prevista
per il 7 agosto del Tribunale speciale dell’Onu sull’autobomba che uccise sempre
a Beirut nel 2005 il padre di Saad, l'ex premier Rafik Hariri assieme ad altre
21 persone. Tra gli accusati ci sono esponenti di primo piano di Hezbollah,
l’organizzazione islamica sciita vicina a Iran e Siria molto forte anche
politicamente in Libano. Finora comunque non è arrivato alcun tipo di
rivendicazione.
Crisi, aerei spia, esplosioni: cosa si è scatenato in Libano.
Lorenzo Vita il 6 agosto 2020 su Inside Over.
L’esplosione che ha trafitto Beirut non ha ancora una causa certa, né un
responsabile o tantomeno un eventuale mandante. E tutto lascia credere che
l’inferno che ha squarciato la capitale del Libano resterà per molto tempo
coperto da un fitto alone di mistero.
Il caos incendia il Paese. Nessuno per ora ha indicato un
colpevole. E questo è già una novità nel difficilissimo ginepraio libanese, dove
le fazioni lottano tra loro e dove il settarismo è prima di tutto uno strumento
di controllo di potenze esterne. Ma la situazione resta estremamente complessa e
il caos sembra destinato a governare il Paese ancora per molto, come del resto
l’intera regione. Come spiega Matteo Bressan, docente di Relazioni
internazionali alla Lumsa e analista presso il Nato College Foundation, “l’unico
dato certo è che il porto di Beirut è fuori uso e questo è un ulteriore danno
per l’economia di un Paese già ridotto allo stremo”. Ma non solo, “la tragedia
che ha trafitto la capitale libanese – rispetto alla quale non si può escludere
l’ipotesi di un incidente o legata all’incuria nello stoccaggio del nitrato
d’ammonio – si è materializzata nel contesto di una crisi di vastissime
proporzioni, assenza di prospettive politiche (la stessa che aveva portato
migliaia di persone a scendere in piazza negli scorsi mesi), e in un insieme di
tensioni regionali che possono esplodere ovunque, dall’Iraq alla Siria fino,
appunto, al Libano. Una situazione complessa in cui l’esplosione colpisce, forse
definitivamente, anche l’attuale classe dirigente che una parte consistente del
Paese ha già dimostrato di rifiutare”. E le proteste sono continuate fino a
pochi giorni prima della tragica esplosione.
Il fuoco interno ed esterno. Per ora le certezze sono molto
poche. Le indagini, come ormai noto, si concentrano sul sito di stoccaggio
di nitrato d’ammonio. Ma la presenza di questa sostanza, presumibilmente in
enormi quantità vista la grandezza dell’esplosione, è solo una parte dei nodi da
sciogliere di una deflagrazione che rischia di avere ripercussioni profonde in
un panorama internazionale già molto complesso. Non è un mistero che
il Libano sia da sempre il termometro dei cambiamenti che sconvolgono il Medio
Oriente. Il settarismo che caratterizza il Paese è stato il terreno perfetto per
far si che ogni contesa regionale trasformasse Beirut in un laboratorio di
guerra regionale. Lo è stato per lo scontro tra Stati Uniti e Urss, lo è tra
Israele e Iran, e lo è in parte anche nella grande sfida mondiale tra le tre
superpotenze che decidono i destini della regione: Usa, Cina e Russia.
Investimenti, aerei spia e visite. Nelle scorse
settimane, Associated Press aveva portato all’attenzione della stampa
internazionale l’interessamento della Cina nei confronti del Libano. La crisi
economica che sta devastando il Paese, unita all’interesse di Pechino nel
crearsi una porta sul Mediterraneo visto il freno subito in Israele, potrebbe
creare l’humus perfetto per una penetrazione cinese anche nel piccolo ecosistema
libanese. Un ingresso di non poco conto, che si innesta in un clima già
compromesso e in una fase di piena delegittimazione della classe dirigente
legata o al mondo arabo e americano o a quello iraniano. Proprio il porto di
Beirut, vero e unico hub dell’import-export del Paese, sarebbe stato il fulcro
di questo inserimento della Cina: ma è chiaro che ora gli investimenti
potrebbero – se confermati – essere dirottati nella ricostruzione più che nello
sfruttamento. E non sarebbero certo visti con molto entusiasmo da parte degli
Stati Uniti, preoccupati dalla presenza cinese nel Mediterraneo, ma anche dai
russi, che da sempre giocano un ruolo di primo piano nel delicato equilibrio
libanese, confermato sia dai rapporti costruiti negli anni con Hezbollah, sia
per gli interessi nel settore del gas, sia in ottica militare e strategica
avendo la base di Latakia a pochi chilometri dalla linea di confine. L’occhio
americano si è posato da tempo sul Libano in cerca di certezze. Occhio politico,
innanzitutto, con Mike Pompeo che già nella sua prima visita nel Paese aveva
chiesto al popolo di sollevarsi contro Hezbollah e avvertito, a stretto giro di
posta, che la presenza di fabbriche di armi, missili e siti di stoccaggio del
Partito di Dio sarebbe stata motivo di raid da parte di Israele. Una pressione
continua, che si unisce all’assedio nei confronti dell’Iran (sanzioni confermate
in queste ore), e a cui si aggiungono gli occhi, fisici e indiscreti, che da
qualche tempo hanno iniziato a vegliare più da vicino sul Mediterraneo orientale
e sulle coste siriane e libanesi. Circa 24 ore prima dell’esplosione che ha
devastato Beirut, i siti di tracciamento dei voli militari hanno più volte
segnalato un inusuale traffico di aerei americani che facevano avanti e indietro
nel tratto di mare davanti alle cose della Siria e poco a nord del Libano.
Un Lockheed EP-3 e tre P-8 Poseidon partiti dalle basi di Sigonella e di Souda
(a Creta) hanno perlustrato per ore il tratto di mare in questione per poi
tornare alla base. Nel frattempo arriva un altro segnale da non
sottovalutare: Emmanuel Macron, con un gesto inaspettato, ha annunciato la sua
visita a Beirut con la volontà – spiegano le fonti dell’Eliseo – di incontrare
“tutti gli attori politici”. Non è un mistero l’interesse che da sempre la
Francia nutre nei confronti del Libano, ma è altrettanto importante sottolineare
la mossa repentina di Macron, che in questo modo si accredita come interlocutore
privilegiato europeo in Libano nel momento peggiore della crisi. Parigi sa che è
un’opportunità da cogliere e si è mossa molto rapidamente. I legami con l’Iran e
il riavvicinamento con la Russia possono essere una base importante per Macron
per strappare consensi e posizioni di forza in Libano. E da parte Usa potrebbe
esserci il semaforo verde per un intervento più massiccio della diplomazia
francese. E l’Italia deve stare attenta, visto che il comando italiano
di Unifil è oggi un elemento fondamentale che ci pone in un punto di forza
rispetto agli altri attori europei.
Il nodo Hezbollah e le mosse di Israele. Tutto questo ricade poi
nella guerra non dichiarata (ma combattuta) che coinvolge Israele e Iran. E in
cui il Libano, soprattutto tramite la presenza di Hezbollah, diventa
inevitabilmente uno dei principali terreni di scontro. Il governo israeliano ha
per ora concesso piena disponibilità per aiutare il Libano. Ma se da parte di
Beirut tutto tace, confermando l’enorme freddezza nei rapporti, non va
sottovalutato il fatto che i media dello Stato ebraico inizino a parlare
del pericolo della presenza dei siti di stoccaggio di nitrato d’ammonio o
di munizioni di Hezbollah nelle aree residenziali del Libano. Il Jerusalem
Post e Haaretz, tra i maggiori quotidiani israeliani con una versione in
inglese, hanno acceso nuovamente i riflettori su questa strategia del movimento
di Hassan Nasrallah, ricordando anche di come il leader sciita aveva minacciato
di colpire Israele proprio attraverso “bombe di ammoniaca”. Ed è chiaro che la
conferma della presenza di migliaia di tonnellate di nitrato d’ammonio nel porto
di Beirut potrebbe essere il volano di Israele per condurre una più massiccia
campagna di intelligence e mediatica contro Hezbollah in Libano.
Strage a Beirut, sei allarmi ignorati «Arrestare i
responsabili del porto. Marco Ventura per “il
Messaggero” il 6 agosto 2020. Il day after di Beirut ha il volto di una città
ufficialmente dichiarata disastrata dal governo libanese, con tre giorni di
lutto e diversi ospedali distrutti dalla terribile esplosione di martedì, con i
malati di Covid costretti in strutture da campo e gli altri nosocomi al
collasso, la disperata ricerca di sangue, medici e infermieri, e l'allarme
dell'Unicef per la situazione dei bambini, i più fragili i più colpiti, lo
spettro di un avvitamento della già catastrofica crisi economico-finanziaria e
politica del Paese dei Cedri, di Beirut la Parigi del Medio Oriente, e la corsa
del mondo a mandare aiuti.
IL BILANCIO. Il bilancio delle vittime ieri sera parlava di 135
morti e 5mila feriti. Molti purtroppo i dispersi, sepolti dalle macerie con le
squadre di soccorso. Come nell'11 Settembre. Uccisi 16 pazienti e dipendenti del
Saint George University Hospital, 4 erano infermieri. Ed era una delle maggiori
cliniche private impegnate nella lotta al Covid-19. L'entità della devastazione
provocata dalla deflagrazione di 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio stoccate
nel porto è come se fosse stata provocata da un terremoto di magnitudo 3.3. I
quartieri orientali cristiani più vicini al porto sono quelli investiti
direttamente: Mar Mikhael, Geitawi, Ashrafieh, Bourj Hammoud. Ma ci sono anche
una base Unifil e molte residenze internazionali. Ferita gravemente la moglie
dell'ambasciatore dei Paesi Bassi. La rappresentanza è stata colpita in pieno.
IL FUTURO. C'è chi parla di classe media di Beirut ridisegnata
dalla tragedia. Per tutti i libanesi si annunciano adesso giorni spaventosi,
perché nel porto c'erano i silos del grano, l'85 per cento delle riserve cereali
del Libano e anche se il ministro dell'Economia e Commercio rassicura i
connazionali dicendo che c'è da mangiare a sufficienza, tutte le scorte del
porto, anche quelle non annientate, devono considerarsi contaminate dalle
sostanze tossiche sprigionate da incendi e deflagrazione. C'è quindi un allarme
chimico, che sembra ridursi di ora in ora con il deposito delle sostanze a
terra. Il presidente della Repubblica, Michel Aoun, ha convocato una riunione
con il governo, chiedendo che i responsabili siano presto individuati.
L'esecutivo ha chiesto alla magistratura militare di mettere agli arresti
domiciliari durante l'inchiesta tutti i responsabili che nel porto hanno avuto a
che fare con la gestione del nitrato di ammonio, che secondo il ministro
dell'Interno, Mohammed Fehmi, vi era stoccato dal 2014. I funzionari doganali
inviarono cinque/sei lettere ai giudici tra il 2014 e il 2017 chiedendo loro
cosa fare del carico sequestrato, che venne messo nel deposito numero 12 del
porto. Le richieste dei funzionari sono sempre cadute nel vuoto.
LO SCENARIO. La misura dello scenario da ecatombe è data anche
dalle immagini della nave da crociera,la Orient Queen, di proprietà
dell'imprenditore libanese Mari Abu Mehri, stava attraccando e si è lentamente
eclissata: i due membri dell'equipaggio rimasti uccisi vengono chiamati martiri,
difficile in Medio Oriente distinguere le tragedie accidentali dal lessico della
guerra. Ci sono poi i senza casa, i numeri oscillano fra 250mila e 300mila. Per
la Federazione alberghiera libanese, il 90 per cento degli Hotel nella capitale
è stato danneggiato. Intanto il Tribunale speciale dell'Onu ha deciso di
rinviare al 18 agosto la sentenza, in origine prevista per venerdì, sulla morte
dell'ex primo ministro Rafik Hariri. I tafferugli scoppiati tra seguaci e
avversari di Hariri che punta l'indice contro i terroristi sono già una prima
avvisaglia dell'onda d'urto politica del grande boato di martedì.
Marco Ventura per "il Messaggero" il 9 agosto 2020. La rabbia dei
libanesi in Piazza dei Martiri, nel centro di Beirut. Scene di guerriglia
urbana. A migliaia invocano le dimissioni dell'intero governo. Nel buio prodotto
dal black out dopo l'apocalittica esplosione di martedì, contro i bagliori e i
fumi dei mezzi della protezione civile dati alle fiamme spiccano le sagome dei
manifestanti che lanciano pietre e sbandierano gli striscioni per la
rivoluzione! contro i politici («Andatevene, assassini!»). Ai lanci di pietre,
esercito e poliziotti rispondono con appelli alla calma («Anche noi abbiamo
avuto i nostri martiri al porto») e con pallottole di gomma e lacrimogeni. In
serata 238 i feriti, a decine portati in ospedale. Un poliziotto muore
precipitando nel pozzo di un ascensore, inseguito dai rivoltosi. In fiamme la
sede dell'Associazione delle banche e l'edificio davanti al ministero degli
Esteri, dove un manipolo capeggiato da un ufficiale dell'esercito in pensione
irrompe e lo ribattezza sede della Rivoluzione.
ASSALTO AI MINISTERI. È l'inizio dell'assalto ai ministeri. In
fiamme quello dell'Energia. Riecheggiano per le strade i canti del 2011, quelli
della Primavera araba: «La gente vuole la caduta del regime». Giovani stanchi
della vecchia classe dirigente si uniscono agli sfollati che a Beirut sono ormai
centinaia di migliaia. «Non avete coscienza, non avete moralità! Go home!
Andatevene. Dimettetevi, quando è troppo è troppo». I cittadini di Beirut
protestano non più solo perla crisi economico-finanziaria epocale, ma per la
vita e la morte dopo la deflagrazione simbolo dell'incapacità e corruzione del
regime. Gli USA appoggiano i rivoltosi e la Francia sceglie di smentire il
tentativo del presidente Aoun di attribuire a interferenze esterne (bomba,
missile, altro?) la devastazione che ha distrutto un terzo delle case di Beirut
e provocato 158 vittime, 21 ancora da identificare, e 25 dispersi. «Ci sono
elementi oggettivi a sufficienza per ritenere che l'hangar sia esploso per
motivi accidentali», dichiara l'Eliseo. Ieri è morta Hedwig Waltmans-Molier, 55
anni, moglie dell'Ambasciatore d'Olanda, investita dall'esplosione nel suo
salotto. E se al ministero degli Esteri i rivoltosi strappano dai muri e
frantumano le fotografie del presidente Aoun, in Piazza dei Martiri i
manifestanti alzano finte forche, col manichino fra gli altri del leader degli
Hezbollah, Hassan Nasrallah. C'è pericolo che si scontrino tra loro le fazioni.
Vedendo il fantoccio del leader al capestro, i miliziani sciiti filo-iraniani
cercano di raggiungere la piazza, fermati solo dall'esercito sul Ring. Sotto
attacco, in serata, i ministeri dell'Economia, del Commercio e dell'Ambiente. Si
sentono spari. In un estremo tentativo di mitigare la rabbia della gente, il
premier Hassan Diab in un discorso alla nazione assicura che «la strage del
porto non resterà impunita» e dà un ultimatum di due mesi ai partiti politici
per trovare una soluzione, altrimenti si andrà a elezioni anticipate. Promessa
che non basta a una popolazione inferocita, che non ha visto un solo leader
confrontarsi direttamente nelle strade o visitare i luoghi della sofferenza per
dare risposte. Solo sermoni alla Tv e dichiarazioni rilanciate dalle agenzie.
BLACKOUT INTERNET. Intanto cede la rete Internet, forse come
conseguenza dell'esplosione, o forse per decisione delle autorità, per sabotare
le comunicazioni tra i rivoltosi. Altri gruppi cercano di travolgere le barriere
in cemento che chiudono la strada verso il Parlamento. Altri edifici in fiamme.
Nelle mani di chi protesta c'è la foto di Alexandra, 4 anni, che regge una
minuscola bandiera del Paese dei Cedri in uno dei cortei dello scorso ottobre.
Ma Alexandra è tra i morti dell'esplosione. «L'hanno uccisa! Protestate per
lei», incita un internauta. Intanto è volato ieri a Beirut il presidente della
UE, il belga Charles Michel. E oggi si terrà la conferenza dei donatori
organizzata da Francia e Onu, parteciperà via web Trump ma non l'Iran. E cresce
l'attivismo della Turchia che si offre per la ricostruzione del porto di Beirut,
mette a disposizione quello di Mersina nell'Anatolia Orientale, e promette aiuti
alimentari e finanziari.
Rivoluzione a Beirut, irruzione nei Ministeri: “Dimettetevi”.
Morto poliziotto, oltre 100 feriti. Redazione su Il
Riformista l'8 Agosto 2020. Tensione alle stelle a Beirut dove da diverse ore è
in corso una protesta rivoluzionaria contro il Governo. La polizia ha
sparato gas lacrimogeni contro i dimostranti che hanno tentato di raggiungere il
Parlamento. Lo hanno riferito i media locali. I manifestanti, che secondo video
diffusi sui social media sfilano nelle strade scandendo slogan contro il governo
e l’elite politica, hanno lanciato pietre contro gli agenti e tentato di
abbattere barriere metalliche. Le proteste seguono la violenta esplosione al
porto di Beirut, che ha causato la morte di oltre 150 persone e la devastazione
della capitale. I dimostranti libanesi a Beirut hanno fatto irruzione del
ministero degli Esteri, nel distretto di Achrafieh. Lo ha riferito al-Arabiya.
IL BILANCIO MOMENTANEO: OLTRE 100 FERITI E UN MORTO – Un
poliziotto libanese è morto nel corso degli scontri a Beirut, nelle violente
proteste contro la classe politica. Lo hanno riferito i media locali. Ventidue
persone sono state invece portate in ospedale a Beirut, dopo che sono rimaste
ferite nelle manifestazioni contro il governo a seguito dell’esplosione in cui
sono morte oltre 150 persone. Altre sono state curate sul posto. L’ha fatto
sapere su Twitter la Croce rossa libanese. Il bilancio momentaneo dei feriti è
di 109 unità.
IRRUZIONE MINISTERO DEGLI ESTERI: “SEDE RIVOLUZIONE” – Un gruppo
di dimostranti, tra cui ex militari in pensione, ha occupato il ministero degli
Esteri di Beirut. I dimostranti hanno dichiarato che il palazzo sarà la sede
della “rivoluzione” e hanno chiesto al governo di dimettersi. Uno degli
ufficiali in pensione, Sami Ramah, ha letto una dichiarazione all’ingresso
dell’edificio, dopo che circa 200 manifestanti hanno fatto irruzione sventolando
le bandiere con l’immagine del pugno, simbolo delle proteste contro l’elite
politica: “L’autorità deve dimettersi”. I dimostranti hanno anche dato fuoco a
documenti e fotografie del presidente Michel Aoun.
MINISTERO ECONOMIA – Irruzione anche negli uffici del ministero
dell’economia nel centro di Beirut. I manifestanti hanno gettato dalle finestre
una pioggia di documenti e un’immagine del presidente Michel Aoun. Lo ha
riferito un giornalista di Al Jazeera sul posto. I militari hanno sparato gas
lacrimogeni e pallottole di gomma per disperdere la folla. Una parte dei
manifestanti si è riparata dietro un muretto di pietra accanto alla Moschea al
Amin, nella Piazza dei Martiri, gridando: “Rivolta! Rivolta!”.
ALLESTITE FORCHE – Nella piazza sono state allestite delle forche
da cui pendono numerosi capestri, simbolo della rabbia popolare contro l’elite
al potere. Quella odierna è la prima grande manifestazione dopo la tragedia di
martedì e gli organizzatori hanno previsto di tenere un simbolico funerale per
le vittime. Intanto, sono subito scoppiati scontri: gruppi di giovani hanno
lanciato pietre contro gli agenti di sicurezza. Vicino al palazzo del
Parlamento, la polizia in assetto antisommossa ha sparato contro i lacrimogeni
contro quanti lanciavano oggetti e tentavano di superare le barriere per
avvicinarsi all’edificio. I dimostranti hanno anche dato fuoco a un camion che
era stato posto in strada per rafforzare le barriere.
LA PROTESTA DEL PARTITO CRISTIANO – Intanto il presidente del
partito cristiano libanese Kataeb, Samy Gemayel, ha annunciato che i tre
deputati del gruppo in Parlamento si dimetteranno per protesta contro il governo
per l’esplosione mortale di questa settimana. Gemayel ha parlato al funerale di
un alto funzionario del partito che è stato ucciso dall’esplosione al porto di
Beirut. Il partito fa parte dell’opposizione ed è noto per le sue aspre critiche
al governo, sostenuto da Hezbollah e dai suoi alleati. Il Parlamento libanese ha
128 membri e alcuni deputati hanno annunciato che si dimetteranno per protesta
contro la corruzione diffusa. Marwan Hamadeh si è già dimesso in settimana.
ONU E FRANCIA: PUNTO SU DONATORI – L’ufficio del presidente
francese, Emmanuel Macron, ha confermato che domani (domenica) si terrà una
conferenza internazionale sugli aiuti per sostenere il Libano dopo l’esplosione
di Beirut. La videoconferenza, in programma alle 14, sarà ospitata dalla Francia
e dalle Nazioni unite, ha dichiarato l’ufficio di Macron. Il presidente degli
Stati Uniti, Donald Trump, venerdì ha dichiarato che parteciperà, così come
anche altri leader internazionali. Macron, che giovedì è stato in visita a
Beirut, ha promesso che gli aiuti non andranno in “mani corrotte”, ma a ong e
popolazione civile. Il presidente francese è stato il primo leader straniero a
visitare il Paese dopo la devastante esplosione.
MORTA MOGLIE AMBASCIATORE OLANDESE – Il ministero degli Esteri
olandese ha fatto sapere che Hedwig Waltmans-Molier, moglie dell’ambasciatore
del Paese in Libano, è morta per le ferite riportate nella massiccia esplosione
che ha colpito Beirut all’inizio della settimana. Waltmans-Molier, che lavorava
nel dipartimento delle risorse umane dell’ambasciata, è morta in mattinata,
all’età di 55 anni. “Era in piedi nel soggiorno accanto a Jan e per pura
sfortuna è stata colpita dall’esplosione”, ha spiegato il governo olandese,
aggiungendo che la famiglia era recentemente tornata a Beirut dopo una vacanza.
Il ministro degli Esteri Stef Blok e l’omologa del Commercio estero Sigrid Kaag
hanno espresso le condoglianze alla famiglia.
Libano, il generale Angioni: “Sono tutti colpevoli,
scongiurare nuova Siria”. Umberto De Giovannangeli su
Il Riformista il 9 Agosto 2020. «Il “mio” Libano non merita di morire. E
l’Italia non può, non deve tirarsi indietro dall’impegno di contribuire alla
rinascita, non solo economica, di un popolo meraviglioso, generoso, che ho avuto
modo di conoscere e apprezzare in uno dei momenti più drammatici della sua
storia. Ma per rinascere, il Libano è chiamato a superare quel “comunitarismo”
etnico-religioso che rischia di soffocarlo». A sostenerlo in questa intervista a
Il Riformista è il generale Franco Angioni, già comandante delle truppe
terrestri Nato nel Sud Europa e del contingente italiano in Libano negli anni
più duri della guerra civile che dilaniò il Paese dei Cedri.
Generale Angioni, il Libano piange le vittime della tremenda
esplosione di martedì scorso al porto di Beirut. Il dolore si sta trasformando
in rabbia, come dimostrano gli scontri dell’altra notte tra dimostranti e
polizia. Il Libano sta morendo?
«Vivo con dolore e trepidazione i
tragici eventi che stanno segnando un Paese e un popolo che ho imparato a
conoscere e ad amare. C’è un detto napoletano che quando qualcuno lascia un
posto in cui sei stato bene, in quel posto lascia un piezz’e core. Ed io ho
lasciato un pezzo del mio cuore lì dove si era verificato qualcosa: o si era
nati, o ci si era formati, o si era vissuto, o si era trovato il meglio della
propria vita. La mia parentesi libanese ha sicuramente lasciato il segno
indelebile nella mia formazione e nella mia stessa vita. Di conseguenza sono
legato a questo Paese, perché mi ha consentito non solo di rivelarmi, ma di
rivelare anche agli altri le cose importanti che l’Italia era in grado di
realizzare, la capacità di essere vicino alla gente, e di uscire dignitosamente
da una impresa che all’inizio aveva destato molte perplessità. Il mio ricordo
del Libano, è un ricordo umano ma anche culturale. Ho apprezzato molto questo
Paese per la sua formazione, per le sue antiche radici, che sono cambiate nel
tempo in maniera vistosa e che continuano ancora a cambiare. Quando noi eravamo
in Libano, il Sud del Paese era una parte negletta, quasi inesistente. Poi è
nato qualcosa di pericoloso e complesso…»
Vale a dire?
«Hezbollah. Ma con Hezbollah quella
parte del Libano non è “rinata”. È nata. E questa “nascita” ha rafforzato una
esperienza favolosa da tanti punti di vista: umano, professionale, ma anche da
un punto di vista morale, perché abbiamo assistito a un cambiamento di un Paese
importante, non solo per il Mediterraneo ma credo per il mondo».
Oggi, però, quel Libano nel quale lei ha lasciato un pezzo di
cuore, sembra sempre più uno Stato fallito, con una crisi economica e sociale
devastante ed oggi ancora più aggravata da questa immane tragedia che ha colpito
Beirut. Per il Libano siamo all’inizio della fine?
«Il Libano non è stato distrutto con
l’esplosione del deposito di nitrato d’ammonio e di chissà cos’altro al porto di
Beirut. Il Libano ha cominciato a spegnersi più di quindici anni fa, lentamente.
Dopo un cambiamento favoloso, il Paese dei Cedri è precipitato. Il cambiamento
favoloso si è avuto quando si è scoperto che il Sud del Libano non era la parte
negletta del Paese, ma era semplicemente una parte abbandonata, trascurata. E
invece ha avuto dei momenti di grande pulsione. E questo si deve, è inutile
nascondercelo, alla nascita di un partito: Hezbollah. Quando sono nati, nel Sud
del Libano, gli hezbollah hanno dato vita a questa parte del Paese. E i
cristiani maroniti, nonostante la loro gloria, la loro storia meravigliosa,
questa parte del Libano avevano sempre un po’ trascurato. Di conseguenza, il
Libano che io ho conosciuto e che ho poi lasciato, era formato da due
componenti: la comunità maronita, cioè i cristiani, e i sunniti, la parte
musulmana del Libano che però non era la più numerosa. Tutto il resto è come se
non fosse esistita. E invece, a un certo punto, la parte più numerosa della
popolazione, che era abbandonata e che stazionava soprattutto nel Sud del
Libano, la comunità sciita, ha ripreso a vivere. E checché se ne dica, ha
ripreso a vivere grazie a Hezbollah. Hanno dato l’anima, hanno dato vigore a
questa comunità emarginata, senza potere. E quindi il Libano si è risvegliato,
ma in modo contraddittorio e alla fine negativo. Il Libano era un paradiso, la
“Svizzera del Medio Oriente”. Gli hezbollah inizialmente dettero una scossa di
grande vigore, e poi...»
E poi, generale Angioni?
«Poi sono rimasti ancorati ai propri
aspetti più negativi: il contrasto con Israele, lo scontro costante ha fatto sì
che non ci fosse sviluppo nel Paese. E così il Libano si è accartocciato su se
stesso, e di conseguenza questo florido esempio di comunità nell’ambito del
Mediterraneo, questa terra benedetta da Dio, con il suo clima eccezionale, con
la sua rigogliosa natura, questa terra è stata violata e distrutta dalla volontà
di non ricercare una visione condivisa da parte delle varie comunità.
L’identitarismo comunitario ha prevalso sul senso di appartenenza nazionale. Le
comunità, che erano state il motore del Paese, hanno finito per pensare solo a
se stesse, vedendo le altre come una minaccia, come un nemico da combattere. Il
bene comune è venuto meno. E la tragedia di Beirut ha messo in evidenza, una
tragica evidenza, di come è stato ridotto questo Paese meraviglioso. Dopo questa
esplosione, il Libano ha necessità di risorgere. E l’Europa non deve sottrarsi a
questa missione».
Risorgere, ma come?
«Con la volontà degli uomini,
compresi quelli che l’hanno portato alla distruzione. Nessuno può chiamarsi,
ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Non c’è differenza tra sciiti,
sunniti, maroniti, sono tutti colpevoli, nessuno di loro ha pensato che il
diritto a tutelare la propria comunità, che va rispettato, non può trasformarsi
nella volontà di distruggere le altre. Il Libano deve tornare ad essere un
Paese, una comunità nazionale anche se articolata in comunità con diverse
storie, culture, esperienze, tradizioni ma queste diversità possono essere una
ricchezza comune e non strumenti di odio e di violenza. La ricostruzione, non
solo materiale ma morale, deve essere inclusiva, altrimenti è destinata al
fallimento. E allora sì che il Libano precipiterebbe nel baratro».
Si fanno numerose congetture e ipotesi su quello che è
realmente accaduto nel porto di Beirut. C’è anche l’ipotesi di un attentato.
Sulla base della sua esperienza, che idea si è fatta in proposito?
«In base a quanto ho letto, l’idea
che mi sono fatto è che la ricostruzione dell’accaduto offerta dalle autorità
libanesi può essere veritiera all’80%. Ma non è tutta la verità. Non ho elementi
per sostenere l’ipotesi dell’attentato. È probabile che a esplodere non sia
stato solo il nitrito d’ammonio custodito in un hangar del porto ma anche un
deposito di armi. Ciò che resta inconcepibile, sotto ogni punto di vista, è che
quelle tonnellate di nitrito d’ammonio siano state custodite per anni in un
porto nel cuore della città. Questa non è incuria, dabbenaggine, è una
responsabilità in strage che deve essere sanzionata in un’aula di tribunale. Se
incidente è stato, è stato colposo. E il popolo libanese lo ha capito e per
questo esige verità e giustizia per le vittime di questa tragedia. Le
responsabilità vanno ricercate a ogni livello, senza fare sconti a nessuno.
L’impunità sarebbe come oltraggiare la memoria delle vittime e dei loro
famigliari, oltre che prova di arroganza di poteri che si credono al di sopra
della legge. Il Libano è uno Stato sovrano, con un suo legittimo esercito. È
lecito, però, chiedersi chi esercitava davvero il controllo di quella zona, che
certo non poteva essere considerata una “zona franca”».
Mercoledì scorso, il giorno dopo la tragedia al porto di
Beirut, il presidente francese Emmanuel Macron si è precipitato nella capitale
libanese. E la sua, è stato rilevato da più parti, non è stata solo una visita
di solidarietà umanitaria ma anche di un forte valore politico. A Beirut erano
assenti le autorità italiane, il presidente del Consiglio, il ministro degli
Esteri. L’Italia si sta autoemarginando, o viene messa ai margini, dalla scena
mediorientale?
«Purtroppo questa preoccupazione è
fondata. Il pericolo c’è. Ed è un peccato, perché è come rinunciare ad una
eredità. L’Italia ha acquisito in Libano, fin dal 1982, ma anche prima, una
reputazione, una ammirazione notevolissime. Non va dimenticato che l’Italia è
presente nel Sud del Libano, con i nostri militari inquadrati nella missione
Unifil dell’Onu, peraltro con responsabilità di comando. E questa missione sta
garantendo da 14 anni, per restare a Unifil II, una stabilizzazione della
frontiera tra Israele e il Libano. L’Italia deve rivendicare questa presenza e
affiancarla implementando la cooperazione con il Libano, favorendo le nostre
imprese impegnate in vari settori, tanto più oggi che il Libano deve essere
aiutato a risollevarsi. Dobbiamo farlo, perché non scompaia un Paese che, sia
pure tra mille fragilità, resta un esempio, non solo istituzionale, di una
possibile convivenza tra comunità etnico-religiose diverse. E questo vale
soprattutto per la presenza della Chiesa cattolica e dei cristiani, come
sottolineato più volte da papa Francesco. Il Libano non deve trasformarsi in una
“nuova Siria”».
La testimonianza di Sara, l’italo-libanese: “Nel mio paese c’è
l’inferno, è il peggior periodo della sua storia”.
Roberta Caiano de Il Riformista il 6 Agosto 2020. “L’esplosione mi ha
letteralmente spezzato il cuore in due, il dolore immenso che in questo momento
provo è lacerante non per l’evento catastrofico in sé, ma perché è l’ennesima
goccia in un mare di disastri che si susseguono ormai da più di un trentennio
senza fine. E’ devastante tutto ciò che sta martoriando da mesi il mio Paese.
In Libano c’è l’inferno, letteralmente”. Ad accompagnare questo toccante
racconto sono le lacrime di Sara, una ragazza italo-libanese poco più che
trentenne che tra rabbia e dolore prova a dare dignità ad un popolo che sta
vivendo la fase più buia della sua storia. L’esplosione accaduta lo scorso 4
agosto a Beirut è stata devastante, un disastro forse senza precedenti. Il
bilancio delle vittime e dei feriti continua a salire vertiginosamente, così
come il numero dei dispersi e degli sfollati. Le persone assumono lo stesso
stato d’animo di una città afflitta e distrutta. In poco tempo il mondo della
rete si è riempito di immagini e video che mostrano gli attimi della
deflagrazione, così come anche di ipotesi e spiegazioni alla causa di questo
disastro. Non è chiaro, infatti, quale sia stata l’origine delle esplosioni.
Fatto sta che questo terribile episodio giunge in un periodo delicato per il
Libano, in preda ad una gravissima crisi economica e al forte malcontento
popolare per cattiva gestione e corruzione da parte dell’élite al potere.
IL RACCONTO – La stessa Sara ci racconta che “il Libano sta
vivendo il peggior periodo della sua storia; peggiore della guerra civile degli
anni 80, peggiore della guerra del 2006, peggiore dei tanti attentati subiti dal
popolo; peggiore di sempre”. Vissuta tra il Libano e l’Italia, Sara è molto
addolorata per ciò che sta accadendo al suo Paese. Il richiamo delle origini la
fa sprofondare in un sentimento di tristezza e dolore per ciò che il popolo
della sua terra è costretta a subire. “Il popolo libanese è noto da sempre per
essere un popolo allegro, ospitale, fiero, speranzoso e forte, in grado di
alzarsi anche dopo la peggiore delle catastrofi”, racconta la ragazza
preoccupata per la piega che sta prendendo la situazione nella Terra dei Cedri.
La storia di Sara, infatti, spazia tra il territorio italiano e quello libanese,
ed è lei stessa a voler descrivere “con orgoglio e fierezza” la sua storia. “Ho
la fortuna di essere nata in una splendida famiglia multiculturale, mio padre
italiano e mia madre libanese, si sono incontrati proprio in Libano durante gli
anni bui della guerra civile – spiega Sara – Io sono nata in Italia, ma ancora
piccola ci siamo trasferiti in Libano e ho avuto un’altra grande fortuna: quella
di studiare e crescere in Libano ed imparare a leggere e scrivere l’arabo, il
francese, l’inglese e non solo. Nel frattempo, siamo rientrati in Italia e ho
proseguito i miei studi secondari e l’università in Italia. Attualmente io e la
mia famiglia viviamo a Roma, ma il mio cuore non ha mai lasciato il
Libano”. Sara ripercorre le tappe della sua vita da “meticcia” con emozione,
affermando di vivere questo mélange di culture “in maniera serena e fiera:
quando ero in Libano, venivo chiamata “l’italiana” e spesso i miei coetanei
erano curiosi della mia storia; lo stesso mi è successo quando sono tornata in
Italia, nonostante parlassi perfettamente l’italiano, ero la “libanese”, e ne
sono sempre andata fiera”. I parenti materni di Sara, infatti, vivono in Libano
ma come lei spiega “vengono regolarmente da noi in Italia, e parlano tutti
l’italiano in maniera impeccabile”. Nonostante siano originari
di Sarba e Jounieh, a 15 chilometri da Beirut, hanno sentito il boato fortissimo
dell’esplosione nella capitale e “sono saltati in piedi, spaventatissimi, ma
nessun effetto collaterale stavolta per fortuna”. Già, stavolta. Perché come
racconta Sara, “nella guerra del 2006 mio cugino più piccolo era rimasto
traumatizzato dalle bombe e ogni volta che sentiva anche un semplice aereo
sorvolare vicino casa correva a nascondersi sotto il letto“. Racconti che ci
sembrano così distanti da noi, eppure così vicini.
GLI HEZBOLLAH – “La mia famiglia è cristiana maronita, siamo
originari di due quartieri che sono tradizionalmente cristiani, e anche da
piccola non ho mai percepito o visto attriti tra musulmani e cristiani. Questa
terra è magica anche perché è riuscita a creare una pacifica convivenza tra fedi
così opposte e diverse“. Per una collocazione geopolitica ben definita della
Terra dei Cedri, il tassello che Sara va ad incastrare nella scacchiera
complessiva dei giochi di potere è fondamentale. Per riuscire ad avere un’idea
ancora più chiara, lo zio di Sara, un avvocato cittadino libanese cristiano,
afferma che per noi occidentali “è difficile comprendere quanto sia complicato
creare un governo in Libano, poiché il paese è composto da metà cristiani e metà
musulmani (sunniti e sciiti a loro volta). I musulmani sunniti e sciiti sono
l’uno contro l’altro, attriti in cui l’Iran ricopre un ruolo
importantissimo”. Il Libano in effetti è l’unico Paese nel Medio Oriente,
insieme all’Iran, che ha un orientamento piuttosto europeo per la presenza di
cristiani che ha un peso davvero rilevante. Ed è qui che si inseriscono i
famigerati Hezbollah, i ministri sciiti ovvero filo iraniani finanziati
direttamente da Teheran. “I Hezbollah sono ben radicati nella società e nella
politica libanese perché il loro obiettivo è quello di prendere il potere e
soggiogare il libano. Aiutano e finanziano quei quartieri in cambio di
combattenti che stiano dalla sua parte. “Aiutano il popolo” così come la mafia
aiuta in Italia, per creare un paragone valido…”, spiega la ragazza. “I
Hezbollah hanno rappresentanti al governo perché la popolazione delle regioni
del sud del Libano li votano e vengono così sostenuti economicamente, inoltre
chi si rifiuta di votarli o li contrasta vengono cacciati via e – aggiunge
– dove ci sono grandi interessi i hezbollah aiutano solo la parte sciita per
poter continuare ad avere un ruolo attivo nel governo libanese”. In poche
parole, pagano il popolo Sud libanese per essere votati, costruiscono scuole,
strade e cercano di aiutarli in questo modo in cambio di “mercenari” e di
persone che li votano per poter rimanere al governo. E in tutto questo, qual è
il ruolo di Israele e degli Stati Uniti? “Sono alleati, sono contro l’Iran e di
conseguenza contro i hezbollah. La situazione tragica che sta vivendo la mia
terra è una conseguenza dei “duelli” fantasma tra America e Iran che fanno
sfociare i loro scontri indirettamente, in Libano. Francia, Italia e Stati Uniti
hanno classificato hezbollah come organizzazione terroristica”, conclude Sara.
LA SITUAZIONE IN LIBANO – Attraverso i racconti di
un’italo-libanese possiamo renderci conto di quanto sia dura vedere il proprio
popolo in ginocchio. “I libanesi stavano già combattendo contro le ingiustizie
politiche, contro una crisi finanziaria e la disoccupazione dovuta proprio a
questi sporchi giochi politici, contro la fame, il caldo, la mancanza di
elettricità, contro il cibo e l’acqua contaminati. Questa esplosione è stata la
goccia che ha fatto traboccare il vaso”. Nella terra medio orientale, infatti,
si portano avanti manifestazioni, per lo più assolutamente pacifiche, guidate da
studenti e giovani con la voglia di avere un futuro nel proprio paese, contro un
governo che continua a imporre tasse senza nessuno sguardo ai bisogni reali
della popolazione. Queste manifestazioni sono sfociate in un declino economico
vertiginoso, gli enti finanziari hanno bloccato tutti i conti correnti, le
società non avevano più liquidità e, non potendo più pagare i dipendenti sono
state costrette a chiudere. La lira libanese è stata svalutata al punto che, al
supermercato oggi 10.000 lire libanesi ne valgono 1.000. Senza soldi, senza
lavoro, senza nessuna soluzione all’orizzonte il popolo inizia a deprimersi e a
non vedere più la luce. Sara stessa ci descrive che “il tasso di suicidi è
centuplicato, gli attacchi cardiaci con conseguente morte non si contano più. La
gente è stanca di vivere una vita non più dignitosa. Le persone, ad oggi, non
hanno elettricità, hanno i frigoriferi vuoti se non spenti, e mangiano e vivono
alla giornata. Chi, qualche mese fa era un affermato professionista, oggi fa i
conti con quanta farina ha come riserva e se riesce a cucinare abbastanza per
poter sopravvivere al domani. Gli ospedali sono senza elettricità, ho visto
immagini sconvolgenti di dottori e infermieri che operavano con la luce dei
telefoni, niente più” – continua Sara – “Chi ha bisogno di cure, non può più
curarsi perché l’assicurazione sanitaria costa molto e non si hanno più i soldi
per potersela permettere. In Libano vige un sistema a stampo americano, la
maggior parte delle strutture sono private e non ci sono i servizi pubblici
essenziali come in Italia. Nel frattempo, l’epidemia di coronavirus, che sta
dilagando in tutto il mondo, non ha di certo risparmiato il Libano. E così si
aggiungono disastri su disastri”. L’auspicio di Sara è che questa situazione
venga sottoposta quanto più possibile sotto i riflettori di tutto il mondo,
compresa l’Italia: “Non possiamo permettere che questa splendida terra, così
amata dagli italiani, così vicina a noi, possa morire dimenticata da tutti”.
Chi è la sposa di Beirut protagonista del video durante
l’esplosione. Redazione de Il Riformista il 7 Agosto
2020. Felice, con l’abito bianco nel giorno del suo matrimonio si lascia
riprendere dal fotografo in mezzo a una piazza. Poi all’improvviso l’esplosione
del porto di Beirut dilaga alle sue spalle e scappa. Questo il video che negli
ultimi giorni sta facendo il giro del mondo. Il New York Times ha rintracciato
la sposa e ha raccontato la sua storia. Si chiama Israa Seblani, ha 29 anni e
sta completando una specializzazione in endocrinologia in un ospedale
di Detroit, negli Stati Uniti. Da poco era rientrata in Libano per sopsare il
suo compagno, Ahmad Sbeih. Un sogno che si realizza: da tre anni stavano
rimandando perché lui era in attesa di ottenere i visti per raggiungerla
negli USA. Poi avevano deciso di sposarsi in Libano. Al momento dell’esplosione
era in compagnia del fotografo mentre giravano il video e le foto per il
matrimonio. Si trovava nel quartiere di Saifi, a un chilometro e mezzo dal
porto, epicentro dell’esplosione. Poi all’improvviso il boato e l’esplosione che
li ha travolti. Così Israa è fuggita sotto braccio con il suo Ahmad. La ragazza
racconta che è successo tutto all’improvviso: l’urto dell’esplosione l’ha
buttata a terra, mentre il compagno è stato sbalzato a due metri di distanza. I
due sposi poi sono fuggiti trovando riparo in un ristorante lì vicino per
cercare di capire cosa stesse accadendo. Poi sono risaliti sull’auto e sono
tornati a casa. Non hanno però rinunciato a coronare il loro sogno d’amore: la
sera stessa si sono sposati in una piccola cerimonia familiare. Israa sarebbe
infatti dovuta dopo poco ritornare negli USA e non avrebbe mai lasciato il suo
compagno in un luogo insicuro dove ancora non si riesce a ricostruire cosa sia
successo.
Maria racconta l’inferno di Beirut: “Mio marito e mia figlia
salvi, qui da mesi giocano con il dollaro”. Ciro
Cuozzo su Il Riformista l'8 Agosto 2020. “Mio marito e mia figlia stavano lì,
a Beirut, a sei chilometri di distanza dall’esplosione. Pensavano che il palazzo
stesse cadendo a causa di un terremoto. Per qualche secondo hanno perso l’udito,
poi si sono resi conto di quello che era realmente accaduto”. E’ il racconto
di Maria Russolillo, 58enne napoletana che dal 1992 vive in Libano dopo aver
sposato l’ingegnere Kamel Chahrour, conosciuto nel capoluogo
partenopeo.”Frequentava la facoltà di ingegneria a piazzale Tecchio, io invece
lavoravo come infermiera a villa Cinthia in via Epomeo, a Soccavo. Dopo la
laurea ci siamo sposati ma poi abbiamo deciso di trasferirci in Libano perché
mio marito a Napoli non trovava lavoro“. Maria, pronipote del Beato don Giustino
Maria Russolillo, dall’inizio della pandemia di coronavirus vive in un paesino
di montagna che si trova a una settantina di chilometri dalla capitale libanese.
“Ma abbiamo casa anche a Beirut perché mio marito lavora lì. Scende due giorni a
settimana in città e martedì 4 agosto si trovava lì con mia figlia di 27 anni”.
Per fortuna la sua abitazione non è stata danneggiata dall’esplosione perché
“c’erano le finestre aperte e quindi non c’è stata pressione”. Madre di cinque
figlie femmine, Maria ricorda quei drammatici momenti: “Eravamo fuori
al giardino e anche a 70 chilometri di distanza abbiamo sentito il boato.
L’esplosione ha interessato anche il mare e si è sentito prima un rimbombo
spaventoso, poi un risucchio”. Maria conosceva alcune delle oltre 150 vittime
come “la ragazza che lavorava dei vigili del fuoco, intervenuti inizialmente per
domare l’incendio nel deposito di fuochi d’artificio prima della drammatica
esplosione”. Per le prossime settimane la sua famiglia continuerà a vivere nel
paesino di montagna fuori Beirut. “C’è paura, tensione per quello che è
successo. Qui da diversi mesi, diciamo da gennaio, la situazione è cambiata
radicalmente e stiamo vivendo una forte crisi economica dovuta soprattutto al
rincaro del dollaro che ha toccato cifre assurde. Stanno giocando troppo con la
moneta americana”. Basti pensare che “un dollaro prima valeva 1500 lire
libanese. Adesso ne vale 10mila lire”. Un rincaro clamoroso che ha messo in
ginocchio l’economia del piccolo paese del Medio Oriente dove da settimane ci
sono le proteste dei cittadini contro il Governo. Una crisi economica che ha
provocato la chiusura di molte attività, soprattutto straniere, creando un tasso
di disoccupazione elevato. “Mio marito è nell’edilizia e ha difficoltà ha pagare
i 40-50 operai che lavorano con lui perché le banche non consentono di prelevare
più di 2 milioni di lire libanesi al mese”. Nonostante il rincaro del dollaro la
sua famiglia, che ha diversi immobili in fitto, ha mantenuto i prezzi di sempre
ma “ora è dura continuare ad andare avanti in queste condizioni”. In Libano però
– ci tiene a precisare Maria – si è sempre vissuto bene. C’è integrazione tra
cattolici e musulmani. “La gente qui ha lo stesso calore dei napoletani, lo
stesso amore per la famiglia, per lo stare insieme. Poi il lungomare mi ricorda
quello partenopeo” commenta la 58enne. Maria, tuttavia, non torna a Napoli da
decenni. “I primi anni dopo il trasferimento qui in Libano tornavo spesso a
Napoli. Poi dopo l’attacco alle Torri Gemelle nel 2001 ho iniziato ad avere il
terrore degli aerei. Stavo ritornando nel 2006 ma poi c’è stato l’attacco
israeliano durato poco più di un mese. Spero però di farmi coraggio e tornare
presto, magari insieme a figlie e nipoti per una piacevole vacanza”.
Strage Beirut, storia di un Paese in ginocchio tra
disoccupazione e prezzi alle stelle. Umberto De
Giovannangeli su Il Riformista il 6 Agosto 2020. Una città in ginocchio, ferita,
sgomenta. La capitale in macerie di uno Stato fallito. È salito a 135 morti,
oltre 5 mila feriti e un centinaio di dispersi il bilancio della doppia
devastante esplosione di martedì pomeriggio nei pressi del porto di Beirut.
«Stiamo assistendo ad un’enorme catastrofe», ha detto il capo della Croce Rossa
libanese George Kettani ai media locali. «Ci sono vittime e vittime ovunque.
Oltre 100 persone hanno perso la vita. Le nostre squadre stanno ancora
conducendo operazioni di ricerca e salvataggio nelle aree circostanti», ha
spiegato. «Ho fatto un giro per Beirut, quasi metà della città è distrutta o
danneggiata», dice alla France presse il governatore della capitale
libanese, Marwan Abboud, che ha quantificato i danni provocati dalle esplosioni
avvenute ieri “tra i tre e i cinque miliardi di dollari”. Una nave della task
force marittima Unifil attraccata nel porto è stata danneggiata e alcuni soldati
delle forze di pace navali sono rimasti feriti, alcuni dei quali gravemente.
Ieri sono stati messi agli arresti domiciliari tutti gli ufficiali dell’autorità
portuale della città, responsabili dello stoccaggio dei materiali nei magazzini
e della sicurezza della struttura. I militari ai domiciliari saranno controllati
dall’esercito. Il responsabile della dogana, Baabri Daher, ha reso noto che la
sua agenzia aveva ripetutamente richiesto di rimuovere dal porto il nitrato
d’ammonio ma ciò non è mai accaduto. L’esplosione è stata la più distruttiva di
tutta la storia del Libano: «È stata scioccante anche per una città che ha visto
15 anni di guerra civile, attentati suicidi, bombardamenti israeliani e omicidi
politici», ha scritto l’Associated Press. Secondo il centro di ricerca tedesco
di geoscienza GFZ, l’esplosione ha causato un terremoto di magnitudo 3.5 che si
è sentito fino a Cipro, circa 200 chilometri di distanza. Secondo fonti dei
servizi di sicurezza citate da Reuters e alcuni media locali, l’incendio che ha
causato l’esplosione sarebbe iniziato durante i lavori di saldatura che erano in
corso nel magazzino che conteneva il nitrato di ammonio. Il presidente
libanese, Michel Aoun, ha parlato di 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio che
erano state sequestrate dalle autorità sei anni fa, e che poi erano state
lasciate nel porto senza che venissero gestite con le necessarie misure di
sicurezza. Sono circa 300.000 le persone rimaste senza casa. Direttamente
investite dall’onda d’urto sono state la zona di Mar Mikhail, il quartiere
armeno oggi sede dei negozi e dei locali più alla moda, e tutta l’area
di Ashrafieh, il cuore cristiano della città. Devastata è anche piazza dei
Martiri, il cuore della protesta dei tanti, soprattutto giovani, che si
battevano da mesi per un Libano migliore. “Lasciate Beirut”: è il drammatico
consiglio che il ministro della Salute libanese Hassan ha rivolto a chiunque
possa andare via dalla città. La capitale del Libano è piombata nel sangue, nel
caos, nella disperazione, in un incubo che il governatore ha sintetizzato così:
«Sembra quello che è successo a Hiroshima e Nagasaki». Le scene sono di
spaventosa devastazione: moltissimi gli edifici danneggiati seriamente nel
raggio di chilometri. Tra questi anche il palazzo presidenziale e diverse
ambasciate. In questo scenario apocalittico, Israele ha fatto sapere che non ha
nulla a che vedere con la terrificante esplosione avvenuta nel porto di Beirut,
ma una fonte dello Stato ebraico ha tenuto a sottolineare che, secondo
informazioni non corroborate, il magazzino presso cui è avvenuta la
deflagrazione, veniva utilizzato da Hezbollah, il movimento sciita filo-iraniano
che ha sempre giocato un ruolo di spicco nella politica libanese. Fonti di
Hezbollah attribuiscono invece ad un sabotaggio israeliano la responsabilità
della potente esplosione che ha sconvolto Beirut. «In questo momento Israele è
alle prese con l’emergenza coronavirus e di certo non ha alcun interesse a
provocare un conflitto che stornerebbe risorse e acuirebbe la crisi in atto»,
confida a Il Riformista una fonte molto vicina al primo ministro Benjamin
Netanyahu. E poi la rivelazione: «I servizi d’intelligence libanesi sanno che
Israele non c’entra niente in questa tragedia, e a confermarlo sono anche le
intelligence di Giordania ed Egitto». Il ministro della Difesa Benny Gantz e il
titolare degli Esteri Gabi Ashkenazi – ambedue esponenti del partito centrista
Blu e Bianco – hanno dichiarato di essersi avvalsi di mediatori internazionali
per offrire assistenza umanitaria e medica al Libano. «Ipotizzare che un Primo
ministro possa pensare di poter contenere la protesta di massa esplosa per la
sua disastrosa gestione della crisi pandemica, aprendo un fronte di guerra è
francamente impensabile anche per chi pensa il peggio possibile di Netanyahu –
riflette Zvi Bar’el, firma di punta di Haaretz, il quotidiano progressista
israeliano, raggiunto telefonicamente a Tel Aviv -. Piuttosto – aggiunge – le
autorità libanesi dovrebbero interrogarsi su chi controlla davvero Beirut e il
suo porto: se l’esercito o le milizie di Hezbollah». Intanto è stata rinviata al
18 agosto la sentenza, che era attesa per domani, del Tribunale speciale per
il Libano (Tsl), con sede all’Aja, sull’omicidio di Rafiq Hariri, assassinato il
giorno di San Valentino del 2005 sul lungomare di Beirut in un attentato che
cambiò la storia del Libano. La decisione è stata presa «per rispetto delle
innumerevoli vittime di Beirut», ha dichiarato il tribunale. Alla sbarra ci sono
quattro imputati in contumacia, tutti membri del movimento sciita libanese
Hezbollah: Salim Ayash, Habib Merhi, Hussein Oneissi e Assaad Sabra. C’era anche
un quinto imputato, Mustafa Badreddin, considerato la mente dell’attentato di
San Valentino, ma è stato misteriosamente ucciso a Damasco nel 2016. Certo, la
pista dell’incidente resta quella più accreditata. Ma c’è chi solleva dubbi in
proposito come “Futuro”, il partito dell’ex presidente libanese Saad
Hariri, figlio del premier assassinato. «Ci sono gravi sospetti che gettano la
loro ombra sull’esplosione, sulla sua tempistica, circostanza e luogo e sulla
sua modalità e sui materiali incendiari che lo hanno causato”, ha affermato ieri
in un comunicato. Per il presidente Usa, Donald Trump, le esplosioni sono state
causate da una bomba. Una tesi che è stata però contraddetta da tre fonti
anonime della Difesa statunitense citate dalla Cnn, secondo le quali non ci sono
indicazioni di attacchi. La tragedia di Beirut rende ancor più drammatica la
situazione sociale, economica, di vita del Paese dei Cedri. Tutti gli indicatori
sono in rosso. Il prezzo dei generi alimentari è aumentato del 55%, la
disoccupazione ha raggiunto quasi il 33% della popolazione attiva, la valuta
nazionale crolla e le interruzioni della corrente elettrica sono ormai la norma.
Dalla fine della guerra civile nel 1990, il Libano ha costruito un’economia di
servizi basata su finanza, immobili e turismo. Ha finanziato il Pil con capitale
straniero, in gran parte proveniente dalla diaspora. Un dollaro valeva 1.500
lire libanesi, un cambio fisso che durava dal 1997. Il mese scorso un dollaro
veniva scambiato a 4mila lire sul mercato nero. I prezzi hanno subito un balzo
superiore al 50%. La classe media è sparita, i poveri sono diventati indigenti,
ha fatto capolino la fame. A Tripoli, città sunnita e poverissima nel Nord, il
60% della popolazione guadagna meno di un dollaro al giorno. La metà della
popolazione è sotto la soglia della povertà. Da mesi la gente muore negli
ospedali per mancanza di elettricità. La guerra civile nella vicina Siria,
scoppiata nella primavera del 2011, ha poi dato il colpo di grazia. Un milione e
mezzo di profughi siriani si è riversato nel piccolo e impreparato Libano,
trasformandolo nel Paese con il più il più alto rapporto al mondo di rifugiati
per abitante. Le sue strutture e infrastrutture, già insufficienti per i
libanesi, hanno resistito ma alla fine non hanno retto alla pressione. I suicidi
sono aumentati, tanto che Embrace, una ong che si occupa di salute mentale, ha
da alcuni mesi messo a disposizione un servizio telefonico di prevenzione. Come
scriveva alcuni giorni fa Ave Tavoukjian, giornalista del Daily Star, quotidiano
in lingua inglese del Paese, «negli ultimi mesi, il popolo libanese ha guardato
con allarme alla situazione: le loro preoccupazioni sono giustificate, la
maggior parte di coloro che gestiscono attività ha visto i propri ricavi ridursi
praticamente a nulla, una conseguenza del ridotto potere d’acquisto della
popolazione». «Eppure tutto ciò – concludeva – non è nulla in confronto a ciò
che deve ancora venire». Mai affermazione fu più tragicamente profetica. Così la
redazione di L’Orient -Le Jour, il giornale in lingua francofona
di Beirut, esprimeva i propri sentimenti nelle ore successive all’apocalisse:
«Cosa dire, cosa scrivere? Come tutto il Libano, siamo rimasti sbalorditi,
martedì sera, dalla portata del disastro. Storditi dalla violenza
dell’esplosione che ha devastato Beirut. Siamo rimasti scioccati dal bilancio
dei morti e dei feriti. Siamo rimasti scioccati dalle immagini di edifici
abbattuti, di finestre fatte saltare in aria e di porte divelte. Regnava il caos
negli ospedali, alcuni dei quali sono stati pesantemente danneggiati. Beirut
ieri sera sembrava un teatro di guerra. Ieri sera, in un Libano già in
ginocchio, eravamo tutti totalmente sbalorditi da questo ennesimo colpo del
destino. Quando le parole ci sfuggono, lasciamo parlare le immagini…». Le
immagini di uno strazio infinito.
IL DOPPIO DISASTRO DELL'ESPLOSIONE A BEIRUT.
Estratto dell’articolo di Daniele Raineri per “il Foglio” il 5
agosto 2020. (…) Il disastro accidentale arriva in un momento di crisi
profondissima e potrebbe aggravare l’emergenza umanitaria che in questi mesi
colpisce il Libano. Il paese importa tutto, anche il sessanta per cento del cibo
che consuma, da fuori, e adesso il porto e i depositi sono stati distrutti, con
tutte le scorte che contenevano e i terminal per ricevere le importazioni
dall’estero. Il terminal del grano è quello che si vede saltare in aria nei
video dell’esplosione, da lì passa quasi tutto il fabbisogno del Libano, di
solito comprato dalla Russia. E’ possibile che il medesimo problema ci sarà per
il carburante, che arriva al porto da Kuwait e Algeria, e alimenta le centrali
elettriche.
Lorenzo Cremonesi per il “Corriere della Sera” il 4 agosto 2020.
Sono tempi difficilissimi per il Libano in ginocchio. L'esplosione di ieri non
può che mettere in luce le deficienze di un apparato statale che non funziona
più. E ad aggravare la situazione c'è la strana coincidenza con il momento
cruciale nell'annoso processo per l'assassinio dell'ex premier Rafiq Hariri 15
anni fa. Domina la crisi economica lacerante, le banche chiuse, l'inflazione
alle stelle con l'affossarsi della lira libanese e il valore dei salari medi
sprofondato in meno di un anno da circa 900 dollari mensili ai 150 attuali. «Non
possiamo più ritirare i nostri risparmi dalle banche. Nascondiamo i pochi
dollari che ci restano sotto il materasso. Non possiamo viaggiare all'estero,
non c'è futuro», ci spiegava solo pochi giorni fa Christian Francis, un
imprenditore di Beirut che solo nel 2018 trascorreva le vacanze in Francia e ora
non ha più neppure il contante per pagare la bolletta della luce. Del resto gli
serve molto poco. Al momento l'energia elettrica subisce tagli sino a 20 ore al
giorno persino nei quartieri residenziali della capitale. Gli uffici pubblici
funzionano a singhiozzo, con la valuta scivolata al 20 per cento del suo valore
trionfa il mercato nero. Crescono nel frattempo le proteste di piazza contro i
partiti e il governo. Le manifestazioni erano iniziate nell'autunno scorso.
Sciiti, sunniti, cristiani, tutti uniti contro la corruzione imperante. Si
parlava di una nuova primavera araba che forse poteva cambiare le cose e porre
fine ai settarismi tradizionali. Ma poi sono arrivate le paure per il
coronavirus e le serrate delle attività economiche. La gente si è chiusa in
casa. Il turismo, una delle tradizionali fonti di ricchezza, è collassato. Oggi
le proteste sono riprese, mentre i media locali parlano apertamente di «Stato
fallito». Sono diminuiti a quasi nulla gli invii di valuta pregiata che in
genere la forte diaspora libanese ha sempre garantito ai parenti rimasti in
patria. A rendere tutto più complicato saranno le tensioni politiche in vista
del verdetto, atteso per venerdì, del tribunale internazionale organizzato
dall'Onu per investigare la morte del premier sunnita il 14 febbraio 2005.
Allora un'autobomba non molto lontano dal luogo dell'esplosione di ieri uccise
Hariri assieme a una ventina tra passanti e guardie del corpo. Il dito fu subito
puntato contro il movimento sciita di Hezbollah (il Partito di Dio) alleato col
regime siriano di Bashar Assad e sostenuto dall'Iran. Hariri era l'unico
politico di spessore che potesse separare il Libano dall'abbraccio di Damasco e
Teheran. E infatti da allora il figlio Saad, che ne prese il posto, ha sempre
dovuto mediare da una posizione di estrema debolezza. Oggi i quattro sospetti in
attesa di verdetto sono tutti militanti di Hezbollah. Un quinto, Mustafa Amine
Badreddine, uno dei massimi comandanti militari dell'organizzazione, venne
ucciso combattendo contro le milizie della rivolta sunnita in Siria nel 2016.
Oggi però Bashar è più forte. Grazie al sostegno russo, ha messo in ginocchio la
rivolta in casa e sta cercando di riprendere il controllo del Libano. Lo
rivelano anche le crescenti tensioni con Israele. Ovvio che, anche nel caso
l'esplosione di ieri fosse accidentale, le memorie della sanguinosa guerra
fratricida tra il 1975 e 1990 tornano più preoccupanti che mai.
Domenico Quirico per “la Stampa” il 5 agosto 2020. Un amico
libanese tre anni fa mi portò davanti a una delle innumerevoli banche di Beirut,
i veri monumenti della città : «Vedi, fino a quando queste funzioneranno il
Paese è salvo. Non c'è guerra o turbolenza che possa mettere in discussione
l'incredibile miracolo del mio Paese». Il cielo di Beirut ieri sera si blindava
di squame livide, rossastre per una catastrofica e misteriosa esplosione che ha
squassato il porto e la città. Chissà se il mio amico potrebbe ancora ripetere
quelle sillabe presuntuose. E' vero, il Libano sembrava poter resistere a tutto,
più i Paesi vicini venivano risucchiati dal furore degli eventi e cercavano di
trascinarlo con sè, più resisteva e rinasceva dalla cenere. Beirut era un luogo
imperfetto, un po' volgare, un po' vizioso, un po' furbo. Ma accanito
sfacciatamente a sopravvivere, a domare un storia spesso imbizzarrita e crudele.
Il libanese con la sua volontà accanita, la dolorosa pazienza, un antico decoro
ci stupiva sempre. E ora? Il miracolo libanese è avvilito e ottuso, un
deliberato inganno, una pia frode destinata pare a spegnersi nella impotenza
politica e nella catastrofe economica. La moneta che aveva resistito a tutto ha
perso il 60% del suo valore, lo Stato ha dichiarato fallimento decapitato da un
debito che è il 160% del Prodotto interno lordo; il 45% dei libanesi vivono
sotto la soglia di povertà. La pandemia pesa come un macigno anche qui, con un
sistema sanitario al collasso, mancano a tratti la corrente elettrica e l'acqua
e il telefono come nelle città devastate dalla guerra e dalle miserie del vicino
oriente, la vita quotidiana si è fatta travagliosa, piena di crucci e paure.
Israele e hezbollah, il partito di dio sciita, con il suo esercito bis si
scambiano segnali di guerra. Tutto parla di declino, povertà, inimicizia,
impotenza. Forse a malincuore bisogna rassegnarsi: il Libano è un'altra
primavera che si estingue, arrivata in ritardo con le manifestazioni
dell'ottobre del 2019. Da esplosione euforica, vibrante contro scompigli
disastri e imposture è diventata cattiva, colma di un selvatico risentimento, in
preda alle strumentalizzazioni di gruppi estremisti. Non poteva essere
diversamente, forse: troppo divisa all'interno senza una leadership capace di
guidarla, zavorrata dall'avvento del coronavirus e dalle difficoltà della vita
quotidiana che hanno costretto alla resa molti entusiasmi. Sunniti e cristiani
accusano hezbollah di essere la causa dei problemi del Paese mentre Trump che
spera di piegare una costola essenziale del grande progetto sciita e iraniano,
muove la leva delle sanzioni, sfrutta il tracollo economico. Hezbollah combatte
in Siria dove ha salvato Bashar e addestra gli huthi dello Yemen. Ma l'idea che
il partito di Nasrallah sia indebolito e stia per perdere il controllo del
Libano è probabilmente illusoria. Anzi: gli attacchi americani rinsaldano il
legami nella comunità sciita, offrono argomenti per tacitare i dubbiosi. Il
problema è che dopo molti anni il Libano deve drammaticamente reinventarsi. Il
suo modello economico che si basava su un debito sfrenato fino dagli anni
Novanta non regge più, il Paese deve imparare a produrre mentre oggi importa
praticamente tutto, l'aiuto della diaspora potente e ricca (il 12% del Pil) non
copre più come una protesi ortopedica gli abissi del debito. Ma è soprattutto
sul piano politico che tutto deve cambiare perché tutto è finto. Ha fallito una
classe politica formata da uomini corrotti, da spregiudicati acrobati del
compromesso, da capi clan che hanno convertito la mimetica delle milizie con il
doppiopetto ministeriale, gente che si sollazza negli equilibri più impropri e
vietati. Continuano imperterriti a dominare le loro tribù illudendole di essere
lo scudo dei loro interessi e della loro sopravvivenza: praticano solo i loro
affari.
Gian Micalessin per “il Giornale” il 6 agosto 2020. L'incidente
non è solo la causa più probabile del disastro, ma anche, vista l'entità della
strage, la più comoda e conveniente per tutti. Proprio per questo non sapremo
mai se dietro l'esplosione delle 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio
ammassate nel porto di Beirut si nasconda qualcosa di più sofisticato e
premeditato della banale scintilla scaturita durante la saldatura di una porta
del magazzino 12. In compenso nella capitale libanese voci e ipotesi si
sprecano. Sul fronte di Hezbollah si ipotizza un cyber-attacco israeliano,
simile a quelli messi a segno recentemente in Iran. I nemici del Partito di Dio
scommettono, invece, sulla deflagrazione delle testate missilistiche ammassate
da Hezbollah in un sito adiacente al magazzino 12. Altri ancora ipotizzano un
tentativo di mettere le mani sul carico di nitrato di ammonio in vista di un
prossimo attacco allo Stato ebraico. Fino alle voci che vogliono l'intervento di
«manovalanza» di Hezbollah per accendere la miccia e accusare poi Israele. Voci
e ipotesi alimentate dall'imminenza della sentenza del processo Hariri -
rinviata proprio ieri - che poteva vedere la condanna in contumacia dei
militanti del Partito di Dio accusati dell'attentato costato la vita, 15 anni
fa, al premier libanese. L'ipotesi incidente non basta comunque ad assolvere
dalle loro responsabilità Hezbollah e quanti hanno trasformato il Libano in un
Paese dei balocchi sospeso tra l'incubo di una guerra incombente e il sogno di
un benessere infinito. Tra quell'incubo e quel sogno si nascondono le cause
dell'insipienza che ha originato l'incidente. Dietro l'incuria che ha permesso a
giudici e autorità di dimenticare 2.750 tonnellate di nitrato di potassio c'è la
corruzione di un sistema che per trent' anni ha distribuito poteri, agi e
ricchezze in maniera rigorosamente settaria. L'esigenza di scegliere un
presidente cristiano affiancato da un premier sunnita e da presidente del
Parlamento sciita ha dato vita, a cascata, a una simmetrica ripartizione di
risorse, ricchezze e cariche pubbliche. E questo spiega perché, in mancanza di
una specifica responsabilità o di un adeguata bustarella, nessuno si sia preso
la briga di rimuovere una minaccia letale dal cuore di Beirut. Con la stessa
logica nessuno si è mai preso la briga di garantire a una metropoli dove, fino a
qualche anno fa, giravano i miliardi di dollari del Golfo, un sistema di
trasporti pubblici o una centrale elettrica capace di garantire forniture
stabili. Così per decenni l'apparente dolce vita di Beirut e la miseria dei suoi
sobborghi hanno fatto i conti con i miasmi dei gas di scarico sputati da
traffico e generatori. Ma la strage di lunedì prende forma sullo scenario
dell'ulteriore degrado innescatosi due anni fa quando il principe ereditario
Mohammed Bin Salman bloccò definitivamente i flussi di capitali sauditi mettendo
con le spalle al muro un premier Saad Hariri poco disposto a uno scontro
frontale con Iran ed Hezbollah. Il crollo del prezzo del petrolio e le sanzioni
americane a Teheran hanno fatto il resto lasciando in mutande un Partito di Dio
sciita che - dopo aver sacrificato risorse e militanti nella guerra di Siria -
sperava nei proventi garantiti dagli ayatollah iraniani. Dissolti i dollari di
Riad e Teheran del vecchio sistema settario sono rimaste in piedi solo le
ineguaglianze e le ingiustizie aggravate ed esacerbate, negli ultimi mesi,
dall'ulteriore crisi innescata dal Coronavirus. In questo scenario la Beirut
ferita a morte dall'immane esplosione di lunedì rischia di affondare non sotto i
colpi di Hezbollah o dei militanti sunniti, ma di chi si ritrova alla fame a
causa delle malversazioni garantite e permesse dai due eterni nemici.
Libano, sentenza Hariri: "Nessuna prova che sia stato
Hezbollah". Pubblicato martedì, 18 agosto 2020 su La
Repubblica.it da Giampaolo Cadalanu. Non ci sono prove che sia stata la mano di
Hezbollah, cioè del “partito di Dio” sciita sostenuto dall’Iran, a compiere
l’assassinio di Rafik Hariri, primo ministro straziato sul lungomare di Beirut
da una bomba potentissima il giorno di San Valentino di quindici anni fa: il
giudice David Re, presidente del Tribunale speciale per il Libano, ha iniziato
la lettura del riassunto di 2600 pagine di sentenza definendo “circostanziali”
le prove contro gli accusati in contumacia: Salim Ayyash, accusato di essere il
pianificatore, Hussein Oneissi, Assad Sabra e Hassan Merhi. I quattro sono
collegati all’assassinio grazie alle tracce lasciate da telefoni cellulari,
mentre l’organizzazione non è accusata direttamente, anche se molti libanesi
ritengono proprio il gruppo responsabile dell’attentato. Quel 14 febbraio 2005
altre 21 persone rimasero uccise. Si racconta che l’esplosione sia stata
tremenda, tanto da sventrare gli edifici vicini. Ed era stata preparata per
bene, con tattiche militari, al punto che non era servita a niente la raffinata
difesa del convoglio, fornito persino di sistemi elettronici in grado di fermare
le trasmissioni radio e impedire dunque l’uso di ordigni telecomandati. Ma dove
la tecnologia di guerra non era bastata, era servito lo sdegno generale, che
dopo alterne vicende aveva portato al ritiro delle forze siriane, alleate di
Hezbollah, dal Libano. La sentenza che il Tribunale speciale dell’Aja rende
pubblica è destinata a lacerare ancora di più un Paese stremato dalla crisi
economica e ferito dall’esplosione dello scorso 4 agosto, che ha devastato la
zona portuale di Beirut. Anche per quest’ultima catastrofe, una fetta di
cittadinanza punta il dito sul “partito di Dio”, ipotizzando che all’origine del
disastro sia stato un arsenale di missili e non i materiali chimici abbandonati
in un magazzino. La comunità sciita ha sempre giudicato la Corte dell’Aja un
organismo di parte, creato ad hoc contro Hezbollah. In qualche modo, la vicenda
ha un parallelo negli sviluppi dell’inchiesta sull’esplosione al porto: anche
qui il “partito di Dio”, affiancato dal presidente cristiano Aoun, rifiuta la
prospettiva di una commissione internazionale d’inchiesta. Ma una grossa fetta
dei libanesi ha poca fiducia nel sistema giudiziario nazionale e invoca un
ricambio politico globale. Oggi sono previste due diverse manifestazioni vicino
al palazzo presidenziale: nonostante i richiami alla moderazione da parte dei
figli di Hariri, l’ex premier Saad e il fratello Baha, la tensione è alta.
Paradossalmente potrebbe essere la diffusione della pandemia, con il numero dei
contagiati in crescita rapida, l’unico elemento a ridurre la presenza nelle
piazze.
Il figlio di Hariri: "Hezbollah consegni l'assassino di mio
padre". Il tribunale speciale per il Libano ha
condannato in contumacia un militante del "partito di Dio", che però esclude di
permetterne l'arresto. Pubblicato mercoledì, 19 agosto 2020 da Giampaolo
Cadalanu su La Repubblica.it. “Hezbollah deve consegnare alla giustizia
l’ideatore dell’attentato contro mio padre”: così Saad Hariri, figlio dello
statista assassinato nel 2005 e anch’egli ex premier libanese, ha puntato il
dito contro il “partito di Dio”, nelle cui file militava Salim Jamil Ayyash,
unico condannato dal Tribunale speciale. I giudici dell’Aja hanno sottolineato
che sia Ayyash che gli altri tre imputati, tutti in contumacia, facevano parte
di Hezbollah, ma non sono andati oltre, rilevando che non c’erano prove di un
coinvolgimento diretto dell’organizzazione nell’attentato di San Valentino. Di
Hezbollah faceva parte, come alto ufficiale, anche un quinto imputato, Mustafa
Amine Badreddine, che però è morto nel 2016. Il figlio di Rafiq Hariri ha
ribadito con la tv Al Arabiya (di proprietà saudita ma basata a Dubai) che
Hezbollah va considerato responsabile per il crimine, perché non poteva non
sapere che cosa i suoi militanti stavano organizzando. “Il condannato dev’essere
consegnato”, sottolinea Saad Hariri. Il “partito di Dio”, che raccoglie una
buona fetta degli sciiti libanesi ed è apertamente collegato con il governo
iraniano, ha sempre negato ogni coinvolgimento nell’attentato. Già nei giorni
precedenti la sentenza, il leader Hassan Nasrallah aveva dichiarato con forza
che, quali che fossero i risultati dell’inchiesta, Hezbollah non avrebbe
permesso l’arresto dei suoi uomini. Il verdetto dell’Aja è stato accolto con
totale silenzio da parte dell’organizzazione, anche se la tv saudita segnala
l’accensione di qualche fuoco d’artificio nei quartieri sciiti di Beirut. La
linea ufficiale di Hezbollah attribuiva l’attentato a Israele. Ma negli anni
scorsi diverse fonti di stampa mediorientali hanno segnalato che il “partito di
Dio” aveva preso molto sul serio l’ipotesi di una condanna generalizzata, che
individuasse responsabilità dirette nell’organizzazione. Secondo i giornali, la
struttura di comando aveva per l’occasione elaborato piani complessi per un
colpo di Stato, arrivando addirittura a una “prova generale” nel 2010.
Andrea Morigi per “Libero quotidiano” il 6 agosto 2020. Giunto
ormai da mesi sull'orlo dell'abisso con il default finanziario, messo in
ginocchio dall'emergenza Covid-19 il Libano si vede precipitato improvvisamente
verso un punto di non ritorno. Prevale il fatalismo, fra gli abitanti della
capitale: «Non importa quanto è dura la situazione, la nostra unica certezza è
che domani sarà peggio», dicono i loro tweet rassegnati dopo la strage di
martedì. A meno che, con le principali infrastrutture disintegrate dalle
esplosioni, scatti l'ora della risurrezione. Stefano Piazza, esperto svizzero di
sicurezza, propone di guardare ai prossimi appalti per la ricostruzione. «Il
porto di Beirut è distrutto, gli ospedali funzionano a fatica, il numero di
famiglie rimaste senza casa è incalcolabile, ci sono tonnellate di vetri da
sostituire. Inoltre non sappiamo quali sostanze si siano sprigionate nell'aria.
Ma intanto si apre uno scenario. C'è da rifare tutto».
È il business della ricostruzione, che produce sempre profitti.
Chi pensa che se ne occuperà?
«Sarà il presidente turco Recep Tayyp Erdogan a dire: "Vi aiuto
io" e a saltare sull'affare. Ha già telefonato al suo omologo libanese Michel
Aoun, rassicurandolo sulla disponibilità della Turchia a fornire "ogni aiuto
necessario" per far fronte alle conseguenze dell'evento. Inoltre la Turchia si è
già fatta avanti offrendosi di costruire a Beirut un ospedale da campo e
mandando la Fondazione turca per il soccorso umanitario (Ihh) a scavare per
recuperare i corpi sepolti sotto le macerie».
Si aspetteranno un ringraziamento concreto. Cosa potranno
chiedere in cambio?
«Attualmente, l'economia turca non se la passa bene, ma è
sostenuta finanziariamente dal Qatar, che peraltro proprio pochi mesi fa aveva
rifiutato di aiutare il Libano. Ma questa è un'opportunità che consentirebbe ad
Ankara di aggirare la Siria, che geograficamente circonda il Libano. ed
espandere lteriormente la propria influenza nel Mediterraneo orientale».
L'unico confine che rimarrebbe sarebbe quello meridionale che
divide il Libano da Israele. Sarebbe una minaccia verso lo Stato ebraico?
«Gerusalemme non ha nessun interesse a entrare in un conflitto
con il Libano, dal quale peraltro attualmente si deve già difendere, perché
dalle proprie postazioni Hezbollah continua a lanciare quotidianamente missili
verso il territorio ebraico».
Il premier israeliano Benjamin Netanyahu fra l'altro aveva
avvertito l'Onu della presenza di esplosivo nel porto della capitale libanese e,
fra le ipotesi, c'è quella che il magazzino saltato in aria a Beirut celasse un
deposito di armi delle milizie sciite libanesi. È azzardato immaginare che si
sia tratto di un attacco volontario?
«Non si può escludere che qualcuno abbia intenzionalmente gettato
il Libano nel caos per approfittare della situazione. Per ora, si può soltanto
dire che il presidente Michel Aoun ha convocato il Consiglio di Difesa. E in
quei Paesi lo si fa soltanto in caso di guerra. E il premier Hassan Diab ha
dichiarato che tutti i responsabili della catastrofe saranno chiamati a
risponderne. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara. Le indagini diranno
che cos' è saltato, se soltanto il nitrato di ammonio oppure anche qualcos'
altro. A quel punto forse si capirà qualcosa in più sull'origine di quella
tragedia».
Libano, Trump insiste: Nessuno sa causa esplosioni Beirut,
forse un attacco. (LaPresse/AP il 6 agosto 2020) - Il
presidente americano Donald Trump continua a suggerire che la massiccia
esplosione che ha ucciso almeno 135 persone al porto di Beirut possa essere
stato un attacco deliberato, anche il Libano e il segretario alla Difesa Mark
Esper hanno dichiarato che si ritiene che si sia trattato di un incidente.
"Qualunque cosa sia successa, è terribile, ma non sanno davvero cosa sia", ha
insistito Trump, "nessuno lo sa ancora". "Come puoi chiamarlo incidente se
qualcuno ha lasciato alcuni terribili dispositivi di tipo esplosivo e cose in
giro? Forse è stato quello. Forse è stato un attacco", ha detto Trump ai
giornalisti durante un briefing alla Casa Bianca, "credo che nessuno possa dirlo
adesso". "Alcune persone pensano che sia stato un attacco e alcune persone
pensano che non lo sia stato. In ogni caso, è stato un evento terribile", ha
rimarcato Trump.
Estratto dell’articolo di Marco Ventura per “il Messaggero” il 6
agosto 2020. Incidente, attentato o addirittura raid aereo. La violenza e
complessità della situazione libanese e mediorientale scatena la caccia alla
verità, la ridda delle ipotesi, persino il botta e risposta a distanza tra il
presidente Trump che parla di «qualche tipo di bomba» e il Pentagono che in
forma anonima esclude seccamente «un attacco terroristico». I vertici libanesi
accreditano la tesi dell'incidente e mettono agli arresti domiciliari, con le
guardie sulla porta di casa, tutti i dirigenti dell'area portuale. (…)
Da adnkronos.com il 7 agosto 2020. Il presidente libanese, Michel
Aoun, non esclude l'ipotesi di un'interferenza esterna come causa delle
esplosioni di martedì a Beirut, pur sottolineando che l'ipotesi principale resta
quella di materiale mal immagazzinato. "La causa delle esplosioni ancora non è
stata determinata dato che esiste la possibilità che si sia prodotta
un'interferenza esterna attraverso un missile, una bomba, o una qualsiasi altra
azione", ha affermato Aoun parlando con la stampa, citato dall'emittente
libanese Mtv. Il presidente ha rivelato quindi di aver chiesto al suo omologo
francese Emmanuel Macron, che la Francia fornisca al Libano "le immagini aeree
dell'esplosione. Se non le hanno, chiederemo ad altri Paesi per determinare se
si sia trattato di un attacco esterno".
Guido Olimpio per corriere.it il 7 agosto 2020. Su quanto è
avvenuto a Beirut proliferano le teorie. Per adesso sono poche le prove, mentre
è profonda la sfiducia nelle istituzioni. Queste alcune delle tesi.
Numero 1. Colpa della negligenza, dell’incuria, della corruzione.
Il nitrato di ammonio è da troppo tempo dentro l’hangar 12, le fiamme partono
per motivi accidentali durante dei lavori di manutenzione (girano le foto dei
presunti saldatori), innescano prima dei fuochi d’artificio — anche questi
ospitati in un capannone — e poi il resto. Al momento è la versione ufficiale
più accreditata.
Numero 2. Qualcuno ha provocato l’esplosione, un attentato
dunque. Da parte di cellule terroristiche o di servizi segreti. Sono stati
citati sciiti, altri gruppi, israeliani. Donald Trump ha parlato di «attacco»,
il portavoce del Pentagono ha ribadito che «non c’è ancora nulla di definitivo»
e non ha escluso l’incidente.
Numero 3. Israele voleva distruggere uno dei bunker segreti
dell’Hezbollah, ma non sapeva dell’esistenza del nitrato o forse ha
sottovalutato gli effetti. Potrebbe averlo fatto usando un missile oppure con
l’aiuto di complici.
Numero 4. Nell’edificio, oltre al nitrato scaricato anni fa dalla
nave, c’erano altri ordigni. Una presenza tollerata e non dichiarata da parte
delle autorità. Oppure nota solo ad alcuni. Di chi erano queste armi
supplementari? Di nuovo sono chiamati in causa i miliziani filo-iraniani. Oppure
poteva trattarsi di «merce» legata a traffici clandestini.
Numero 5. Gli esperti che hanno analizzato i video non hanno
pareri uniformi: c’è chi ritiene che colore del fumo/fiamme sia compatibile con
quello del nitrato, altri «vedono» i segni di materiale militare.
Numero 6. La tragedia avrà conseguenze politiche. Ieri il
presidente francese Macron, con un’invasione di campo e dopo aver visitato le
macerie, ha auspicato riforme profonde. Tanti poi guardano all’Hezbollah
libanese che dispone nella capitale di strutture militari mimetizzate e coperte.
L’immane tragedia sarà usata dai suoi avversari per invocare uno spostamento
altrove dei suoi dispositivi? È bene essere cauti, alcuni di questi scenari sono
rilanciati in base a convenienze e convinzioni politiche, non è netto
nell’immediato il fine di un eventuale atto doloso, ci sono speculazioni che
potrebbero diventare «fatti» grazie alle indagini oppure perché lo si vuole
credere.
Fausto Biloslavo per “il Giornale” il 7 agosto 2020. «Non
possiamo escludere che ci fosse anche del materiale bellico. Sappiamo solo che
la quantità saltata in aria era ingente, ma da dove derivasse, se fosse solo il
nitrato sequestrato anni fa o esplosivo di altro genere non lo possiamo dire con
certezza. Tutte le ipotesi sono aperte» spiega al Giornale, un'alta fonte
internazionale. Per la sensibilità dell'argomento e la posizione non possiamo
rivelare il suo nome. «Sicuramente erano in molti a sapere che nel porto di
Beirut fossero immagazzinate da anni tonnellate di fertilizzante, che potevano
diventare estremamente pericolose» osserva la fonte esclusiva. Dalle prime
analisi delle immagini video di specialisti militari sul posto «l'effetto
devastante l'ha provocato il nitrato d'ammonio, ma tenendo conto della sequenza,
delle colonne di fumo e dal loro colore è stato innescato da altri esplosivi,
saltati in aria, presumibilmente militari» rivela un'altra fonte del Giornale.
La prima versione dei fuochi d'artificio fa acqua e va chiarito il possibile
«intervento maldestro di alcuni saldatori sulla porta di un magazzino, che ha
preso fuoco provocando una reazione a catena». Anche l'ipotesi di materiale
bellico sequestrato dall'esercito a gruppi jihadisti sunniti regge poco. «Questo
materiale si trovava in un'altra zona del porto non interessata dall'esplosione»
spiega la fonte internazionale. Il controllo e le operazioni nella zona del
disastro sono stati assunti dal ministro della Difesa, Zeina Adra, una donna che
è pure vice primo ministro. Unifil, la missione dei caschi blu nel Sud del
Libano, comandata dal generale italiano Stefano Del Col, che da decenni fa da
cuscinetto fra Israele e il partito armato filo iraniano Hezbollah, ha messo a
disposizione il proprio personale. Sia reparti del genio per rimuovere la
macerie, sia esperti di esplosivi, tutti italiani. In particolare, se la Difesa
libanese sarà d'accordo, si sta preparando a intervenire un'unità speciale, il
«Weapons intelligence team». Esperti di esplosivi, che si sono fatti le ossa in
Afghanistan analizzando nei minimi dettagli i risultati delle trappole minate e
degli attacchi suicidi per risalire alla «mano» che ha confezionato le bombe. «A
Beirut potrebbero scoprire cosa sia realmente accaduto e trovare preziosi indizi
sulle cause dell'esplosione e sul materiale saltato in aria» spiega una fonte
militare italiana. Però i francesi sono già pronti. Le forze armate israeliane
hanno ufficialmente smentito qualsiasi coinvolgimento. «Però non mi stupirei se
ci fossero stati osservatori dal cielo» il giorno dell'esplosione, spiega la
fonte internazionale. Il 27 luglio la tensione sulla blue line, la linea non
ufficiale di confine fra Israele e Libano, si è impennata attorno alle fattorie
di Sheeba. Gli israeliani si sono scontrati con gli Hezbollah scambiandosi
reciproche accuse. «Subito dopo le violazioni di Tel Aviv dello spazio aereo
libanese sono aumentate da 6-7 al giorno al numero folle di 50-60» rivela la
fonte. Uno degli effetti dell'esplosione di Beirut è stato il rinvio del
verdetto del tribunale dell'Onu sull'omicidio del premier Rafik Hariri fatto
saltare in aria nel 2005. «La tempistica del disastro è sospetta? Ni - risponde
la fonte internazionale - C'erano altri sistemi meno cruenti al posto di radere
al suolo una città». Il vero problema «è il collasso economico. I giovani in
piazza chiedono riforme, che sono la condizione posta anche dal Fondo monetario
internazionale per ingenti prestiti che salvino il paese dei cedri». Lo spettro
della guerra civile o di un nuovo conflitto con Israele è dietro l'angolo. «Fino
a poco tempo fa temevo che la proteste di piazza si trasformassero in rivolta
armata - sottolinea la fonte internazionale - Per non parlare della possibile
recrudescenza della tensione lungo la blue line. Ai problemi economici, politici
e sociali del paese si è aggiunta la devastante esplosione. Il colpo è tale che,
per assurdo, il pericolo immediato di una guerra si allontana, ma per il Libano
sarà inevitabile la resa dei conti».
Il mistero delle sostanze chimiche stoccate al porto, molto
vicino al centro abitato. Pubblicato il 4 agosto 2020
su Il Corriere della Sera da Guido Olimpio.
1. Il Libano è da sempre terreno di scontro. Hezbollah, Israele,
gruppuscoli, il cosiddetto contagio del conflitto siriano.
2. Il disastro avviene alla vigilia del verdetto sull’attentato
costato la vita all’ex premier Hariri, azione per il quale sono sospettati
alcuni appartenenti all’Hezbollah. Un movimento che è ben di più di una fazione
perché rappresenta una fetta di potere politico e militare consistente.
3. Beirut, con le fazioni, le spaccature confessionali e ora con
una crisi sociale senza precedenti si presta a qualsiasi gioco. Il materiale non
manca. In queste ore le hanno dette tutte: un missile, il sabotaggio, l’incuria,
la “manipolazione” del materiale, la disgrazia… Ognuno avrà la sua tesi, basata
su dati o interessata.
4. Anche se si è trattato di un incidente – e vedremo cosa
diranno le indagini - resta sempre lo spazio per una narrazione alternativa,
appoggiata a possibili indizi, a segnalazioni non sempre verificabili ma che le
esperienze passate di questo paese portano a considerarle.
5. Una tragedia di queste proporzioni ha comunque un impatto
politico, come se ci fosse stato un attacco.
6. Ovviamente c’è da chiedersi come sia stato possibile che
sostanze così a rischio fossero conservate nell’area portuale, molto vicina al
centro abitato. E l’altra domanda riguarda chi doveva controllare.
7. Memo. Nel luglio 2011 a Cipro si verificò un disastro analogo:
in una base della Marina esplose per cause fortuite un deposito di munizioni
sequestrate. Tredici le vittime.
Beirut, l'esperto di esplosivi: "Non è nitrato di ammonio.
Perché credo che ci fossero delle armi". Libero
Quotidiano il 05 agosto 2020. Altro che nitrato di ammonio e fuochi d'artificio,
per Danilo Coppe l'esplosione che ha distrutto il porto di Beirut ha una solo
causa: gli armamenti. Il massimo esperto di esplosivi in Italia ha parecchi
sospetti su quanto sia realmente accaduto nella tragica giornata di martedì 4
agosto: "Premettiamo una cosa: tutte queste considerazioni derivano dai video
che ho visto, non ho altre informazioni, non sono stato lì. Ma non credo al
nitrato di ammonio per diverse ragioni - spiega al Corriere della Sera -.
Intanto la quantità: 2.700 tonnellate vorrebbe dire che qualcuno ha
costruito una piscina olimpionica e l'ha riempita di quella sostanza". Per
"mister dinamite", così è chiamato sul campo, "avrebbe dovuto esserci un
catalizzatore, perché altrimenti la sostanza non sarebbe esplosa tutta insieme".
Non solo, perché Coppe con tanto di tecnicismi ribadisce che "il nitrato di
ammonio, quando deflagra, genera una inequivocabile nuvola gialla". Nel video
che ritraggono l'esplosione, invece, si vede una sfera bianca e una colonna
arancione mattone tendente al rosso vivo, tipica della partecipazione di
litio. E qui l'esperto arriva al punto: "Il propellente per i missili militari è
proprio sotto forma di litio-metallo. Penso che lì ci fossero degli armamenti",
è la sua conclusione. Per Coppe l'ipotesi più probabile dunque è "un
accantonamento temporaneo di armamenti. Le munizioni infatti fanno botti tutti
uguali". L'incidente sarebbe così stato causato da una prima esplosione di buona
entità, che può aver dato il via a un incendio dove erano stoccate delle
munizioni". E da lì il disastro.
(ANSA il 5 agosto 2020) - A monte della catastrofe che ha colpito
Beirut pare esserci una nave, la Rhosus, battente bandiera moldava ma di
proprietà di un armatore russo di stanza a Cipro, Igor Grechushkin. Il vascello,
salpato dalla Georgia e diretto nel Mozambico, nell'ormai lontano settembre del
2013, fu costretto a una sosta nel porto di Beirut a causa di problemi tecnici.
Nelle sue stive la bellezza di 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio. Le
autorità libanesi, dopo le ispezioni, vietano alla nave di proseguire il suo
viaggio. Così, per l'equipaggio, in prevalenza di cittadinanza ucraina, inizia
un calvario. La loro storia viene descritta da ShipArrested.com, che si occupa
della vicenda nel 2014 e offre assistenza legale all'equipaggio bloccato a
Beirut, abbandonato dall'armatore "senza stipendi e senza aiuti". Il capitano,
Boris Prokoshev, racconta che Grechushkin, invece di affrontare i problemi, "ha
abbandonato la nave, dicendo di essere finito in bancarotta, ha smesso di pagare
i salari e ha privato la nave di tutti i collegamenti, tra cui internet,
satellite e telefono". Le autorità libanesi, dopo l'intervento del consolato
ucraino e di quello russo, hanno permesso ad alcuni marinari di fare ritorno in
patria ma il capitano e altri quattro marinai sono rimasti bloccati sulla Rhosus
per mesi. Stando a ShipArrested.com, i legali della Baroudi & Associates hanno
presentato un esposto alla corte di Beirut per chiedere la liberazione
dell'equipaggio, con successo. "A causa dei rischi associati alla conservazione
del nitrato di ammonio a bordo della nave, le autorità portuali hanno scaricato
il carico nei magazzini del porto: la nave e il carico rimangono ad oggi in
porto in attesa di essere messi all'asta e/o smaltiti correttamente", recita il
bollettino di ShipArrested.com datato ottobre 2015. Secondo quanto ricostruito
dalla testata russa Mediazona, la Rhosus era stata bloccata per sei giorni anche
nel porto di Siviglia, nel luglio del 2013.
CHE DIAMINE È IL NITRATO DI AMMONIO? UN INNOCUO FERTILIZZANTE
TRASFORMATO IN ESPLOSIVO DAI TERRORISTI. Fra. Ian.
per “la Stampa” il 6 agosto 2020. Il nitrato d'ammonio è un fertilizzante di
facile reperibilità, solubile in acqua e di per sé inerte. Ma se combinato con
un olio combustibile si trasforma in Anfo (Ammonium Nitrate Fuel Oil), un
potentissimo esplosivo. Per farlo esplodere serve soltanto un detonatore adatto.
Normalmente l'Anfo è utilizzato nell'estrazione del carbone. Come esplosivo è
molto stabile e praticamente non può detonare accidentalmente, ma allo stesso
tempo è soggetto alle variazioni di temperatura e umidità che ne possono
modificare il tipo di esplosione. Se la miscela non detona completamente si
sviluppa una nube tossica ricca di biossido d'azoto: è questo il motivo per cui
le autorità libanesi hanno ordinato l'evacuazione di Beirut a un gran numero di
residenti. In America è stato utilizzato da terroristi islamici nell'attentato
del 26 febbraio 1993 alle Torri gemelle: morirono sei persone e ne rimasero
ferite più di mille. L'altro attentato, sempre negli Usa, risale al 19 aprile
del 1995 e fu compiuto a Oklaoma City da terroristi americani, i morti furono
168 e i feriti 672.
COS'È E COSA FA IL NITRATO DI AMMONIO. Da lastampa.it il 5 agosto
2020. Il nitrato di ammonio, responsabile delle devastanti esplosioni a Beirut,
è uno dei fertilizzanti maggiormente utilizzati in agricoltura al mondo.
Prodotto sottoforma di piccoli granuli porosi e altamente solubile, è anche uno
dei componenti principali di molti tipi di esplosivi utilizzati nelle miniere e
nelle cave, dove viene fatto esplodere dopo essere miscelato con carburante.
Noto più comunemente con il nome di salnitro, viene classificato come materiale
pericoloso e quindi sottoposto a una serie di regolamentazioni. I maggiori
depositi si trovano nel deserto di Atacama in Cile, da dove viene estratto.
Rappresenta l'80% di tutti gli esplosivi industriali utilizzati negli Stati
Uniti. Oggi quasi il 100% della sostanza chimica utilizzata è sintetica,
prodotta facendo reagire l'ammoniaca con l'acido nitrico. Relativamente stabile,
è economico da produrre. Quello che non può accadere è che il nitrato di ammonio
s'infiammi da solo. Al contrario, può fungere da fonte di ossigeno e accelerare
la combustione di altri materiali. A temperature decisamente elevate, però, il
nitrato di ammonio può decomporsi da solo. Questo processo può creare gas tra
cui ossidi di azoto e vapore acqueo. Ed è questo rilascio di gas che può
provocare un'esplosione. La decomposizione del nitrato di ammonio può essere
innescata se si verifica un'esplosione nel luogo in cui è immagazzinata o se c'è
un vasto incendio nelle vicinanze. Quest'ultimo scenario è quello che è successo
nell'agosto del 2015 a Tianjin, nella Cina orientale a 110 chilometri a sudest
di Pechino, dove 173 persone morirono per l'esplosione che si verificò in una
fabbrica di prodotti chimici dove erano stoccate sostanze chimiche infiammabili
e nitrato di ammonio. Al 1947 risale l'esplosione di 2.300 tonnellate di nitrato
di ammonio in Texas, dove quasi 500 persone persero la vita. Un'esplosione di
nitrato di ammonio, come quella che si è verificata a Beirut, produce enormi
quantità di ossido di azoto. Il biossido di azoto è un gas rosso dal cattivo
odore e nelle immagini di Beirut dopo l'esplosione si notava una nuvola di
colore rossastro vicino al luogo dell'esplosione. Gli ossidi di azoto sono
presenti nell'inquinamento urbano, ma ad alti livelli possono essere
particolarmente pericolosi per persone che hanno problemi respiratori.
Matteo Sacchi per “il Giornale” il 6 agosto 2020. Ci sono tanti
misteri, al momento, relativi alla tremenda esplosione che ha devastato il porto
di Beirut. Forse li ricostruiranno gli esperti messi in campo dal governo
libanese, forse no. Però esistono anche alcune certezze. Spesso nei porti ci
sono accumuli di sostanze pericolose che possono portare a devastanti incidenti.
Questo non è il primo ci sono almeno due precedenti storici di sconvolgente
tragicità: l'incidente di Halifax e il disastro di Texas City. Entrambi sono
noti per essere le più devastanti esplosione registrate prima dell'invenzione
degli ordigni nucleari. Il primo dato da registrare è che la capacità di carico
delle navi è enorme e, spesso, il carico che portano può avere caratteristiche
molto ambigue. Nel caso di Beirut al centro della deflagrazione devastante, che
meglio potrebbe essere descritta come una catena di deflagrazioni, c'è, secondo
i primi rapporti, un enorme quantitativo di nitrato di ammonio. Il nitrato di
ammonio è fondamentalmente un fertilizzante e, come tale, era stoccato per un
quantitativo di 2.750 tonnellate nel magazzino 12 del porto da più di 6 anni,
dal 12 settembre 2013. La caratteristica della sostanza, in condizioni normali
molto stabile, è però quella di essere in grado di liberare ossigeno se
coinvolta in reazioni chimiche debitamente innescate. Detto in soldoni: è la
base di esplosivi molto amati dai terroristi, soprattutto miscelato a liquidi
infiammabili (accadde nell'attentato di Oklahoma City nel 1995). Nei porti può
essere depositato in quantitativi però che nessun terrorista può sognare. I due
esempi storici di cui parlavamo all'inizio possono darcene l'idea. L'esplosione
di Halifax è avvenuta il 6 dicembre 1917 in Canada. Halifax era fondamentale per
rifornire Inghilterra e Francia coinvolte in pieno nella Prima guerra mondiale.
Due navi cariche di esplosivi, di cui molti a base di nitrato di ammonio, la Imo
e la Mont Blanc, si scontrarono. Divampò un incendio, che colpì soprattutto la
Mont Blanc. Si intervenne per spegnerlo ma nessuno calcolò davvero cosa
significava il fuoco attorno a una nave a pieno carico di sostanze
termosensibili. La popolazione di Halifax invece di scappare uscì dalle case e
si mise a osservare la lotta contro le fiamme. Quando la Mont Blanc esplose
sprigionò sul colpo un energia pari a 3 chilotoni (contro i 16 della bomba
nucleare di Hiroshima). Vennero uccise 2mila persone, rasa al suolo qualsiasi
struttura nel raggio di 1,6 kilometri. Il disastro di Texas City avvenuto il 16
aprile 1947 negli Usa è ancora più illuminante. La nave francese SS Grandcamp
era stata caricata di nitrato a uso agricolo. Nessuno era pronto a fronteggiarne
la pericolosità era trattato come «concime». Quando il fuoco, per cause
inspiegabili, iniziò a sprigionarsi dalla stiva l'equipaggio mise in atto
procedure normali. Procedure che invece aumentarono la possibilità di innesco.
Tutto questo mentre il vapore arancione prodotto dalla combustione attirava una
folla di curiosi verso il molo. L'esplosione improvvisa provocò 581 morti e più
di 3mila feriti, radendo al suolo quasi mille edifici e creando esplosioni a
catena su altre navi. Potenza stimata, 3,6 chilotoni. Ma, evidentemente, queste
tragiche lezioni non sono state ancora apprese.
Nitrato di ammonio: cos’è la sostanza causa dell’esplosione di
Beirut. Notizie.it il 05/08/2020. Cos'è il nitrato di
ammonio, sostanza utilizzata in diversi ambiti che avrebbe causato l'esplosione
di Beirut. Potrebbe esserci un’ingente quantità di nitrato di ammonio dietro
l’esplosione che ha coinvolto Beirut martedì 4 agosto causando un bilancio di
almeno 73 vittime e 4.000 feriti: cos’è questa sostanza e per cosa viene
utilizzata?
Cos’è il nitrato di ammonio. Si tratta di un composto chimico con
formula NH4NO3 che, avendo caratteristiche che lo rendono molto versatile, viene
utilizzato in diversi ambiti. Per il 90% viene utilizzato in agricoltura, in cui
costituisce la base di numerosi fertilizzanti, ma possiamo trovarlo anche
nel ghiaccio istantaneo del quale è il principale composto. Il nitrato di
ammonio serve inoltre produrre miscele esplosive. Nel corso del tempo gli uomini
lo hanno impiegato sia per scopi civili, per esempio nelle miniere dato il
contenuto rilascio di calore che provoca e che impedisce la fuoriuscita di gas,
sia per scopi militari e di terrorismo. Essendo poco costoso e facilmente
reperibile, è infatti stato ampiamente usato per fabbricare ordigni. Per questo
la sua commercializzazione è ora disciplinata da specifici regolamenti con prove
di detonabilità.
I disastri causati dal composto. Quella di Beirut non è purtroppo
la sola esplosione (presumibilmente) causata da questa sostanza. Un altro
incidente che l’ha coinvolta è quello verificatosi il 17 aprile del 2013 alla
West Fertilizer, un’industria di fertilizzanti del Texas. In tale occasione
morirono 15 persone e ne rimasero ferite oltre 150. Sempre nel medesimo stato
americano nel 1947 si verificò quello che è noto come disastro di Texas City in
cui un’esplosione pari a circa 3,2 kilotoni causò la morte di almeno 580
cittadini. Da non dimenticare è poi quella verificatasi al porto di Tientsin nel
2015 che uccise 173 persone.
Nitrato d’ammonio: cos’è e perché è così diffuso nel mondo.
Francesca Salvatore il 5 agosto su Inside Over. Il
famigerato nitrato di ammonio, formula chimica NH4NO3, sarebbe il responsabile
della strage di Beirut. Che si tratti di un attentato o di una sfortunata catena
di eventi, nelle ultime ore si è diffuso il nome di questa sostanza sconosciuta
ai più ma molto più comune di quello che si crede.
Cos’è. Il composto chimico è utilizzato prevalentemente
come fertilizzante (viene applicato sotto forma di granuli e si dissolve
rapidamente quando esposto all’umidità, permettendo all’azoto di essere
rilasciato nel terreno), ma è diventato negli anni uno strumento utile a
produrre, con maggiore facilità, esplosivi. E’ facile, dunque, capire come una
sostanza del genere faccia il giro del mondo passando attraverso miniere e siti
militari. Sostanza cristallina inodore, è stata la causa di numerose esplosioni
industriali nel corso dei decenni: tra questi, un’esplosione in un impianto di
fertilizzanti del Texas del 2013 che ha ucciso 15 persone, in uno stabilimento
chimico di Tolosa, in Francia, che nel 2001 ha ucciso 31 persone. Ma ad
appropriarsene non solo più soltanto agenzie “riconosciute” ma terroristi e
guerriglieri di tutto il Mondo: il nitrato, mescolato ad ordigni semplici e
benzine, è divenuta la terribile arma in mano ai veicoli kamikaze nei teatri
iracheni e afgani post 11 settembre. Due tonnellate sono state usate per creare
la bomba nell’attacco di Oklahoma City del 1995 che ha distrutto un edificio
federale, uccidendo 168 persone. Queste formule sono sicuramente meno costose e
più abbordabili di altre, come ad esempio l’esplosivo al plastico che, sul
mercato nero, può arrivare anche a costare 2000 euro al chilogrammo. Cosa è
successo a Beirut resta ancora un mistero. Tuttavia, in normali condizioni di
stoccaggio e senza calore molto elevato, è difficile accendere il nitrato di
ammonio, ha dichiarato all’agenzia di stampa AFP Jimmie Oxley, professore di
chimica all’Università del Rhode Island. “Se si guarda il video [dell’esplosione
di Beirut], quella è stata una reazione incompleta”. “Suppongo che ci sia stata
una piccola esplosione che ha scatenato la reazione del nitrato di ammonio – sia
che quella piccola esplosione sia stata un incidente o qualcosa di
intenzionale”. Il nitrato di ammonio è un ossidante: intensifica la combustione
e consente ad altre sostanze di infiammarsi più facilmente, ma non è di per sé
molto combustibile. Ecco perché ci sono generalmente regole molto rigide su dove
può essere immagazzinato: per esempio, deve essere tenuto lontano da
combustibili e fonti di calore. Molti paesi dell’Unione Europea, per questa
ragione, richiedono che il carbonato di calcio venga aggiunto al nitrato di
ammonio per creare nitrato di ammonio di calcio, più sicuro. Negli Stati Uniti,
i regolamenti sono stati inaspriti in modo significativo dopo l’attacco di
Oklahoma City. In base agli standard antiterrorismo delle strutture chimiche, ad
esempio, le strutture che immagazzinano più di 900 kg di nitrato di ammonio sono
soggette a ispezioni.
Perché nel porto di Beirut. I competitors che producono
ufficialmente nitrato di ammonio nel mondo sono numerosi ma almeno una decina di
loro (dalla Russia all’Europa, dall’India al Medio Oriente, passando per gli
Usa) possono ritenersi leader del mercato: tra questi l’egiziana Abu Qir
Fertilizers è il vero leader mediorientale nel settore. Il materiale, inquesto
caso, proveniva da una nave di proprietà di un uomo d’affari russo, secondo
quanto riportato dalla televisione libanese. Le autorità libanesi nel 2014
avevano sequestrato 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio da una nave moldava
chiamata Rhosus, (fonte canale televisivo LBCI). Il Rhosus è di proprietà
di Igor Grechushkin, cittadino russo residente a Cipro. Il noto sito di
investigazione giornalistica Bellingcat ha rilevato che il composto era
apparentemente conservato in grandi sacchi accatastati l’uno sull’altro.
L’immagine mostra grandi sacchi con l’etichetta “Nitroprill”. Nitropril (con una
L) è il nome commerciale di una forma di nitrato di ammonio prodotto da Orica,
multinazionale australiana tra i maggiori fornitori al mondo di esplosivi
commerciali e sistemi di brillamento per i mercati minerario, estrattivo,
petrolifero, del gas e delle costruzioni. A causa della leggera differenza
nell’ortografia del nome, è possibile che i sacchi visti nella foto siano una
“imitazione” del prodotto originario o che siano legati ad una società
brasiliana chiamata Nitro Prill Bombeamento de Explosivos, l’unica al mondo,
pare, ad utilizzare questa denominazione. La nave stava viaggiando dalla Georgia
al Mozambico nel 2013, quando si è verificata un’anomalia e ha fatto una sosta
non programmata a Beirut. Poco dopo, secondo quanto riferito, Grechushkin
dichiarò bancarotta e “abbandonò” la nave lì, lasciando l’equipaggio bloccato
per mesi prima che il nitrato di ammonio potesse essere scaricato e collocato
nell’Hangar 12 del porto di Beirut, una grande struttura grigia di fronte alla
principale autostrada nord-sud del paese all’ingresso principale della capitale.
Da allora, le autorità del porto hanno chiesto almeno cinque volte la rimozione
di quel carico pericoloso temendo il peggio, come è poi accaduto. Erano allo
studio perfino tre proposte ben articolate: esportare il nitrato di ammonio,
consegnarlo all’esercito libanese o venderlo alla Lebanese Explosives Company.
Tutte proposte rimaste lettera morta e che si sono perse nella cattiva e
corrotta gestione del porto che, non a caso, è chiamato dai locali “Cavernadi
Alì Babà e dei quaranta ladroni” per la grande quantità di fondi statali rubati
lì nel corso dei decenni.
Geopolitica del nitrato di ammonio. Il nitrato di ammonio si
trova come minerale naturale nelle regioni più aride del deserto di Atacama in
Cile, spesso come crosta a terra o in combinazione con altri minerali. Il
nitrato di ammonio è stato estratto lì in passato, tuttavia, oggi quasi il 100%
della sostanza chimica attualmente utilizzata è di provenienza sintetica. Il
caso ha voluto che, tra la crisi Covid-19 e l’incombente recessione economica,
questi prodotti siano divenuti essenziali. Si stima il mercato dei nitrati di
ammonio in tutto il mondo crescerà di circa 2,4 miliardi di dollari USA.
Giappone, Germania e Stati Uniti sembrano le nazioni destinate ad avere la
leadership produttiva del composto: le mutevoli relazioni tra la Cina e il resto
del mondo, inoltre, influenzeranno la concorrenza e le opportunità del mercato
del nitrato stesso. Il monitoraggio continuo per i segni emergenti di una
possibile nuova crisi post-Covid-19 dell’ordine mondiale è un in questi mesi un
imperativo categorico per imprese e i loro astuti leader, che cercano di trovare
successo nel panorama in evoluzione del mercato dei fertilizzanti. Un punto
fondamentale per comprendere i flussi di questi materiali è la natura sempre più
incerta della geopolitica e delle tensioni commerciali nel mercato globale. Un
esempio di ciò sono state le sanzioni statunitensi contro l’Iran che hanno
provocato un reindirizzamento dei flussi commerciali. Stessa cosa dicasi per il
conflitto geopolitico tra Russia e Ucraina o per il caso del porto di Yuzhny sul
Mar Nero, dove molti prodotti azotati vengono esportati nel mercato globale.
Nuovi sviluppi ha fatto registrare il Brasile negli ultimi due anni, con le
attività legate all’azoto da parte del gigante Petrobras. A ciò si aggiungono i
casi di paesi dove si sono verificati massicci interventi statali nel settore
dei fertilizzanti come l’India, dove la Vijay Gas Industry Pvt. Ltd. si colloca
come una delle aziende leader del settore.
Sharon Nizza per repubblica.it il 20 agosto 2020. Hezbollah ha
acquistato ingenti quantità di nitrato d’ammonio nel 2013, ovvero nel periodo in
cui il materiale chimico è stato immagazzinato nell’hangar 12 del porto di
Beirut”. E’ quanto riporta oggi il quotidiano tedesco Die Welt, citando
“esclusive informazioni fornite da fonti di intelligence occidentali”. Il
Partito di Dio avrebbe acquistato circa 670 tonnellate di nitrato d’ammonio per
centinaia di migliaia di euro, in quattro spedizioni avvenute dal luglio 2013
all’aprile 2014, documentate in diverse ricevute di cui il Die Wielt cita date e
importi. Non è provato che le spedizioni in questione siano legate al materiale
che si trovava nell’hangar 12 del porto, le ormai note 2750 tonnellate del
componente chimico che, secondo le indagini libanesi ancora in corso, sono tra
le cause dell’enorme esplosione che ha devastato il centro di Beirut il 4
agosto, facendo 180 vittime e migliaia di feriti. I rifornimenti di nitrato di
ammonio destinati a Hezbollah arrivano dall’Iran, in operazioni coordinate dalla
Forza Quds, l’unità di élite delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane, guidata dal
generale Qasem Soleimani che è stato ucciso a gennaio a Baghdad in un raid
americano. La Forza Quds avrebbe recapitato il materiale via mare, via aerea e
via terra. Una delle compagnie aeree coinvolte nelle spedizioni è l’iraniana
Mahar Air, cui è impedito atterrare sul suolo tedesco dall’anno scorso. Nel
reportage di Die Wielt viene citato anche Mohammed Qasir come responsabile
dell’approvvigionamento del nitrato di ammonio. Qasir, noto anche come Hajj
Fadi, guida da Damasco l’Unità 108 di Hezbollah, incaricata del contrabbando di
armi dall’Iran al Libano, attraverso la Siria. Nonostante sia noto, come
denunciato anche da reporter locali, che Hezbollah sia l’entità che di fatto
gestisce il porto di Beirut, Hassan Nasrallah, il leader del Partito di Dio, ha
negato categoricamente qualsiasi coinvolgimento o responsabilità rispetto
all’esplosione del 4 agosto. L’anno scorso sono state rivelate diverse
operazioni che hanno collegato Hezbollah all’utilizzo del nitrato di ammonio.
Nel giugno 2019 i servizi segreti inglesi hanno reso noto che, nel 2015, avevano
sequestrato tonnellate del materiale chimico in quattro proprietà a Londra
gestite da cellule locali della milizia sciita. Nello stesso anno, la polizia di
Cipro ha arrestato Hussein Bassam Abdallah, doppia cittadinanza libanese e
canadese, trovato in possesso di oltre 8 tonnellate di nitrato d’ammonio.
Abdallah ha ammesso l’affiliazione a Hezbollah e patteggiato una pena di 6 anni.
Lo scorso aprile, la polizia tedesca ha sventato una cellula terroristica di
Hezbollah e nelle indagini è emerso lo stesso modus operandi di Londra: ingenti
quantità di nitrato di ammonio conservate in finti pacchi di ghiaccio
istantaneo. In concomitanza con l’operazione che ha portato all’arresto di
diversi operativi per complotto a fini terroristici, la Germania ha inserito
Hezbollah nella lista delle organizzazioni terroristiche.
La guerra per il porto di Beirut.
Lorenzo Vita l'11 agosto 2020 su Inside Over. Duemilasettecento tonnellate
di nitrato d’ammonio scaricate da una nave e rimaste immagazzinate in deposito
nel porto di Beirut. Qualche segnalazione da parte delle autorità portuali
lasciata cadere nella polvere dei cassetti di chi di dovere. Anni di oblio di
quel carico finché qualcosa – forse dei saldatori o forse qualcosa di diverso –
innesca una miccia che devasta il porto di Beirut, Gemmayzeh e lacera il
cuore del Libano. La capitale libanese non ha ancora quantificato i danni. Le
autorità provano a capire di cosa si tratti ma l’impressione è che la verità non
sarà mai del tutto appurata. Troppi gli interessi in gioco, i rischi politici,
economici e sociali. Beirut brucia in questi giorni e il Libano vive una crisi
economica figlia di un sistema ormai al collasso, dove parte del Paese chiede un
cambiamento drastico, che assomiglia a un regime change. Uno stravolgimento che
nasce da quel porto ormai raso al suolo e che rappresenta la chiave di tutto,
dell’inizio come della fine.
Il porto decide il destino del Libano. Il porto di Beirut è per
il Libano uno snodo cruciale. La maggior parte dell’import-export entrava e
usciva dal Libano attraverso i terminali della capitale ed era da sempre una
delle principali via d’accesso del Mediterraneo orientale e al Medio Oriente. E
di certo chi voleva avere (e chi vuole ancora) le chiavi del Libano non può che
passare per quell’hub di cui ora si contano i morti e le macerie. Oggi dal porto
di Beirut parte un triplo binario attraverso cui si snoda il futuro del Libano.
Qui ha avuto origine il tutto, rappresentato da quella nave Rhosus partita dalla
Georgia e forse diretta in Mozambico – diciamo forse perché dal Paese
africano sono arrivate in tal senso delle smentite – con annesso carico di
nitrato d’ammonio stipato nel silo deflagrato la scorsa settimana. E le indagini
partiranno proprio da questo: da ciò che era stipato nel porto, come veniva
controllato e come è stato innescato l’incendio. Un’inchiesta statale, su
esplicita richiesta dei vertici libanesi, che vogliono evitare a tutti i costi
che l’inchiesta diventi da statale a internazionale. Per orgoglio, sicuramente,
perché il Libano si considera naturalmente uno Stato pienamente in grado di
operare un’indagine, ma anche per evitare che dall’indagine internazionale si
passi al controllo internazionale. Un pericolo soprattutto per le fazioni
politiche e militari che compongono il mosaico libanese, preoccupate dal fatto
che altre potenze esterne – anche attraverso organizzazioni internazionali –
possano mettere Beirut e il suo porto sotto la propria egida.
Sradicare Hezbollah dall’hub libanese. La questione è chiaramente
di primaria importanza. Per le autorità libanesi, che si trovano a dover far
rispettare con estrema difficoltà il proprio potere sul porto di Beirut, ma
soprattutto pere Hezbollah e i nemici internazionali della milizia sciita, che
da tempo hanno individuato nell’hub marittimo della capitale uno snodo
fondamentale dei suoi traffici. Le informazioni attualmente disponibili fanno
propendere per una grave negligenza generale (documenti Reuters parlano anche
della presidenza a conoscenza del nitrato d’ammonio nel porto) ma nessuno sembra
puntare il dito direttamente contro Hezbollah. Tuttavia, ed è quello su cui
adesso molti puntano per minare la milizia di Nasrallah, nessuno può credere che
Hezbollah non fosse a conoscenza della quantità di nitrato d’ammonio sbarcata
dalla Rhosus. Particolare da non trascurare perché metterebbe sullo stesso piano
le autorità civili con il partito-milizia. A questo proposito, l’Atlantic
Council ha confermato questa linea anti Hezbollah ricordando che il governo
americano ha messo sotto osservazione Wafiq Safa, capo della sicurezza del
Partito di dio, per la sua influenza sulla gestione del porto. Una questione di
particolare rilevanza, su cui puntano anche molti analisti americani che, non a
caso, iniziano a porre l’accento sul controllo del porto di Beirut da parte
delle forze sciite. Lo dimostra Fox News, sito apertamente avverso a Hezbollah,
che in un articolo ha rilevato come diverse fonti affermino che molte delle
operazioni che si svolgevano nel porto erano sotto il controllo “non ufficiale”
del partito, molte delle quali illegali. Mentre altri vedono nel porto delle
capitale del Libano come un possibile luogo di approdo per i traffici di armi
legati anche alla Siria, e che partono dall’Iran.
Le interferenze esterne e il controllo sul Libano. L’accusa sui
traffici di Hezbollah unita a quella sulla presenza di depositi di armi degli
sciiti nelle città libanesi sono le accuse con cui in molti vogliono scardinare
il dominio della milizia nelle sue roccaforti. Partire dal controllo del porto
post-esplosione potrebbe essere fondamentale, al pari del monitoraggio sulle
riforme interne e sulla ricostruzione dello stesso hub. La corsa alla sua
ricostruzione, come quella per gli aiuti umanitari, è già una lotta politica per
avere le chiavi di una parte essenziale del Paese e il suo futuro. In questo
senso, le parole dell’ambasciatore russo in Libano, Alexander Zasypkin – che ha
messo in guardia sulle “interferenze negli affari interni del Libano sotto la
copertura di una catastrofe umanitaria” – risuonano come un avvertimento
importante. Perché è chiaro che Mosca parli da diretta interessata visto che il
Libano è una delle porte del Mediterraneo e oggetto (ennesimo) di un’eterna
contesa che decide il destino della regione.
La guerra tra Israele ed Hezbollah del 2006.
Mauro Indelicato il 14 agosto 2020 su Inside Over. La guerra
tra Israele ed il movimento libanese Hezbollah è un conflitto che si è
combattuto nell’estate del 2006, scoppiato il 12 luglio e fermato soltanto il 14
agosto successivo a seguito del via libera del cessate il fuoco. La guerra del
2006 ha visto contrapposte le forze israeliane a quelle del movimento Hezbollah:
quest’ultimo rappresenta un gruppo sia politico che paramilitare formato
soprattutto da sciiti e per tal motivo molto vicino all’Iran. Gli Hezbollah sono
molto radicati nelle zone a maggioranza sciite del Libano, le quali si trovano
soprattutto nella zona meridionale del Paese dei cedri. La tensione nel sud del
Libano è sempre stata molto elevata, proprio a causa della vicinanza delle
frontiere con Israele.
Il contesto storico in cui matura il conflitto tra Israele ed
Hezbollah. Tra il governo israeliano ed il movimento Hezbollah il rischio di una
vera e propria guerra è sempre stato molto elevato. Al pari di Hamas,
l’organizzazione palestinese ramificata soprattutto nella striscia di Gaza,
Hezbollah rappresenta forse il pericolo più importante avvertito da Israele. Dal
canto suo, in Libano il movimento vanta un importante radicamento sul territorio
ed un supporto politico non indifferente da parte degli sciiti libanesi. Anche
per questo motivo Hezbollah nel corso degli anni si è potuta rafforzare,
specialmente per quanto concerne l’aspetto paramilitare: il movimento si è
dotato di un corpo di fanteria tra i più importanti del medio oriente, forse
anche più forte di alcuni eserciti della regione. Nel luglio del 2006 al timone
del governo in Israele vi era Ehud Olmert: quest’ultimo era l’erede di Ariel
Sharon, l’ex leader del Likud che l’anno precedente aveva fondato Kadima, un
nuovo partito di centro sorto dopo la scissione con la storica formazione di
centro – destra. Sharon però, nel dicembre del 2005, è entrato in coma a causa
di una grave malattia e non ha più potuto esercitare i suoi ruoli di premier e
capo di partito, andati per l’appunto ad Olmert. L’eredità politica principale
di Sharon in quel momento era l’abbandono della striscia di Gaza, con tutte le
colonie israeliane evacuate nell’estate del 2005. Un episodio che sembrava
favorire la ripresa del processo di pace, ma che ha incontrato poi parecchie
resistenze interne e non ha portato agli effetti sperati. A far degenerare poi
la situazione definitivamente, quanto poi accaduto lungo il confine tra Israele
e Libano.
L’attacco a Zar'it-Shtula. La guerra è scoppiata al mattino del
12 luglio 2006: un commando degli Hezbollah ha effettuato infatti un’imboscata
in territorio israeliano poco dopo il lancio di alcuni razzi, partiti dal sud
del Libano, e diretti contro alcune postazioni dell’esercito dello Stato
ebraico. L’incursione, avvenuta nei pressi del villaggio di Zar’it-Shtula, ha
determinato l’uccisione di tre soldati israeliani, il ferimento di due e la
cattura di altri due membri dell’esercito. L’obiettivo degli Hezbollah era
proprio quello di prendere alcuni prigionieri per poterli poi scambiare con
propri membri detenuti in Israele. A dichiararlo, nelle ore successive
all’attacco, il leader degli Hezbollah, Hassan Nasrallah. Quest’ultimo ha
denominato l’incursione “Operazione Promessa Fedeli”, in quanto il blitz era
stato promesso un anno prima in caso di fallimento di precedenti trattative
diplomatiche volte a riportare in Libano alcuni prigionieri del movimento. A
quest’operazione la replica israeliana non si è fatta attendere: il premier
Olmert ha parlato di vero e proprio “atto di guerra”, accusando il governo
libanese di essere responsabile dell’accaduto. Da Beirut, il premier Siniora ha
respinto le accuse attribuendo la paternità dell’attacco soltanto ad Hezbollah e
condannando l’operazione effettuata dal movimento sciita. Il fatto però che la
stessa Hezbollah avesse due ministri nel governo libanese, non ha deposto a
favore di un’immediata azione diplomatica sviluppata anche da attori terzi. Nel
pomeriggio di quel 12 luglio, l’aviazione israeliana è entrata in azione
bombardando alcuni obiettivi del movimento sciita nel sud del Libano. Colpi di
artiglieria sono stati sparati sempre verso il sud del Paese dei cedri, mentre
poche ore più tardi i bombardamenti coinvolgevano anche l’aeroporto di Beirut.
Dal canto suo, Hezbollah rispondeva con lanci di razzi verso le città del nord
di Israele.
23 luglio: inizia l’offensiva di terra di Israele. Dopo diversi
giorni di tensione, con bombardamenti da parte israeliana e lanci di razzi dal
Libano operati dagli uomini di Hezbollah, il governo dello Stato ebraico ha
deciso di lanciare un’operazione di terra per provare a distruggere le basi di
lancio usate dai rivali. Il 23 luglio un primo contingente israeliano è
penetrato in territorio libanese nell’area di Maroun al-Ras. Ad avanzare sono
stati diversi reparti dell’esercito, i quali ben presto si sono dovuti scontrare
con la resistenza messa in campo da Hezbollah. Obiettivo principale da parte
delle forze israeliane era la città di Bint Jbeil e questo sia per una
motivazione militare che simbolica: questa località infatti dal 1982 al 2000 è
stata sotto occupazione israeliana nell’ambito dell’operazione avviata in Libano
negli anni ’80 dal governo di Tel Aviv. L’allora premier Barak nel 2000 ha
deciso di lasciare Bint Jbeil, che da allora è diventato un centro molto
importante per Hezbollah. Dunque, riprendere il controllo di questa cittadina
avrebbe significato infliggere un duro colpo per la milizia libanese. Tuttavia
l’avanzata israeliana è stata arrestata, la battaglia si è rivelata molto dura
ed entrambe le parti hanno subito diverse perdite tra morti e feriti. Operazioni
di terra ad opera di truppe israeliane sono state registrate anche a Baalbeck,
mentre i bombardamenti tra fine luglio ed inizio agosto hanno riguardato anche
la città di Tiro, oltre che l’intero sud del Libano ed i quartieri di Beirut a
maggior radicamento sciita.
I lanci di razzi nel nord di Israele. Il mezzo usato da Hezbollah
per rispondere ai bombardamenti israeliani e per provare a destabilizzare la
situazione nello Stato ebraico sotto il profilo della sicurezza ha riguardato il
continuo lancio di razzi. Durante buona parte della guerra infatti, dal sud del
Libano sono piovuti centinaia di razzi diretti verso diverse località
israeliane. Non solo obiettivi militari o piccoli villaggi di confine, bensì
anche città più grandi come tra tutte Haifa: considerata come la terza
“metropoli” israeliana dopo Gerusalemme e Tel Aviv, il suo territorio era tra i
più esposti al costante lancio di razzi operato dal Libano tra luglio ed agosto.
Durante tutte le settimane del conflitto, la quotidianità nel nord di
Israele era scandita dal suono delle sirene che sia di giorno che di notte
annunciavano l’arrivo di missili dall’altra parte del confine. In diverse
occasioni la contraerea non ha potuto neutralizzare la minaccia: ad Haifa, come
nelle altre località colpite, in molti casi le esplosioni hanno causato la morte
od il ferimento anche di civili.
Il sud del Libano in ginocchio. La conta dei danni è stata ancor
più drammatica nel sud del Libano: è qui che si è concentrato il grosso della
reazione israeliana, le città di questa parte del Paese dei cedri sono state
duramente colpite sia dai bombardamenti che, lì dove si è combattuto, dalle
operazioni di terra. Tiro, Sidone, ma anche Baalbek più a nord, i paesi di
confine ed i quartieri meridionali di Beirut hanno accusato la distruzione di
intere zone e la morte di centinaia di civili. Si calcola che nel solo sud del
Libano siano decedute quasi 1.000 persone, escludendo militari e miliziani
Hezbollah. A questo, occorre aggiungere che l’economia di queste aree è stata
completamente bloccata: dal turismo al commercio, il sud del Libano ha dovuto
fare i conti con un contesto sociale ed economico uscito ridimensionato dal
conflitto.
La risoluzione 1701 dell’11 agosto. Sul fronte diplomatico molte
iniziative non sono andate a buon fine. Gli Stati Uniti hanno da subito
appoggiato l’operazione israeliana, il governo libanese dal canto suo ha cercato
sponde in seno al consiglio di sicurezza dell’Onu per provare un accordo di
cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah. Le due parti sono sempre apparse
molto distanti da ogni possibile intesa: il movimento sciita ha chiesto sia a
luglio che ad agosto un cessate il fuoco incondizionato, lo Stato ebraico invece
ha posto la condizione del rilascio dei due soldati israeliani rapiti il 12
luglio. All’inizio di agosto però la guerra era giunta in una fase di stallo:
Israele non riusciva ad avanzare in profondità in Libano e molte guarnigioni
filo sciite sono rimaste operative, Hezbollah dal canto suo ha sì dimostrato una
certa capacità di resistenza ma le condizioni disastrose in cui stava iniziando
a vivere il sud del Libano rischiavano di minare il proprio radicamento
territoriale. Per questo dunque si sono create, all’interno del consiglio di
sicurezza dell’Onu, le condizioni per un accordo di cessate il fuoco. L’11
agosto il consiglio ha approvato la risoluzione 1701, con la quale è stata
chiesta la fine delle ostilità.
Arriva il cessate il fuoco. Il giorno dopo il voto unanime
espresso dal consiglio di sicurezza, il governo libanese ed il movimento
Hezbollah hanno accettato l’accordo di cessate il fuoco. Il 13 agosto invece, è
arrivato il via libera all’intesa anche da parte del governo israeliano. Per
questo il cessate il fuoco è stato dichiarato da ambo le parti a partire dalle
ore 8:00 del 14 agosto 2006. Da quel momento in poi le armi hanno iniziato a
tacere e non si sono verificati più scontri di grossa entità. Entrambe le parti
in conflitto hanno cantato vittoria: Hezbollah ha celebrato l’inizio del cessate
il fuoco come una vera e propria vittoria, proclamando come risultato storico
quello di aver fermato le velleità militari di Israele. Dall’altro lato, il
governo israeliano ha dichiarato che la risoluzione Onu 1701 ha decretato un
vantaggio per i propri interessi nazionali: da un lato ha posto le basi per il
rilascio dei soldati israeliani, dall’altro ha fatto in modo di congelare un
conflitto che avrebbe comunque, a detta del premier Olmert, ridimensionato la
forza di Hezbollah. In realtà, i 32 giorni di conflitto hanno provocato danni e
perdite su entrambi i fronti: Hezbollah ha sì cantato vittoria, ma al tempo
stesso ha dovuto fare i conti con un conteggio elevato di vittime, forse più di
500, tra le proprie fila e si è ritrovato con le regioni libanesi in cui appare
più radicato completamente distrutte e con oltre mille civili morti a seguito
del conflitto. Israele invece, ha speso molto per una guerra che, come poi
ammesso da Olmert, è stata condotta non senza errori e problemi. Tra gli
israeliani si sono contate 43 vittime tra i civili e 119 tra i militari.
La missione Unfil 2 dell’Onu. Dopo il cessate il fuoco,
preoccupazione principale della comunità internazionale era quella di evitare
nuove tensioni e nuovi conflitti nell’area. Per questo sono state intavolate
trattative diplomatiche per permettere uno scambio di prigionieri, volto a dare
un primo segnale di distensione. Da subito si è poi lavorato per creare le
condizioni affinché potesse essere impiantata nel sud del Libano una forza di
interposizione. Per la verità nell’area insisteva già una missione che aveva
questo obiettivo era nata nel 1978: si trattava della missione Unfil, posta
sotto l’egida delle Nazioni Unite. La risoluzione 1701 ha disposto, tra le altre
cose, la possibilità di potenziare Unfil con l’obiettivo di favorire il ritorno
dell’esercito libanese del sud del Paese, a discapito delle postazioni degli
Hezbollah. La nuova fase della missione Unfil è stata avviata nel settembre del
2006: a prendervi parte sono 37 contingenti di altrettanti Paesi. L’Italia ha
fornito ad Unfil l’apporto più significativo in termini numerici e politici. Il
nostro Paese è arrivato con un proprio contingente in Libano sbarcando a Tiro
nel settembre 2006.
La situazione oggi. La tensione dell’estate 2006 non è mai stata
più raggiunta: il fronte del Libano meridionale si è progressivamente
raffreddato, anche se non mancano elementi di tensione a partire dai rapporti
tra Hezbollah ed Israele. Questi ultimi risentono molto a loro volta del
rapporto tra il governo israeliano e l’Iran, principale sponsor del movimento.
Hezbollah viene considerato come un elemento determinante per la strategia della
“mezzaluna sciita” portata avanti negli ultimi anni da Teheran e dal generale
Qasem Soleimani, ucciso a Baghdad da un raid Usa il 3 gennaio 2020. Per questo
la tensione, lì dove nel 2006 si è scatenata una breve ma intensa guerra,
rimarrà ancora molto alta per diverso tempo.
Chiara Clausi per “il Giornale” il 23 settembre 2020. Un boato e
poi una grossa colonna di fumo nero. Una nuova grande esplosione è avvenuta ieri
pomeriggio nel villaggio di Ain Qana, nel sud del Libano. Ha provocato un
incendio e un denso fumo nero. Secondo i primi elementi, l'esplosione è avvenuta
in un edificio di proprietà di Hezbollah, ma non è ancora chiaro se fosse un
magazzino di armi o l'abitazione di un quadro del partito. Una fonte all'interno
dei servizi di sicurezza ha precisato che un deposito di armi appartenenti a
Hezbollah è stato distrutto dall'esplosione a seguito di un errore tecnico. «La
terra ha tremato e poi abbiamo sentito una forte esplosione. All'inizio pensavo
si trattasse di un raid israeliano», ha detto Mahmoud, un abitante del posto.
«Ma poi ci siamo resi conto che era in una casa ai margini del villaggio e
abbiamo sentito le ambulanze». Quattro sono le vittime secondo fonti e testimoni
locali. Hezbollah è la forza politica dominante nel sud del Libano e mantiene un
potente braccio militare che ha più di 100 mila razzi. Un portavoce di Hezbollah
ha riferito però che l'esplosione è avvenuta in un centro di sminamento
collegato al gruppo sciita in cui erano immagazzinate munizioni inesplose di una
precedente guerra con Israele. Il portavoce ha anche confermato che l'esplosione
è stata causata da un errore tecnico, ma ha negato che ci siano state vittime.
Secondo fonti locali invece diversi sono i feriti, ma non si hanno numeri
precisi. L'esplosione è avvenuta in una zona residenziale, una ventina di
abitazioni sono state danneggiate e diverse auto distrutte. I residenti nella
zona in preda al panico sono stati evacuati e sono corsi nella direzione opposta
al fumo, mentre altri sono rimasti increduli a guardare. I membri di Hezbollah
hanno isolato il luogo dell'esplosione e hanno impedito ai giornalisti di
avvicinarsi all'area. Secondo l'Agenzia nazionale libanese, dalla mattina fino
al momento dell'esplosione erano stati notati intensi sorvoli israeliani, con
aerei da guerra e droni-spia, nelle zone di Iklim al-Touffah e Nabatiye, vicino
a dove è avvenuta l'esplosione. Il botto è stato sentito fino alla città di
Saida, a circa trenta chilometri di distanza. Ma ieri è stata una giornata
travagliata anche per altri motivi. Al mattino, un piccolo incendio è divampato
nel perimetro del porto di Tripoli nel nord del Libano. E un altro è avvenuto
nel pomeriggio in un magazzino di pitture nel distretto di Ouzai, nella
periferia sud di Beirut, senza fare feriti. Questa ennesima esplosione arriva in
un momento difficile e preoccupante per il Libano. Il Paese è ancora
traumatizzato dalla doppia esplosione del 4 agosto, che ha dilaniato il porto di
Beirut, e ha ucciso più di 190 persone e ferito 6.500. Quel fatidico 4 agosto,
l'incendio è scoppiato in un hangar del porto di Beirut dove erano immagazzinate
2.750 tonnellate di nitrato di ammonio, custodite senza alcuna misura di
sicurezza. Il 10 settembre è scoppiato un nuovo incendio nello stesso porto, che
ha provocato un forte fumo tossico che ha ricoperto la città e causato un
tremendo panico tra i beirutini ancora traumatizzati dal disastro di agosto.
Quello di ieri è l'ennesimo incidente, Beirut e il Libano sono stremati e
davanti ad una grande prova di coraggio e resistenza.
·
Quei razzisti come
gli Iraniani.
Guerre antiche e nuove dell'Iran "apocalittico".
L'uccisione del leader del progetto nucleare di Teheran riapre
anche il dibattito geopolitico. Fiamma Nirenstein, Mercoledì 16/12/2020 su Il
Giornale. Mohammed Al Saaed, l'analista politico del giornale saudita Okaz
scrive il 30 novembre «come si può condannare l'uccisione di un uomo che ha
dedicato la sua vita a costruire una sinistra bomba atomica per un regime
malvagio, mentre non condannano l'uccisione di tanti innocenti nella regione.
L'Iran uccide Siriani, Iracheni, Libanesi, ha distrutto lo Yemen, e sponsorizza
gruppi terroristici...». A cui, aggiungiamo noi, l'Iran uccide americani,
francesi cittadini di ogni origine, colore, credo... e programma il genocidio in
un intero Paese che «verrà cancellato dalla faccia del mondo», Israele. L'uomo
di cui qui si parla è Moshen Fakhrizadeh. È stato definito scienziato, fisico,
professore universitario. Ma non c'è nulla che rappresenti meglio delle reazioni
pietistiche di questi giorni all' eliminazione di Fakhrizadeh la confusione e
l'ignoranza sul regime degli Ayatollah e sui suoi molteplici significati. In
realtà le condoglianze, se si da ai dolenti il beneficio di inventario, sono
suonate più che altro come una nota di amaro biasimo nei confronti di Israele. È
stata un'occasione irresistibile per mostrare i propri colori, per dare di
gomito al regime più feroce del mondo che perseguita, soprattutto, i propri
cittadini soggiogati e perseguitati dalle Guardie della Rivoluzione degli
Ayatollah. Ma le lacrime sullo «scienziato nucleare» Moshen Fakhrizadeh sono
lontane dalla comprensione di quel che Fakhrizadeh rappresentava per la guerra
iraniana. Il punto di vista umanitario, tipico della nostra cultura, non
funziona quando si parla di un generale in guerra, e qui di questo si tratta: di
un altissimo ufficiale, responsabile del programma fondamentale per uno scontro
in atto nel presente. Fakhrizadeh, infatti, non era uno in primis scienziato o
professore universitario, ma un generale della Guardia Rivoluzionaria che,
mentre insegnava fisica all'Università delle Guardia Imam Hussein, aveva un
ruolo strategico nel maggiore fra i disegni di conquista di uno Stato islamico
mondiale, da compiersi per passi successivi, in cui l'atomica è fondamentale. E
Fakhrizadeh era il padre della bomba da quando, nel 1998, era stato messo alla
testa del programma nucleare, col ruolo di capo del PHRC, il centro di ricerche
per lo sviluppo nucleare. La determinazione di Fakhrizadeh a raggiungere la
bomba si articola in mille invenzioni e cambiamenti di strada. La maggioranza
degli sciiti appartiene all corrente dei duodecimani: crede alla sequenza dei
dodici imam succeduti a Mometto. Il dodicesimo, Muhammad ibn Hossein al Mahdi,
nato nell'869, è sparito a 72 anni e dal suo divino nascondimento ma prepara il
suo ritorno e il giorno del giuzio. Dal '79, momento della rivoluzione
khomeinista, esso diventa, per l'Iran, imminente. La guida degli imam verso
l'obiettivo è variamente interpretata, ma sicura, e nella battaglia è fatale
l'uso della Taqiyya, ovvero la dissimulazione per il bene supremo della
comunità, consente di procedere verso l'obbiettivo con bugie e mosse
diplomatiche mentre prosegue lo scontro col mondo degli infedeli e dei traditori
della fede. Il così detto Mahdismo è molto rilevante nella leadership odierna,
gli sciiti, che hanno molto sofferto la loro condizione di minoranza islamica,
pensano che coll'avvento del Profeta le sofferenze avranno fine. E come
Ahmadinejad e anche Khamenei hanno ripetuto, per il ritorno del Mahdi occorre
una conflagrazione universale. Che quindi non è temuta, ma auspicata: il grande
momento del mahdismo è stato quello di Ahmadinejad. Ma anche se c'è chi lo
ritiene più immediato e chi meno, gran parte della leadership civile e militare
è comunque fedele o vicina a questa ideologia compreso il moderato Rouhani. La
bomba atomica, la distruzione di Israele, le ossessive minacce all'Occidente, la
violenza con cui il regime reprime il comportamento indipendente, sia nel campo
delle opinioni che il quello personale (basta pensare all'oppressione delle
donne e dei gay, fino alla condanna a morte), la spesa enorme che si carica per
finanziare gli Hezbollah, Hamas, gli attentati terroristici che ne fanno il
primo Stato terrorista, il mantenimento di milizie come i Basiji e Quds, tutti
addestrati, feroci, pronti a colpire... sono tutti segnali dell'esistenza di uno
stato di guerra continua, la guerra messianica che invoca la rivoluzione
mondiale. Un saggio scritto per l'ASMEA da Norvell B. De Atkine, Historical
considerations in understanding Iran's Military and their way of war, traccia il
rapporto fra la guerra iraniana odierna e quella dei secoli trascorsi. De Atkine
cita fra i molti testi History of Warfare di John Keegan che dipinge le guerre
persiane contro i greci come «evasive, indirette, molto astute psicologicamente
e nell'uso delle informazioni segrete», mentre Kaveh Farook con Ombre nel
deserto spiega che i persiani ottenevano la distruzioine del nemico con l'uso
dei loro arceri, da lontano, prima di dover entrare in un copro a corpo.
Potevano «oscurare il sole» con una nuvola di frecce che piovevano dall'alto.
Bravi e coraggiosi combattenti, tuttavia, come dice Erodoto, avevano metodi di
combattimento di cui il saggio sostiene la permanenza; così anche un intenso
senso di identità di fronte alle ripetute invasioni occidentali e orientali,
dagli arabi agli inglesi; si loda, nel saggio, la capacità persiana di raffinata
immaginazione, di uso della diplomazia e delle informazioni, e anche la superba
capacità di lanciare immense folle nella lotta. Oggi basta pensare alle folle
difronte a Khamenei che gridano «morte all'America», dimostrando una incredibile
hubris e fiducia in sè stesse e nella propria fede. Per capire Tom Holland nel
suo The Persian Fire, sempre citato da De Atkine: «se si guarda a come i
Persiani vedono sè stessi, nessun popolo ha una maggior fiducia nella propria
virtù». Virtù di guerrieri e conquistatori, iscritta nel loro carattere
nazionale e nell'evidente ambizione delle elite, dalla loro convinzione che il
loro ruolo nel mondo è sottostimato e non riconosciuto per ciò che vale.
Recentemente poi l'amara esperienza della guerra con l'Iraq ha insegnato a
cercare di vincere i conflitti evitando la perdita umana ed economica di uno
scontro diretto, ha esaltata l'uso antico di gruppi locali proxy come gli
Hezbollah o Hamas, la raffinato l'uso del sorriso diplomatico alla Zarif. Tutto
questo rientra nella tecnica di una guerra in corso, oggi, ma guerreggiata in
stile diverso. Una guerra in cui Fakhrizadeh era un generale combattente.
Quegli
strani voli tra Iran e Venezuela.
Paolo Mauri su
Inside Over il 10 novembre 2020. Da qualche giorno un Boeing 747-200 registrato
presso la Fars Air Qeshm, che risulta essere una compagnia aerea cargo di
copertura per le attività delle Irgc (Islamic Revolutionary Guard Corps), le
guardie della rivoluzione islamica iraniane note anche come Pasdaran, sta
effettuando la spola tra Teheran e Caracas, facendo scalo in aeroporti diversi
tra Europa e Nord Africa. La Fars Air Qeshm, come riportato dal sito del
Dipartimento del Tesoro Usa, è attualmente sotto embargo per le attività
correlate al supporto delle milizie filoiraniane pro Assad in Siria. Apprendiamo
che la Fars Air Qeshm, che tra il 2006 e il 2013 operava come compagnia aerea
commerciale, ha ripreso le operazioni nel 2017 e la sua flotta di due aeromobili
Boeing 747 ha effettuato voli cargo regolari a Damasco, consegnando merci varie
comprese spedizioni di armi, per conto della Forza Quds delle Irgc. La Fars Air
è strettamente collegata ad un’altra compagnia aerea iraniana sotto embargo,
la Mahan Air: risulta che dipendenti della Mahan occupino posizioni dirigenziali
presso Fars Air e la stessa Mahan Air le fornisca supporto tecnico e operativo,
facilitandone le operazioni illecite. La consegna di armi da parte di Fars Air
ha permesso il sostegno concreto dell’Iran al regime di Damasco, inoltre risulta
che la compagnia che la controlla, la Mahan, sia quella più utilizzata per
trasportare personale della Forza Quds, tra cui anche il fu generale Qasem
Soleimani. Il primo volo di un Boeing 747 della Fars Air Qeshm diretto verso
il Venezuela è stato “beccato” da fonti open source di intelligence lo scorso 27
ottobre. Il velivolo, con le marche Ep-Fab, è decollato da Teheran diretto a
Caracas facendo un primo scalo per rifornirsi a Tunisi, ed un secondo a Capo
Verde, lasciando quindi supporre che il Boeing volasse a pieno carico. L’aereo è
stato poi fotografato mentre scaricava sull’aeroporto della capitale
venezuelana, ma non è chiaro cosa ci fosse sui carichi pallettizzati, che sono
comunque sembrati abbastanza voluminosi. Il 747 è ritornato in Iran due giorni
dopo, questa volta effettuando uno scalo a Belgrado, in Serbia, e sorvolando lo
spazio aereo italiano. Sempre il 27 un altro aereo, un Airbus A340-200,
della Conviasa, una compagnia passeggeri venezuelana, è stato notato sulla
stessa tratta diretto verso Caracas effettuando lo scalo sempre a Belgrado, ma
non è chiaro se sia coinvolto o meno in qualche tipo di traffico illecito.
L’ultimo volo noto, effettuato sempre dal 747 della Fars Air Qeshm, è decollato
da Teheran nella notte tra il 5 ed il 6 novembre, e dopo aver effettuato il
medesimo scalo tunisino, sembra essere in rotta per Capo Verde (evitando
accuratamente lo spazio aereo algerino): probabilmente si tratta sempre di un
carico molto pesante che lascia supporre che l’aereo trasporti armamenti di
qualche tipo. Questi voli cargo arrivano, infatti, a pochi giorni da una strana
dichiarazione del governo venezuelano in merito proprio alla possibilità di
acquistare armi dall’Iran. Nella giornata di ieri, 5 novembre, durante la visita
ufficiale del ministro degli Esteri iraniano Javad Zarif in Venezuela, la sua
controparte locale, il ministro Jorge Arreaza, ha affermato davanti ai
giornalisti che il Venezuela non ha ancora programmato di acquistare sistemi
missilistici dall’Iran sino ad oggi, ma che avrebbe il diritto di farlo qualora
fosse necessario. “Non c’è nessuna nave in arrivo con i missili, ma ci sono
relazioni (con l’Iran n.d.r.), e quando le nostre Forze Armate e i colleghi
iraniani decideranno che sarà necessario acquisire armi, lo faremo. Nessuno e
niente può proibircelo” sono state le parole del ministro Arreaza. Alla fine di
ottobre, l’inviato speciale degli Stati Uniti Elliott Abrams ha affermato che
gli Stati Uniti distruggerebbero i missili iraniani a lungo raggio in caso
venissero venduti al Venezuela: un’altra dichiarazione “strana”, che lascia
supporre che Washington sia al corrente di un qualche tipo di traffico di armi
tra Teheran e Caracas, forse proprio attraverso questi voli cargo o addirittura
sfruttando le petroliere iraniane che sono state viste arrivare nel Paese nelle
settimane e nei mesi scorsi: non sarebbe la prima volta che personale e
componentistica militare varia vengano trasportati con la copertura di
spedizioni commerciali di qualche tipo. A margine si può anche riflettere su
come un Paese che letteralmente galleggia su un mare di idrocarburi abbia
bisogno di importare prodotti petroliferi raffinati dall’estero, evidenziando
come anni di politica chavista sia stata un disastro per l’economia e le
infrastrutture venezuelane. Cercare di capire invece che tipo di armamenti un
Venezuela stremato dalle sanzioni Usa ed europee possa acquistare dall’Iran,
dopo che per il regime degli Ayatollah è finito ufficialmente l’embargo sugli
armamenti lo scorso 18 ottobre. Se da un lato Teheran guarderà, a medio lungo
termine, al mercato degli armamenti russo e asiatico, dall’altro potrebbe
vendere (in futuro) dei suoi prodotti autoctoni come alcuni tipi di sistemi
missilistici da difesa aerea come il nuovo Bavar-373, un sistema terra-aria noto
dal 2016 che è stato recentemente testato con successo durante le
esercitazioni Defenders of Velayat Skies 99, senza dimenticare i missili
da crociera antinave o terrestri della serie Noor e Soumar / Hoveyzeh.
Morirono 176 persone. Aereo abbattuto dopo morte Soleimani,
Iran ammette: Boeing scambiato per missile.
Redazione su Il Riformista il 12 Luglio 2020. Una batteria
di missili disallineata e problemi di comunicazione tra le truppe e i
comandanti. Sono questi i motivi che avrebbero portato all’abbattimento del
Boeing della Ukraine International Airlines, avvenuto lo scorso 8 gennaio, da
parte dell’Iran, dove sono rimaste uccise 176 persone. La conclusione emerge da
un rapporto dell’Aviazione civile iraniana, rilasciato mesi dopo l’accaduto e a
seguito di un’indagine che aveva faticato a decollare: in un primo momento,
infatti, Teheran aveva declinato ogni responsabilità procedendo poi a un cambio
di passo nel momento in cui diversi Paesi occidentali avevano riportato prove
sul suo coinvolgimento. Secondo quanto emerso dal report, la batteria
missilistica terra-aria era stata spostata e non era stata riorientata
correttamente: “i militari che si occupavano dell’equipaggiamento non sarebbero
riusciti a comunicare con il centro di comando, identificando erroneamente il
volo civile come una minaccia e hanno aperto il fuoco due volte senza ottenere
l’approvazione da parte dei funzionari di rango”, è la tesi espressa nel
documento. Il rapporto dell’Aviazione potrebbe segnare una nuova fase
dell’indagine sullo schianto del velivolo, visto anche che la scatola nera
dovrebbe essere inviata a Parigi il prossimo 20 luglio per essere esaminata da
investigatori internazionali. L’abbattimento dell’aereo si era verificato la
stessa notte dell’attacco iraniano a una base Usa in Iraq, lanciato in risposta
dell’uccisione del generale della Guardia Nazionale, Qassem Soleimani, il 3
gennaio scorso a Baghdad, in Iraq. All’epoca quindi le truppe di Teheran si
stavano preparando al contrattacco e, da quanto emerso, avrebbero scambiato il
Boeing ucraino per un missile. Tuttavia il report differisce dalla ricostruzione
citando solo un cambiamento “nel livello di allerta nella difesa aerea
dell’Iran”. Secondo funzionari e analisti di intelligence occidentale, Teheran
avrebbe abbattuto il Boeing con un sistema Tor di fabbricazione russa, noto alla
Nato come SA-15: nel concreto, un sistema montato su un veicolo cingolato che
trasporta un radar e un pacchetto di otto missili.
Il Boeing 737 della compagnia ucraina era appena decollato
dall’aeroporto internazionale Imam Khomeini quando è stato sganciato il primo
missile che ha probabilmente danneggiato le apparecchiature radio. Il secondo,
invece ha colpito direttamente il velivolo, come si evince dai video in cui si
vede l’aereo che esplode prima di schiantarsi alla periferia di Teheran. Il
volo, diretto a Kiev, trasportava 167 passeggeri e nove membri dell’equipaggio
provenienti da diversi paesi, tra cui 82 iraniani, 57 canadesi, tra cui molti
iraniani con doppia cittadinanza, e 11 ucraini, tutti morti nello schianto.
·
Quei razzisti come gli Arabi.
La notte dei lunghi coltelli in Arabia Saudita.
Mauro Indelicato il 26 luglio 2020 su Inside Over. Ufficialmente
il sovrano sta bene, il 22 luglio ha anche presenziato seppur soltanto
virtualmente dall’ospedale ad una delicata riunione del consiglio dei ministri e
l’attività amministrativa va avanti secondo le sue direttive. Ma in Arabia
Saudita è bastata l’indiscrezione circa il nuovo ricovero di Re Salman per
scatenare voci e scenari relativi alla successione. Il capo dello Stato ha 84
anni, più volte la sua salute è stata al centro di indiscrezioni e l’impressione
è che il regno a breve dovrà avvicinarsi ad una delicata successione. Per la
prima volta, comunque vada, l’Arabia Saudita non avrà al trono un discendente
diretto del primo sovrano, Re Abd Al Aziz Al Saud. Questo sta comportando un
certo interesse, a Riad come all’estero, per capire come verrà gestito il
passaggio di testimone. Il quale, per adesso, rimane comunque in mano a Salman.
Il ricovero di Re Salman. Le prime notizie relative al ricovero
dell’anziano sovrano si sono avute a partire dalla giornata di lunedì: i media
locali hanno confermato infatti che Re Salman è stato portato in uno degli
ospedali della capitale a seguito di un’infiammazione alla cistifellea,
specificando però che il suo successivo ricovero è stato dovuto alla necessità
di effettuare alcuni controlli. Nulla di grave dunque, almeno è questa l’idea
che emerge seguendo le indicazioni provenienti dal regno saudita. Per il
momento, la successione è solo rimandata. Ma il problema appare in ogni caso ben
attuale. Al trono dal 2015, quando ha ereditato il dominio del regno dal
fratello Abd Allah, Re Salman ha da subito operato uno strappo nella linea di
successione: come principe ereditario non ha nominato infatti un altro dei suoi
fratelli e dunque dei figli del sovrano fondatore dell’Arabia Saudita, bensì un
uomo della successiva generazione. Si tratta di un fatto inedito nella storia
del Paese. In particolare, poco dopo il suo insediamento Salman ha
nominato Mohammed Bin Nayef quale principe ereditario. Quest’ultimo è figlio di
uno dei fratelli del sovrano, nonché uomo all’epoca di appena 55 anni, altro
elemento inusuale per un Paese quasi sempre abituato ad essere amministrato da
governanti ottuagenari. Appena due anni dopo, nel novembre del 2017 un altro
strappo: Mohammed Bin Nayef è stato sostituito nel ruolo di principe ereditario
da Mohammad Bin Salman. Quest’ultimo è figlio dell’attuale sovrano, con la
monarchia saudita che compirebbe dunque un doppio salto generazionale. Ecco
perché appare molto interessante capire come si svolgerà il passaggio quando
l’attuale sovrano verrà a mancare oppure, anche se quest’ultima eventualità
appare lontana, deciderà di abdicare. Intanto il Re sembra stare bene, il suo
ricovero fatto passare per un elemento quasi di routine e quindi, almeno per il
momento, l’Arabia Saudita dovrebbe rimanere con gli attuali equilibri politici e
dinastici.
Le velleità di Mohammad Bin Salman. Da quando suo padre è al
trono, Mohammad Bin Salman (famoso internazionalmente anche con il suo
acronimo Mbs) ha scalato repentinamente i ranghi delle gerarchie saudite. A poco
più di 30 anni è diventato vice primo ministro e ministro della Difesa,
comparendo inoltre spesso accanto al padre in diverse uscite pubbliche. In
qualche modo, il vestito da “delfino” del sovrano gli è stato cucito addosso già
prima della sua nomina quale principe ereditario. Anzi, ad un certo punto Mbs è
diventato il vero uomo forte del Paese. Dietro molte delle decisioni assunte da
Re Salman, ci sarebbe il suo zampino: dalla guerra nello Yemen iniziata nel
2015, passando per le velleità di quotazione in borsa della società
petrolifera Aramco, fino alle prime timide svolte in campo sociale. Anche il
giro di vite imposto sul finire del 2017 contro uomini d’affari e sceicchi del
Paese, molti dei quali imprigionati ufficialmente per corruzione e colpiti nei
propri beni, ci sarebbe la volontà del giovane rampollo di casa Saud. Da Riad
più spesso sono filtrate indiscrezioni circa le reali ambizioni di Mbs: in
particolare, vorrebbe prendere il controllo di tutti gli aspetti politici ed
economici dell’Arabia Saudita. Ambizioni che sarebbero ben espresse dal suo
progetto, denominato “Vision 2030“, con il quale si vorrebbe trascinare fuori il
Paese dalla dipendenza del petrolio. L’impressione generale, emersa anche
all’estero, è che il principe ereditario già da anni agisca in qualità di vero
sovrano e di “padre padrone” del regno. Velleità supportate dalla sua giovane
età e dall’immagine di “leader riformista” che vorrebbe costruirsi all’estero.
La lotta con Mohammed Bin Nayef. Quando nel 2017 è avvenuto il
passaggio di consegne tra Mbs e Mohammed Bin Nayef, la tv saudita ha trasmesso
un breve video in cui veniva illustrata una piccola cerimonia. Bin Nayef, appena
esautorato da Re Salman quale principe ereditario, abbracciava il nipote
augurandogli buon lavoro e dichiarando alle telecamere di essere stato onorato
di servire il Paese prima di dedicarsi ad un periodo di riposo. Tutto quindi
sembrava svolgersi all’insegna di un normale avvicendamento. Nulla però di più
lontano dalla realtà: prima di essere per appena due anni principe ereditario,
Mohammed Bin Nayef è stato potente ministro dell’Interno e di fatto numero uno
della sicurezza saudita. Non certo quindi una persona in grado di accettare
senza remore la scelta di Re Salman di sacrificarlo a favore del figlio.
Inoltre, grazie ai suoi anni spesi quale ministro dell’Interno, Bin Nayef ha
dalla sua parte una buona fetta della famiglia Saud e degli apparati di polizia
e sicurezza. Gli errori del figlio dell’attuale sovrano, hanno rafforzato molto
probabilmente l’idea da parte dell’ex principe ereditario di poter riprendere il
posto di Re designato. Mbs su molti campi è uscito ridimensionato: la guerra
nello Yemen sta andando molto male, la sua immagine di leader riformista è stata
offuscata dall’omicidio del giornalista Jamal Kashoggi, ucciso all’interno del
consolato saudita di Istanbul il 2 ottobre scorso. Quest’ultimo, editorialista
del Washington Post, era una delle voci più critiche contro Mbs: la sua fine ha
gettato profondi ombre sulla figura del figlio del sovrano. Lo stesso progetto
Vision 2030 non sembra decollare, inoltre le velleità mostrate in questi anni
dall’erede designato hanno fatto storcere il naso a molti esponenti del casato
saudita. In poche parole, per Mohammed Bin Nayef questo potrebbe essere il
momento ideale per attaccare il nipote divenuto acerrimo rivale. Un altro
elemento che ha aggiunto molta curiosità alla notizia del ricovero di Re Salman
e di un possibile deterioramento del suo stato di salute.
Gli equilibri politici in Arabia Saudita. La strada per Mbs
dunque, potrebbe non essere così spianata. All’interno di casa Saud le fazioni e
le posizioni sono talmente divergenti, da rendere molto difficile immaginare un
solo uomo al timone del Paese senza rivali. In questa cornice si colloca
l’inchiesta, uscita proprio in questi giorni, condotta dal Washington Post:
secondo il quotidiano statunitense, il principe ereditario ha puntato gli occhi
su Saad al Jabri. Quest’ultimo è stato per anni il braccio destro di Mohammed
Bin Nayef, andato a vivere in Canada nel 2017 quando ha fiutato un’aria del
tutto favorevole al figlio del sovrano. Mbs sarebbe alla ricerca di Al Jabri, lo
vorrebbe mettere sotto giudizio per corruzione in quanto avrebbe intascato un
miliardo di Dollari quando lavorava all’interno della sicurezza. In realtà, Al
Jabri potrebbe essere un ostacolo alla scalata del principe ereditario in quanto
conosce molto bene molti segreti del casato reale. Il suo nome è l’ultimo
tassello dei principali oppositori di Mbs ancora liberi. Lo stesso Mohammed Bin
Nayef infatti, si troverebbe in galera con l’accusa di tradimento assieme
a Ahmed bin Abdulaziz, fratello di Re Salman ed altro pretendente al trono,
e Nawaf bin Nayef, fratello dell’ex principe ereditario.
Arresti ed accuse di tradimento e corruzione che sottintendono
una faida destinata a non finire adesso per la successione al trono ed equilibri
che, in seno a casa Saud, appaiono tutt’altro che definiti.
Estratto dell’articolo di Francesca Caferri per “la Repubblica”
il 22 luglio 2020. Il re sta bene: viva, comunque il nuovo re. Se si cercasse
uno slogan, sarebbe questo quello migliore per descrivere l' Arabia Saudita in
questi giorni. Dove da tre giorni il sovrano, re Salman - 84 anni e una serie di
acciacchi seguiti con riservatezza massima da un medico italiano - è ricoverato
in ospedale per una serie di controlli, definiti dai media di Stato "di
routine". E contemporaneamente si è aperta una campagna per spianare
ulteriormente la via del trono al suo figlio prediletto, Mohammed Bin Salman, 34
anni, detto Mbs, principe ereditario: l' anima riformista ma anche autoritaria
di un Paese che negli ultimi cinque anni si è lanciato nel futuro a una velocità
che ha ben pochi paragoni al mondo. Arena del dibattito è, come spesso accade
fra Riad e Gedda, Twitter: qui nelle ultime 72 ore è montata una campagna contro
l' ex principe ereditario ed ex ministro dell' Interno Mohammed Bin Nayef, detto
Mbn, destituito dal cugino nel 2017, e il suo ex braccio destro Saad al Jabri,
per 20 anni l' anello di congiunzione in materia di terrorismo fra Washington e
Riad, ora in esilio in Canada. I due sono accusati di corruzione per come
avrebbero gestito oltre 11 miliardi di dollari di fondi del ministero dell'
Interno finalizzati alla lotta contro il terrorismo. (…) Quel che è certo è che
il Paese vive un momento delicatissimo: il crollo dei prezzi del petrolio e le
limitazioni imposte all' Hajj (...) hanno messo in ginocchio l' economia.
Otto Lanzavecchia per formiche.net il 22 luglio 2020. Un’ex spia
saudita è ricercata dal governo del principe Mohammed bin Salman con l’accusa di
essersi intascato almeno un miliardo di dollari durante gli anni prestati al
servizio della corona Al Saud. A raccontarlo è il Wall Street Journal, con
un’inchiesta che ha acceso i riflettori sulle occulte operazioni di intelligence
di Riad, nonché sui rapporti sauditi con gli Stati Uniti. Saad al Jabri, 61
anni, ha alle spalle una carriera ai più alti livelli del ministero dell’Interno
saudita. Per 17 anni ha controllato un fondo ministeriale, nato dopo l’attentato
dell’11 settembre 2001 per finanziare operazioni di antiterrorismo (sono passati
di lì quasi 20 miliardi di dollari). Recentemente, il governo saudita ha emesso
un mandato di estradizione a suo carico con l’accuso di aver dirottato 11
miliardi di dollari e averne trattenuta una parte per sé e i suoi collaboratori.
Ufficiali di intelligence su entrambe le sponde dell’Atlantico hanno evidenziato
che la faida rischia di rendere noti i segreti sul rapporto tra gli Stati Uniti
e l’Arabia Saudita riguardo alle loro operazioni antiterroristiche. Secondo il
Journal al Jabri sarebbe stato il principale contatto nel Golfo delle agenzie di
intelligence statunitensi per più di 15 anni. Stando all’inchiesta del
quotidiano murdochiano, sarebbero implicate anche una serie di multinazionali.
Tra queste, la banca britannica HSBC e le aziende statunitensi Oracle, IBM,
Cisco, e VMware, ree di aver venduto attraverso fondi offshore hardware e
software strategici a Technology Control, di proprietà del ministero
dell’Interno saudita e controllata a intermittenza da familiari di al Jabri, che
avrebbero poi rivenduto gli acquisti a prezzi gonfiati. L’intero sistema,
orchestrato da al Jabri, ha funzionato per anni con il tacito consenso degli
ufficiali di intelligence statunitensi, i quali ritenevano che finchè i soldi
non fossero stati spesi per finanziare il terrorismo, il governo di Riad avrebbe
avuto totale libertà nello spenderli. L’apparato dell’ex spia si sarebbe mosso
attraverso fondi privati per evitare la macchinosa burocrazia saudita. Il caso
si colloca nella cornice del feroce conflitto all’interno della famiglia reale
per il trono saudita. Al Jabri è stato per anni il braccio destro di Mohammed
bin Nayef, cugino dell’attuale principe e nipote del re Salman. Bin Nayef è
stato a sua volta principe dal 2015 al 2017, prima di essere deposto ed
esautorato dal cugino, Mohammad bin Salman, che lo ha fatto arrestare quest’anno
con l’accusa di tradimento. Mentre detronizzavano il suo ex capo, al Jabri era
già fuggito in Canada, dove vive in esilio da allora. Il Journal racconta che il
governo saudita sta tenendo in ostaggio i suoi due figli, di 21 e 20 anni, per
convincerlo a rientrare in patria. Contattati dal giornale statunitense, i
familiari di al Jabri hanno detto di essere aperti a qualsiasi processo
imparziale che non utilizzasse i suoi figli come leva. Riad, invece, ha
dichiarato che non avrebbe commentato un’investigazione in corso, e che starebbe
cercando di rimpatriare al Jabri per investigarlo nell’ottica delle operazioni
anticorruzione del principe. L’amministrazione statunitense mantiene da anni
un’alleanza strategica con l’Arabia Saudita e il suo principe, rinsaldata
dall’inquilino della Casa Bianca, il presidente Donald Trump. Negli scorsi anni,
però, il rapporto ha iniziato a creparsi. Nel 2018, a seguito dell’uccisione del
giornalista Jamal Khashoggi per mano di agenti di bin Salman, il Congresso di
Washington ha votato per implicare il principe nella vicenda e bloccare la
vendita di armamenti alla corona saudita.
Marta Serafini per il "Corriere della Sera" il 13 giugno 2020.
«Sa dove sono sepolti i corpi ed è un archivio vivente dei segreti del
principe». Per molti anni Saad Aljabri è stato uno degli uomini più importanti
dell'intelligence saudita: esperto di intelligenza artificiale con un dottorato
all'Università di Edimburgo, acerrimo nemico di Al Qaeda e in ottimi rapporti
con i Five Eyes (le agenzie di spionaggio di Usa, Regno Unito, Canada,
Australia, Nuova Zelanda), ha aiutato a sventare attacchi terroristici e
complotti. Eppure oggi Aljabri, invece di godersi il meritato riposo, vive sotto
la scure del ricatto del principe ereditario Mohammed Bin Salman, mentre due dei
suoi figli e suo fratello sono scomparsi. Più estroverso del suo capo, capace di
parlare cinque lingue, Aljabri fa carriera e diventa il braccio destro del
principe Mohammed bin Nayef , allora a capo del ministero degli Interni. Nel
2010 contribuisce a sventare un attacco di Aqap (Al Qaeda nella penisola
iberica) su un aereo diretto a Chicago. La sua esperienza è tale che, come
confermano anche i cablogrammi pubblicati da WikiLeaks, viene consultato dai
colleghi su questioni delicate come la situazione in Iraq, Yemen, Afghanistan, i
flussi finanziari dei gruppi jihadisti e le ambizioni regionali dell'Iran. Nel
2015 il vento in Arabia Saudita però inizia a cambiare. Dopo la morte di re
Abdullah, Salman sale al trono e nomina il figlio Mbs come ministro della
Difesa. Per Aljabri e la sua famiglia è l'inizio del calvario. Nei primi mesi
del 2016 Aljabri lascia l'Arabia Saudita. Nel frattempo Mbs ha fatto spodestare
e arrestare il suo mentore e protettore bin Nayef. Così Aljabri decide di
restare all'estero, ben consapevole di non avere altre opzioni. Secondo
Feierstein vicepresidente del Middle East Institute di Washington, Aljabri
durante i suoi decenni nell'intelligence ha sentito e visto talmente tanto che
sa «dove sono sepolti i corpi» dei nemici di Mbs e conosce parecchie
informazioni davvero poco lusinghiere sul suo conto. In esilio in Canada con il
padre parte anche il figlio maggiore Khalid. Altri due (in totale i figli sono
otto), Omar Aljabri, 21 anni, e sua sorella Sarah, 20 anni, rimangono a Riad.
Vengono interrogati e viene chiesto loro di implorare il padre affinché rientri.
Ma lui niente, resiste. Furibondo, Mbs il 16 marzo scorso ordina di arrestare
Omar e Sarah. «Sono stati rapiti dai loro letti. Non so nemmeno se sono vivi o
morti» ha spiegato Khalid Aljabri. Non paghe, la settimana scorsa, le autorità
saudite hanno arrestato anche il fratello, Abdulrahman Aljabri. Così la
famiglia, dopo aver rotto il silenzio in diverse interviste ha assunto una
società di lobbying a Washington per chiedere il rilascio dei loro parenti.
«Sono ostaggi e il riscatto è il ritorno di mio padre», ha spiegato ancora
Khalid. Che ha aggiunto: «Non vogliamo mettere in imbarazzo l'Arabia Saudita ma
rapire Omar e Sarah in questo modo, è un atto criminale».
Marta Serafini per il “Corriere della Sera” il 20 aprile 2020.
«Sono reclusa nella prigione di Al-Ha' ir, senza che sia stata formulata un'
accusa. Non ho fatto nulla di male». Ricompare - almeno in rete - la principessa
ribelle saudita Basmah bint Saud. Sparita nel marzo 2019, la donna ha pubblicato
su Twitter un appello dopo aver, invano, scritto più volte a corte. E
rivolgendosi allo zio, il re Salman, e al principe ereditario, suo cugino, il
potente Mohammed Bin Salman, chiede di essere liberata dalla prigione di massima
sicurezza in cui è detenuta. A spingerla è la paura di morire: «Non sono stata
curata e la mia salute si sta deteriorando così tanto che potrei morire».
Misteri. Perché MBS odia così tanto Basmah bint Saud da
rinchiuderla nello stesso carcere di jihadisti e oppositori? E perché non le
riserva il solito trattamento riservato ai parenti «scomodi», ossia prigionie in
hotel o appartamenti di lusso? La tragedia di Basmah bint Saud inizia nella sua
casa di Gedda sulla costa del Mar Rosso poco più di un anno fa, il 1° marzo 2019
, quando - come ricostruito dalla Deutsche Welle - viene prelevata dagli uomini
della sicurezza dei Saud con sua figlia, Suhoud, 27 anni. Il rapimento scatta
poche ore prima della sua partenza per la Svizzera, dove avrebbe dovuto ricevere
cure mediche, soffrendo di osteoporosi e problemi cardiaci. Poi, per un anno, il
silenzio. Fino a quattro giorni fa. Basmah bint Saud, 56 anni, è nota come voce
fuori dal coro all' interno della potente famiglia dei Saud. Ultima dei 115
figli dell' ex sovrano Abdallah bin Abdulaziz, nasce poco dopo il colpo di Stato
che costringe il padre ad abdicare in favore del fratello Salman. Dopo la morte
del genitore si trasferisce a Londra e da lì inizia a criticare il Paese d'
origine, denunciando la corruzione e le ingiustizie economiche e invocando l'
uguaglianza di uomini e donne. Sta ben attenta però a non scagliarsi
direttamente contro la famiglia reale di cui si sente parte. Ma attacca la fitta
rete di governatori, amministratori e plutocrati che gestiscono il Paese. Infine
nel 2016, torna in Arabia Saudita e alla Bbc , commentando il piano di riforme
del cugino MBS dichiara «Ha una visione, Vision 2030, la cui direzione è chiara:
l' isolamento di tutti coloro che non sono d' accordo con quella visione».
Parole che ora rischiano di costarle la vita. Le autorità saudite non hanno
rivelato i motivi dell' arresto, né lo faranno. E se non è chiaro come la
principessa abbia potuto scrivere dal carcere e se i tweet con l' appello sono
scomparsi dal web, tuttavia è plausibile che i messaggi siano autentici, tanto
più se si considera che lo scorso mese sono stati arrestati il principe Ahmed
bin Abdulaziz al Saud, fratello di re Salman, e suo nipote, il principe Mohamed
bin Nayef, accusati di aver tentato un colpo di stato. Una retata volta a
bloccare la dissidenza interna alla famiglia reale per mantenere lo status quo.
Ma anche l' ultimo di una lunga serie di soprusi, se si considera che dal 2017
MBS è l' artefice di una ferrea repressione ai danni di attiviste per i diritti
delle donne, blogger, giornalisti (uno su tutti Jamal Khashoggi, trucidato
dentro il consolato di Istanbul) ed influenti esponenti religiosi. E che non
risparmia nemmeno i parenti.
Arabia Saudita, Mohammed bin Salman arresta zio e cugini:
“Tentavano il golpe”. Gli arresti non sono stati
confermati da Riad ma riportati dalla stampa americana: potrebbero essere
accusati di tradimento. Francesca Caferri il 07 marzo 2020 su La Repubblica. C'è
un nuovo intrigo di palazzo alla corte reale saudita. E il protagonista, ancora
una volta, è l'uomo che da cinque anni domina la vita di questo Paese pure non
essendone il re, Mohammed Bin Salman (MbS). Il principe ereditario, 33 anni,
nella notte di giovedì avrebbe fatto arrestare tre alti membri della famiglia
reale, probabilmente nel tentativo di spianare ulteriormente la sua strada verso
il trono dell'85nne e malato padre, re Salman. Gli arrestati sono il principe
Ahmed, unico rimasto fra i fratelli del re, discendente diretto del fondatore
del regno Abdulaziz al Saud, e punto di riferimento di quella parte della
famiglia e della società saudita che non condivide la visione autororitaria e
modernizzatrice di MbS. Ahmed rappresentava una minaccia perchè fino all'ascesa
di Salman e del figlio MbS il trono saudita era passato di fratello in fratello:
a lui sarebbe dunque spettata la successione se il fratello non avesse deciso di
puntare su suo figlio. A lungo autoesiliatosi a Londra, due anni fa aveva
espresso opinioni che erano suonate critiche su MbS in un video circolato in
rete: ma poi era rientrato in patria e pareva aver appianato i dissapori con la
leadership. In carcere è finito anche l'ex uomo forte del Paese Mohammed bin
Nayef, 60 anni, detto MbN. Ex ministro dell'Interno, ex principe ereditario,
l'uomo scelto dagli Stati Uniti per traghettare l'Arabia Saudita nel futuro, la
persona che avava decapitato Al Qaeda dopo l'11 settembre nel Paese in cui era
nata l'organizzazione di Bin Laden: era principe ereditario, il primo della
Seconda generazione degli Al Saud, prima che il cugino lo estromettesse
costringendolo a spettacolari dimissioni riprese dalla televisione. La sua
cacciata fu il primo vero segno del potere del nuovo principe nella casa reale.
Arrestato anche il fratello minore. Gli arresti non sono stati confermati da
Riad ma riportati dalla stampa americana: ma del resto notizie di questo genere
raramente sono ufficializzate in Arabia Saudita. I tre, secondo i media Usa,
potrebbero essere accusati di tradimento: capo di imputazione per cui è prevista
la pena di morte. Il loro arresto segnala due cose importanti. Il fatto che lo
scandalo seguito all'omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi nel
consolato di Istanbul è ormai archiviato e MbS si sente libero di agire come
vuole. E la possibile volontà del principe di ascendere ufficialmente al trono
prima di novembre, quando l'Arabia Saudita ospiterà il g20.
Anna Guaita per “il Messaggero” l'8 marzo 2020. Nuovi inquietanti
sviluppi in Arabia Saudita riportano alla ribalta internazionale la figura del
principe ereditario Mohammed bin Salman. Il 34enne erede al trono, che di fatto
già governa il Paese nonostante re Salman sia ancora in vita, ha ordinato
l'arresto di tre figure di primo piano della famiglia reale, accusandoli di
tentato colpo di Stato. In prigione sono finiti il principe Ahmed bin Abdulaziz
al Saud, fratello del re, oltre al principe Mohammed bin Nayef bin Abdulaziz al
Saud, e suo fratello Mohammed bin Nawaf, nipoti di re Salman. Non è la prima
volta che il principe ereditario imprigiona membri della famiglia reale, ma
questa volta la sua azione fa sospettare che la salute di re Salman non sia
ottima e che lui stia facendo piazza pulita di possibili rivali al trono.
Mohammed bin Salman è stato nominato principe ereditario nel 2017, scalzando
Mohammed bin Nayef. Il noto analista americano Howard Feineman, che lo ha
conosciuto, lo definisce «un dottor Jekyll e mister Hyde», un individuo con una
doppia personalità, che desidera lanciare riforme e essere oggetto
dell'ammirazione della sua gente e dell'opinione pubblica internazionale, ma
davanti al dissenso diventa intollerante e durissimo. E' entrato in politica nel
2009, come assistente del padre che era allora governatore di Ryad. Poi il padre
è diventato re, e ha cambiato l'ordine di successione al trono, togliendo il
titolo ereditario al nipote Mohammed bin Nayef, e passandolo a lui. E Mohammed
ha subito fatto capire quali erano i suoi piani per l'Arabia Saudita del futuro,
nella sua «Visione 2030», e cioè un Paese non più dipendente solo dal petrolio,
ma anche centro della finanza internazionale e della ricerca avanzata, un Paese
più moderato in materia religiosa, con un ammorbidimento delle regole sociali al
punto da poter diventare anche una meta turistica internazionale. E in politica
estera un Paese dominante nel firmamento sunnita, al posto dell'Egitto in crisi.
Non tutti i suoi piani sono andati in porto in modo liscio. È vero che ha aperto
le sale cinematografiche, e ha concesso alle donne il diritto di prendere la
patente, che ha tolto alle guardie della religione il diritto di arrestare a
piacere chiunque, che queste riforme gli sono valse il plauso soprattutto dei
giovani, ma è anche vero che ha messo in prigione dissidenti, intellettuali,
scrittori, femministe. Sul campo internazionale, la sua scommessa contro l'Iran
sciita, che odia in modo viscerale, lo ha portato ad allacciare una stretta
amicizia con il genero di Trump, Jared Kushner, e poi con Trump stesso. Ma lo ha
anche spinto a sostenere il governo yemenita cacciato dai ribelli Houti
sostenuti dall'Iran. Il suo errore più appariscente rimane comunque di aver
comandato (come credono sia la Cia che l'Onu) o semplicemente tollerato (come
vorrebbe far credere lui) l'assassinio di Kashoggi, il giornalista ucciso nel
consolato saudita a Istanbul nel 2018. Dopo il processo e la condanna di cinque
individui, a dicembre, gli Usa hanno comunque reagito tiepidamente, limitandosi
a negare il visto a 21 cittadini sauditi legati al caso. Ma non hanno diminuito
gli aiuti militari al Paese, in funzione anti-Iran. Anzi, il segretario di Stato
Pompeo è andato in visita, fermandosi nella Prince Sultan Air Base, dove sono
dislocati 2500 soldati americani, per riconfermare la «importante alleanza» fra
Usa e Arabia Saudita. Il prossimo luglio a Ryad si dovrebbe tenere
l'appuntamento annuale del G20, quando MbS dovrebbe rivelare al mondo il suo
Paese rinnovato e ammodernato. Per il momento tuttavia il Palazzo non ha
rilasciato nessun chiarimento sugli arresti eccellenti, e cosa rischino i tre
principi.
·
Quei razzisti come i Dubaiani.
Alessandro
Logroscino per l'ANSA il 6 marzo 2020. Ricco come un Creso, di casa a Buckingham
Palace come a Washington, al centro di un intreccio di alleanze e interessi
miliardari che spaziano dal Golfo all'occidente, protagonista del jet set,
eppure oggi svergognato agli occhi del mondo. Bollato nei panni del padre
padrone, se non del padrino prepotente e brutale capace di far sequestrare due
figlie, di "torturare" una, d'intimidire l'ultima delle sue consorti. Sono
pesantissime, un'onta, le accuse certificate dai giudici dell'Alta Corte
britannica che hanno condannato Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum, 70 anni,
potentissimo emiro di Dubai, nella causa intentata contro di lui 8 mesi fa
dall'ex moglie, la 45ernne principessa Haya di Giordania, figlia del defunto re
Hussein, fuggita rocambolescamente dagli Emirati nell'aprile scorso per
rifugiarsi a Londra. A mettere il timbro su una vicenda che ha avuto i contorni
della faida familiare fra 2 delle dinastie arabe più influenti, entrambe alleate
di ferro di Usa e Regno Unito, in un ginepraio d'imbarazzi personali, politici e
diplomatici, è stata oggi la pubblicazione delle motivazioni di una serie di
giudizi favorevoli ad Haya emessi a partire dal termine del 2019. Un verdetto,
accolto dall'apprezzamento di vari attivisti dei diritti umani, che il monarca
emiratino aveva cercato invano di far secretare. Ma che i magistrati londinesi
hanno deciso alla fine di rendere note per ragioni "d'interesse pubblico":
rinfacciando a Mohammed Al-Maktoum di "non essere stato aperto né onesto verso
la corte" ed esibendone la colpevolezza in tono inappellabile. Un tono che non
potrà avere conseguenze penali, data l'immunità reale del personaggio, ma che
minaccia di coprirlo d'ignominia, d'intaccarne l'autorità assoluta sui familiari
(almeno all'estero), di allontanarlo da un Paese - la Gran Bretagna - laddove ha
legami consolidati, risorse, proprietà. Inclusa una scuderia di cavalli da mille
e una notte. Stando ai giudici d'oltre Manica, le testimonianze e i documenti
raccolti provano come il signore assoluto di Dubai abbia dapprima imprigionato
in una gabbia dorata Haja, sua sesta moglie. E poi, dopo la fuga di questa con i
due figli minori (avvenuta secondo alcune ricostruzioni nottetempo, con la
complicità di un diplomatico tedesco e di una guardia del corpo britannica
divenuto suo amante), abbia usato l'arma della minaccia contro di lei, affidata
ad agenti incaricati di assediarla nella lussuosa residenza blindata londinese
in cui si era asserragliata da aprile nel miglio dorato di Kensigton Garden
(valore 85 milioni di sterline). Non solo: il verdetto addebita a Mohammed Al
Makhtoum, padre in totale di una ventina di principi e principesse avuti da uno
stuolo di consorti, di aver fatto pure rapire in anni passati due figlie
maggiori di altro letto: la sceicca Shamsa, che nel 2000 aveva provato a sua
volta a scappare in Inghilterra; e la sceicca Latifa, fuggita in ben due
occasioni, la seconda grazie all'aiuto d'uno skipper francese, e ricatturata in
ultimo nell'oceano Indiano per essere ricondotta a viva forza in patria e
rinchiusa in uno stato di detenzione equiparato dall'Alta Corte a un regime di
tortura. Proprio il caso di Latifa aveva spinto a quanto se ne sa Haya,
cavallerizza provetta ed ex olimpionica d'equitazione andata sposa del più
anziano Mohammed nel 2004, alla ribellione: fino alla scelta dell'abbandono del
tetto coniugale filtrata fragorosamente l'anno scorso sui media di mezzo mondo.
E allo scontro in tribunale che le garantisce adesso l'affidamento dei figli
piccoli, oltre a una serie di garanzie economico-legali. Ma che potrebbe non
rappresentare ancora l'ultimo atto di questa sinistra saga fuori dal tempo.
·
Quei razzisti come
i Qatarioti.
Marta Serafini per corriere.it il 20 luglio 2020. «A sua altezza
non piace sentirsi dire no». Ventotto anni, quattordicesimo figlio dell’ex emiro
del Qatar e fratello dell’attuale reggente, fino a ieri Khalifa bin Hamad bin
Khalifa Al Thani era noto più che altro che per il suo account Instagram da 1
milione di follower. Un vero e proprio influencer mediorientale, che accarezza
ghepardi, fa volare falchi e issa sullo yacht pesci di proporzioni inquietanti.
E fin qui. Accade però che il Los Angeles Times dedichi a sua altezza
un’inchiesta di quelle che richiedono mesi di lavoro certosino. E la storia
cambia. Tutto ha inizio nel 2011 quando il giovane KHK piomba a Los Angeles e va
dritto a installarsi al Beverly Wilshire (lo stesso hotel dove Richard Gere
porta Julia Roberts, in Pretty Women, per capirsi). Ma il principe non è a
caccia di avventure galanti. Khalifa bin Hamad bin Khalifa Al Thani, figlio
della seconda moglie dell’ex emiro, Sheikha Moza, avvocatessa di successo e
filantropa, è arrivato negli States per procacciarsi un diploma e una laurea.
Meglio ancora se in una città dove non è costretto, come i suoi 23 fratelli, a
indossare abiti tradizionali e può divertirsi lontano dagli occhi dei
consiglieri di corte. Nel momento stesso in cui la scaletta del jet tocca terra
statunitense, intorno a lui e al suo entourage si crea una vera e propria
economia sommersa. Solo la stanza del suo maggiordomo costa 600 dollari a notte,
gli hamburger che le guardie del corpo ingurgitano vanno giù a suon di 30
dollari per volta. A pensare alle spese e ai conti — ricostruisce sempre il L.A.
Times — è Joseph Jourieh, ex membro della missione Onu del Qatar, noto su
Twitter come il «fixer». Grazie a lui, in sole sei settimane, il Beverly Hills
Rent-A-Car fattura al governo del Qatar 300 mila dollari, tra cui 73 mila per un
avvocato inesistente. Dopo qualche tempo — nel mentre sua altezza ha finito il
college — nell’ufficio del preside della facoltà di scienze politiche della
Ucla, una delle università migliori del mondo, si presenta una delegazione che
porta in dono statue di cammelli in oro con la richiesta di ammettere il
promettente KHK. A riposta negativa, gli emissari insistono: «Ripensateci, a sua
altezza non piace sentirsi dire no». In fondo il Qatar è uno dei maggiori
finanziatori del sistema educativo superiore statunitense, non si vede il perché
di tanta severità. L’attenzione si sposta sulla Usc, altro ateneo da sogno.
Mamma Sheikha Moza si sobbarca un viaggio negli Stati Uniti apposta per parlare
coi dirigenti dell’università. E più o meno nello stesso periodo una fondazione
qatarina destina un’ingente sovvenzione al centro di ricerca marina dell’ateneo
sull’isola di Santa Catalina. Il pargolo può diventare finalmente matricola. Ma
lui ha ben altro da fare che andare a lezione o studiare. Come trovare un rene
al suo personal trainer, un bodybuilder libanese soprannominato il Puma, o
procurare Rolex per gli assistenti dei suoi docenti. In quegli stessi anni i
procuratori di Boston stanno aprendo un fascicolo che porterà all’arresto di
oltre 50 persone, sulle tangenti e lo scandalo delle ammissioni truccate nei più
prestigiosi atenei statunitensi. Il nome Al Thani non compare ma ora le cose
potrebbero cambiare. Non a caso da Doha, interpellati dal quotidiano, i legali
di sua altezza si precipitano a dire: «Questo è razzismo: insinuazioni come
queste non sarebbero mai state sollevate se si fosse trattato di uno studente
bianco desideroso di laurearsi». Peccato che KHK alla cerimonia di laurea
preparata per lui, sull’isola di Santa Catalina, non si sia nemmeno presentato.
·
Quei razzisti come
i Brasiliani.
La tragedia popolare della Copa do mundo perduta.
Storia del Maracanazo del 2014, l’estate più triste del Brasile.
Angela Nocioni su Il Riformista il 13 Agosto 2020. A parte che lì era un tiepido
inverno, quella di sei anni fa fu l’estate più triste del Brasile. No, non cupa
come questa, con epidemia di Covid negata, fosse comuni a Manhaus e un
presidente pistolero ciclotimico che scimmiotta Trump senza riuscirci. Nel 2014
il dramma fu calcistico. Quindi popolare, profondo, terribile. La semifinale
persa in una fresca serata al Mineirão, lo stadio di Belo Horizonte diventato
ormai mèta di esorcismi stregoneschi. La Seleção buttata fuori dalla Copa do
mundo dalla Germania. Una tragedia nazionale. Fu durissima. Perdere è brutto, ma
perdere 1 a 7 nei Mondiali fatti in casa e un’altra cosa. Senza Neymar e Thiago
Silva, il Brasile già soltanto nel primo tempo si vide arrivare un gol di
Mueller, uno di Krose, una doppietta e poi Kedira. Prima dell’intervallo i
verdeoro erano già ko. Mai una semifinale mondiale era finita con sei gol di
scarto. Mai il Brasile, che non perdeva una partita ufficiale in casa dal 1975,
aveva subito sette gol in una partita per la Coppa. Per di più, stavolta, con il
rimorso di aver messo sulle spalle di Neymar – un fuoriclasse, ma pur sempre un
ragazzino di 22 anni – il sogno di trionfo di un Paese intero. Il rimorso
d’avergli fatto male con tanta pressione. Il pomeriggio prima della partita,
costretto in panchina dalla vertebra rotta in un brutto fallo da dietro, Neymar
aveva l’aspetto sollevato, nonostante il dolore alla colonna. S’era portato in
spalla 200 milioni di persone per tre settimane, fino ai quarti di finale,
troppo per chiunque. Fischiato il novantesimo di quella notte terribile al
Mineirão, sugli schermi tv di tutto il pianeta sbucò la faccia rigata dalle
lacrime di un gigante biondo riccioluto che si guardava intorno con gli occhi
increduli di un cinquenne. Piangendo a dirotto, senza nemmeno uscire dal
campo, David Luiz chiedeva perdono così: «Eu so queria dar alegria a mia gente».
Non c’era verso di consolarlo. «Io solo volevo dare allegria alla mia gente.
Disgraziatamente non ci siamo riusciti. Io, io … io chiedo scusa a tutti. Chiedo
scusa ai brasiliani». Visto? Deve aver pensato qualsiasi essere umano di fronte
alla tv in qualsiasi angolo di mondo quella sera, qui, in Groenlandia e in Cina:
non è vero che è un Paese di cuorcontenti, tutto samba, spiaggia e capirinha
ghiacciata. La notte del tracollo fu finalmente anche la notte della verità. La
tristezza sgomenta di un intero popolo e la poesia di quella disperazione
infantile tolsero al Brasile da copertina quell’aurea da bionda scema, troppo
carina, troppo maliziosa, troppo ancheggiante per essere presa sul serio. Il
Paese non se la meritava, è sempre stato molto altro e molto meglio. Quella
notte del 2014 il mondo se ne accorse. Un popolo intero che piange ma non se la
prende con l’arbitro, il tifoso inginocchiato che prega, il giovane capitano che
dice «sono più bravi di noi», furono la prova di quanto ci fosse poco da ridere
sulla cultura brasiliana del sorriso. Il Maracanazo più brutto della storia
nazionale, peggiore della leggendaria sconfitta del 1950 contro il minuscolo
Uruguay (perché stavolta bruciava la fredda superiorità tecnica dei tedeschi)
mostrò un Paese addolorato, giovane e vivo, che tra i suoi molti problemi non ha
quello della repressione delle emozioni. Gente che si dispera senza vergogna con
la stessa naturalezza con cui balla e cammina. Mostrando quanta profonda
vitalità ci sia in quel modo solo loro di danzare lanciando vorticosamente i
fianchi verso un nulla immaginario che nessuno sa cosa sia. Ci fu molto da
imparare dallo spettacolo della tristezza brasiliana. Ducecento milioni di
individui delusi, entusiasti cronici improvvisamente disillusi, tutti presi a
celebrare insieme un dolore collettivo in un Paese grande come un continente,
con sacche di miseria gigantesche e diverse ragioni per infuriarsi, piangendo
molto, senza odio, senza orrori. E senza scatenare un pandemonio. Niente riot,
solo lacrime. Provateci a Berlino. Diogo Mainardi, favoloso polemista
brasiliano, prevedeva alla vigilia: purtroppo questo sarà l’anno della
riscoperta del Brasile. «Cronisti provenienti dai luoghi più improbabili
attraverseranno l’oceano e per sei mesi – scriveva – tempesteranno i loro
disinteressati e disinformati connazionali con i loro disinteressanti e
disinformati resoconti sul Paese. Si raccomanda a tutti loro di rinunciare
subito a qualsiasi tentativo di originalità e di plagiare senza il minimo pudore
il più feroce dei nostri umoristi, Ivan Lessa, che ha saputo riassumere
l’essenza della nostra specie in una sola frase: abbiamo i piedi per terra e le
mani anche.
Se Ivan Lessa, l’Apuleio nostrano, si è contraddistinto per la
capacità di svelare la nostra natura quadrupede – gli asini verde oro – lo
storico Paulo Prado, molto prima di lui, dev’essere ricordato per un’impresa
ugualmente meritoria: lui ha diagnosticato la nostra psiche patologicamente
malinconica. Il suo Ritratto del Brasile, sottotitolato Saggio sulla tristezza
brasiliana del 1926, è ancora oggi una guida insuperabile per orientare gli
osservatori meno avvezzi alle questioni nazionali. L’incipit non lascia dubbi:
in una terra radiosa vive un popolo triste». Nemmeno una settimana dopo nquella
crudele semifinale, un’altra sfida eccessiva, un altro affronto all’orgoglio
nazionale. Toccava ospitare a Rio il nemico antropologico, l’odioso alterego, la
spavalda Argentina del ct Sabella. Gli eterni rivali argentini in finale al
Maracanà, il tempio del calcio brasiliano, contro la Germania. Da spararsi.
Nonostante lo stordimento per la brutta sorpresa, qualcuno a Rio riuscì a
reagire. Invece di buttarsi a capofitto nella Baia di Guanabara con una pietra
al collo, intravide la via d’uscita elegante. Tese idealmente la mano, invece di
ricordarsi di quanto siano mal sopportati in Argentina i fortunati vicini più
ricchi, più belli e con quelle lunghe spiagge dorate con la brezza oceanica
anche a mezzogiorno. Invidiati al punto che dodici ore dopo la notizia della
vertebra rotta di Neymar, sulla Avenida Nueve de Julio, l’arteria principale di
Buenos Aires, già gli ambulanti ai semafori vendevano gli scheletrini di
plastica, riciclati dalle cineserie di Halloween, con l’adesivo: «Acà està la
columna de Brasil», eccola qua la colonna del Brasile. Quella sera d’estate
avvenne l’incredibile: in Brasile ci fu chi tifò Argentina. L’odio reciproco di
due nazionalismi psichiatrici fu sedato (per poche ore) da un’idea. Dal sogno
della Grande Rivalsa che, più o meno, si può tradurre così: ma ve l’immaginate
la Culona Inchiavabile piantata là, nel mezzo del Maracanà, a guardare l’indio
Romero, il capitano della scalcinatissima argentina, che solleva la Coppa del
mondo? E gli implacabili panzer tedeschi, pettinatissimi, impassibili, undici
carri armati sempre in modalità blitz krieg, infilare la strada degli spogliatoi
con le spallone ricurve, per una volta sconfitti, mentre quelle facce da galera
degli argentini ballano felici, finalmente campioni di qualcosa? Ma ci pensate
al batticuore di un continente intero se questi qui riescono a incoronarsi
campioni del mondo sotto la tribuna d’onore del Maracanà, il massimo del
paradiso immaginabile per qualsiasi ragazzino sudamericano abbia mai preso in
mano un pallone? Sarebbe gioia pura per almeno mezzo miliardo di persone.
«Bravo? Se fosse bravo davvero non giocherebbe qua, quelli bravi se li compra
qualcuno l’Europa e se ne vanno a 18 anni» dice di qualsiasi calciatore
sudamericano qualsiasi tifoso locale. E la Selecciòn argentina sei anni fa
provava che quell’amarezza, ora come allora, era fondata: di undici titolari
nemmeno uno, uno!, giocava a casa sua. Sedici dei 23 tedeschi convocati di Jogi
Löw giocavano invece in Bundesliga. E quindi – seppero dire i saggi bevitori che
fanno arredamento essenziale da sempre da “Jobin”, strategico baretto carioca
con tv appese sul marciapiede – certo che gli argentini li detestiamo, certo la
Germania è più brava, che non c’è paragone con la macchina da guerra
di Klose che è disciplinata, compatta e forse paga pure le tasse. Ma stasera
facciamo un’eccezione. Mettiamo da parte l’odio. Fosse solo per vedere il ct
Sabella, con quell’aria da immigrato da dopoguerra mentre smadonna in completo
blu a bordo campo, sentirsi imperatore per una notte a casa nostra, vederlo
trionfare qui nella Cidade Maravilhosa. Intanto a Buenos Aires, per le strade
della «capitale di un impero inesistente», tutti vivevano da una settimana
sospesi nell’illusione di portarsi a casa il trionfo più ambito. In una città
pazzesca sempre sull’orlo del baratro, con più librerie notturne che a Londra,
più fiorai che a Parigi, dove la produzione teatrale è più ricca che a New York
e negli altarini degli ex voto c’è la foto di Maradona vicino a quella della
Vergine della Grazia di Roccella Jonica, in quella metropoli assurda in cui
vanno dallo psicoanalista anche i poveri e le vecchie casalinghe italiane
parlano ancora il cocoliche (mix di castigliano orecchiato male, veneto o
calabrese) tutti, ricchi e poveri, si preparavano a vedere la finale per strada
nonostante fosse inverno pieno. Da Fuerte Apache, la villa miseria di baracche e
lamiera nel centro città da cui è saltato fuori Carlitos Tevez – non convocato a
quei Mondiali per capriccio di Lionel Messi – già dalle prime ore mattino della
domenica della finale salivano boati: «Vamoooos chicooos». La polizia sospese lì
dentro i pattugliamenti antinarcos. Troppo casino, impossibile. Era il giorno
della revancha, della agognata rivincita. E contro la Grande Germania poi,
quella che laggiù ha mandato nazisti in fuga e continua a sbarcare aerei pieni
di turisti con due piedi sinistri che non imbroccano un passo di danza nemmeno
alla centoventicinquesima lezione privata. Anche in Brasile, alla fine, ci si
convinse che era meglio stare dalla parte dei detestabili vicini. Perché
Germania-Argentina era il metodo contro l’estro. Con in mezzo un abisso molto
più profondo dell’Oceano atlantico. Klose, il campione tedesco, disse la sera
della vigilia: «Se sono arrivato a 36 anni al quarto Mondiale è perché faccio
una vita sana: non bevo e non fumo». Eliana Guercio, moglie del portiere Romero,
a un tweet della popstar Rihanna che smaniava alla vista dell’idolo sudaka del
momento rispose: «Querida, se domani vinciamo i Mondiali giuro che te lo
presto». Quella notte, da Città del Messico alla Patagonia, fu la Bundesbank
contro i Tango bond, la Mercedes contro i ladri di biciclette. Finì 1 a 0. Con i
tedeschi in gloria e gli argentini in lacrime. Il Maracanà celebrò i carri
armatini di Klose. E i brasiliani non dovettero vedere la statua del Cristo
Redentor illuminata di biancoceleste, i colori argentini. Obiettivamente per
loro sarebbe stato troppo. Gli spettatori verdeoro consolavano gli sconfitti:
«Immaginate come stiamo noi. Io ogni volta che apro il freezer di casa ho paura
di trovarci dentro un altro gol dei tedeschi».
La disfatta di Bolsonaro, il “Trump brasiliano” va verso
l’impeachment. Angela Nocioni su Il Dubbio il 28
maggio 2020. Indifferente alla critiche, Bolsonaro conta solo sulla sua base
sociale: dalle Chiese evangeliche ai latifondisti deforestatori, fino alla
potente lobby delle armi. Non è facile fare il Donald Trump senza essere Donald
Trump. E il prezzo della disfatta può essere altissimo. Da mesi il presidente
brasiliano Jair Bolsonaro tenta di improvvisare un’imitazione politica della
spavalderia con cui, agli inizi dell’epidemia del Covid19, la Casa Bianca ha
trattato le notizie sul contagio. Ma non gli sta andando benissimo. Tanto che
Donald Trump ha deciso questa settimana il divieto di entrare negli Stati uniti
dal Brasile. Negare l‘ esistenza della pandemia con piglio ideologico sovranista
non è servito a Bolsonaro ad evitare lo schiaffo dal suo sovranista modello alla
Casa Bianca. Prova che le alleanze ( reali o solo da una parte agognate) tra
sovranisti chiacchieroni tendono per loro stessa natura a durar poco. “Questa
non è una pandemia, ma una nevrosi” ha assicurato Bolsonaro alla notizia dei
primi morti europei da virus. “In Italia muoiono in tanti soltanto perché è un
Paese di vecchietti. In ogni condominio italiano ci sono tanti vecchi quanti ne
vedete nei palazzi di Copacabana, solo per questo laggiù muoiono” ha detto il
presidente brasiliano. E via sparandole sempre più grosse. Per alcune settimane
gli è andata bene perché il virus è arrivato in Brasile in ritardo rispetto
all’Europa. Poi, però, il contagio ha cominciato ad essere evidente anche se non
da tutti gli ospedali brasiliani arrivano report attendibilissimi sulle cause
dei decessi avvenuti tra i ricoverati. E anche se non si riesce a contare quelli
che muoiono senza aver messo piede in ospedale. Ufficialmente i contagi sono per
ora sotto i 400mila ( su 200 milioni di abitanti). La giovane età media dei
brasiliani aiuta la resistenza generale al deterioramento delle condizioni di
salute dei contagiati, ma le notizie sui morti sono difficili da cancellare e,
soprattutto, l’effetto mediatico delle foto delle fosse comuni preparate in
Amazzonia non è arginabile né con tweet presidenziali né con dirette tv
minimizzanti. Il timore che le cifre reali dell’epidemia siano molto più alte è
tra i brasiliani assai diffuso. E l’atteggiamento di Bolsonaro in proposito è
sembrato fuori luogo a molti. Nei sondaggi il gradimento dell’ex colonnello
neofascista diventato presidente crolla a vista d’occhio. Sale invece quello dei
governatori di San Paolo e di Rio de Janeiro che avvalendosi dei propri poteri
hanno autonomamente decretato quarantene e politiche di isolamento anticontagio.
Bolsonaro come reagisce? Tenta di rafforzare la sua base sociale sicura. Fa
regali politici e fa arrivare una pioggia di soldi sui gruppi più attivi tra i
suoi elettori. Quindi in questi giorni ogni capriccio di capi di chiese
evangeliche, ogni pressione di latifondisti, ogni richiesta di deforestatori
professionisti e di lobby di produttori di armi sta trovando tappeti rossi al
Planalto. La deforestazione amazzonica prosegue a ritmi inediti. L’invio
dell’esercito sul posto, con l’obiettivo formale di controllare gli incendi, è
denunciato dai professionisti dell’Ibama, l’Istituto brasiliano per la difesa
dell’ambiente, come un pericolosissimo mezzo per annientare la loro azione
poiché sotto l’autorità dell’esercito (e quindi di Bolsonaro) devono stare
tutti, compresi gli ambientalisti. Che ne saranno, dicono, annientati. D’altra
parte in questi giorni il video più cliccato del Brasile è quello perfidamente
diffuso dal Tribunale supremo, che ha deciso di desecretarlo, in cui oltre a un
Bolsonaro visibilmente alterato si ascolta il ministro dell’Ambiente
raccomandare a Consiglio dei miistri di approfittare dell’attenzione mediatica
tutta concentrata sull’epidemia per accelerare le deforestazioni. Anche per la
lobby dei produttori di armi arriva solo musica dal Planalto. Ad aprile è stata
revocata l’ordinanza per rafforzare il rastrellamento di armi e munizioni. Un
decreto presidenziale moltiplica per 12 il numero massimo di munizioni che si
possono acquistare legalmente. Per alcune armi il limite massimo è di 6000
all’anno. Ma il regalo più sostanzioso è per la lobby evangelica, trasversale e
potentissima in Brasile. Alle autorità fiscali sarebbe già arrivata, secondo
un’inchiesta del giornale di San Paolo “Estadão”, la richiesta presidenziale di
cancellare con un tratto di penna i debiti delle comunità evangeliche con il
fisco. Almeno 160 milioni di euro. Bolsonaro è in difficoltà politica crescente.
Il Tribunale supremo sta investigando sull’ingerenza che il presidente, secondo
l’ormai ex ministro di giustizia Sergio Moro – l’ex giudice principale alleato
di Bolsonaro diventato ora suo nemico politico – avrebbe avuto sulla Polizia
federale nel tentativo di sotterrare indagine a carico di Bolsonaro e dei suoi
potentissimi figli. Moro, prima di dimettersi, ha accusato il presidente di
voler controllare la Polizia federale per bloccare indagini e per ottenere
dossier riservati. Lo ha accusato anche di aver falsificato atti pubblici. Nel
video desecretato dal Tribunale supremo, che riprende integralmente il Consiglio
dei ministri del 22 aprile, si ascolta incredibilmente il presidente Bolsonaro
confermare con abbondante turpiloquio, di fronte a ministri e parti sociali
convocate alla bizzara riunione, che quelle pressioni le ha fatte, eccome. Su di
lui pendono al molte diverse richieste di impeachment, per ora parcheggiate al
Congresso e la minacciosissima denuncia penale fatta da Sergio Moro per reati
federali su cui sta indagando il Tribunale supremo.
Daniele
Mastrogiacomo per “la Repubblica” il 28 aprile 2020. È un pessimo momento per
Jair Messias Bolsonaro. Il più basso (30 per cento) nei consensi e il più alto
(57) nelle richieste di impeachment. L' ex capitano ribelle dell' esercito è
giunto a un bivio nella sua tumultuosa esperienza da presidente del Brasile.
Persino nella gestione del Covid 19, con 61.888 infetti e 4.205 morti, Bolsonaro
non si è dimostrato all' altezza. Ha costretto alle dimissioni il ministro della
Salute, Luiz Henrique Mandetta. E ha preteso che il ministro della Giustizia lo
informasse delle inchieste che riguardano la sua famiglia. Ma Sergio Moro si è
dimesso e lo ha attaccato, mettendolo nei guai. Che sono anche pesanti: 4
inchieste a carico di tre dei suoi figli. La prima riguarda il cosiddetto
"ufficio dell' odio" e punta a Carlos Bolsonaro. Durante la campagna del padre
ha creato una macchina dei fake cha ha sommerso di messaggi e video i social. Si
è scoperto che la maggioranza era rilanciata da robot. Carlos è accusato di
diffusione di notizie false. Il fratello Flavio rischia ancora di più: è
accusato di aver usato fondi pubblici per pagare gli stipendi di due
collaboratori quando era deputato regionale a Rio. Gli investigatori sono
risaliti a due ex ufficiali della Polizia militare passati nelle file di gruppi
paramilitari che agiscono da criminali nelle favelas. I loro nomi sono apparsi
come reali amministratori di tre piccola società di costruzioni che 4 anni fa
hanno acquistato illegalmente dei terreni a Rio das Pedras, ovest di Rio,
realizzando una grande speculazione edilizia. Centinaia di appartamenti che sono
serviti a riciclare una montagna di denaro, frutto di tangenti e estorsioni.
Parte di questo denaro, con un giro di transizioni che coinvolge 86 persone,
sarebbe finito nelle tasche di Flavio Bolsonaro. Con un' aggravante. I due ex
poliziotti sono stati arrestati come sicari della consigliera comunale e
attivista sociale Marielle Franco, freddata il 14 marzo del 2018. Infine,
Eduardo. Non è coinvolto in indagini. Ma è molto amico di Alexandre Ramagem,
direttore generale dell'intelligence brasiliana. Ha sostituito il capo della
Polizia federale cacciato da Bolsonaro e che ha portato alle dimissioni del
ministro della Giustizia. L' uomo giusto al posto giusto per blindare i
fratelli. E con loro il padre presidente.
Rocco Cotroneo per corriere.it il 25 aprile 2020. Vuol mettere le
mani sulla Polizia federale per bloccare indagini che lo toccano da vicino e
insiste per ottenere dossier riservati. E inoltre falsifica atti pubblici. Le
più pesanti accuse mai formulate contro il presidente brasiliano Jair Bolsonaro
non arrivano dall’opposizione, ma dal suo (ex) più fedele alleato. Sergio Moro,
ministro della Giustizia, si è infine dimesso dall’incarico sparando ad alzo
zero. Moro non è un nome qualsiasi. Era il giudice dell’operazione
anticorruzione chiamata Lava Jato, che dalla procura di Curitiba ha terremotato
la politica nazionale, svelato finanziamenti illegali alla politica e, alla
fine, ha abbattuto il mito Lula. Fu Moro a condannare l’ex presidente e portare
al suo arresto. Poi, tra mille polemiche e sospetti, il giudice lasciò la toga e
accettò l’offerta di entrare nel governo di Bolsonaro come guardasigilli. Quel
che conta oggi però sono le accuse all’ex capitano neofascista, arrivato al
vertice del Brasile da un anno e mezzo. E’ da molto tempo che Bolsonaro mi
chiede di cambiare il numero uno della Polizia federale, rivela Moro nella
conferenza stampa di addio. E l’intenzione di togliere di mezzo altri dirigenti
negli Stati. E’ una interferenza politica inaccettabile. Nemmeno durante le mie
indagini sulla Petrobras, il presidente dell’epoca (Dilma Rousseff, ndr),
nonostante le accuse contro la sua parte politica, aveva osato interferire. Una
rivelazione devastante, e che potrebbe spalancare per Bolsonaro le porte di un
impeachment. Non solo. Dopo un lungo tira e molla con Moro sulla questione, con
il ministro che resisteva al licenziamento di un dirigente con il quale lavora
da anni, Bolsonaro si è mosso alla fine giovedì sera e con una decisione che ha
dell’incredibile: ha rimosso dall’incarico il direttore generale della Polizia
federale Mauricio Valeixo, e nell’atto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ha
fatto apporre anche la firma elettronica del ministro Moro. Quest’ultimo ha
negato di aver mai approvato il licenziamento. Ieri mattina, infine, Moro ha
deciso che era abbastanza e annunciato le dimissioni. Ma quali sono le indagini
e i reati inconfessabili che Bolsonaro vuole insabbiare? Sono almeno tre filoni,
e tutti riguardano i suoi figli, presenza ingombrante e ormai impresentabile al
vertice del Brasile. La Polizia federale indaga da tempo su un reato commesso
dal figlio Flavio quando era deputato: assumeva collaboratori fantasma nel suo
gabinetto, i quali gli restituivano una buona parte dello stipendio. Un assegno
finì anche nelle tasche dell’attuale first lady Michelle Bolsonaro. La seconda e
collegata indagine riguarda i rapporti tra la famiglia Bolsonaro e le milicias
di Rio de Janeiro, cioè le squadre paramilitari che controllano una parte della
periferia della città. Ma è il terzo filone di indagini che porta al cuore del
potere. Il secondogenito Carlos è sotto inchiesta per guidare tutto il
meccanismo di controllo dei social, con abbondanza di fake news e robot, che
sostengono il consenso al governo del padre. E che, con ogni probabilità, hanno
avuto un ruolo decisivo nella vittoria elettorale del 2018.
Cosa c'è dietro le dimissioni di Sergio Moro, stella
dell'Esecutivo di Bolsonaro. La decisione è maturata
dopo che il presidente gli aveva apertamente chiesto di rinunciare alla sua
prerogativa istituzionale. Daniele Mastrogiacomo il 25 aprile 2020 su La
Repubblica. Jair Bolsonaro perde un altro pezzo del suo governo. Stavolta si
tratta di una pedina importante, la stella dell’Esecutivo nato per rivoluzionare
il Brasile: il ministro della Giustizia Sergio Moro. Simbolo della lotta alla
corruzione, artefice di Lava Jato, la mega inchiesta sullo scandalo Odebrecht,
l’ex giudice alla fine ha deciso di rassegnare le dimissioni perché il
presidente gli aveva apertamente chiesto di rinunciare alla sua prerogativa
istituzionale. Aveva bisogno di “qualcuno che potesse chiamare, da cui potesse
raccogliere informazioni di intelligence, quando questo non è davvero il ruolo
della Polizia federale”, ha raccontato Moro in un incontro pubblico. Bolsonaro è
preoccupato delle indagini ordinate dalla Corte Suprema Federale dopo la
manifestazione di domenica scorsa in cui davanti a migliaia di sostenitori aveva
attaccato il Supremo e il Congresso e invocato il ripristino dell’AI-5, il
decreto con cui l’allora giunta della dittatura militare aveva sciolto il
Parlamento e abolito i diritti civili. Così come mostra insofferenza per le
indagini affidate alla Polizia federale sulle malversazioni di denaro pubblico
usato dal figlio, il senatore Flavio Bolsonaro, per pagare gli stipendi a
collaboratori quando era consigliere regionale di Rio de Janeiro. L’ex Capitano
dell’esercito voleva limitare l’indipendenza decisionale del suo pupillo
trasformando il ministero della Giustizia in una centrale a cui rivolgersi per
avere notizie sulle inchieste più scottanti che riguardavano lui e la sua
famiglia. Per farlo aveva bisogno di un uomo di fiducia. Ma il direttore
generale della Polizia Federale, il commissario Mauricio Valeixo, braccio destro
di Moro al ministero, il funzionario con cui aveva condiviso tutta la partita di
Lava Jato e che si era portato dietro quando era stato chiamato alla Giustizia,
non si era mostrato disponibile. Così, dopo molte telefonate e molte riunioni
con Moro, il presidente gli aveva comunicato la sua intenzione di trasferire
Valeixo a Rio de Janeiro e di sostituirlo con qualcuno più malleabile. Il
ministro ha pensato ad una forzatura; era convinto che si trattasse solo
dell’ennesimo sfogo per questa mancata collaborazione. Ma aveva subito chiarito
che non si sarebbe prestato ad un cambio che minava la sua indipendenza di
azione. Era stato chiaro e deciso: se trasferisci lui, mi dimetto. Jair
Bolsonaro lo ha chiamato per l’ennesima volta giovedì mattina e quando ha visto
che Moro restava fermo sulle sue posizioni ha deciso per il cambio. Non lo ha
avvertito e il ministro della Giustizia si è trovato il decreto di trasferimento
del commissario Mauricio Valeixo direttamente pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale. Tutti pensavano all’ennesimo scontro in un momento turbolento e
drammatico per il Brasile alle prese con la crisi del Covid-19. I morti sono
3.313 e 50 mila i contagiati, anche se si pensa che siano 10 volte di più. C’era
stato appena il cambio al ministero della Salute, al termine del lungo braccio
di ferro con il ministro Henrique Mandetta, fautore del lockdown; da settimane
era sparito dalla scena anche il fedele ministro dell’Economia Paulo Guedes
assente persino quando Bolsonaro aveva annunciato il suo Piano Marshall per
sostenere l’economia in caduta libera e distribuire soldi a una popolazione
senza più reddito. Ma stavolta era diverso: lo scontro con Moro segnava il
culmine di una crisi che aveva diviso Planalto dai governatori per come gestire
l’emergenza coronavirus, con le passeggiate di Bolsonaro tra la gente, senza
protezioni, sfogando colpi di tosse, starnutendo e stringendo mani, invitando
tutti a tornare ad uscire di casa e a tornare al lavoro. L’ex giudice ha capito
che non c’erano più spazi di azione. “Ci siamo visti”, ha raccontato, “e ho
detto al presidente che quello che lui chiedeva equivaleva a una interferenza
politica. Lui mi ha risposto che era esattamente così. E’ stato chiarissimo, non
ha nascosto nulla. Mi ha ribadito che voleva avere una persona di fiducia, un
contatto che poteva chiamare, da cui avere informazioni, raccogliere rapporti di
intelligence. Insomma: voleva essere regista delle indagini per coprire se
stesso. Ma questo non è compito della Polizia”. Una cosa, ha aggiunto Moro, che
non è mai accaduta: neanche con i governi Lula e Rousseff. “Immaginate se
durante il processo Lava Jato un ministro o un direttore generale o gli stessi
presidenti di allora avessero chiamato il capo della Polizia federale…
L’autonomia della Giustizia è un valore fondamentale. Il problema non è chi
invade un altro campo istituzionale ma perché lo fa. Mi chiedo se altri saranno
in grado di dire no al presidente su altri argomenti”. Il ministro dimissionario
ha anche ricordato che Bolsonaro, quando lo aveva chiamato alla Giustizia, gli
aveva dato carta bianca. Nelle nomine e nelle azioni. “Ci eravamo impegnati a
combattere la corruzione e il crimine”, ha aggiunto. “Ma le cose sono andate
diversamente. Durante i governi del Pt l’autonomia della Polizia federale era
garantita. Non avremmo mai potuto fare quello che abbiamo fatto con l’inchiesta
Lava Jato”. Moro getta la spugna anche perché si stanno sfumando le possibilità
di finire alla Corte Suprema così come aveva concordato con lo stesso Bolsonaro.
Si è rotto un rapporto che non è mai decollato. L’ex giudice era finito nella
bufera con le rivelazioni sulle sue interferenze nel lavoro dei pm incitati a
trovare prove per arrestare Lula. Le stesse interferenze che adesso subisce da
Bolsonaro. Il presidente sta già pensando a un sostituto. Si parla di Jorge
Oliveira, primo ministro del Segretariato generale della presidenza. E’ un
maggiore della Polizia militare. L’ennesimo militare in un governo dominato dai
militari.
Coronavirus, Bolsonaro: "In Italia muore tanta gente perché è
un Paese di vecchi". Le parole di Bolsonaro
sull’Italia “terra di vecchi” sono state pronunciate neanche un giorno dopo il
primo decesso in Brasile per coronavirus. Gerry Freda, Giovedì 19/03/2020 su Il
Giornale. Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro ha ultimamente commentato
l’emergenza-coronavirus in corso in Italia evidenziando l’alta percentuale di
popolazione anziana del Belpaese. Il leader nazionalista ha rimarcato il legame
tra invecchiamento della popolazione e dilagare del coronavirus nel corso di un
recente incontro con i giornalisti verde-oro, incentrato proprio sulle misure
che il governo del gigante sudamericano avrebbe a breve messo in campo per
contrastare il Covid-19. Lo stesso presidente conservatore, nei giorni scorsi,
si è sottoposto in via precauzionale al test anti-morbo, che ha allora rilevato
la negatività di Bolsonaro al contagio. Il Brasile, appena questo martedì, ha
però dovuto piangere la sua prima vittima dell’agente patogeno che sta mettendo
in ginocchio la comunità internazionale. Parlando nel corso di una
conferenza-stampa tenuta a Brasilia, il capo dello Stato verde-oro, ha riferito
ieri SkyTg24, ha provato a stemperare la crescente preoccupazione dei suoi
connazionali riguardo alla diffusione della malattia incriminata nel Paese
latinoamericano. Egli ha infatti cercato di rassicurare l’opinione pubblica
locale affermando che l’epidemia colpirebbe principalmente nazioni “vecchie”,
come sarebbe a suo dire l’Italia. Bolsonaro, citato dall’emittente, ha quindi
affermato: “L'Italia è una città... un Paese pieno di vecchietti. In ogni
palazzo ce n'è almeno una coppia, come a Copacabana. Per questo motivo ci sono
tanti morti”. Il presidente, riporta AdnKronos, ha successivamente aggiunto:
“Gli anziani hanno altre malattie, ma dicono che muoiano per coronavirus. Non li
uccide il coronavirus che arriva alla fine, quelle persone sono già debilitate”.
I tentativi del leader conservatore di sdrammatizzare la bomba-coronavirus,
uniti alla sua propensione a tacciare di isterismo chiunque denunci la
pericolosità della pandemia e a criticare i governatori e i sindaci brasiliani
che hanno introdotto misure restrittive anti-contagio, non stanno suscitando, ad
avviso di SkyTg24, grande consenso popolare. Ad esempio, martedì scorso, fa
sapere la medesima rete televisiva, i cittadini di molte grandi città del Paese
hanno dato vita a una curiosa iniziativa di protesta nei riguardi del capo dello
Stato: lanciare delle pentole fuori dai loro balconi, simbolicamente contro
l’esponente nazionalista, al grido di “fuori Bolsonaro”. L’uscita del presidente
verde-oro sull’Italia quale “terra di vecchietti” ha subito provocato forti
critiche da parte dei politici del Belpaese. Uno di questi, ossia Andrea Romano,
deputato del Pd e membro della commissione Esteri alla Camera, ha appunto
rivolto a Bolsonaro le seguenti dure parole, riportate sempre da SkyTg24:
"Auguriamo agli amici brasiliani, anche a quelli di una certa età, di non
passare mai quello che sta passando l'Italia. Ma pretendiamo che la presidenza
brasiliana rispetti l'Italia e la sua sofferenza, astenendosi da affermazioni
deliranti e offensive come quelle di Bolsonaro”.
·
Quei
razzisti come gli Inglesi.
Brexit, c'è l'accordo tra Londra e Bruxelles: ecco cosa
cambierà dal primo gennaio. Libero Quotidiano il 24
dicembre 2020. Scampato il "no deal". Londra e Bruxelles hanno raggiunto
finalmente un accordo. La Gran Bretagna può dunque esultare: dal primo gennaio
2021 è fuori dall'Unione europea senza troppi scossoni. E ora con la Brexit? Il
governo britannico dispiegherà 1100 funzionari in più alle dogane e
all’immigrazione. Incerto, nonostante le promesse, il programma Erasmus così
come quello del programma di ricerca Horizon. In sostanza dall’anno prossimo gli
studenti europei dovranno chiedere il visto e le rette universitarie
raddoppieranno. Non solo, perché chi arriva in Inghilterra per lavoro dovrà
avere un visto, ottenibile solo se ha già un’offerta in tasca e un salario
previsto di almeno 25.600 sterline (circa 28 mila euro, meno solo in caso di
lavori essenziali come nel settore sanitario). Una brutta notizia per chi arriva
a Londra in cerca di fortuna. D'ora in avanti sarà più difficile riuscire a
venire nel Paese di Boris Johnson a fare i camerieri. Idem per i turisti che non
avranno bisogno di visto, ma sarà necessario il passaporto e non si potrà
restare per più di tre mesi. L’accordo non copre però il settore finanziario.
Il divorzio "amichevole" della vigilia di Natale.
Brexit, c’è l’accordo tra Ue e Regno Unito: stop Erasmus, ecco
cosa cambia per gli europei. Redazione su Il Riformista il 25 Dicembre 2020. La
trattativa è durata mesi estenuanti ma alla fine c’è l’accordo post Brexit tra
Ue e Regno Unito. Un accordo di libero scambio che seppellisce l’incubo di un
traumatico ‘no deal’ commerciale. E che, se non cancella lo scossone storico del
divorzio e dei contraccolpi che non potranno non seguirne, fa svanire almeno i
timori di una rottura traumatica: l’ombra di un caos doganale, di una guerra di
dazi, di conseguenze sulla stretta cooperazione fra l’isola e il continente in
settori cruciali come la sicurezza o come la ricerca scientifica, vitale in
tempo di emergenza Covid. “Tutto ciò che è stato promesso all’opinione pubblica
britannica durante il referendum del 2016 e nelle elezioni politiche dello
scorso anno è garantito da questo accordo”. Lo si legge in una nota di Downing
Street, arrivata subito dopo l’accordo raggiunto con l’Ue sulla Brexit,
ribadendo che è stata recuperata la sovranità del Regno Unito. Soddisfatta ma
non felice per il divorzio amichevole anche la presidente della Commissione
europea, Ursula von der Leyen: La “strada è stata tortuosa ma abbiamo ottenuto
un buon accordo, bilanciato ed è stato la cosa giusta da fare per entrambe le
parti”, ha detto in conferenza stampa. Il testo, 2000 pagine di dettagli tecnici
da scrutinare riga per riga, è stato definito a Bruxelles dopo un anno di
trattative fiume fra i team negoziali guidati da Michel Barnier e dal lord David
Frost. Fino a tradursi nel più grande trattato di libero scambio mai concepito
al mondo (668 miliardi di sterline di giro d’affari nel 2019) e nel primo patto
bilaterale del genere “a zero dazi e zero quote”. Un accordo annunciato
separatamente ai rispettivi fronti interni dalla presidente della Commissione
Ue, Ursula von der Leyen, e dal premier Tory britannico, Boris Johnson, alfiere
per antonomasia del referendum che nel 2016 innescò il passo d’addio. Entrerà in
vigore dal primo gennaio, alla scadenza esatta di quella fase di transizione che
Johnson non ha voluto categoricamente estendere. In regime provvisorio, fino al
completamento dei necessari processi di ratifica che Westminster potrebbe
chiudere in forma sprint addirittura fra Santo Stefano e Capodanno, ma che il
Parlamento Europeo intende portare a termine con cura e senza fretta: a inizio
2021, secondo il suo presidente David Sassoli. La quadratura del cerchio è
avvenuta anche sui punti più controversi: dall’allineamento normativo del
cosiddetto level playing field utile a scongiurare rischi di concorrenza sleale
su temi come i diritti dei lavoratori, le tutele ambientali o gli aiuti di
Stato; alla governance sui contenziosi futuri (con l’esclusione di qualsiasi
ruolo della Corte di Giustizia Europea); sino al dossier della pesca, piccolo ma
ostico. Punti definiti per lo più grazie a compromessi incrociati, a dispetto
dei proclami di vittoria negoziale sbandierati ora dalle due parti (Londra in
primis): come nel caso della pesca, risolto con conteggi “sgombro per sgombro”,
secondo fonti diplomatiche. Von der Leyen ha salutato la svolta “con
soddisfazione e sollievo”, ma non con gioia, di fronte a quello che resta un
divorzio, seppure amichevole. Mentre ha parlato di un’intesa equilibrata,
rispettosa degli interessi europei e che permette di lasciare ora “la Brexit
alle spalle” rimanendo “partner”. E toni simili sono venuti da Giuseppe Conte,
da Angela Merkel, da Emmanuel Macron e da altri leader. Johnson, a cose fatte,
ha da parte sua potuto alzare i pollici, rivendicando di aver mantenuto le
promesse (non tutte in realtà), di aver restituito “la sovranita'” e “il
controllo” al Regno in uscita dal mercato unico e doganale e di aver rimesso “il
destino” nazionale nelle mani del suo Paese. Un Paese che resta “amico e
alleato” dei 27 dell’Ue, oltre che “principale mercato” del continente, ha
rimarcato. Ma che, in attesa di chissà quali nuove opportunità globali, si
prepara intanto ad affrontare “cambiamenti” inevitabili e – almeno
nell’immediato, non ha potuto fare a meno di ammettere BoJo – non tutti
indolore. Come ad esempio accadrà, fra tanti altri, con il tramonto definitivo
della piena libertà di movimento a cavallo della Manica, con il ritorno dei
visti, con un regime d’immigrazione più severo, con la rinuncia britannica agli
scambi di studenti del programma Erasmus. Senza dimenticare i malumori interni
al Regno: primi fra tutti quelli dei secessionisti scozzesi, la cui leader,
Nicola Sturgeon, non ha perso tempo a rilanciare la propria sfida: “La Brexit –
ha twittato – arriva contro la nostra volontà. È tempo che la Scozia diventi una
nazione europea indipendente”.
Francesco Guerrera per ''La Stampa''
il 22 dicembre 2020.
Dio salvi il Regno Unito. Lo si dovrebbe cantare a Oxford Street,
deserta perché il "nuovo virus" ha chiuso tutti i negozi, in Kent, dove i
camionisti in fila aspettano che i francesi riaprano la Manica, o di fronte alla
porticina nera del numero 10 di Downing Street dove il governo britannico sta
cercando di salvare la faccia (e l'economia) nel dopo-Brexit. La "Gran" Bretagna
si è scoperta piccina, piccina ieri, strizzata tra la sfortuna di una
terrificante variante del virus e la spacconeria incompetente del divorzio
dall'Europa. E il riconoscimento tardivo che quest'anno terribile non era
proprio il momento per essere egoisti, nazionalisti e protezionisti. Lo
"splendido isolamento" di un Paese che non doveva niente a nessuno quando era
una superpotenza mondiale nel XIX secolo si è trasformato in tragica solitudine,
una nazione respinta dalle altre per ragioni sanitarie, economiche e politiche.
Ho vissuto a Londra per 15 anni (in due fasi) e non ho mai visto così tanta
paura tra investitori, capitani d'industria e gente comune. Nemmeno all'epoca
degli attentati dell'Ira negli anni '90, dei disordini di Londra nel 2011 o dei
più recenti attacchi di fondamentalisti islamici. Per la prima volta dalla fine
della seconda guerra mondiale - che, come è solito ricordare da queste parti, la
Gran Bretagna "vinse" a nome dell'Europa - i consumatori hanno paura di non
trovare frutta e verdura nei negozi, i mercati temono un colossale crac
economico, e gli imprenditori non sanno come riusciranno a mandare avanti il
proprio business. Quando John Allan, presidente di Tesco, dice di non essere
sicuro di come e quando le merci ritorneranno sugli scaffali dei suoi
supermercati perché il virus e Brexit sono "enormi incognite", è chiaro che la
sesta economia del mondo è in crisi. Parte dell'Armageddon britannico è dovuto
alla sfortuna delle mutazioni del Covid - anche se, come ha detto il virologo
Walter Ricciardi, Downing Street avrebbe dovuto lanciare l'allarme molto prima
sulla "variante inglese". Ma gran parte dei problemi attuali sono dovuti alle
scelte incaute del popolo britannico e dei suoi governanti. La Brexit vinse un
referendum nel 2016, voluto dall'allora primo ministro David Cameron perché era
convinto che l'unione con l'Europa avrebbe prevalso. I suoi successori Theresa
May e, ora, Boris Johnson, si sono ammantati di slogan ("La Brexit significa
Brexit"; "Riprendiamo il controllo del nostro destino") senza sincerarsi di
avere del potere negoziale con un blocco economico molto più importante. È una
triste ironia per la Gran Bretagna che il suo fallimento nei negoziati con
l'Unione europea (perché di fallimento si tratta, qualunque sia il risultato a
fine anno) coincida con sussurri di un accordo commerciale gigantesco tra Cina e
Ue. La gestione del virus è stata rovinata da analoga impreparazione. In ogni
momento importante, Johnson e i suoi hanno scelto l'ottimismo populista invece
del competente pragmatismo per cui la Gran Bretagna era famosa una volta.
L'insistenza del primo ministro a non "cancellare il Natale" è dietro sia la
lenta risposta alla variante del virus sia al panico scatenato dalla repentina
inversione di marcia e il lockdown di sabato. Come ha scritto Clare Foges, che
ha lavorato per anni con Johnson, sul Times: "Basta con l'ottimismo
irresponsabile di questo governo". Le perdite - di vite, denaro e opportunità -
sono già notevoli ma nel lungo termine, il Regno Unito rischia di buttare via un
elemento fondamentale della propria identità: il senso di essere nel giusto, di
fare le cose perbene (il famoso "fair play") e di essere una culla
internazionale di cultura, finanza e politica. A noi anglofili non resta che
sperare che Dio salvi il Regno Unito.
Il “trucco” degli inglesi per trasportare le forze speciali.
Davide Bartoccini su Inside Over il 18 dicembre 2020.
Potrebbero sembrare delle “strane capsule” montate sui piloni sub-alari di
caccia ed elicotteri da combattimento: come i vecchi Harrier GR.9, gli Ah-64
Apache, ma anche i moderni F-35 Lightning II. Ma potrebbe sembrare anche dei
missili da crociera o dei capienti serbatoi supplementari. In realtà sono degli
singolari alloggiamenti che trasportano esseri umani: piloti, membri delle forze
speciali o agenti segreti. Studiati e impiegati, all’occorrenza, per infiltrare
ed esfiltrare personale sensibile dalla zone nemiche – sebbene ci siano metodi
molto più “semplici” e sicuramente molto più comodi. Almeno per il passeggero.
Progettati dalla Avpro Uk Ltd alla fine degli anni ’90, e brevettati in seguito
dal ministero della Difesa britannico, sebbene non vi sia mai stata prova
effettiva del loro impiego in missione, gli “Exint pod” sono a tutti gli effetti
delle capsule – documentate nella loro esistenza da numerose fotografie
ed apposite illustrazioni – sviluppate per trasportare qualcuno nel più breve
tempo possibile proprio nel bel mezzo nella zona operazioni. Oppure per
l’esatto contrario: ad esempio salvare un pilota caduto dietro le linee
nemiche dopo l’abbattimento del suo velivolo. Un’eventualità, soprattutto
quest’ultima, che diede non poche preoccupazioni durante le guerre nei Balcani e
durante la Guerra del Golfo. Finendo con l’ispirare il concetto stesso, sebbene
già durante la seconda guerra mondiale venissero impiegati
degli escamotage simili. Sebbene possa sembrare un concetto estremamente
stravagante, questo metodo alternativo per inserire ed estrarre forze speciali,
personale ferito o sotto copertura dalla prima linea, è il risultato diretto
delle esperienze operative vissuta in numerosi conflitti dove i vertici militari
si sono trovati davanti alla necessità di mettere in salvo – nel più breve tempo
possibile – l’equipaggio di cacciabombardiere o di un elicottero abbattuto. Si
pensi ai casi di abbattimento riscontrati nei conflitti nell’ex-Jugoslavia, dove
vennero abbattuti diversi jet, compreso un F-117, o ai due Panavia Tornado
abbattuti durante la guerra del Golfo, o di inserire, segretamente, personale
altamente qualificato, fosse un agente dei servizi segreti o un membro
delle forze speciali. Per ovviare a tutto questo, venne concepita una “capsula”
dotata di sistemi per fornire ossigeno e riscaldamento, e appositi vani per
consentire il trasporto di armi o strumentazione, e per permettere ad un aereo
“Stovl” – ossia un velivolo progettato per effettuare decolli corti ed
atterraggi verticale come l’Harrier o l’F-35 – di trasporre sotto le ali, come
fosse un missile, una o due persone, viaggiando ad alte velocità, nonché ad
elevate altitudini. Il pod, che incontrò subito il problema dell’enorme rumore
che avrebbe dovuto sopportare il passeggero posto in una specie di bara
climatizzata, era addirittura dotato di un “sistema di recupero assistito
satellitare” e ovviamente di un paracadute. Questo qualora il pilota del
velivolo ospite si fosse trovato costretto a sganciare la capsula prima del
tempo; magari in caso di combattimento, come avviene con i serbatoi
supplementari dei caccia che vengono immediatamente sganciati per acquistare
maggiore velocità e manovrabilità. Il sistema, del quale qualcuno si è
disturbato a disegnare un render che rappresenta un F-35 che atterra nel deserto
e raccoglie due piloti in tenuta di volo, non è mai stato usato realmente,
secondo le fonti ufficiali, ma è ancora contemplato per essere utilizzato dagli
elicotteri Apache e Cobra delle Forze armate israeliane, che forse, a nostra
insaputa, potrebbero essere state “pioniere” anche in questa infausta occasione.
Va ricordato, ad onor del vero, che oggi un pilota esfiltrato dal campo di
battaglia in caso massima di emergenza, finirebbe legato con un moschettone al
carrello di un Mangusta o di un Apache come previsto nella pratica del “Buddy
Rescue“; quindi forse, se potesse scegliere, preferirebbe infilarsi in un
apposito “pod”. Per quanto scomodo come una bara.
La Storia, il Potere, i re e... Cromwell.
Hilary Mantel racconta l'ascesa e la caduta del braccio destro di
Enrico VIII Tudor. Hilary Mantel, Giovedì 29/10/2020 su Il Giornale.
Rovine (I) Londra, maggio 1536. Mozzata la testa alla regina, se
ne va. Il morso dell'appetito gli rammenta che è ora di una seconda colazione o
magari di un pranzo anticipato. Le circostanze di questa mattina sono inedite e
non ci sono regole a guidarci. I testimoni, che al trapasso dell'anima si sono
inginocchiati, si alzano e si rimettono il cappello. Sotto le falde, i volti
sono sbigottiti. Poi però torna sui suoi passi, per ringraziare il boia. Ha
eseguito il suo compito con stile; e sebbene il re lo abbia ben retribuito, è
importante ricompensare un buon servizio con un incentivo e una gratifica in
denaro. Lui, che è stato povero, lo sa per esperienza. L'esile corpo giace sul
patibolo nel punto in cui è caduto: prono, le mani distese, nuota in una pozza
color cremisi mentre il sangue cola fra le tavole. Il francese hanno fatto
venire il boia da Calais aveva raccolto la testa, l'aveva avvolta in un telo di
lino e l'aveva porta a una delle donne velate, rimaste accanto ad Anna negli
ultimi momenti. La donna aveva preso il fardello rabbrividendo da capo a piedi.
Eppure l'aveva tenuto saldamente, e una testa pesa più di quanto ci si aspetti.
Lui, che ha combattuto in guerra, sa anche questo. Le donne si sono comportate
bene. Anna sarebbe stata fiera di loro. Non permettono che venga toccata dagli
uomini; con i palmi protesi costringono ad allontanarsi chiunque tenti di
aiutarle. Scivolando nel sangue, si chinano sul corpicino inerte. Le sente
trattenere il fiato mentre sollevano quel che resta di lei, tenendola per le
vesti; temono che la stoffa si strappi e le dita sfiorino la carne, che già
comincia a raffreddarsi. Ciascuna ha cura di non calpestare il cuscino fradicio
di sangue dove la regina era inginocchiata. Con la coda dell'occhio, vede
passare una presenza, un uomo snello, con il corpetto di cuoio, che fugge via. È
Francis Bryan, un solerte cortigiano, che corre ad annunciare a Enrico la
ritrovata libertà. Conta pure su Francis, pensa lui: è un cugino della defunta
regina ma anche gli sovviene adesso di quella che verrà. Al posto della bara i
funzionari della Torre hanno trovato una cassa di frecce. Il corpo è piccolo e
ci sta. La donna che tiene la testa si genuflette stringendo il fradicio fagotto
e, non essendovi altro posto, lo sistema ai piedi del cadavere. Si alza
facendosi il segno della croce. Le mani dei presenti si muovono imitandola e si
muove anche la sua; ma poi la ferma, stringendo appena il pugno. Le donne la
guardano per l'ultima volta. Poi si allontanano con le mani discoste per non
sporcare gli abiti. Uno degli uomini di Kingston, il luogotenente della Torre,
tende degli asciugamani di lino troppo tardi perché siano di qualche utilità.
Questa gente è da non credere, dice lui al francese. Giorni e giorni che
preparano, e neanche una bara? Sapevano che sarebbe morta, dubbi non potevano
averne. «Forse invece sì, Maître Cremuel». (I francesi non riescono mai a
pronunciare il suo nome). «Forse ne avevano, perché la signora stessa, io credo,
pensava che il re avrebbe mandato un messaggero a fermare l'esecuzione. Perfino
salendo i gradini s'è voltata a guardare, l'avete vista?». «Il re non pensava
certo a lei. La sua mente è tutta per la nuova sposa». «Alors, forse questa
volta avrà miglior fortuna», dice il francese. «Dobbiamo sperarlo. Se sarò
costretto a tornare, il mio onorario aumenterà». Poi si gira e comincia a pulire
la spada. Lo fa amorevolmente, come se gli fosse amica. «Acciaio di Toledo».
Gliela mostra, per fargliela ammirare. «Per avere una lama come questa dobbiamo
ancora rivolgerci agli spagnoli». Lui, Cromwell, tocca il metallo con un dito. A
guardarlo adesso, non direste mai che suo padre era un fabbro ferraio; ha
familiarità con il ferro e l'acciaio, con ogni materiale estratto dalla terra e
forgiato, colato e battuto, reso a filo tagliente. Sulla lama del carnefice sono
incise la corona di spine di Cristo e le parole di una preghiera. Ora gli
spettatori se ne vanno, cortigiani, aldermanni e funzionari comunali, grumi di
uomini in seta e catene d'oro, con la livrea dei Tudor e le insegne delle
corporazioni di Londra. Decine e decine di testimoni, e nessuno che saprebbe
dire con certezza cos'ha visto; capiscono che la regina è morta, ma tutto è
accaduto troppo in fretta per poter comprendere. «Non ha sofferto, Cromwell»,
dice Charles Brandon. «Magari avreste preferito il contrario, Lord Suffolk».
Brandon gli ripugna. Mentre gli altri testimoni s'inginocchiavano, il duca era
rimasto rigido sulle gambe; odiava talmente la regina da non concederle neppure
quella cortesia. La rivede avanzare incerta verso il patibolo: lo sguardo, come
dice il francese, rivolto alle sue spalle. Anche mentre pronunciava le ultime
parole, mentre chiedeva di pregare per il re, sbirciava oltre le teste della
folla. Eppure non ha consentito alla speranza di fiaccarla. Poche donne riescono
a mostrarsi così risolute nell'ora estrema, e non molti uomini. Si è accorto che
tremava un poco, ma solo dopo l'ultima preghiera. Non c'era il ceppo, il boia di
Calais non l'ha usato. Le è stato chiesto di inginocchiarsi con la schiena
dritta, senza alcun appoggio. Una delle donne le ha legato la benda sugli occhi.
La regina non ha visto la spada, neppure la sua ombra, e la lama le ha
attraversato il collo con un sospiro, più rapida delle forbici nella seta. Tutti
noi be', quasi tutti, a parte Brandon ci rammarichiamo di essere arrivati a
tanto. Ora la cassa di olmo viene portata nella cappella, dove sono state alzate
le lastre tombali, perché Anna possa giacere accanto al cadavere di George
Bolena, suo fratello. «Hanno condiviso il letto da vivi», dice Brandon, «dunque
è giusto che condividano la tomba. Vedremo se si piaceranno ancora». «Venite,
Segretario Particolare», dice il luogotenente della Torre. «Ho fatto preparare
uno spuntino, se vorrete degnarmi di questo onore. Oggi ci siamo alzati tutti
presto». «Riuscite a mangiare, signore?». È la prima volta che suo figlio
Gregory vede morire qualcuno. «Dobbiamo lavorare per mangiare», dice Kingston,
«e mangiare per lavorare. Che può cavare il re da un servo negligente, che in
pancia non ha neanche un tozzo di pane?». «Negligente», ripete Gregory. Di
recente è stato mandato a imparare l'arte di parlare in pubblico e il risultato
è che, sebbene gli manchi ancora quella padronanza necessaria alla dovizia
retorica, ha sviluppato più interesse per le singole parole. A volte sembra che
le trattenga per esaminarle. A volte che le punzecchi con un bastone. A volte, e
il paragone è inevitabile, che le avvicini con l'interesse di un cane, che
scodinzola fiutando la merda di un suo simile. «Sir William», chiede al
luogotenente, «era mai stata giustiziata una regina d'Inghilterra?». «Non che io
sappia», risponde l'altro. «O quantomeno, giovanotto, non da quando sono in
servizio». «Capisco», dice lui: lui, Cromwell. «Dunque gli errori commessi negli
ultimi giorni sono dovuti alla vostra mancanza d'esperienza? Non riuscite a far
qualcosa per la prima volta e a farla bene?». Kingston scoppia a ridere di
cuore. Avrà pensato che era una battuta. «Vedete, Lord Suffolk», dice rivolto a
Charles Brandon. «Cromwell sostiene che ho bisogno di tagliare qualche testa in
più». Non ho detto questo, pensa lui. «È stata una fortuna trovare quella cassa
per le frecce». «Io l'avrei messa in un letamaio», ribatte Brandon, «e il
fratello sotto. E avrei fatto assistere il padre. Non so che cosa abbiate nella
testa, Cromwell. Perché lo avete lasciato vivere, col rischio che ci possa
recare danno?». Si volta verso Brandon, adirato; l'ira è un sentimento che finge
spesso. «Lord Suffolk, voi stesso avete offeso molte volte il re, per poi
chiedere perdono in ginocchio. E poiché siete quello che siete, non dubito che
tornerete a offenderlo. E dunque? Volete un re che sia completamente estraneo al
concetto di clemenza? Se lo amate come sostenete, badate un poco alla sua anima.
Un giorno si troverà al cospetto di Dio per rispondere di ogni suo suddito. Se
dico che Tomaso Bolena non è un pericolo per il regno, non lo è. Se dico che
vivrà ritirato, così sarà». Traduzione dall'inglese di Giuseppina Oneto e
Stefano Tummolini.
Elisabetta II fa i conti col passato schiavista: Kensington
nel mirino. Luigi Ippolito su Il Corriere della Sera
il 28/10/2020. Neppure i palazzi reali sfuggono alla furia del revisionismo
storico che spazza la Gran Bretagna: da Kensington Palace a Hampton Court, il
passato delle residenze della regina verrà messo sotto la lente per portarne
alla luce i legami nascosti con il retaggio schiavista. È un esame di coscienza
che arriva sull’onda del «Black Lives Matter», il movimento anti-razzista
partito dagli Stati Uniti e sbarcato con furore da questa parte dell’Atlantico:
una spinta che ha portato all’abbattimento di statue legate al commercio degli
schiavi ma anche alla messa in discussione di personaggi storici che sembravano
intoccabili, dall’ammiraglio Nelson al filosofo David Hume. Ora tocca ai palazzi
reali: lo ha annunciato in una intervista al Times Lucy Worsley, la curatrice
di Historic Royal Palaces, l’ente che si occupa delle residenze della
monarchia. Tutte le proprietà che risalgono alla dinastia Stuart, ha spiegato,
«contengono un elemento di denaro derivato dalla schiavitù»: dunque un esame
critico del loro passato è più che dovuto. Non che ci si proponga di abbatterli
o di chiuderli: ma si vuole inquadrarli nel contesto che li ha originati, senza
glissare sugli aspetti più controversi: «La Gran Bretagna è brava a mettere da
parte il lato più impegnativo della storia», ha commentato amara Lucy Worsley.
Gli Stuart erano strettamente legati al commercio degli schiavi in quanto re
Carlo II diede il sigillo reale alla Royal African Company, che detenne il
monopolio della tratta degli schiavi fino al 1698 e continuò a praticarla fino
al 1731: e fra i membri della Royal African Company c’era il fratello di Carlo
II, che poi salì a sua volta al trono come Giacomo II. Il commercio degli
schiavi venne bandito in Gran Bretagna solo nel 1807, ma si dovette attendere
fino al 1834 per abolire la schiavitù. Lo scoperchiamento degli scheletri negli
armadi dei palazzi reali fa seguito a un rapporto del National Trust, l’ente che
si occupa del patrimonio culturale britannico, che aveva appurato come una terzo
delle sue proprietà, fra cui anche Chartwell, la residenza di Winston Churchill
nel Kent, fossero legate «al ruolo talvolta scomodo che la Gran Bretagna ha
giocato nella storia globale». Ma adesso nel mirino dell’indagine di Lucy
Worsley c’è soprattutto Kensington Palace, una delle residenze più amate dai
reali, dai londinesi e dai turisti: qui abitano William e Kate — e fino all’anno
scorso anche Harry e Meghan — e qui teneva corte la principessa Margaret, la
sorella ribelle di Elisabetta. Purtroppo il palazzo venne acquistato e
rimodellato da re Guglielmo III, che aveva ricevuto dal mercante di schiavi
Edward Colston azioni della Royal African Company: dunque quelle stanze sono
state in parte costruite sul sangue degli schiavi. E così Hampton Court, la
reggia di Enrico VIII fuori Londra, pure venne ricostruita da Guglielmo III
grazie a proventi sospetti.
Caterina Belloni per “la Verità” il 21 ottobre 2020. Nome, età,
indirizzo, titolo di studio, caratteristiche della casa in cui si abita, mezzi
usati per recarsi al lavoro. In un censimento nazionale rientrano tutti questi
elementi, ma alla raccolta dati del Regno Unito presto sarà aggiunto un quesito
in più: le preferenze sessuali. Ai sudditi di Sua Maestà Elisabetta verrà
chiesto infatti di precisare quale opzione descrive meglio il loro orientamento
sessuale, indicando tra alcune possibilità: eterosessuale, gay o lesbica,
bisessuale, transessuale o con un diverso orientamento sessuale, che però va
precisato per iscritto. Una domanda decisamente intima, che sarà rivolta a tutti
i cittadini che hanno compiuto 16 anni, all'interno del Censimento previsto in
primavera. Chi non se la sente potrà evitare di dare la risposta, ma
probabilmente non verrà visto di buon occhio, visto che la raccolta dei dati
personali da questa parte della Manica è una faccenda più che seria. Viene
realizzata dall'Istituto nazionale di statistica ogni dieci anni sin dal 1801, è
obbligatoria per legge e quindi prevede per chi non restituisce il questionario
compilato una multa che arriva anche a mille sterline. Ragion per cui l'adesione
è sempre molto alta, come dimostra il fatto che dieci anni fa il 94 per cento
dei cittadini ha completato il modulo e l'ha restituito nei tempi previsti. A
spingere l'Istituto di statistica ad inserire una domanda tanto «delicata» è
stato il desiderio di raccogliere maggiori informazioni sulle inclinazioni dei
britannici, in modo che Governo, istituzioni pubbliche e associazioni abbiano un
quadro il più possibile preciso del territorio e dei suoi bisogni e possano
programmare interventi mirati. Come ha spiegato chiaramente Iain Bell,
responsabile del progetto: «Senza dati precisi sulle dimensioni della comunità
Lgbt a livello nazionale e locale, chi prende le decisioni deve agire alla
cieca, privo di informazioni sulla natura dei problemi che queste persone vivono
in termini di salute, di educazione, di impiego». Per il momento la Gran
Bretagna ha delle stime sull'orientamento sessuale a livello nazionale e
regionale, ma secondo Bell un censimento dettagliato consentirebbe di fornire
alle autorità locali e centrali un quadro migliore. La sua spiegazione ha
convinto anche Nancy Kelley, direttore esecutivo dell'associazione di
volontariato Stonewall, che si batte per i diritti della comunità Lgbt. «Da
sempre gay, lesbiche, bisessuali e transessuali stanno in incognito e proprio
questa mancanza di visibilità ha limitato la possibilità di offrire loro
supporto e garanzie» ha dichiarato parlando alla stampa. Con britannico aplomb,
insomma, nessuno fa polemica all'idea che la gente venga costretta a confessare
quali siano le sue inclinazioni sessuali nel censimento del 2021, che costerà
allo Stato qualcosa come 906 milioni di sterline (poco meno di un miliardo di
euro) e coinvolgerà 30.000 operatori almeno. Se venisse fatta in Italia
probabilmente la stessa richiesta susciterebbe reazioni indignate e anche il
sospetto che si tratti di uno stratagemma per mappare alcune categorie. Pratica
del resto diffusa pure in Gran Bretagna, come dimostra un episodio del 2016.
All'epoca sui moduli di iscrizione delle scuole di Londra alle famiglie italiane
era stato chiesto di precisare se i loro figli fossero «italiani»,
«italiani-siciliani» o «italiani-napoletani». Una domanda assurda, accolta come
una forma di discriminazione. E contro la quale si era mobilitato anche Pasquale
Terracciano, allora ambasciatore italiano in Uk.
Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera” il 19 ottobre 2020.
Ma chi è veramente Boris Johnson? The Gambler - il giocatore d' azzardo -
sostiene il sottotitolo della monumentale biografia appena uscita in Gran
Bretagna e che sta facendo versare fiumi d'inchiostro ai giornali londinesi. L'
autore è Tom Bower, uno scrittore aduso ai ritratti al vetriolo (si è cimentato
in passato con le vite di Mohamed al-Fayed e Richard Branson, di Tony Blair e
del principe Carlo): solo che questa volta l' intento era quello di delineare un
personaggio in maniera simpatetica, se non assolutoria. Lui in fondo fa parte
della stessa cerchia («Boris non è un estraneo nella mia casa», lascia cadere en
passant ), e soprattutto è sposato con l' ex direttrice dell'Evening Standard,
il giornale di Londra che aveva lanciato Johnson a sindaco della capitale. Per
l'intero libro, il protagonista è semplicemente «Boris», mentre tutti gli altri
vengono indicati ovviamente per cognome. Ma nonostante ciò, il risultato è
devastante: Johnson viene fuori come un uomo fondamentalmente tarato,
psicologicamente devastato, divorato dai suoi demoni interiori. E la colpa è
tutta di suo padre, Stanley: un farabutto che picchiava la moglie - fino a
spaccarle il naso, una volta, e farla finire in casa di cura per esaurimento
nervoso -, un adultero seriale, uno che convinceva le ragazze alla pari a girare
nude in casa con la scusa che non c' era acqua per lavare i vestiti (e se ne è
portata una a letto sotto gli occhi dei figli), che metteva i suoi quattro
ragazzi in competizione esasperata fra di loro e che infliggeva loro continue
torture psicologiche. È su questo sfondo da incubo che Boris si costruisce la
sua corazza: non poteva raccontare fuori quello che succedeva tra le mura di
casa e allora si rinchiude in se stesso, decide che da grande diventerà «il re
del mondo» per essere invincibile, inviolabile, isolato dal dolore. Il Boris
persona pubblica che tutti conosciamo - teatrale, buffonesco, esuberante, carico
di ottimismo a ogni costo, travolgente e tracotante - è una maschera che
nasconde un uomo solitario, che ha pochissimi amici, insicuro, bisognoso di
approvazione, ma soprattutto profondamente infelice. Uno che vuole piacere a
tutti ed è costantemente in cerca di affetto, persino da parte dei suoi nemici.
Ovviamente la movimentata vita sentimentale di Johnson occupa una parte notevole
del libro: a partire dal primo matrimonio con la compagna d' università Allegra
Mostyn-Owen, laddove Boris dimentica il certificato di nozze nei pantaloni
imprestati e poi perde l' anello nuziale. Ma la vera vittima è Marina Wheeler,
la seconda moglie, che si vede sfilare sotto il naso una teoria di amanti (e
figli illegittimi), fino a cacciarlo di casa definitivamente quando si
invaghisce di Carrie Symonds, di 24 anni più giovane di lui. Ed è un quadro
familiare, il più agghiacciante di tutta la ricostruzione: quando i parenti
litigano al suo capezzale, mentre Boris lotta tra la vita e la morte in preda al
Covid. Bisogna trascinare i figli, ormai in rotta con lui, a dargli un
(possibile) ultimo saluto, mentre il padre Stanley si rifiuta di telefonare a
Marina. Per il suo biografo, insomma, è il retroterra caotico e doloroso che
spiega tutto ciò che è venuto dopo: l' ambizione, l' esibizionismo, l'
inaffidabilità, le vulnerabilità di Johnson. Ma dipingerlo come una vittima non
basta ad assolverlo: perché quest' uomo si è ritrovato in mano i destini di una
delle nazioni più fulgide del pianeta nel mezzo di una crisi epocale. E leggere
The Gambler non è rassicurante.
Deve fare la quarantena e lo trovano al ristorante: bufera su
Blair. Polemiche per l'ex premier britannico Tony
Blair, il quale è stato pizzicato in un noto ristorante londinese, dopo essere
rientrato da un viaggio negli Usa. "Non ha rispettato la quarentena", tuonano i
conservatori. Mariangela Garofano, Domenica 18/10/2020 su Il Giornale. L’ex
premier britannico Tony Blair è finito nell’occhio del ciclone per
aver “infranto le regole” relative al protocollo Covid. Volato negli Stati Uniti
il 14 settembre, per partecipare ad una conferenza sulla situazione tra Israele
ed Emirati Arabi Uniti, l’ex primo ministro è rientrato a Londra il 16 ed è
stato avvistato il 26 nell’esclusivo Harry’s Bar di Mayfair. Come riporta
il Daily Mail, Blair avrebbe trasgredito le regole, che impongono a tutti i
cittadini una quarantena obbligatoria di 14 giorni, di ritorno dagli Usa. Il
conservatore David Jones ha dichiarato al quotidiano che Blair con la sua
condotta “ha dato un pessimo esempio ai viaggiatori, in qualità di ex premier
che trasgredisce le regole”. In risposta alle accuse, il portavoce di Blair ha
specificato che l'ex premier britannico “ha seguito tutte le regole imposte dal
governo Usa e della Gran Bretagna. Il signor Blair è stato sottoposto ad un test
Covid prima di lasciare gli Uk, un altro all’arrivo alla Casa Bianca ed ed è
stato testato diverse volte dal suo ritorno. Tutti i test sono risultati
negativi e non ha partecipato ad altri incontri”. Dal Ministero degli Esteri
fanno inoltre sapere che i diplomatici in viaggio di lavoro per conto del
governo della Gran Bretagna sarebbe esenti dalla quarantena. “Il Foreign Office
fornisce esenzioni ai diplomatici che viaggiano per affari relativi agli intessi
della Gran Bretagna”, ha dichiarato un portavoce dell’FCO, sottolineando
che “queste persone, i loro dipendenti e familiari non devono seguire
l’isolamento di 14 giorni”. Ma Tony Blair ha lasciato il suo incarico come
inviato in Medio Oriente nel 2015, diventando da allora un privato cittadino a
tutti gli effetti. Le regole sono molte chiare a tal proposito, affermano i
conservatori. L’esenzione dalle norme in vigore vengono applicate esclusivamente
a diplomatici, il loro staff e ai membri dell’Onu, per le “conferenze
internazionali”. Non è stata risparmiata dalle critiche neppure la regina
Elisabetta, che pochi giorni fa ha fatto la sua prima apparizione dopo mesi di
isolamento nella “Covid bubble”.
La regina appare in pubblico dopo 7 mesi. Ma non indossa la
mascherina. La sovrana si è presentata al pubblico senza mascherina insieme al
nipote William, cosa che ha suscitato parecchie critiche, visto l’incremento dei
casi di Coronavirus in Uk. “Anche la regina dovrebbe rispettare le regole”,
hanno puntualizzato in molti sul web. Ma dopo 7 mesi di confinamento, Elisabetta
ha rispettato un rigoroso distanziamento di sicurezza durante la sua prima
apparizione pubblica.Cristina Marconi per il Messaggero il 20 ottobre 2020.
Senz' altro la Royal Navy non sarà felice che il mondo sappia che il
responsabile dei suoi missili nucleari, roba da provocare trenta Hiroshima, è il
tipo che arriva al lavoro dopo una notte di bevute, ancora «sbronzo lercio» e
con in mano un cartoccio contenente degli avanzi di pollo arrosto per il pranzo.
Ma la storia del vicecomandante Len Louw ormai sta facendo il giro del mondo,
andando ad accrescere il numero di scandali che hanno coinvolto negli ultimi
tempi il sommergibile HMS Vigilant, ormeggiato per manutenzione nella base
militare statunitense di Kings Bay, a Camden County, in Georgia. Tutto inizia a
settembre, quando Louw, responsabile ingegneristico di tutte le armi e i sensori
di bordo di uno dei quattro sottomarini da 3 miliardi di sterline che formano il
sistema di deterrenza nucleare del Regno Unito - roba in grado di uccidere 60
milioni di persone si presenta a inizio turno in condizioni pessime. Prima
ancora che il quarantenne prenda servizio, i suoi colleghi sollevano qualche
perplessità non è chiaro se per la sua ubriachezza o altro anche perché era in
corso un' operazione delicata: stavano per scaricare i missili, che pesano 60
tonnellate ciascuno e della cui manutenzione Louw era responsabile. «La persona
da cui stava prendendo le consegne ha capito che c' era qualcosa di gravemente
fuori posto», ha raccontato una fonte ai tabloids, spiegando che Louw «non era
in condizioni di essere responsabile delle armi nucleari» e che «non c' era
altra scelta che allertare i superiori». Un ex sommergibilista ha usato parole
ancora più severe nei suoi confronti: «È assolutamente sconcertante. E' la
persona responsabile del sistema missilistico Trident, Non ha rispettato i suoi
doveri e non è difficile immaginare il peggio che sarebbe potuto succedere». Per
il momento il vicecomandante è stato dichiarato «inadatto» e rispedito alla base
navale di Faslane, in Scozia, dove normalmente opera. Le autorità cercheranno di
fare luce sul suo comportamento e sulla decisione di assegnargli un ruolo tanto
delicato. «C'è un'inchiesta in corso e per questo sarebbe inappropriato fare
ulteriori commenti», ha spiegato un portavoce della Royal Navy, aggiungendo che
«tuttavia, qualora la condotta di un individuo non rispettasse gli alti standard
che ci aspettiamo, non esiteremmo a prendere misure adeguate». Il portavoce ha
aggiunto che «sebbene non commentiamo i dettagli, va detto che ci sono numerosi
controlli di sicurezza e procedure per tutelare la sicurezza e l' utilizzo di
armi a bordo di tutti i sottomarini». Su ciascuno dei 16 missili della HMS
Vigliant ci sono tre testate nucleari, che hanno all' incirca la portata di
trenta delle bombe lanciate su Hiroshima nel 1945. Trident è il costosissimo
sistema di deterrenza nucleare britannico, iniziato nel 1980 e avviato
ufficialmente nel 1994. Attualmente è in corso un programma per sostituire i
sottomarini di classe Vanguard con una nuova flotta Dreadnought, che sarà
operativa dal 2028. Andrà quindi in pensione entro il 2032 il glorioso HMS
Vigilant, soprannominato HMS Sex and Cocaine' per tutto quello che è avvenuto a
bordo negli ultimi anni, prima ancora che il vicecomandante Louw si presentasse
con il suo cartoccio di pollo fritto e l' ubriacatura ancora evidente: nell'
ottobre 2017 un ex comandante e un primo ufficiale sono stati rimossi per aver
avuto rapporti sessuali con ufficiali donne di prima leva, violando la regola
che impone di «non toccare», ossia di non avere relazioni intime a bordo. Poco
dopo altri nove membri dell' equipaggio erano stati licenziati per aver sniffato
cocaina. E la settimana scorsa è emerso che un quarto dell' equipaggio è
risultato positivo al Covid, probabilmente per via dell' abitudine di andare in
giro per locali non solo in Georgia, ma anche in Florida, tra le zone più
colpite dalla pandemia negli Stati Uniti. «Sono stati gomito a gomito per
settimane e i marinai fanno quello che fanno i marinai», ha efficacemente
riassunto una fonte.
(ANSA l'1 ottobre 2020) - "La Commissione europea ha inviato
oggi al Regno Unito una lettera di messa in mora per aver violato i suoi
obblighi ai sensi dell'accordo di recesso" sulla Brexit. "Ciò segna l'inizio di
un procedimento formale di infrazione contro il Regno Unito. Ha un mese per
rispondere alla lettera di oggi". Lo ha annunciato la presidente della
Commissione europea Ursula von der Leyen. "L'articolo 5 dell'accordo di recesso
stabilisce che l'Unione europea e il Regno Unito devono adottare tutte le misure
appropriate per garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dall'accordo di
recesso e che devono astenersi da qualsiasi misura che possa compromettere il
raggiungimento di tali obiettivi. Entrambe le parti sono vincolate dall'obbligo
di cooperare in buona fede nell'esecuzione dei compiti derivanti dall'accordo di
recesso", precisa la nota della Commissione europea. Il governo britannico
rivendica le sue "ragioni" dietro il progetto di legge nazionale (Internal
Market Bill) che rimette in discussione parte degli accordi di divorzio
sottoscritti con l'Ue in risposta alla lettera con cui la Commissione europea ha
confermato l'intenzione di avviare un'azione legale contro Londra se la
questione non sarà chiarita entro un mese. "Risponderemo alla lettera a tempo
debito", ha tagliato corto un portavoce di Boris Johnson, ma "abbiamo
chiaramente indicato le nostre ragioni per introdurre (attraverso la legge
contestata, già approvata dalla Camera dei Comuni e ora in discussione in quella
dei Lord, ndr) le misure relative al protocollo sull'Irlanda del Nord". Si
tratta, ha insistito, di "creare una rete legale di sicurezza per proteggere il
mercato interno del Regno Unito" e al contempo "tutelare il processo di pace"
irlandese.
McQueen, un esteta contro il razzismo nell'Inghilterra anni
'70. Il regista premio Oscar presenta la sua serie tv
"Small Axe" sulle comunità d'origine caraibica. Cinzia Romani, Sabato 17/10/2020
su Il Giornale. Roma. Impugna l'ascia, Steve McQueen, regista premio Oscar (12
anni schiavo) omonimo della spericolata star idolo di Vasco Rossi. E alla Festa
del Cinema di Roma vengono giù i pregiudizi, mentre, al secondo giorno, l'autore
britannico con base ad Amsterdam presenta la sua serie televisiva Small Axe,
cinque film a sfondo antirazzista, da novembre su Amazon Prime. Un racconto
viscerale sui ribelli anti-colonialisti che, nella Londra tra i primi anni
Sessanta e i tardi Settanta del secolo scorso, infiammarono il West End con il
loro attivismo contro le repressioni della polizia, accusata di razzismo nei
confronti della comunità caraibica. «È una storia importante e ignorata dal
mondo anglosassone. Ci ho messo undici anni per partorirla», spiega McQueen, sul
red carpet con la moglie Bianca Stigter e i loro figli Dexter e Alex, per poi
ricevere, dalle mani del direttore artistico Antonio Monda, il Premio alla
carriera. Già in rassegna ai Festival di Londra e di New York, la serie targata
Bbc, anche selezionata dal festival di Cannes, «cerca di colmare il gap tra il
1968 e metà anni Settanta, in un Paese, l'Inghilterra, che ha perso due
generazioni di artisti a causa del razzismo», dice l'autore, che prende il
titolo della sua opera da una canzone di Bob Marley, tratta dall'album Burnin'
(1973), dove si parla di una piccola ascia («small Axe») che taglia i grandi
alberi del pregiudizio razziale. A sua volta, la canzone prende spunto da un
proverbio africano: «Se tu sei il grande albero, noi siamo la piccola ascia».
Sbarcato in Inghilterra nel 1948, a bordo della Empire Windrush, il popolo
caraibico basato a Londra viene descritto da McQueen tra orgoglio e resilienza.
Ieri si sono visti tre episodi della serie, che capita a fagiolo mentre il
movimento Black Lives Matter fa parlare di sé: non a caso, la serie Small Axe è
dedicata alla memoria di George Floyd, vittima della polizia americana.
Nell'episodio Red, White and Blue, ispirato alla vera storia di Leroy Logan,
ufficiale di polizia di colore che si scontra col razzismo dei poliziotti
londinesi, si vedono canti, balli e lacrime dei non-bianchi. Magnificamente
interpretato da John Boyega (Star Wars), l'episodio sfodera la visionarietà di
McQueen e le eleganti architetture estetiche, che l'hanno reso caro alla
Biennale d'arte di Venezia. Nell'episodio Mangrove si racconta dell'omonimo
ristorante a Notting Hill, dove i dissidenti caraibici si davano pacifico
convegno, a metà degli anni Sessanta, per poi venir incriminati di sovversivismo
ed essere assolti. Per McQueen si tratta anche di storia personale: mamma di
Trinidad e papà delle Grenadine, egli conosce da vicino certa difficoltà. Tra
l'altro, suo padre era amico di uno dei «Mangrovia Nine», i nove dissidenti
riuniti a Notting Hill, mentre la figura di sua zia rivive nella protagonista
dell'episodio Lovers Rock. «Nel mio film circola universalità. Mio zio teneva
aperta la porta di casa a mia zia, che stava fuori tutta la notte, di festa in
festa», scandisce McQueen, omaggiando le proprie radici. E a proposito dei nuovi
standard adottati dall'Academy, in senso inclusivista, l'autore non si dichiara
soddisfatto. «Gli Oscar cercano di dare il meglio. Ma io sono più interessato
alle persone che vengono chiamate a lavorare nell'industria del cinema. Quando
vedrò che, alla base della montagna, c'è gente che la scala per salire in cima,
mi dichiarerò soddisfatto. C'è voluto l'episodio di George Floyd e una pandemia,
per farci scoprire che il razzismo esiste ancora. Non sono fautore della
violenza, ma a un certo punto scatta la frustrazione», riflette il regista di
Shame e Hunger.
Giampaolo
Scacchi per "blitzquotidiano.it" il 20 ottobre 2020. Ecco l’esperienza
dell’avvocato di colore Alexandra Wilson. Vittima di un fenomeno spontaneo
di razzismo inglese. Per ben tre volte, nel giro di un giorno, in tribunale è
stata scambiata per l’imputato. Commenta Giampaolo Scacchi: Sembravano passati i
tempi descritti da Walter Scott in Ivanohe, quasi mille anni fa. In fondo fanno
parte del Governo Johnson ministri figli di immigrati indiani. Così il ministro
dell’Economia e quella dell’Interno. Il fatto ha provocato un certo
scombussolamento. Al punto che Lord Reed, presidente della Corte Suprema, si è
sentito in dovere di intervenire. Contro “l’ignoranza e il pregiudizio
inconscio” che devono essere necessariamente affrontati dall’ordinamento
giudiziario. In un’intervista alla BBC, Lord Reed ha sostenuto che prima di
andare in pensione spera di vedere nelle aule più giudici di colore, asiatici e
di minoranze etniche. Ha spiegato che il trattamento subito da Alexandra Wilson
è stato “vergognoso”. L’avvocato, in merito all’episodio, su Twitter ha scritto:
“Sul mio viso deve esserci qualcosa che dice “non sei un avvocato”. Un piccolo
saggio di humour. Una volta lo chiamavano humour inglese. Lord Reed ha
sostenuto: “Alexandra Wilson è una giovane avvocatessa molto dotata, laureata a
Oxford e ha vinto numerose borse di studio. Essere trattata in quel modo, per
lei è stato a dir poco estremamente deludente”. Kevin Sadler, acting chief
executive del Her Majesty’s Courts and Tribunals Service, si è scusato con
Wilson, ha parlato di un “comportamento totalmente inaccettabile” e riguardo
all’episodio avrebbe indagato sul ruolo del suo staff. Secondo Judicial
Diversity Statistics, ad aprile 2019 circa il 7% dei giudici del tribunale era
BAME, acronimo di black, asiatico, minoranza etnica. Gli asiatici o gli
asiatici-britannici rappresentavano il 4% della totalità dei giudici della corte
e l’etnia mista il 2%. I restanti gruppi, neri o neri-britannici e altri gruppi
etnici, rappresentavano ciascuno circa l’1%.
Regno Unito, il caso dell'avvocata Wilson: "Scambiata per
imputata perché sono nera". Pubblicato sabato, 26
settembre 2020 su La Repubblica.it da Enrico Franceschini. Nell'arco di un
giorno è stata fermata quattro volte in tribunale, nonostante indossasse la
toga. La barrister britannica ha denunciato la sequenza di scambi sui social,
come forma di discriminazione razziale per il colore della sua pelle. Il
direttore dei servizi legali di Inghilterra e Galles le ha presentato una
dichiarazione scritta di scuse. In Inghilterra gli avvocati si dividono in due
categorie: "solicitors" e "barristers". Questi ultimi sono l'élite della
professione forense, gli unici abilitati a difendere nei tribunali di grado più
importante. Ma una barrister di origine africana, Alexandra Wilson, ha rivelato
che il modo in cui viene trattata nelle corti di giustizia dipende in primo
luogo dal colore della sua pelle. Questa settimana, nello spazio di una singola
giornata, l'avvocata è stata fermata per quattro volte in aula da persone che
l'hanno scambiata per un imputato. "Il primo è stato una guardia all'esterno
della corte, che ha chiesto di sapere il mio nome per vedere se ero nella lista
delle persone sotto processo quel giorno, e ho pensato che fosse un errore
innocente", ha raccontato Wilson al Guardian. "Poi, mentre mi avvicinavo
all'aula, un membro del pubblico mi ha fatto presente che, in quanto imputato,
dovevo aspettare il mio avvocato per entrare. Quindi, una volta dentro, un altro
avvocato mi ha detto che gli imputati non possono entrare se non accompagnati
dal proprio difensore. Un impiegato del tribunale, infine, mi ha gridato di
uscire perché non avevo diritto di stare lì. Quando gli ho spiegato chi ero, ha
risposto semplicemente: "Ah, okay". Definendo l'esperienza "umiliante e
frustrante", la barrister ha denunciato il caso su Twitter come una forma di
discriminazione razziale. Il suo cinguettio è diventato virale ed è finito sui
giornali. A questo punto il direttore dei servizi legali di Inghilterra e Galles
le ha presentato una dichiarazione scritta di scuse. Chiaramente nessuno pensava
che una donna nera potesse essere una barrister e per questo l'hanno scambiata
per un'imputata. Ora Wilson chiede che ci siano corsi speciali per assicurare
che tutti ottengano rispetto nelle corti di giustizia, indifferentemente dalla
razza. "Se un barrister è trattato in questo modo, ti domandi se un imputato
nero ottiene un equo trattamento", afferma. "Non basta dire: "Non ho idee
razziste e quindi non sono razzista". Dobbiamo combattere anche il razzismo
inconscio". Dopo la sua denuncia del caso, l'avvocata, autrice di un libro sui
problemi del razzismo nel sistema giudiziario intitolato "In black and white"
(In bianco e nero), dice di avere ricevuto numerosi messaggi da altri avvocati
che hanno sofferto discriminazioni razziali analoghe, inclusi tre barrister con
il titolo di Queen's Counsel (in sostanza, "consulente legale della regina"), la
crema assoluta della professione.
Simonetta Agnello Hornby per “la Stampa” il 25 settembre 2020.
Dal 1998 sono cittadina britannica e ne sono fiera. Questo non mi impedisce di
provare una profonda vergogna di fronte al primo ministro Johnson: un buffone,
un uomo squallido, volgare, un manipolatore. Con le spalle al muro, ha provato a
gettare fango su Italia e Germania stigmatizzando l' alleanza Mussolini-Hitler.
Una insinuazione pseudo storica con cui ha creduto di far polvere e di poter
giustificare l' alta percentuale di inglesi infetti di Covid. Johnson ha
spiegato che l' Inghilterra è una "freedom loving country", e gli inglesi, a
differenza degli italiani e dei tedeschi dell' anteguerra, rifiutano ordini
dall' alto. Il presidente Mattarella ha risposto con la solita dignità: "Anche
noi italiani amiamo la libertà, ma abbiamo a cuore anche la serietà". La freedom
loving country di cui parla Johnson non ha dato libertà ai popoli colonizzati,
anzi ne ha uccisi tanti e innocenti. Penso anche ai nativi americani che gli
inglesi hanno trattato in modo disumano, e che continuano a essere segregati e
umiliati negli Stati Uniti e nel Canada. Noto che poche voci si sono sollevate
per loro, nonostante il movimento Black Lives Matter. Il Regno Unito non è una
freedom loving country più di altri Paesi europei. È una nazione astuta che ha
avuto l' intelligenza di invitare europei e stranieri discriminati per religione
o politica: ha assorbito i rifugiati e gli emigranti perché facevano comodo come
manodopera. Alla fine Johnson dice: "È quindi molto difficile chiedere al popolo
britannico di obbedire uniformemente alle direttive oggi necessarie". Certo, è
molto difficile per noi britannici, come per la gente di tutto il mondo,
obbedire alle sue direttive, le direttive di un premier incoerente, privo di
sani principi. Credo nella giustizia e nel buon governo, e ho fiducia nel mio
secondo Paese. Johnson non rimarrà a lungo. Lui lo sa, ma non è intelligente
come lui crede di essere. È un incompetente e non c' è giustificazione per tanta
incompetenza: il volgare disprezzo per gli altri non fa che accelerare la sua
caduta. Boris Johnson, ultracinquantenne, è un personaggio tragico; ispirerebbe
pietà se non fosse per il danno che ha arrecato al Regno Unito e al mondo. Il
partito conservatore si sta rivoltando contro di lui. Non avrebbe vinto se non
fosse stato per la debolezza del Partito laburista nella scelta di un leader di
estrema sinistra e populista. Anche Johnson è un populista nel suo genere. È un
affabulatore, un comico, un attore. In siciliano lo si direbbe "un fimminaro",
fino all' ultimo. Sa circondarsi di gente efficiente, determinata, che farebbe
di tutto per ottenere i risultati voluti: sono i suoi special advisors. Famoso è
Dominic Cummings, un uomo di grande intelligenza e astuzia che ama tanto la
propria libertà da aver trasgredito le leggi del lockdown, clamorosamente. È
rimasto impunito e ha avuto l' onore di dare una conferenza stampa nel giardino
di Downing Street come nessun altro prima di lui. Le indicazioni date al popolo
da Johnson per sconfiggere il Covid cambiano settimanalmente, talvolta più
spesso, sono contraddittorie e quasi incoerenti. Il popolo non lo stima e
nemmeno i suoi colleghi al Parlamento, ma non c' è nessun altro in vista nel suo
partito. I bravi e gli efficienti deputati non hanno il supporto della
maggioranza del partito. Siamo di fronte a un processo di degradazione, non
soltanto dei conservatori e del Parlamento, ma di tutto il Paese. Io continuo a
sperare che gli stessi conservatori si rivoltino contro di lui in nome di un
"freedom loving party". I conservatori che hanno osato criticare in profondità
il loro premier sono stati epurati. È questa la libertà di cui parla Johnson?
Filippo Ceccarelli per “la Repubblica” il 25 settembre 2020. La
superiore libertà degli inglesi, la più efficace serietà degli italiani: al di
là della sparata del premier Johnson e della replica del presidente Mattarella,
vista in prospettiva sembra una di quelle dispute cui è difficile venire a capo.
Forse dipende dal Covid e parecchio ha pure a che fare con la Brexit, due eventi
comunque destinati a cambiare il reciproco immaginario. E magari non c'entra
tanto, o appena quanto basta per ricordarlo oggi, fatto sta che nel settembre
del 2003, quando ancora faceva il giornalista allo Spectator , l'allora 39enne
Boris interruppe le sue vacanze e raggiunse villa La Certosa dove, insieme con
il suo amico e connazionale Nicholas Farrell, intervistò a lungo il presidente
del Consiglio Silvio Berlusconi. E anche in questo caso, tra libertà e serietà,
si perde la bussola, perché il Cavaliere si sbottonò dicendone di cotte di crude
sui magistrati che erano dei pazzi, sui grandi giornalisti "gelosi" di lui,
sulla guerra in Iraq che non lo convinceva e su Mussolini che in fondo non aveva
ammazzato nessuno e anzi mandava i suoi oppositori a farsi un bel soggiorno
sulle isole. Poi però, viste le reazioni, smentì tutto a suo modo, cioè in
allegria, rivelando che durante l' incontro i due britannici avevano bevuto un
sacco di champagne. Al che il futuro premier del Regno Unito reagì: «Niente
champagne, purtroppo, solo tè freddo». E pubblicò una seconda puntata. L'
Economist, d' altra parte, settimanale di diverso orientamento, aveva da poco
giudicato Berlusconi "unfit", inadatto. Ma a dirla tutta, e con maggior forza
dopo che il direttore di quell' illustre magazine ha in qualche modo rivalutato
il Cavaliere, il sospetto è che per gli inglesi non esistano proprio, per
principio e per definizione, presidenti italiani che risultino, a loro giudizio,
adatti. Anche Prodi, per dire, non gli andava bene e per tutto il periodo in cui
fu a capo della Commissione europea la stampa britannica lo trattò malissimo.
Ora, in questo campo è impossibile, oltre che ingiusto, generalizzare, ma pure
gli italiani qualche pregiudiziale riserva contro gli inglesi ce l' hanno, o
almeno gli viene fuori con una certa facilità - vedi la freddezza, se non
peggio, mostrata nel momento in cui, era il 1982, la Marina di Sua Maestà andò a
riconquistarsi le isole Falkland a scapito dell' Argentina, oltretutto a quei
tempi guidata dai sanguinari generali golpisti. Spropositato pare qui rammentare
il contributo, non solo politico, della Gran Bretagna al Risorgimento, come del
resto conviene tener fuori dall' odierno e lieve contenzioso la frase con cui
durante l' ultima guerra mondiale il giornalista iperfascista Mario Appelius
concludeva le sue perorazioni radiofoniche: "Dio stramaledica gli inglesi" (pure
augurando loro "la mala notte"). Il punto, piuttosto, è che se nei rapporti fra
popoli e nazioni la politica e la diplomazia possono mentire, l' interesse
geopolitico e commerciale dice sempre la verità; e in questo senso fa riflettere
un' annotazione di Churchill (si trova ne "Il Golpe Inglese" di
Cereghino-Fasanella, Chiarelettere, 2011) che in un appunto del 1953 designa gli
italiani quali "amici e avversari di infimo ordine!", là dove nel paese dell'
understatement, quel punto esclamativo suona di inaudito rinforzo. Si trattava,
guarda caso, di petrolio: l'Italia come una minaccia agli interessi energetici
inglesi nel Mediterraneo e specialmente in Medio Oriente. Di qui, anche, un
alternarsi di infastidita alterigia da una parte e indimenticabili soddisfazioni
agonistiche dall' altra (il gol di Fabio Capello che ammutolì Wembley nel 1973);
una storia intricata e spesso sotterranea che ha portato Londra a diffidare per
mezzo secolo (con l' eccezione di Cossiga) dell' anticolonialismo di Enrico
Mattei, poi del terzomondismo di Fanfani, quindi del filoarabismo di Moro e
sempre del fervore papalino di Andreotti. Ma ecco che tutto questo appare
lontano e vicino, superato e attuale; come se invocare la presunta libertà degli
inglesi e l' ipotetica serietà italiana servisse un po' a convincersi, con
qualche sforzo, dell' una e dell' altra.
Il baronetto Simpson e il doping sul Ventoux.
Piero Mei il 21 settembre 2020 su Il Quotidiano del Sud. Il “caso
Simpson” non è qui quello di Wallis, l’americana divorziata di Baltimora, per
amore della quale un re d’Inghilterra rinunciò al trono, né quello di Orenthal
James, l’americano divorziato di San Francisco, “OJ” per tutti, famoso prima
come running back sui campi del football americano e poi come presunto assassino
dell’ex moglie, fuggitivo sull’autostrada della California, inseguito in diretta
tv dalle auto della polizia e poi assolto, e più tardi come rapinatore a mano
armata, condannato. Questo “caso Simpson” è quello di Thomas detto Tom (o
Tommy), inglese, ciclista, felicemente coniugato, che la Regina fece baronetto,
colpita dalla rarità, oltre Manica, dell’impresa sportiva che Simpson compì: la
vittoria nella Milano-Sanremo, insolita a quei tempi (era il 1964) per uno
sportivo britannico. Le glorie inglesi sui pedali, e sulle strade di mezzo
mondo, erano ancora lontane: c’era stato sì il pistard Reginald Harris di
Manchester con i suoi quattro titoli mondiali, ma lo tsunami di Union Jack sui
velodromi con Chris Hoy e compagni di pedali era allora inimmaginabile, come
l’avvento della generazione di Sir Bradley Wiggins o di Chris Froome, per non
citare che due dei tanti del Terzo Millennio. Questo “caso Simpson”, che accadde
il 13 luglio 1967, ebbe per scenario, nella tredicesima tappa del Tour di
quell’anno, il Mont Ventoux: “Fisicamente il Ventoux è terribile. È calvo. È
l’essenza dell’aridità. Il suo clima lo rende un terreno dannato, un luogo
adatto agli eroi. È come il più alto degli inferni. Il Ventoux è un Dio del Male
al quale bisogna sacrificare. Non accetta debolezze ed esige un ingiusto tributo
di sofferenze”, come lo aveva raccontato Roland Barthes, nei suoi “Miti d’oggi”,
dieci anni prima del “caso”. La conquista di questo monte era già stata narrata
sei secoli prima da Francesco Petrarca in una lettera al padre agostiniano
Dionigi, di Borgo San Sepolcro, una lettera “sui propri affanni” che Petrarca
scrisse fra cronaca e allegoria. È probabile che Tommy Simpson non avesse letto
né l’uno né l’altro. Sapeva, forse, che di lassù, 1912 metri sul livello del
mare e un territorio dall’aspetto di Luna, bianco e deserto, il Tour era passato
per la prima volta nel ’51, e che nel ’55, su quella cima, il campione svizzero
Ferdi Kubler era stramazzato al suolo ed aveva annunciato il proprio ritiro
dicendo semplicemente “Ferdi si è suicidato”. E forse Simpson sapeva pure che
giusto nel marzo di quel 1967 il Mistral, il vento che con la complicità del
sole dà a quegli ultimi cinque chilometri verso la vetta, l’aspetto di una
montagna di sale che si vede da tutta la Provenza, soffiò a 313 chilometri
l’ora, un record. Simpson, ormai Sir, era divenuto campione del mondo nel ’65 e
quell’anno aveva vinto anche il Giro di Lombardia. Ma voleva la consacrazione
ciclistica che solo il Tour regala: difficile entrare in bicicletta nel Pantheon
dei campioni se non vinci lì almeno una volta, tra i pochissimi Francesco Moser
c’è riuscito. Tommy era settimo in classifica generale quella mattina, partenza
da Marsiglia, arrivo a Carpentras, città che era stata la prima sede del Papa e
della Curia nel periodo del Papato di Avignone, dove uno chef di nome Silvestro
aveva confezionato per primo i berlingots, caramelle di zucchero al sapore di
menta, proprio per il Papa Clemente V. Ma non era di berlingots che si era
approvvigionato Tommy nell’albergo di Marsiglia la notte prima della tappa:
nella stanza dove alloggiava con Colin Lewis, uno dei tre gregari che gli erano
rimasti nella squadra di Gran Bretagna, era stato raggiunto da un paio di ceffi
italiani ed aveva acquistato, al prezzo di 800 sterline, alcuni tubetti di
Mickey Finns, come le chiamava lui, un po’ gergale e un po’ letterario: erano
amfetamine. Simpson era stanco ma si finse allegro al raduno di partenza: gli
organizzatori del Tour avevano distribuito foglie di verza da mettere sotto il
berretto perché aiutassero i ciclisti a tenere la testa fresca sotto il sole;
Tommy teneva in mano la borraccia e ne spruzzava l’acqua su quella verdura degli
amici, benedicente come sulle palme della domenica prima di Pasqua. Si toccò i
taschini posteriori della maglietta di cotone: Mickey Finn era lì. Partirono
verso Carpentras: bisognava passarci, poi scalare il Ventoux e ornarci
dall’altra parte del Gigante della Provenza, lo chiamavano i locali, quel Dio
del Male “salire sul quale non è da pazzi: lo è ritornarci” come scandiscono gli
abitanti del posto. Lì, quando la strada comincia a salire verso il cielo dove è
invece l’inferno, sì incontrano prima una foresta che nasconde il sole, poi una
macchia mediterranea e infine il nulla che lo svela, lo sposa con i venti che
s’incrociano da sud e da nord e porta al nulla. Le pendenze sono anche del 15
per cento. Jimenez, scalatore spagnolo, cominciò a menare la danza; Poulidor gli
si incollò alla sella, superandolo di quando in quando ma non per aiutarne la
fuga bensì per interromperne il ritmo perché il suo capitano, Pingeon, doveva
difendere la maglia gialla. In quel gruppetto intrepido con loro tre erano
Gimondi e Balmamion e, tra i pochi, Janssen che avrebbe vinto la tappa. Tommy
cominciò ad arrancare quando fu investito dal sole senza riparo. Colin Lewis, il
gregario, si fermò a un bar: prese una coca cola e un quarto di bottiglia di
cognac per il capitano assetato e disidratato; passò Aimar, ciclista francese, e
offrì una borraccia a Tommy che nemmeno si accorse del gesto. Aveva lo sguardo
sperduto, le gambe pedalavano da sole e faticosamente, Tommy dov’era? Prese il
cognac, bevve per mandar giù la compressa che aveva tirato fuori da uno dei tre
tubetti. Andava avanti a zig zag che sembrava stesse per cadere da un attimo a
quello dopo, attimi eterni. “On, on, on” diceva, “avanti, avanti, avanti”. Lo
fermarono, lo sdraiarono su di una petraia, il medico del Tour, il dottor Pierre
Dumas, gli praticò la respirazione bocca a bocca, un chilometro e mezzo più su
Jimenez scollinava per primo e solitario. Fu ripreso nella discesa, mentre un
elicottero arrivò per portare Simpson all’ospedale di Avignone. In discesa
ripresero Jimenez, fecero una volata a Carpentras; Janssen arrivò primo. Tommy
arrivò morto ad Avignone. Nella chiesa sconsacrata di Carpentras dove era posta
la sala stampa il dottor Dumas comunicò la tragedia: “Non è stata autorizzata la
sepoltura” disse, annunciando l’autopsia. I risultati furono resi noti il 2
agosto: l’amfetamina fu catalogata come una delle cause, insieme con il caldo,
il sole, il vento che aiutavano a nascondere quel che era successo quel giorno
nel ciclismo, quando non erano arrivati soltanto Janssen al traguardo di tappa,
Simpson alla fine della sua vita: era arrivato, ufficialmente, il doping nel
ciclismo.
Paola De Carolis per il "Corriere della Sera" il 19 settembre
2020. David Cameron che alza il gomito dopo il referendum sulla Brexit. La
moglie Samantha che beve prima delle dimissioni del marito. Boris Johnson che
accusa la solitudine. Realtà o satira? Diary of an MP' s Wife sembrerebbe
finzione, ma i nomi sono veri, l'autrice idem e la domanda sulla bocca di tutti
ora è: come ha fatto Sasha Swire, moglie di un deputato conservatore e figlia
del ministro della Difesa di Margaret Thatcher, a ottenere il nullaosta alla
pubblicazione? Per quasi 20 anni Lady Swire ha osservato i conservatori da
vicino, grazie all'amicizia e all'intimità che la lega (o forse la legava) ai
principali protagonisti: la sera prendeva appunti frettolosamente, senza
autocensurarsi. Quando il marito ha lasciato la politica, Swire ha consegnato il
diario a un agente, «senza neanche rileggere» ciò che aveva scritto. Ha capito
quando fosse indiscreto quando per i diritti è nata una battaglia che ha
coinvolto diverse case editrici. Old Ma May, così, è l'ex primo ministro Theresa
May, Boy George è George Osborne, l'ex cancelliere dello scacchiere, Raab C
Brexit, l'attuale ministro degli Esteri Dominic Raab. Phil il greco? Il principe
Filippo, duca di Edimburgo, marito di Elisabetta. È un volume che non risparmia
nessuno. Se il laburista Keir Starmer viene identificato subito, dal suo arrivo
in parlamento, come un futuro leader del partito, i conservatori non fanno una
bella figura. Sono pronti a oltrepassare le regole per favorirsi a vicenda, sono
permalosi, si offendono per un invito mancato. È un circolo chiuso che sa di
privilegio - Hugo Swire ha frequentato Eton come Cameron e Johnson - ricchezza e
superficialità. Johnson è «un calcolatore freddo», un uomo che nonostante la
debolezza per «la volpina giovane e sexy» - si presume la compagna Carrie
Symonds - «è disperatamente solo e triste». Cameron è «provinciale», ha la
battuta facile, è capace di fare apprezzamenti pesanti sull'attrice Keira
Knightley e «rovinare ogni weekend imponendo agli ospiti assurde prove sportive
che è destinato a vincere». Lui e Samantha nel libro sparlano spesso di Theresa
May e la chiamano «Maybot». Il consigliere di Johnson, Dominic Commings, è come
«un'ameba da esperimento», Michael Gove un traditore. È da giorni che la stampa
britannica parla del volume. La pubblicazione per estratti sul Times ha regalato
con ogni puntata nuovi particolari al limite della credibilità. Se la moglie di
Gove, Sarah Vine, sul Daily Mail ha rivelato che per alcuni (ex) amici di Lady
Swire il diario è «un suicidio sociale» e «un atto di vendetta» per il mancato
arrivo del marito al consiglio dei ministri, il Guardian ha voluto riconoscere
l'acume politico dell'autrice. Come spiega la politica? «Solo il dieci per cento
è quanto avviene in superficie, il resto è dovuto all'influenza delle mogli, dei
segretari, dei ricercatori, della pubblica amministrazione. I deputati, in cima,
sono come cavalli da mettere in mostra, ma dietro ci sono mogli che si
impicciano di tutto, soprattutto alcune, come me, Samantha Cameron, Sarah Vine».
Quale sarà la reazione tra i conservatori rimane da vedere. Certo è che, assieme
al marito, Lady Swire ha fatto parte del nucleo di fedelissimi che spianò la
strada per Cameron nel 2005. Se sino a pochi giorni fa erano ospiti di David e
Samantha in campagna, è difficile che l'amicizia resista all'uscita del libro.
Dagonews il 25 agosto 2020. La Gran Bretagna dovrebbe abolire le
leggi sui diritti umani per fermare il flusso di migranti che attraversano la
Manica. È l’avvertimento di alcuni parlamentari conservatori britannici a Boris
Johnson. Si tratta di una 40ina di deputati riuniti nel “Common Sense Group”,
che hanno chiesto una “riforma radicale” del sistema di asilo per dissuadere le
persone da tentare l’attraversamento del Canale. Le richieste arrivano dopo
settimane di tensione per gli sbarchi record dei migranti (più di 5mila) – la
ministra Priti Patel ha spedito le pattuglie della Royal Navy per rispedire in
Francia chi arriva. Il fondatore del gruppo Sir John Hayes, ex ministro della
sicurezza, ha affermato che la questione dovrebbe essere “una priorità
nazionale" in un'estate che ha visto un numero record di attraversamenti
illegali. "La legge sui diritti umani nella sua forma attuale non è adatta allo
scopo", ha affermato Hayes. 'Ovviamente alcuni diritti legali, come il diritto a
un processo equo, sono importanti ... ma la legge sui diritti umani così com'è è
oggetto di abusi da parte di un intero esercito di avvocati. La maggior parte
dei migranti che attraversano la Manica non ha diritto all'asilo quando vengono
esaminati i loro casi, ma anche in questo caso è molto difficile rimuoverli
senza che i loro casi si intasino nei tribunali.
Gb, pubblicato rapporto su interferenze russe: "Governo lento
nel riconoscere la minaccia". Pubblicato martedì, 21
luglio 2020 da La Repubblica.it. La Gran Bretagna è "uno dei principali
obiettivi della Russia" per il suo ruolo centrale nella "lobby occidentale
anti-Mosca" e per la sua vicinanza con gli Usa. Lo sostiene l'atteso rapporto
del Comitato britannico di Intelligence e Sicurezza sull'interferenza di Mosca
nella politica britannica pubblicato oggi e con cui si chiede al governo
"un'azione immediata" per aiutare i servizi a fermare questo "abile avversario".
Provare l'ingerenza della Russia nelle votazioni sulla Brexit è "difficile se
non impossibile" ma "il governo britannico è stato lento a riconoscere
l'esistenza della minaccia", si legge nel dossier dell'ISC (Intelligence and
Security Committee of Parliament) che copre una serie di argomenti, tra cui
campagne di disinformazione, tattiche informatiche ed espatriati russi nel Regno
Unito. Ma gran parte dei dettagli "altamente sensibili" non saranno pubblicati a
causa dei timori che la Russia potrebbe usare le prove per minacciare il Regno
Unito. Il rapporto, riporta la Bbc, accusa inoltre il governo di Londra di
"accogliere a braccia aperte" gli oligarchi russi. Downing Street è stata
accusata di aver ritardato l'uscita del rapporto per non condizionare le
elezioni di dicembre scorso. Alla presentazione dell'inchiesta oggi uno dei
membri del comitato, Kevan Jones, ha ribadito le critiche al premier Boris
Johnson che, ha detto, "non aveva ragioni per ritardarne l'uscita". Stewart
Hosie, uno dei membri del comitato ISC ha dichiarato che nessuno al governo
voleva toccare il problema dell'interferenza russa "neanche con un palo da tre
metri di stanza" e nessuno sapeva se la Russia avesse tentato di interferire con
il referendum Ue 2016 "perché non voleva saperlo". "Ciò è in netto contrasto con
la risposta degli Stati Uniti alle interferenze segnalate nelle elezioni
presidenziali del 2016", ha aggiunto. "Ci dovrebbe essere stata una valutazione
delle interferenze russe nel referendum dell'Ue e ora deve essercene una, la
genteo deve conoscere i risultati di tale valutazione". Il collega del
comitato Kevan Jones ha aggiunto che il governo ci ha "deluso" non cercando
alcuna interferenza nel referendum sull'indipendenza scozzese del 2014. Da Mosca
il Cremlino respinge le accuse di interferenze nella politica britannica. Il
portavoce del presidente Vladimir Putin, Dmitri Peskov, replica dicendo che "la
Russia non si è mai intromessa nei processi elettorali di nessun paese del
mondo, né negli Stati Uniti né nel Regno Unito né in altri". "Noi - continua
Peskov - non lo facciamo e non tolleriamo quando altri Paesi cercano di
interferire nelle nostre questioni politiche. Anche se questo rapporto conterrà
alcune effimere accuse, già ora scommetto che saranno basate sul nulla, saranno
di nuovo delle accuse infondate".
Erica Orsini per "Il Giornale" il 14 luglio 2020. Immigrazione,
nel Regno Unito dall'anno prossimo cambia tutto. Ieri il ministro dell'Interno
Priti Patel ha illustrato il nuovo sistema a punti che regolerà gli ingressi dei
cittadini stranieri e che entrerà in vigore dal gennaio del 2021. Con la fine
del periodo di transizione e della libera circolazione delle persone, potrà
venire a vivere e lavorare in Gran Bretagna soltanto chi totalizzerà un minimo
di 70 punti nel test d'ingresso. Per guadagnarseli dovrà soddisfare determinati
criteri come avere una qualifica per il lavoro richiesto, un'offerta di lavoro
preesistente, una buona conoscenza della lingua inglese o uno stipendio
superiore a 22mila sterline. La soglia salariale potrà venir ridotta, ma solo in
caso di scarsa offerta di lavoratori nazionali. In generale però non verranno
rilasciati permessi di soggiorno ai lavoratori privi di specifiche competenze
perché la nuova linea del governo di Boris Johnson è chiara: prima gli Inglesi.
Anche se il premier nega di voler sbarrare il Paese, anzi «laddove la gente può
contribuire a questo Paese, fare grandi cose, avremo un sistema umano e
sensibile». «In un periodo in cui un numero sempre maggiore di persone nel Paese
è in cerca di lavoro - spiega da parte sua Patel - il nuovo sistema a punti
incoraggerà gli imprenditori a investire in forza lavoro interna piuttosto che
appoggiarsi semplicemente a quella estera. Ma stiamo anche facendo dei
cambiamenti necessari in modo che sia più semplice per le aziende attrarre nel
Regno Unito le menti più brillanti e il meglio che c'è nel mondo per completare
le competenze che di cui già disponiamo». I nuovi immigrati inoltre dovranno
pagare un contributo per usufruire del servizio sanitario nazionale che invece
attualmente è gratuito. Un'eccezione verrà fatta per coloro che sono impiegati
nel servizio stesso, come medici, assistenti sociali paramedici, esclusi i
dipendenti delle case di riposo. Una vera e propria rivoluzione che riguarda da
vicino anche i moltissimi italiani che continuano a considerare il Regno Unito
come una delle mete lavorative preferite. Finito il periodo di transizione la
situazione muterà radicalmente e non in meglio. Attualmente risiedono nel Paese
circa 700mila italiani, di cui soltanto 350mila sono iscritti all'Aire, il
registro dei residenti all'estero. Molti non si sono mai iscritti, ma 454mila
sono in possesso della previdenza sociale, il documento necessario per lavorare.
Al momento rappresentano la terza forza straniera dopo romeni e polacchi e il 30
per cento di loro ha una laurea. Per tutti questi, anche non in possesso di
particolari competenze, non dovrebbe cambiare nulla se avranno fatto richiesta
dello status di residenza permanente e l'avranno ottenuto. Ma per i ragazzi che
ogni anno sognano di prendere un volo low-cost, atterrare sul suolo britannico
con quattro soldi in tasca, una conoscenza scarsa della lingua e trovare un
posto nei tanti caffè e ristoranti londinesi sempre in cerca di baristi e
camerieri, nel 2021 le porte si chiuderanno. I dettagli rimangono sfumati, ma
anche per studenti e laureati sono previsti cambiamenti. La prossima estate
verrà creato un nuovo percorso per i secondi in modo «da trattenere sul
territorio i migliori laureati». Parole del ministro, che intanto garantisce una
permanenza tranquilla di due anni dopo la laurea e la possibilità di lavorare
per tutti gli studenti durante il corso degli studi.
MARCO BONARRIGO per il Corriere della Sera il 13 luglio 2020. Lo
scoop Il quotidiano inglese Daily Mail ha recuperato e pubblicato ieri i
«contratti» secretati siglati da Uk Sport, l'agenzia governativa britannica per
lo sport olimpico, e 91 atleti per l'assunzione di un prodotto sperimentale a
base di chetoni in vista dei Giochi olimpici di Londra 2012. Non vietato Il
prodotto non era proibito ma Uk Sport addebitava agli atleti ogni responsabilità
in caso di positività o problemi per la salute, poi presentatisi (sotto forma di
nausea e vomito) in molti casi Oxford Sviluppati a Oxford per l'esercito Usa,
molto costosi, i chetoni sono prodotti sintetici che ridurrebbero il consumo
delle scorte energetiche dell'organismo e la produzione di acido lattico. Ma gli
studi che confermerebbero la loro efficacia sono una minima parte degli oltre
500 effettuati Tra il 2011 e il 2012, Uk Sport, l'agenzia governativa britannica
per lo sport olimpico, utilizzò 91 atleti di altissimo livello come cavie per
sperimentare un prodotto chimico non in commercio e con pesanti effetti
collaterali. Lo scopo? Dominare i Giochi di Londra. Nell'accordo con gli atleti,
secretato, ciascuno di loro si assumeva ogni potenziale rischio per la salute e
in caso di positività al doping. Esploso ieri grazie a una meticolosa inchiesta
del Daily Mail , il «caso DeltaG» rischia di sbriciolare la reputazione dello
sport inglese e di macchiare la memoria di Olimpiadi trionfali. DeltaG non era
in vendita: nessuno ne aveva autorizzato l'uso commerciale. Non era proibito
perché non era mai stato studiato dall'antidoping, non si sa se migliorasse le
prestazioni (cosa che non è chiara nemmeno oggi, dopo decine di studi) ma di
certo provocava gravi malesseri: il 40% delle «cavie» vomitava o aveva problemi
di stomaco, nel 28% dei casi così forti da far sospendere immediatamente
l'assunzione. I cronisti hanno scoperto che il magico beverone conteneva chetoni
sintetici, composti organici ritenuti «miracolosi» nel migliorare l'utilizzo di
energia da parte dell'organismo e studiati segretamente nei laboratori militari
americani. Ciascuna «cavia» firmava un documento con cui si impegnava a non
divulgare nulla sull'esperimento, a farsi carico degli eventuali rischi per la
salute e addirittura di eventuali problemi con i controlli antidoping. «Uk Sport
- si legge in un "contratto" recuperato dal quotidiano - non può garantire o
assicurare che gli estratti di chetone siano completamente a norma rispetto al
Codice mondiale antidoping ed esclude ogni sua responsabilità in caso di
positività». Rassicurando però le «cavie» (con un passaggio eticamente
micidiale) sul fatto che «le variazioni della chetosi dell'organismo sono
fisiologiche e quindi l'assunzione è difficile da riscontrare e dimostrare in
eventuali controlli post gara e il prodotto al momento non è proibito». Il
progetto DeltaG era nato nell'ambito di un programma governativo «per portare a
livelli di forma altissimi i britannici e massimizzare il numero di medaglie»:
gli inglesi ne conquistarono 65, garantendosi il terzo posto nel ranking per
nazioni. Ieri Uk Sport ha cercato di parare il colpo senza grandi risultati: «Il
nostro era un progetto di ricerca e innovazione condotto in linea con i più
elevati standard etici, nell'ambito delle regole dello sport internazionale e
valutato da un gruppo consultivo indipendente di esperti». I nomi dei 91
«chetonici» non sono stati resi noti ma British Cycling, che dominò in maniera
quasi imbarazzante le prove su pista e su strada del ciclismo, ha confermato che
«molti dei suoi atleti usarono DeltaG nel periodo di preparazione».
Doping, atleti Gb usati come cavie per sostanza sperimentale a
Giochi 2012. Pubblicato domenica, 12 luglio 2020 da La
Repubblica.it. Gli atleti olimpici britannici sarebbero stati usati come cavie
per testare una sostanza sperimentale in un progetto segreto costato centinaia
di migliaia di sterline di denaro pubblico nel tentativo di migliorare le loro
prestazioni durante i Giochi olimpici di Londra 2012. Lo rivela l'edizione
odierna del Daily Mail. Il comitato olimpico britannico avrebbe costretto gli
atleti a firmare liberatorie a propria discolpa se qualcosa fosse andato storto
e preso accordi in modo da impedire agli atleti di parlarne. Ma alcuni documenti
pubblicati dal Mail on Sunday mostrano come 91 sportivi britannici di livello
mondiale in otto sport olimpici siano stati sottoposti al trattamento, che
consisteva nell'assunzione di una bevanda energizzante, il DeltaG. La sostanza,
una versione sintetica di un acido corporeo naturale, i chetoni, è stata
originariamente sviluppata da scienziati dell'Università di Oxford con 10
milioni di dollari di finanziamenti da parte del Dipartimento della Difesa
americano in modo che le forze speciali statunitensi potessero operare più a
lungo dietro le linee nemiche pur a corto di viveri. I chetoni sono composti
organici prodotti dal fegato in mancanza di carboidrati per bruciare grassi,
sfruttati anche in alcune diete dimagranti. UK Sport, l'agenzia governativa
responsabile del finanziamento dello sport olimpico e paralimpico in Gran
Bretagna, ha prodotto un "foglio informativo per i partecipanti" per
accompagnare la domanda di progetto che recita così: "UK Sport non garantisce,
ma promette e assicura che l'uso della bevanda chetonica è assolutamente
conforme al codice antidoping mondiale e quindi esclude se stessa da ogni
responsabilità. La WADA potrebbe raccogliere campioni di sangue o testare
retrospettivamente vecchi campioni. Ciò può verificarsi se questa storia
diventasse di dominio pubblico. Tuttavia la chetosi è uno stato fisiologico
temporaneo e sarebbe difficile da dimostrare o testare con qualsiasi campione
post-evento." Lo scorso anno, durante il Tour de France, era emerso che la
Jumbo-Visma, la formazione olandese del numero uno delle classifiche Uci Primoz
Roglic, stesse usando una bevanda miracolosa a base di chetoni. Le prestazioni,
secondo alcuni studi, migliorerebbero del 15%. L'uso dei chetoni non è comunque
illegale, anche se all'interno del mondo del ciclismo c'è grande discussione
sulla loro liceità.
Luigi Ippolito per "corriere.it" il 7 luglio 2020. È già
diventata un caso politico – con un secco intervento del leader laburista Keir
Starmer – l’aggressione della polizia inglese a Bianca Williams, stella
dell’atletica britannica e già medaglia d’oro ai campionati europei e ai giochi
del Commonwealth.
La perquisizione dei due velocisti. I fatti risalgono a sabato,
quando l’automobile con a bordo la Williams e il suo partner, l’atleta
portoghese Ricardo Dos Santos – anche lui nero, come la velocista britannica –
viene fermata dalla polizia a Londra. Gli agenti sostengono che la macchina
procedeva sul lato sbagliato della carreggiata e non si è fermata all’alt: ma
sta di fatto che i due atleti sono stati trascinati fuori e ammanettati,
nonostante che nella vettura ci fosse anche il loro figlioletto di pochi
mesi. La perquisizione è durata ben 45 minuti, dopo di che Dos Santos e Williams
sono stati lasciati andare.
«Ho una Mercedes, pensano sempre che l’abbia rubata». «È sempre
la stessa cosa con Ricardo – ha detto poi lei in lacrime ai microfoni di una
radio -. Pensano che stia guidando una macchina rubata o che abbia fumato
cannabis. È una schedatura razziale». La macchina della coppia è una Mercedes: e
Dos Santos racconta che da quando l’ha comprata, nel 2017, lo hanno fermato
almeno quindici volte, mentre con la precedente utilitaria non gli era mai
successo. La coppia ha deciso di sporgere un reclamo formale dopo l’accaduto e
anche il loro allenatore, l’ex campione olimpico Linford Christie, ha accusato
Scotland Yard di «razzismo istituzionale».
L’intervento di Keir Starmer: «Manette ingiustificate». Ma le
parole più ferme di condanna sono arrivate dal leader laburista Keir Starmer:
«Non penso che la polizia abbia gestito la cosa molto bene. L’uso delle manette
è sempre controverso e non vedo come fosse giustificato in questo caso. Se fossi
un alto ufficiale e vedessi il video dei fatti, mi sentirei molto a disagio». Un
intervento tanto più significativo se si considera che Starmer è l’ex
procuratore generale d’Inghilterra, dunque uno dei più alti magistrati. «Quando
la polizia agisce in modo così violento – ha concluso Bianca Williams – tutto
può andare storto. E non si sono neppure scusati quando ci hanno tolto le
manette e ci hanno detto che eravamo liberi di andare».
Lorenzo Nicolao per “corriere.it” il 7 luglio 2020. Dopo anni di
sevizie quella che credevano fosse la normalità per eccellere è diventata
all’improvviso una violenza contro la loro salute fisica e psicologica. Decine
di ginnaste in Gran Bretagna hanno denunciato gli allenatori che le
costringevano a digiunare se pesavano troppo, ad allenarsi con antidolorifici se
erano infortunate, a subire punizioni corporali se non raggiungevano i risultati
sperati. In un periodo così lungo hanno creduto non vi fossero alternative per
raggiungere il successo, ma il film trasmesso da Netflix sulla vicenda di Larry
Nassar ha all’improvviso aperto loro gli occhi. Molte si sono immedesimate in
quelle cinquecento donne, fra le quali le campionesse Aly Raisman, Simone Biles
e McKayla Maroney, che hanno accusato di stupro e molestie il medico del team
Usa, condannato poi a 175 anni di carcere per abusi sessuali reiterati ai danni
delle ginnaste. Un andazzo poi proseguito in parte anche dopo. Ne è nato uno
scandalo che travolge così la federazione britannica di ginnastica proprio come
è accaduto qualche tempo fa alla corrispettiva statunitense.
Denuncia pubblica. Le atlete hanno fatto sentire la propria voce
attraverso i canali televisivi ITV news e Sky News. Lisa Mason, oggi 38enne, ha
raccontato di quando doveva allenarsi fino a che non le fossero sanguinate le
mani, perché solo attraverso questo sacrificio estremo si poteva ambire al
gradino più alto del podio. Già campionessa dei Giochi del Commonwealth,
l’atleta ha precisato di far riferimento a fatti che risalgono anche a quando
aveva 10 anni, prima che fosse nota in tutto il mondo per aver gareggiato alle
Olimpiadi di Sydney nel 2000. Le ha fatto subito eco la giovane collega
Catherine Lyons, ora 19enne ma già ex campionessa nazionale ed europea. «Sono
stata molestata dal mio allenatore, da quando avevo 12 anni se non riuscivo
negli esercizi sapevo già che le punizioni corporali sarebbero passate da un
bastone. Se prendevo qualche etto di troppo invece ero certa di dover digiunare,
a volte anche per un’intera settimana». Un’altra atleta ha invece affermato che,
nel caso non fosse riuscita a raggiungere i risultati sperati, era inevitabile
la violenza fisica. «Spesso mi è capitato di dover subire senza reagire, solo
perché il mio allenatore doveva ribadire il mio senso di inadeguatezza. Credevo
non ci fosse altro modo per migliorare, perché tutti questi comportamenti erano
la norma».
Violenza sistemica. L’uso eccessivo degli antidolorifici per
potersi allenare e gareggiare anche se infortunate è stato un metodo che hanno
confermato molte altre ginnaste, che hanno avuto ora il coraggio di denunciare
quella che sembra una violenza diffusa, tanto da attribuire le responsabilità
direttamente alla federazione. La ginnastica inglese ha espresso forte choc per
quanto rivelato dalle atlete e con un comunicato cercherà di intervenire
prontamente sulla questione, identificando e isolando tutti i casi di violenza.
«Non possiamo tollerare comportamenti che vadano a danneggiare la salute fisica
e mentale delle nostre ginnaste», così si legge nel testo trasmesso dal board
esecutivo. «Condanniamo all’unanimità ogni comportamento abuso e faremo in modo
che casi simili non si ripresentino più». Negli Stati Uniti ci sono state
condanne e processi contro i responsabili. Per la Gran Bretagna le vittime
confidano nello stesso esito, anche attraverso le denunce deliberatamente
manifestate attraverso i media, ma al di là dei tanti anni nei quali questi
comportamenti sono stati perpetrati, appare sempre più evidente quanto fossero
diffusi, includendo anche la Gran Bretagna in una violenza sistemica, per lungo
tempo percepita nel settore come «normale».
Davide Zamberlan per “il Giornale” il 7 luglio 2020. Il leader
del partito laburista inglese, Keir Starmer, intraprenderà un corso per
contrastare i propri pregiudizi razzisti, un unconscious bias che gli
impedirebbe di capire a pieno la portata del movimento di protesta Black Lives
Matter. Ad annunciarlo è stato lo stesso Starmer su LBC Radio, durante la mezz'
ora mensile durante cui dialoga in diretta con gli spettatori. «Credo che tutti
dovrebbero intraprendere un corso simile - ha detto al co-presentatore Nick
Ferrari - non bisogna credere di essere immuni a un razzismo inconscio di cui
non ci si rende conto. Noi come partito laburista offriremo questa opportunità a
tutte le persone che lavorano con noi e io intendo dare l'esempio: farò il corso
appena sarà possibile prenotarlo». Durata? 2/3 ore. Starmer dal 4 aprile è
divenuto il nuovo leader del partito, battendo l'antagonismo dell'ala più
radicale che ha sostenuto la corbynista Rebecca Long-Bailey. Dall'insediamento
sulla plancia di comando l'azione rinnovatrice di Starmer ha portato al
cambiamento dei vertici di partito e a una marcata inversione ideologica verso
il centro. Le prime parole da neo-leader sono state per la comunità ebraica,
spesso critica verso l'inazione (nel migliore dei casi) della precedente
dirigenza nel contrasto alle spinte antisemite interne al partito. Allo scoppio
delle proteste successive alla morte di George Floyd Starmer ha tenuto un
atteggiamento criticamente favorevole al movimento BLM, attento a non apparire
appiattito su posizioni troppo benevole. È stato «completamente sbagliato» tirar
giù la statua del commerciante di schiavi Edward Colston e gettarla nel porto di
Bristol, dichiarò a inizio giugno sempre ai microfoni di LBC. Meglio seguire un
percorso condiviso e riporla poi in un museo. Sulla richiesta del movimento di
togliere i fondi alla polizia per punirla di un uso razzista del potere di stop
and search, cioè di fermo e perquisizione di una persona per strada sulla base
del solo sospetto, Starmer ha parlato di «non senso, nessuno dovrebbe dire
alcunché sul de-finanziare la polizia». Ricevendo il plauso anche di Nigel
Farage. «Il movimento Black Lives Matter o momento, se preferite a livello
internazionale è qualcosa di differente. È riflettere su qualcosa di spaventoso
che è successo in America solo poche settimane fa, riconoscendo che è un momento
che sta attraversando il mondo». L'uso ripetuto della parola «momento» è stato
letto da alcuni sostenitori BLM come un tentativo di sminuirne l'importanza.
Avrei dovuto parlare di momento decisivo, ha detto ieri Starmer, è quello che
volevo dire e sarebbe stato più chiaro. Il riferimento al corso anti pregiudizi
aiuta quindi a riposizionare la figura del leader laburista che non dimentica di
avere bisogno anche dell'ala più di sinistra per ricostruire un partito che
competa coi conservatori. E giunge proprio mentre nel Regno Unito divampa
l'ennesima polemica a sfondo razziale, protagonisti la velocista inglese Bianca
Williams, oro nella 4x100 agli Europei di Berlino 2018, e il compagno portoghese
primatista dei 400m, Ricardo dos Santos. I due, entrambi di colore, sono stati
fermati dalla polizia mentre tornavano dagli allenamenti. «Ci hanno ammanettati
e per 45 minuti hanno perquisito l'auto dove c'era mia figlia di 3 mesi», ha
dichiarato Williams che vuole denunciare la polizia. «Pattugliavamo una zona a
rischio, l'auto non si è fermata al nostro alt e i passeggeri si sono
inizialmente rifiutati di scendere» si sono difesi gli agenti. Gli esercizi di
equilibrismo di Starmer sono destinati a continuare.
Harry
imbarazza la Regina: l’impero britannico si scusi per errori del colonialismo.
Il Corriere della Sera il 7 luglio 2020. Avrà avuto un
soprassalto sul trono, la regina Elisabetta, ad ascoltare l’ultima uscita di suo
nipote, quel principe Harry traslocato in California: il duca di Sussex,
affiancato da una estatica Meghan, se l’è presa con l’impero britannico e con il
suo erede, quel Commonwealth di cui la sovrana è tuttora la guida. In un video
dalla loro residenza a Los Angeles, Harry ha affermato che è venuto il momento
per il Commonwealth di «riconoscere il passato» anche quando è «spiacevole», e
di «raddrizzare i torti». E Meghan ha aggiunto che è il momento di «fare i
conti» con gli errori di ieri. I duchi di Sussex in questo modo si mettono in
scia del movimento anti-razzista che sta scuotendo il mondo anglo-sassone e che
in Gran Bretagna ha preso la forma di una revisione critica del passato
imperiale: ma colpisce che quelle affermazioni arrivino dalle labbra di un
principe i cui antenati hanno costruito l’impero e la cui nonna, la regina,
distribuisce tuttora ogni anno onorificenze intitolate all’Ordine dell’Impero
Britannico. Harry e Meghan sono disperatamente alla ricerca di un ruolo: la
pandemia li ha colti in contropiede e li ha costretti a mettere in pausa le
progettate iniziative in campo benefico (e commerciale). Dunque cosa c’è di
meglio, per tornare sotto i riflettori, che cogliere al volo lo Zeitgeist
anti-razzista? Purtroppo però i duchi di Sussex sono tuttora membri della
famiglia reale britannica: per i quali vale la regola non scritta di non
immischiarsi in politica. Soprattutto quando si va a mettere nel mirino tutto il
proprio retaggio storico.
Lo schiaffo
di Harry e Meghan alla regina: "La Gran Bretagna faccia i conti col suo
passato".
Harry e Meghan incoraggiano la Gran Bretagna a fare i conti con
il proprio passato coloniale, un gesto che ha stupito i sudditi di Sua Maestà e
la corte inglese. Francesca Rossi, Lunedì 06/07/2020 su Il Giornale.
Harry e Meghan volevano una vita libera e indipendente dai doveri di corte e
sono stati accontentati. Pur tra mille polemiche, scontri familiari e presunte
faide che avrebbero diviso in fazioni i Windsor, i duchi di Sussex sono riusciti
a spuntarla. Nessuno, però, avrebbe mai immaginato che questa ricerca della
libertà si trasformasse in un voltafaccia, anzi, qualcosa di fin troppo vicino a
un tradimento. Come riporta la CNN Harry e Meghan hanno tenuto un discorso
durante la sessione del Queen’s Commonwealth Trust che si è tenuta lo scorso
mercoledì 1° luglio. Durante l’intervento il principe Harry ha detto delle
parole con un peso politico ben preciso. Il duca, infatti, ha dichiarato che la
Gran Bretagna dovrebbe “fare i conti” con il suo passato coloniale. Già
questo concetto da solo potrebbe aver fatto sobbalzare la regina Elisabetta.
Harry, però, non si è fermato qui, puntualizzando che il suo Paese di nascita
avrebbe il dovere di riconoscere i “torti” perpetrati ai danni delle nazioni che
oggi compongono il Commonwealth. Se le parole fossero pugnali o proiettili,
Harry e Meghan avrebbero già eliminato tutta la corte e, forse, una buona parte
dei cittadini britannici. Il duca di Sussex ha proseguito affermando con
decisione che il popolo inglese dovrebbe “riconoscere il passato”, anche quando
si tratta di una resa dei conti dolorosa, che si preferirebbe ignorare. Harry ha
aggiunto: “Guardando il Commonwealth non c’è modo di andare avanti se non
riconosciamo il passato. Così tante persone hanno fatto un lavoro incredibile
nel riconoscere il passato e nel cercare di correggere quei torti, ma penso che
tutti riconosciamo che ci sia ancora molto da fare”. Il Commonwealth è composto
da 54 nazioni e quasi tutte hanno fatto parte dell’ex impero britannico. Si
tratta di una pagina di Storia ancora oggi molto discussa (pensiamo soltanto al
caso del dominio e della spartizione dell’India). C’è un’ampia bibliografia in
merito, ma rimane un tema spigoloso, poiché da questo impero sono nate molte
delle moderne nazioni, ma anche diversi, gravi problemi politici e militari che
sembrano irrisolvibili a tutt’oggi. Questioni diplomatiche intricate che si
trascinano da decenni e su cui gli esperti ancora si arrovellano. Harry e Meghan
sono andati a toccare un punto dolente e controverso della storia inglese,
qualcosa di cui perfino la regina Elisabetta evita di parlare in pubblico. I
Sussex si sono presi una libertà inconcepibile fino a pochi mesi fa, quando
ancora vivevano a Londra ed erano altezze reali. Nessuno avrebbe mai pensato che
i duchi si spingessero fino a questo punto, soprattutto Harry, il quale ha
anche detto: “Ci sentiremo un po’ in imbarazzo, perché è solo accettando
quell’imbarazzo che potremo superarlo e trovare tutti il modo di trarre
beneficio da ciò. L’uguaglianza…ci mette tutti sullo stesso piano, che è un
diritto fondamentale dell’uomo”. Può sembrare strano che un simile discorso
arrivi proprio dal principe Harry, cresciuto in quella stessa corte inglese che
ha governato l’antico impero. A tal proposito il duca ha ammesso: “Non possiamo
negare o ignorare il fatto che tutti noi siamo stati educati a vedere il mondo
in modi diversi. Comunque, una volta che inizi a realizzare che c’è un
pregiudizio, allora hai bisogno di prenderne atto, di lavorare per diventare più
consapevole…in questa maniera puoi dare un aiuto affinché ci si ribelli contro
qualcosa di sbagliato, che non dovrebbe essere accettabile nella nostra società
oggi”. In quest’ultima frase cogliamo il riferimento al movimento Black Lives
Matter e alle proteste di queste settimane contro il razzismo. Anche il discorso
di Meghan Markle contro la discriminazione razziale è stato molto forte e
deciso. La duchessa ha invitato il pubblico a comprendere il potere dell’odio,
che può manifestarsi anche nell’acquiescenza. Ribadiamolo. Harry e Meghan non
avrebbero mai potuto pronunciare neanche la metà del loro intervento, se fossero
rimasti sotto l’ala protettrice della regina Elisabetta. Forse con
questo discorso Harry ha voluto rinnegare la famiglia d’origine, la royal
family in cui è nato o cresciuto? Molti iniziano a pensare che questa
possibilità non sia poi così remota. Possiamo davvero parlare di una specie di
rivalsa contro la regina Elisabetta, di una ribellione a uno stile di vita e a
un pensiero imposto? Non è semplice capire se vi sia questa vendetta e quale sia
il suo limite, dove lasci posto a un’idea davvero libera di Harry e Meghan.
Coronavirus, "Una scusa per gli italiani per non fare niente": il commento
infelice di un presentatore britannico.
Lui è Christian Jessen, medico e presentatore di programmi "spazzatura". La
battuta inopportuna l'ha pronunciata premettendo che può "essere un po'
razzista". Di Maio: "Qualcuno ha confuso la pandemia con uno show". Enrico
Franceschini il 13 marzo 2020 su La Repubblica. "Il coronavirus? Una scusa
degli italiani per prolungare la loro siesta". Un commento a dir poco
vergognoso, specie davanti a 15mila malati e oltre mille morti nel nostro Paese,
quello del dottor Christian Jessen, 43enne medico britannico, scrittore e
presentatore televisivo di show stile tabloid, come "Embarassing bodies" (Corpi
imbarazzanti) e "Supersize vs Superskinny" (Supergrassi contro supermagri). Ha
anche prodotto e narrato un documentario intitolato "Cure me, I am gay"
(Curatemi, sono gay), su presunte terapie per "curare l'omosessualità". Che le
sue parole siano imbarazzanti è lui stesso ad ammetterlo, durante l'intervista
radiofonica alla rete Fubar, secondo quanto riporta il quotidiano Independent:
"Quello che dico potrebbe essere un po' razzista, e mi toccherà scusarmi, ma non
pensate che il coronavirus sia un po' una scusa? Gli italiani, sappiamo come
sono, per loro ogni scusa è buona per chiudere tutto, interrompere il lavoro e
fare una lunga siesta". Usa proprio il termine spagnolo, "siesta", diffuso anche
in inglese, alludendo a un prolungato riposino pomeridiano, ovvero nelle ore
lavorative. A quel punto il conduttore gli domanda se è d'accordo con la
decisione di Boris Johnson di ritardare la chiusura delle scuole. "Concordo in
pieno", risponde il dottor Jessen. "Penso che sia un'epidemia vissuta più sulla
stampa che nella realtà. In fondo anche l'influenza uccide migliaia di persone
ogni anno". Il che è vero: le vittime della normale influenza sono circa 8mila
l'anno soltanto in Gran Bretagna. Ma a parte che il coronavirus a detta di
medici e scienziati non sembra una "normale" influenza, l'intervistatore gli fa
notare che comunque già 10 persone sono morte nel Regno Unito per l'infezione
arrivata dalla Cina. "Lo so, è tragico per le persone coinvolte, ma non si
tratta di grandi numeri. Non colpisce le madri, non riguarda le donne incinte, e
nemmeno i bambini per quanto sappiamo, perciò perché questo panico di massa?
Diciamo la verità, è solo un brutto raffreddore. Non è una vera epidemia, o
meglio, ovviamente lo è, ma ci preoccupiamo troppo. Beh, spero di non dovermi
rimangiare queste parole!" Laureato in medicina al prestigioso University
College London, il dottor Jessen ha una specializzazione proprio alla London
School of Hygiene & Tropical Medicine, la facoltà che studia i nuovi virus.
Esercita tuttora la professione di medico presso una clinica privata di Harley
Street a Londra, anche se il suo principale mestiere è diventato fare la star
delle tivù sensazionale. Questa sera è arrivata, sulla sua pagina Facebook, la
reazione del ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio: “Qualcuno ha confuso
il coronavirus per uno show. E personalmente provo imbarazzo per queste persone.
Dopo l’insulto alla pizza italiana (su cui poi sono arrivate le scuse della tv
francese), ora arriva l’ultimo dei conduttori televisivi, tale Christian Jessen,
inglese, già noto per i suoi programmi di grande approfondimento culturale come
“Malattie imbarazzanti”... Questo straordinario statista, in merito
all’emergenza che stiamo vivendo, ha detto che 'gli italiani usano delle scuse
per chiudere tutto e smettere di lavorare per un po’, per avere una lunga
siesta'. Io non lo commento nemmeno. E stavolta, sono sincero, non ci servono
nemmeno le scuse, ancor meno le sue. È un piccolo uomo, lasciamolo alle sue
farneticazioni e guardiamo avanti. Con dignità, come abbiamo sempre fatto”.
Da leggo.it il 23 gennaio 2020. Sì definitivo del Parlamento
britannico alla Brexit. Il Parlamento ha chiuso oggi l'iter per la ratifica
della legge attuativa dell'accordo sull'uscita dall'Ue, aprendo definitivamente
la via alla Brexit alla scadenza del 31 gennaio. La Camera dei Lord ha
rinunciato infatti in serata a riproporre i suoi 5 emendamenti al testo,
sgraditi al governo Johnson, che la Camera elettiva dei Comuni aveva in
precedenza cancellato. Ora perché la legge entri in vigore manca solo l'atto
dovuto della firma della regina (Royal Assent). Poi è attesa la scontata
ratifica dell'Europarlamento. La firma della regina è attesa per domani e
segnerà la fine di un dibattito durato circa tre anni, fra accese divisioni sia
all'interno del palazzo di Westminster sia in seno al Paese. Un dibattito
attraversato da scontri aspri, dal cambiamento di governi nel Regno Unito, dal
passaggio di consegne in casa Tory fra la premiership di Theresa May e quella di
Boris Johnson e da due successive elezioni politiche anticipate - nel 2017 e nel
dicembre scorso - dopo il risultato favorevole alla Brexit del referendum del
giugno 2016. L'epilogo era ormai scontato sulla scia del successo conservatore
alle urne del mese scorso, conquistato da Johnson all'insegna dello slogan «Get
Brexit done» («Portiamo a compimento la Brexit»), che ha garantito al primo
ministro in carica il sostegno di una larga maggioranza ai Comuni. «Siamo al
termine di un lungo cammino, un risultato che qualcuno di noi aveva pensato non
sarebbe mai arrivato», ha commentato con sollievo dopo l'atto finale della
Camera alta lord Martin Callanan, viceministro per la Brexit. Il quale ha
tuttavia cercato di rassicurare anche le opposizioni e le voci contrarie
all'uscita dall'Ue: garantendo che il Parlamento avrà ampio spazio per
«scrutinare i temi discussi» nell'ambito della legge quadro appena approvata (EU
Withdrawal Agreement Bill) nei prossimi passaggi normativi riguardanti i
molteplici e complessi aspetti del divorzio dall'Ue e del dopo Brexit nel Regno.
Cristina
Marconi per “il Messaggero” il 24 gennaio 2020. La Brexit è legge. Con l'assenso
reale dato ieri da Elisabetta II al cosiddetto accordo di revoca, il cui iter
parlamentare è dovuto passare attraverso due primi ministri e due elezioni per
arrivare a un esito felice, non ci sono più ostacoli per l'uscita del Regno
Unito dall'Unione europea il 31 gennaio prossimo alle 11 di sera. Mancano solo
la firma del premier Boris Johnson e la ratifica del Parlamento europeo, che si
riunirà il 29 di questo mese. A tre anni e mezzo dal referendum del 23 giugno
del 2016, la Brexit «ha superato il traguardo», aveva dichiarato il premier
qualche giorno fa, anche se da parte dello Scottish National Party sono arrivati
messaggi poco concilianti: «Siamo nella situazione senza precedenti in cui il
governo di Edimburgo, quello di Belfast e quello di Cardiff non hanno dato il
loro consenso», ha spiegato Ian Blackford, capogruppo degli indipendentisti
scozzesi a Westminster, aggiungendo che questo «contravviene pienamente al
sistema di devoluzione» e che «ci troviamo oggi con un parlamento ignorato»,
visto che la Scozia ha votato remain al referendum. Ma per vedere in atto tutti
i cambiamenti profondi e inevitabili dovuti a questo storico passaggio bisognerà
aspettare la fine del 2020, quando terminerà il periodo di transizione che il
governo aveva negoziato per aiutare imprese e cittadini ad adeguarsi alle nuove
regole. E soprattutto per portare a termine le trattative con l'Unione europea
sulle relazioni future, che Downing Street spera essere un accordo di libero
scambio e che invece Bruxelles immagina come qualcosa di molto più limitato e
rudimentale, a meno che non venga chiesta una nuova estensione per lasciare il
tempo di studiare soluzioni più articolate. Per l'anno in corso, ad ogni modo, i
viaggi continueranno a funzionare allo stesso modo, anche se dal 2021 la
Commissione Ue ha annunciato che i britannici dovranno fare domanda per un
Etias, acronimo del sistema di informazione e autorizzazione per il viaggio
europeo, simile al sistema che è stato annunciato da Londra. Sebbene ai
cittadini europei residenti nel Regno Unito siano state offerte varie
rassicurazioni e la promessa che con il sistema di registrazione per il settled
status, il permesso di residenza, i loro diritti rimarranno gli stessi, per chi
arriverà dopo la Brexit verranno applicate le regole della legge
sull'immigrazione che il governo di Boris Johnson deve ancora mettere a punto ma
che, almeno stando alle promesse della campagna elettorale, dovrebbe seguire il
modello australiano «a punti», con tre tipi di visti. Il premier sembrerebbe
aver abbandonato l'idea di imporre un reddito minimo a quota 30mila sterline,
ossia circa 35mila euro, per chi vuole stabilirsi nel paese, andando contro la
volontà dei falchi del partito che ritengono che senza dei criteri precisi si
rischia di non tagliare l'immigrazione in modo sufficiente. Intanto, mentre il
paese si prepara a liberarsi almeno ufficialmente di tutto ciò che è retaggio
europeo, tutto è pronto per i festeggiamenti per la sera del 31 gennaio, Brexit
day, tra chi promette fuochi d'artificio visibili dalla Francia e una serie di
eventi organizzati dal governo dopo che Johnson non è riuscito a raccogliere le
500mila sterline necessarie per far rivivere i sonori rintocchi del Big Ben,
attualmente in riparazione e quindi chiuso, per segnare il momento storico. Gli
toccherà accontentarsi di un discorso alla nazione, di un gioco di luci con
tanto di conto alla rovescia da proiettare su Downing Street e di una moneta
commemorativa.
Matteo
Castellucci per “Libero quotidiano” il 24 gennaio 2020. «Andate a cercare
fortuna altrove». Suona così la stretta sull' immigrazione impressa dal governo
conservatore: dopo la Brexit, fra i criteri per stabilirsi nel Regno Unito ce ne
sarà uno salariale, anche se sulle cifre - costate all' esecutivo precedente,
guidato da Theresa May, risse intestine - i Tories non si sono ancora
compattati. A fine mese, la Gran Bretagna sarà una volta per tutte fuori dall'
Unione Europea. Fine della libertà di movimento. Tornerà sovrana delle
frontiere, con l' intenzione di renderle meno permeabili del passato. Esibire il
passaporto, please. E non si torna indietro: l' accordo per il divorzio
negoziato da Boris Johnson è ufficialmente legge, oltremanica, dove ha incassato
anche «l' assenso reale» di Elisabetta II. La settimana prossima tocca all'
Europarlamento votarlo, poi sipario. Concluso l' anno di transizione, Downing
Street varerà un piano ispirato al modello australiano per gestire,
contraendoli, i flussi migratori. Il sistema sarà a punti: ogni persona riceverà
una specie di pagella, dalla quale dipenderà l' ingresso o il rifiuto. Fra i
criteri di valutazione, spiccheranno le abilità professionali, l' esperienza
lavorativa, la capacità di parlare l' inglese e, non secondario, se si sarebbe
disposti a trasferirsi in aree dove c' è mancanza di manodopera, indirizzando,
di fatto, su binari forzati la scelta di dove stabilirsi. I conservatori
caldeggiano una linea dura, che si attesta su una ghigliottina patrimoniale in
entrata, vale a dire un salario minimo di 30 mila sterline annuali. La May si
era impuntata su questa soglia, indebolendo un gabinetto già azzoppato. Se
restasse operativa, gli europei sarebbero accomunati al resto del mondo, senza
trattamenti di riguardo, in barba alla contiguità geografica e a mezzo secolo di
alleanze politiche. Una decimazione: il 76% di chi è già in Inghilterra guadagna
di meno, riporta il Financial Times. Per leggere il dato in prospettiva, nel
2018 lo stipendio medio britannico ha superato di poco il limite: 35mila
sterline all' anno per mansioni a tempo pieno. Ma è un calderone dentro cui
ricadono carriere e condizioni di vita agli antipodi. Nelle tabelle dell' Office
for National Statistics, si incontrano medici che guadagnano 41mila sterline e
avvocati da 63mila, ingegneri da 48mila e direttori del marketing quasi a
100mila, però si tratta di posizioni apicali. Un grafico si ferma a 27mila,
mentre pure una figura in voga come un web designer ne prende 32mila. L' isola
è, o era, meritocratica, ma la maggior parte di chi sbarca - italiani in testa,
più di mezzo milione, in totale, secondo le stime - non è così fortunato da
cominciare al top, almeno in termini retributivi. C' è la gavetta. Una grossa
fetta di gente non ha curriculum blindati, è qui per un nuovo inizio. Non è
forza lavoro qualificata, stando all' incasellamento burocratico. Ed è su di
loro, gli espatriati per sbancare il lunario, che si abbatterà la scure. Un
barista riceve 15mila sterline per 12 mesi di servizio, esattamente come
barbieri e camerieri; cuochi e commessi arrivano fino a 21mila, comunque più di
chi presidia la reception (17mila). Se non puoi certificare un reddito da libero
professionista, meglio se ti presenti come turista. tornano i visti Il dominus
del partito, forte del trionfo alle urne, resta Boris. In Parlamento ha una
maggioranza secca di 80 voti: può far passare ciò che vuole, ammesso si decida.
La frangia più radicale di euroscettici è ancora una sacca di potere interna con
cui fare i conti. Dovrà far digerire a loro eventuali correzioni di rotta se,
come lo ritiene in procinto di fare il Times, volesse ammorbidire il muro
pecuniario. «L' elettorato, inclusi coloro che di solito non ci votano, si
aspetta che il primo ministro mantenga la sua parola sulla riduzione dell'
immigrazione - ha scandito Alp Mehmet, a guida del Migration Watch UK, voce
pro-Brexit -, ma un sistema australiano di per sé non è una bacchetta magica.
Dobbiamo impedire che i numeri ci sfuggano di mano di nuovo, altrimenti la
nostra credibilità crollerebbe». Si prospetta un ritorno ai visti, salvo per i
settori chiave che imploderebbero senza gli stranieri. Su tutti, sanità,
ristorazione e alberghi. Sono settimane arroventate. Westminster ha costretto il
governo, sconfitto in aula questo lunedì, a conferire una prova fisica, e non
digitale, del diritto di residenza per chi già lavora nel Regno Unito. In
campagna elettorale, Boris era stato risoluto: gli europei non potranno più
trattarci come «fossimo la loro nazione», dal welfare ai sussidi pubblici. Oggi
oltre tre milioni i cittadini comunitari sono anche sudditi di Sua Maestà e
questo clima contribuisce, in anticipo, a non farli più sentire a casa loro.
(ANSA il 23 gennaio 2020) - Brutta tegola e nomina alla Camera
dei Lord sempre più a rischio per John Bercow, l'ex speaker della Camera dei
Comuni britannica divenuto celebre per i suoi richiami in aula al grido di
'order, order!'. Contro di lui è stata infatti depositata nelle ultime ore una
denuncia formale di fronte alla commissione parlamentare per gli standard etici
per presunti atteggiamenti di bullismo contro lo staff risalenti ai suoi 10 anni
di presidenza dell'assemblea elettiva. La denuncia, riferisce la Bbc, è firmata
niente meno che da Robert Rogers, ex alto funzionario parlamentare e Clerk of
the House (qualcosa come segretario generale dei Comuni) fra il 2011 e il 2014.
I contenuti delle accuse di Rogers, dimessosi poco più di 5 anni fa e nominato
membro della camera alta dal governo Cameron con il titolo di Lord Lisvane, non
sono al momento noti; ma per la Bbc al centro della questione c'è proprio il
bullismo. Un sospetto avanzato a più riprese da semplici dipendenti del
Parlamento verso Bercow, e sempre negati dall'interessato. Ma che ora potrebbe
essere corroborato a un altro livello. John Bercow ha replicato definendo
"curiosa la tempistica" dell'iniziativa, visto che Lord Lisvane avrebbe potuto
denunciarlo da anni "e finora non lo aveva mai fatto". Una tempistica che
secondo lui e i suoi sostenitori si lega probabilmente all'ipotesi di una nomina
imminente per un seggio alla Camera dei Lord: omaggio riservato di prassi agli
ex speaker dei Comuni, non di diritto, e che il governo conservatore di Boris
Johnson questa volta non sembrava voler concedere sullo sfondo delle accuse di
parzialità anti-Brexit rivolte negli ultimi anni a Bercow da molti colleghi del
suo partito di origine; ma che secondo indiscrezioni insistenti si stava
comunque profilando grazie alla designazione di Mr order da parte del leader
laburista uscente Jeremy Corbyn, nella quota di candidati Lord che spetta
all'opposizione indicare.
Brexit, Europarlamento approva accordo divorzio.
(LaPresse/AP il 30 gennaio 2020) - L'Europarlamento ha approvato l'accordo di
recesso del Regno Unito dall'Unione europea. I voti favorevoli sono stati 641,
quelli contrari 49, le astensioni 13. "Vi ameremo sempre e non sarete mai
lontani". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der
Leyen, intervenendo al Parlamento europeo e facendo riferimento all'uscita del
Regno Unito dall'Unione europea.
Brexit,
fine di un matrimonio infelice. A mezzanotte a Londra inizia la sfida.
Pubblicato venerdì, 31 gennaio 2020 su Corriere.it da Luigi Ippolito,
corrispondente da Londra. Il compimento di un percorso tortuoso durato tre anni
e mezzo è arrivato. Si apre una nuova fase: tutto il 2020 sarà occupato dai
negoziati fra Regno Unito e Ue. Stasera si scioglie un matrimonio infelice
andato avanti per ben 47 anni. La Gran Bretagna lascia a mezzanotte l’Unione
europea: arriva così a compimento il mandato del referendum del giugno del 2016,
che aveva visto il 52% dei britannici votare a favore della Brexit. È stato un
percorso tortuoso e accidentato. Il voto di tre anni e mezzo fa non aveva
placato la contrapposizione tra filo e anti-europei: anzi l’aveva esacerbata.
Gli oppositori della Brexit hanno fatto di tutto per bloccarla e questo ha
portato il Parlamento e la politica britanniche alla paralisi: e alla fine lo
scontro è costato il posto a Theresa May, la premier che all’indomani del
referendum era stata incaricata di attuarlo. La situazione si è sbloccata solo
con le elezioni dello scorso dicembre, quando Boris Johnson ha ottenuto una
maggioranza schiacciante e un mandato chiaro per portare a compimento l’uscita
dalla Ue. E così è stato. La questione tuttavia non è chiusa, nonostante il
governo di Londra insista a dire che è arrivato il momento di voltare pagina.
Tutto il 2020 sarà occupato dai negoziati per definire le relazioni future tra
Gran Bretagna e Unione europea: si punta a un ambizioso trattato di libero
scambio, ma difficilmente si farà in tempo a concluderlo. E allora il rischio è
che alla fine dell’anno si materializzi una rottura drammatica e definitiva. Ma
per il governo di Boris Johnson la sfida è anche interna: dovrà riuscire a
tenere assieme il Paese, di fronte alle spinte secessioniste della Scozia
filo-europea e alle sirene della riunificazione irlandese. Alla fine, il prezzo
da pagare per la Brexit potrebbe rivelarsi molto alto.
E adesso
meglio lasciarsi con il sorriso (perché la storia non è ancora chiusa).
Pubblicato giovedì, 30 gennaio 2020 su Corriere.it da Beppe Severgnini. Dopo il
divorzio Ue e Gran Bretagna hanno 11 mesi per negoziare il loro futuro: dovremo
darci da fare per non far allargare il divario politico e psicologico tra noi e
loro. Mancano poche ore all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, dov’era
entrato il 1° gennaio 1973. Fa uno strano effetto, ma questo è il momento in cui
le emozioni vanno messe da parte, e bisogna provare a ragionare. Tutti: gli
europei del continente e gli europei dell’isola. Anzi, delle isole: perché
l’Irlanda, in questa vicenda, ha una parte non piccola. Sul voto per Brexit — 23
giugno 2016 — è stato scritto e detto molto, forse troppo. È sembrata una scelta
impulsiva, una miscela di presunzione, fastidio e nostalgia, condita di cattiva
informazione. Ma la democrazia non esclude i sentimenti: quel voto va
rispettato. Sono seguiti tre anni e mezzo surreali, conditi di negoziati,
ripicche, incomprensioni, elezioni, dimissioni e imboscate parlamentari: una
prova d’inefficienza che ha stupito, deluso e imbarazzato gli stessi inglesi. Il
12 dicembre 2019, il voto che ha confermato al governo il conservatore Boris
Johnson, che di Brexit aveva fatto una bandiera. L’impressione è che gli
elettori non ne potessero più, e volessero chiudere in fretta questa storia. Ma
la storia è chiusa? Non ancora, anche se due date rappresentano altrettante
pietre miliari. Quella di oggi, 31 gennaio 2020: il Regno Unito esce dall’Unione
Europea, secondo quanto stabilito dall’art. 50 del Trattato istitutivo. La
seconda data è 31 dicembre 2020, quando finirà il periodo di transizione,
durante il quale Uk e Ue dovranno trovare un nuovo accordo, che ne regolerà i
rapporti in ogni settore (dalle dogane ai trasporti, dall’immigrazione ai
diritti dei lavoratori, dalla finanza alla sicurezza, dall’industria alla
pesca). Boris Johnson non vuole proroghe, e ha fatto approvare dalla Camera dei
Comuni una legge che le vieta. Pur di chiudere, ha lasciato l’Irlanda del Nord
nel mercato unico europeo: non è poco. Non si capisce, però, come undici mesi
siano sufficienti per un negoziato tanto vasto e complesso: il Comprehensive
Economic and Trade Agreement (Ceta) tra Ue e Canada, che ha eliminato il 98%
delle tariffe, ha richiesto sette anni di negoziati. In caso di mancato accordo
(no deal), i rapporti tra Uk e Ue verranno regolati dalle regole
dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (Wto). Questo significa: tariffe,
quote, costi e un incubo logistico. Pensate ai commerci: oggi il Regno Unito
esporta nell’Unione Europea servizi per 30 miliardi di euro, ma importa beni per
100 miliardi. I porti di Dover e Calais, e tutti gli aeroporti britannici,
diventerebbero un girone infernale. Ma non si dovrà lavorare soltanto sulle
regole. Gli umori e gli atteggiamenti sono altrettanto importanti. In questa
giornata storica — per una volta, l’aggettivo non è retorico — dobbiamo
chiederci: il divario politico e psicologico tra il Regno Unito e il resto
d’Europa è destinato ad allargarsi? Nell’eventualità di una crepa sul muro,
applichiamo un pezzetto di vetro: se si spezza, iniziamo a preoccuparci. Nel
caso di Brexit dovremo usare altri indicatori. Per esempio, osservare il
linguaggio. Sarà interessante capire quanto verrà usata in Gran Bretagna
l’espressione «the Europeans» per indicare i cittadini dell’Unione Europea.
Nessun referendum, infatti, può cambiare la geografia e la storia. I britannici
escono da un’organizzazione internazionale, non da un luogo dove sono da secoli
protagonisti. Erano, sono e resteranno europei. Speriamo se ne rendano conto.
Anche noi europei del continente, e gli irlandesi, abbiamo compiti e
responsabilità. Dovremo evitare di condire Brexit di cattiveria: non sarebbe
utile, e non sarebbe giusto. La tentazione di punire gli inglesi esiste ed è
spiegabile: negli ultimi quattro anni, i toni e gli argomenti usati verso
l’Unione sono stati talvolta sgradevoli. Ed è probabile che nel corso del
negoziato — intenso, considerato i tempi ristretti — nasceranno nuove tensioni.
Sembra quasi certo, infatti, che il governo britannico utilizzerà la
disinvoltura bancaria e la leva fiscale per attirare investitori e capitali di
ogni provenienza (più di quanto abbia fatto finora). Questo rischia di irritare
Bruxelles e gli altri governi europei. Il periodo che precede un divorzio è
sempre il più difficile: vale per le persone e per le nazioni. Ma il divorzio,
nel caso di Brexit, ormai è avvenuto. Manteniamo la calma e, se possibile, il
sorriso: renderà la vita più facile a tutti. Gli avversari sono altrove. In Gran
Bretagna vivono, e continueranno a vivere, i nostri amici. E anche molti di noi.
Stefano Boldrini per la Gazzetta dello Sport il 31 gennaio 2020. Brexitball.
Alle 23 di stasera, orario di Londra, il Regno Unito e l' UE si separeranno dopo
47 anni. Il pallone, come la vita, continuerà a rotolare, ma non prendiamoci in
giro: l' Europa, dopo questo divorzio, non sarà più la stessa e anche nel calcio
cambierà qualcosa. Come? È questo il grande quesito, domanda che si allarga però
all' intera Brexit: finito il tempo dei proclami elettorali e delle frasi ad
effetto, nessuno, a cominciare dai grandi organismi finanziari mondiali, sa
fornire una risposta. Tutto dipenderà dagli accordi commerciali che saranno
siglati entro il 31 dicembre 2020: 11 mesi sono in teoria tanti, ma per
risolvere le mille questioni sul tappeto, rischiano di essere pochi. Lo sport,
scivolando in coda rispetto ad altre priorità, potrebbe pagare un prezzo minore.
La Premier preme per mantenere lo status quo. La Football Association ha invece
avanzato la proposta di modificare gli attuali parametri, secondo i quali nella
rosa base di 25 calciatori dei club sono consentiti 17 stranieri e 8 britannici.
Il progetto della federazione di Londra è di abbassare a 13 la prima quota e di
elevare a 12 la seconda. La FA considera la Brexit «un' opportunità per lo
sviluppo dei nostri talenti, spesso bloccati da giocatori stranieri mediocri».
Queste osservazioni sono contenute in un rapporto di 33 pagine: «Access to
Talent Discussion Desk». La Premier non ci sta ed è pronta ad affidarsi a una
consulenza legale di alto livello per imporre le sue ragioni. «Le misure
proposte dalla FA ridurranno la qualità della Premier e di conseguenza il valore
economico globale del prodotto. Se si impoverisce la Premier, s' impoverisce
tutto il calcio, comprese le serie minori. Il progetto della FA è radicale e
speculativo». Il calciomercato con la Brexit dovrebbe registrare un nuovo
scenario: meno Inghilterra, più affari in Germania, Italia, Spagna e Francia.
Sul piano fiscale, non sono attese novità: con la vittoria dei conservatori, è
scongiurata l' ipotesi di un rialzo delle tasse. A Londra è fissato nei prossimi
giorni un incontro tra le due parti e sarà un primo banco di prova per Richard
Master, neo amministratore delegato della Premier. Il governo britannico attende
una proposta entro aprile: in programma meeting «esplorativi» con l' Home Office
- il ministro dell' Interno -.La Brexit cambierà gli scenari nei settori
giovanili. Non sarà più consentito il tesseramento agli Under 18 europei. La FA
lo considera una grande vittoria per i ragazzi inglesi, ma anche qui il
rischio-retorica è fortissimo: Rashford (Manchester United), Foden (Manchester
City), Alexander-Arnold (Liverpool) non hanno avuto difficoltà ad imporsi: il
talento non ha passaporto. Da domani, i calciatori europei dovrebbero essere
equiparati a tutti quelli che, finora, sono stati considerati extracomunitari e
per i quali esiste una discriminante stabilita dai punteggi. I parametri sono
fissati dal numero di gare disputate con le nazionali e dall'«importanza
tecnica» del giocatore in questione. Con la Brexit, tana libera tutti. I club si
sarebbero già attrezzati, mandando osservatori in Sud America a caccia di
talenti. Sulla questione-punteggi, per far digerire alla Premier la proposta
delle nuove quote, 13+12, la FA sarebbe pronta ad abbassare i requisiti. Stasera
si chiude un' epoca. Klopp ha detto la sua al Guardian: «La Brexit è un errore.
La storia ha dimostrato che quando stiamo insieme possiamo risolvere i
problemi». Il calcio celebrò l' ingresso della Gran Bretagna in Europa con un'
amichevole a Wembley il 3 gennaio 1973, in campo le miste dei nuovi soci - Regno
Unito, Irlanda e Danimarca - contro i 6 fondatori del Mec - Italia, Francia,
Germania, Olanda, Belgio e Lussemburgo -. I capitani furono Bobby Charlton e
Gunther Netzer. L' Italia fu rappresentata da Zoff. Vinsero 2-0 i «nuovi».
Sembrava l' inizio di una nuova epoca, ma una dichiarazione dell' inglese Alan
Ball avrebbe meritato maggior attenzione: «L' unica cosa che mi interessa è se
l' adesione al mercato comune renderà le vacanze estive della mia famiglia più
economiche».
Caterina Belloni per “la Verità” il 31 gennaio 2020. Il conto alla rovescia per
la Brexit è iniziato davvero e stasera, alla mezzanotte europea (le 23 a Londra)
verrà anche proiettato con un riflettore sui mattoni scuri di Downing Street. Il
primo ministro Boris Johnson farà un discorso alla nazione, tutti i palazzi del
centro saranno illuminati, la bandiera inglese sventolerà sui pennoni di
Parliament Square. Ma sotto il profilo pratico, che cosa cambierà da domani.
Ecco le sette cose da ricordare per gli europei che non vogliono rinunciare a
visitare Londra.
1
Nel periodo di transizione, che durerà fino al 31 dicembre 2020, gli europei
potranno continuare a entrare in Gran Bretagna usando la carta di identità,
anche se a un certo punto questo documento verrà considerato non più accettabile
e si dovrà passare all' uso del passaporto. Nello stesso periodo, anche i
passaporti per gli animali e la patente di guida europei continueranno a essere
riconosciuti.
2
Sotto il profilo della salute, la European health insurance card, o Ehic, sarà
ancora valida durante il periodo di transizione e consentirà di ottenere un
intervento di assistenza dal servizio pubblico in caso di malattia o incidente
anche nel Regno Unito, come accade già ora. Successivamente, le regole
potrebbero cambiare, ma dipenderà da come procederanno gli accordi con i singoli
Paesi.
3
Lavorare e vivere nel Regno Unito resterà possibile senza restrizione per gli
europei nel periodo di transizione, all' interno del libero diritto di
circolazione. Dopo invece per trasferirsi a Londra ci saranno regole precise,
ancora in fase di definizione. Inizialmente si parlava di libero accesso solo
per chi avesse un lavoro con un reddito di oltre 30.000 sterline l' anno, poi
questo tetto - troppo alto - è stato eliminato. A quanto si intuisce al momento,
però, dal prossimo gennaio sarà possibile trasferirsi nel Regno solo se si ha
un' offerta di lavoro, quindi non verrà più consentito arrivare senza una
destinazione precisa e poi trovare una professione una volta in loco.
4
Un altro nodo da sciogliere riguarda le pensioni. Gli inglesi che vivono in
Europa dovrebbero continuare a percepirle come adesso, cosa che vale anche per
gli italiani in Uk, ma non si esclude che dal 2021 cambi il regime di tassazione
e a definirlo saranno gli accordi che verranno avviati da domani in poi.
5
Nel periodo transitorio, poi, il Regno Unito sarà costretto a continuare a
contribuire al bilancio dell' Unione europea, anche se non avrà più i «suoi»
parlamentari (73 andranno a casa) e il primo ministro Johnson non parteciperà
più ai meeting dei capi di governo. La Corte di Giustizia europea, però, resterà
quella di riferimento per le dispute di tipo legale.
6
L' argomento degli scambi commerciali tra Unione europea e Regno Unito diventerà
la vera questione calda. Il Dipartimento per la Brexit, creato da Theresa May
nel 2016, chiuderà oggi e da domani tutti gli incontri e le negoziazioni
verranno gestite da un comitato insediato direttamente a Downing Street. Che
dovrà valutare come gestire lo scambio di merci senza rincari, blocchi in
frontiera ed eccessive complicazioni. Fino alla fine del 2020, in realtà, non ci
saranno modifiche, ma dal primo gennaio 2021 serviranno nuovi patti sottoscritti
e approvati bilateralmente, perché il flusso delle merci tra il Vecchio
continente e l' isola non venga compromesso.
7
In termini di moneta, infine, non ci saranno variazioni, anche perché il Regno
Unito funziona in modo indipendente in questo senso già da molto prima che si
cominciasse a parlare della Brexit. La sterlina resterà la valuta in vigore, con
una sola aggiunta che sancisce il divorzio: la diffusione di una moneta da
cinquanta pence dedicata al Brexit Day con il motto «Peace, prosperity and
friendship with all nations», ovvero «Pace, prosperità e amicizia con tutte le
nazioni». Oggi ne saranno messe in circolazione tre milioni, con altri sette in
arrivo nei prossimi mesi. Per la gioia dei collezionisti.
Stefano Zurlo per “il Giornale” il 31 gennaio 2020. Pronunci la parola Brexit e
lui sospira: «Per l' Italia sarà un bel guaio». Antonio Martino, ministro degli
Esteri e poi della Difesa con Berlusconi, parlamentare per sei legislature,
scandisce le parole: «Gli inglesi bilanciavano in qualche modo l' asse (...)
(...) franco-tedesco».
Adesso?
«Ora saremo più deboli davanti allo strapotere di Berlino».
Che cosa ha spinto la Gran Bretagna ad andarsene?
«Il grande errore di questa Europa».
Quale?
«Confondere l' unità con l' uniformità».
In pratica?
«Negli Usa a nessuno viene in mente che tutte le macchine debbano avere targhe
uguali».
Ogni Stato fa come gli pare?
«Esatto. Da noi, invece, la Ue ha imposto regole comuni rigidissime. Una
follia».
Ma Londra era già fuori dall' euro e dal trattato di Maastricht. Non era
sufficiente?
«Gli inglesi hanno un'identità molto marcata e non sopportano che dei signori in
poltrona a Bruxelles decidano come devono comportarsi a casa loro».
Ma così non finisce l'Europa?
«Al contrario. L' Europa avrà un senso quando si occuperà delle tre cose
fondamentali per tenere insieme un Paese: politica estera, difesa, libertà nel
commercio interno».
Tutto il resto?
«Non è decisivo. Negli Usa, ci sono Stati che hanno la pena di morte e altri che
l' hanno bandita, Stati virtuosi e altri che hanno bilanci zoppicanti, ma
nessuno si sogna di imporre da Washington un fiscal compact».
La Gran Bretagna non aveva sulla testa i vincoli fiscali che ingabbiano
l'Italia.
«Non importa. Io credo che gli inglesi ora si sentano più liberi. E poi
attenzione a non sottovalutare il loro nazionalismo».
Più radicale di quello francese?
«Quello francese è più esibito, ostentato, gridato, ma gli inglesi dietro le
loro facce impassibili hanno convinzioni incrollabili. Ancora di più se, come è
successo, i tedeschi trattano l'Europa come una loro colonia».
Addirittura?
«Sa cosa disse un giorno mio padre Gaetano, che fu ministro degli Esteri negli
anni Cinquanta con Scelba, al leader liberale Giovanni Malagodi?».
Ce lo sveli.
«Papà gli spiegò che i tedeschi hanno molte virtù e pochi difetti, ma un paio di
volte in un secolo mettono le virtù al servizio dei difetti».
Un vero complimento.
«Un leader della sinistra tedesca, non italiana o inglese, Joschka Fischer, è
andato anche oltre: Due volte in un secolo i tedeschi hanno distrutto l' Europa,
ora si apprestano a farlo per la terza volta».
Si riferiva alla Grecia.
«Per salvare le banche tedesche e francesi, che avevano in pancia montagne di
titoli greci, hanno spolpato Atene».
Per questo servivano gli inglesi?
«Londra bilanciava l'egemonia franco tedesca. Ma la diffidenza inglese viene da
lontano».
Dalla storia e dalla geografia.
«Mio padre invitò anche gli inglesi alla conferenza di Taormina nel 1954. Si
studiava un'Europa della difesa comune che poi fu bocciata da Parigi su
pressione dei socialisti. E che infatti non si è mai fatta, perché sul punto
nessuno vuole cedere: col risultato che i Paesi europei spendono la metà degli
Usa in armamenti ma hanno una potenza militare che è forse il 10 per cento di
quella americana».
Gli inglesi?
«L'ambasciatore venne a Taormina con un' auto che lasciò me, bambino, a bocca
aperta».
In conclusione?
«Gli inglesi si sfilarono».
L'Europa è sempre stata una costruzione difficile.
«I padri fondatori capirono che il continente non era pronto per l' unità
politica e iniziarono dall' economia. Consapevoli che gli scambi commerciali
avrebbero favorito la pace. Dove non passano le merci passano le armi».
Poi?
«Purtroppo l' Europa si è avvitata in questa mania regolatoria».
Qualcun altro seguirà gli inglesi?
«La breccia è aperta. Altri potrebbero infilarsi nel varco».
Da dove ripartirà l' Europa?
«Gli americani hanno una Costituzione chiara e semplice che sta su un foglio A4,
fronte e retro».
Noi?
«Abbiamo la Carta di Lisbona, migliaia di pagine piene di farneticazioni che
nessuno ha letto. È arrivato il momento di scrivere una Costituzione dell'
Europa. Pochi articoli e un pugno di concetti per non darla vinta agli
euroscettici e attribuire finalmente un' anima a un' Unione in ritardo sulla
storia».
La lezione di Londra.
Lorenzo Vita su Inside Over il 30 gennaio 2020. Il momento della verità
(l’ennesimo – verrebbe da dire) sembra essere arrivato. Allo scoccare della
mezzanotte, il Regno Unito non farà più parte dell’Unione europea e Boris
Johnson potrà dire completato, almeno in parte, il suo piano per confermare il
divorzio tra Londra e Bruxelles. Un momento storico per il Regno Unito e per
l’Europa che dimostra che quel colpo assestato nel 2016 dalla maggioranza dei
britannici ha avuto i suoi frutti. Nonostante tutto. Nonostante l’opposizione
mediatica, il pantano imposto dall’Unione europea,i tecnicismo burocratici e una
netta opposizione da parte dell’establishment europeo. E se sarà solo il futuro
a dire se e i britannici avranno fatto la scelta giusta, quello che resta, nel
Regno Unito, è il rispetto della volontà popolare. Un dato non sempre scontato
in un’Europa solitamente poco incline nell’accettare la decisione presa dagli
elettori. Per Londra sono sicuramente momenti complessi. È chiaro che le sfide
per il Regno sono tutt’altro che semplici dal momento che Johnson non solo sta
convogliando il Paese in un futuro assolutamente aleatorio nei rapporti con
l’Europa, ma anche sul fronte interno. La Scozia ribolle, il confine con
l’Irlanda resta un nodo da sciogliere significativo. I negoziati con Bruxelles
non sono finiti e di certo qualcuno metterà i bastoni tra le ruote alla macchina
avviata da Londra. Ma in ogni caso Londra potrà farlo con la coscienza di chi ha
accettato non la volontà altrui, ma quella del popolo: e questo è già un vanto
per un governo. Step by step, come direbbero gli inglesi. Perché il percorso non
è finito e le tappe sono ancora molte. Tuttavia con l’idea che da domani il
futuro sarà libero dai vincoli europei. E anche con l’impressione di aver fatto
scattare una scintilla in molti movimenti europei che per decenni hanno creduto
di non poter ottenere alcuna modifica del proprio destino, convinti o disillusi
sul fatto che l’Unione europea sarebbe comunque stata la via maestra
dell’Europa. La lezione britannica invece dimostra il contrario. La democrazia a
volte vince e anche se non piace. E il messaggio rivolto a Bruxelles e a tutte
le cancellerie europee è che esiste un modo per uscire dal pantano. Certo: lo fa
l’unica nazione che avrebbe potuto farlo e soprattutto nel mondo più indolore.
La Gran Bretagna ha una moneta, ha avuto per più di quarant’anni un rapporto
burrascoso con l’Ue, ha una propria strategia autonoma nei confronti del mondo e
storicamente così come politicamente è sempre più rivolta verso l’Atlantico che
verso l’Europa. Anzi, se ha avuto un avversario è quasi sempre stato quel cuore
dell’Unione europea rappresentato dalla Germania e dalla Francia. Imperi nemici
prima, vertici dell’asse franco-tedesco ora. Ed è quindi chiaro che un vecchio
impero mai rassegnato a contare poco in Europa avrebbe accettato ben volentieri
la fuga da una struttura europea sempre più fragile e sempre meno incline a
rappresentare il volere di tutte le facce del continente. Londra guarda a
Oriente, parla con l’America e interagisce con l’Africa. E un’Europa con un
potere troppo forte tra Berlino e Parigi è sempre stato il suo peggiore incubo.
E uscire facendolo anche con il rispetto dell’elettorato è un segnale
importante: doppio colpo all’Europa verticistica e franco-tedesca. Politico e
d’immagine. Il colpo è arrivato. Ed è chiaro che sia doloroso per entrambe le
parti. Il governo britannico pagherà un pesante dazio per aver deciso di
abbandonare Bruxelles. Ma la Global Britain potrebbe essere un contrafforte
importante. Dall’altra parte l’Unione europea ha incassato il colpo sperando nel
Vietnam politico: ma gli effetti della Brexit non sono minimi nemmeno per l’Ue.
Vero che molti ritengono che l’Europa possa lavorare meglio proprio grazie
all’assenza di una “serpe in seno” come la Gran Bretagna. Ma è altrettanto vero
che adesso avranno un competitor dall’altra parte della Manica, un Paese che ha
fatto capire ai movimenti sovranisti di poter cambiare le sorti dell’Ue. E
soprattutto ha dato l’impressione che la decisione di un Paese (chiaramente non
il più piccolo) ha prevalso sulla forza del blocco europeista. E soprattutto che
quegli elettori “brutti, sporchi e cattivi” che hanno scelto la Brexit hanno
avuto la meglio su quelli preferiti dall’establishment.
Londra, la festa di Boris Johnson «Non è la fine, ma un nuovo
inizio». Pubblicato venerdì, 31 gennaio 2020
su Corriere.it da Luigi Ippolito. Londra È andata. Ieri sera noi italiani,
francesi, spagnoli, ecc. di Gran Bretagna siamo andati a dormire in Europa e
stamattina ci siamo svegliati da un’altra parte. Londra ha lasciato la Ue, si è
aperto un capitolo nuovo nella storia delle isole britanniche ma anche del
Continente. Gli ultimi 60 minuti in Europa sono stati scanditi da un orologio
luminoso proiettato su Downing Street, la residenza del primo ministro:
all’interno, Boris Johnson e i suoi ministri brindavano con spumante inglese
accompagnato dal tradizionalissimo roast beef e Yorkshire pudding. Ma fuori
c’era anche chi piangeva, come i sostenitori della Ue che hanno sfilato nel
centro di Londra con le bandiere azzurro-stellate e le candele come a una veglia
funebre. Davanti al Parlamento, invece, i promotori della Brexit festeggiavano
chiassosi assieme a Nigel Farage, che è stato visto cominciare a tracannare
birra fin dalle 3 del pomeriggio. «L’alba di una nuova era», l’ha salutata il
primo ministro Boris Johnson nel discorso trasmesso in tv poco prima che
scoccasse l’ora fatidica (la mezzanotte in Italia, le 23 Oltremanica). Un
discorso che non ha cercato la celebrazione di una vittoria — per quanto
perseguita fino allo spasimo — ma ha puntato a guardare alle sfide del futuro:
«Non la fine, ma un inizio». Partendo proprio dal riconoscimento che la Brexit
ha causato divisioni profonde nella società britannica: «Per molti questo è un
momento di speranza, ma ci sono tanti che provano un senso di ansia e di
perdita», ha ammesso Johnson. E dunque il suo obiettivo dichiarato è riunire il
Paese e andare oltre. on tutto dell’Europa è da buttare a mare: Johnson ne ha
riconosciuto la «forza» e le «ammirevoli qualità». Ma il problema è che la Ue
«si è evoluta in una direzione che non va più bene al nostro Paese». Nonostante
ciò, «vogliamo che questo sia l’inizio di una nuova era di cooperazione
amichevole fra la Ue e una energica Gran Bretagna, una Gran Bretagna che è
simultaneamente una grande potenza europea ma veramente globale nel suo raggio e
nelle sue ambizioni». Belle parole, belle speranze. Ma forse il senso di tutto
lo dava la copertina dell’Economist di ieri mattina, col il transatlantico
britannico che salpa sotto il titolo: «Verso l’ignoto».
Il giorno della Brexit. Londra non è più nella Ue. Dodici
rintocchi per l'addio: "Era ora". Antonella Guerrero
il 31 gennaio 2020 su La Repubblica. Jane, nome di fantasia "perché le mie
figlie non devono sapere che sono qui", ha 81 anni e una storia straordinaria:
ex impiegata statale, si è trasferita da anni a Londra dal suo Lincolnshire, e
per 18 mesi quasi ogni giorno è venuta a protestare a Westminster "contro questo
schifo di Parlamento" e per l'agognata Brexit. Che, dalle 23 di ieri, tra lazzi
e cori da stadio, è finalmente realtà. "Era ora", racconta, "per un anno e mezzo
ho detto ogni bugia alle mie gemelle per venire qui a invocare la Brexit". Ma
perché? "Perché sono entrambe per la Ue, una ha lavorato persino per il deputato
europeo Bill Newton Dunn, non voglio sfasciare la famiglia. Non sanno che sono
una brexiter. Mio padre venne ucciso a Dunkirk durante la Seconda guerra
mondiale: morì annegato perché non sapeva nuotare. Io non avevo neppure un anno.
Da quel momento non l'ho più perdonata agli europei". A pochi metri da Jane, c'è
la statua di Winston Churchill, colui che trascinò il destino del Regno Unito
fuori da Dunkirk e dall'"ora più buia". Pian piano, qui a Parliament Square, di
fronte a Westminster, arriva il "popolo sovrano", come lo accarezza ogni volta
il premier Boris Johnson che non a caso ieri ha tenuto il Consiglio dei ministri
nella brexiter ed operaia Sunderland. Molti sono "forgotten men", "i
dimenticati" anti Ue che hanno fatto trionfare il premier alle ultime elezioni,
venuti dalla periferia del Regno Unito in una Londra liberal e multicolor. Loro
no: sono quasi tutti bianchi. È la loro festa, è il 31 gennaio 2020, è il Brexit
Day. Anche se piove e si affonda nel fango di Parliament Square, "who fucking
cares?", che ci frega. Si balla, tra gli oltre 10mila accorsi, nell'esaltazione
tricolore della "Union Jack", inzaccherati dal fango e dall'alcol degli
stracolmi pub intorno, al trapanante ritmo tribale dei campanacci scossi da due
omoni sudati nel freddo: "È il nostro Little Ben!", si sbellicano. Perché il
vicino Big Ben è in ristrutturazione e sarebbe costato 500mila sterline farlo
rintoccare come volevano i brexiter. Uno dei due ha la maglia "FCUK EU",
"fanculo all'Ue", con la "u" e la "k" saggiamente invertite, e si batte il pugno
sulla Croce di San Giorgio, il rosso e il bianco del nazionalismo inglese che ha
imposto la Brexit. Sono gli stessi colori del costume medievale dell'eurofobico
Jeff Wyatt, che non è soddisfatto nemmeno della Brexit di Johnson: "È una
farsa!". Un altro brucia invece una bandiera europea. Sono casi isolati perché
questo sabba anti Ue, questo esorcismo collettivo contro Bruxelles, non ha altri
incidenti. Tre, due, uno... il capodanno di una nuova era, il conto alla
rovescia rosso, bianco e blu viene proiettato persino sulla porta di Downing St
n.10. Allo scoccare delle 23 il profeta euroscettico Nigel Farage ruggisce
"finalmente dopo 47 anni siamo indipendenti dall'Ue! Evviva!", mentre decollano
le gloriose note di "Dio Salvi la Regina", con un velo di tristezza degno del
finale del "Cacciatore". "L'Ue è morta!", esulta un giovane. Una ragazza: "We
are the Champions! Happy Brexit!". È la mezzanotte di fuoco, anzi "l'alba di una
nuova era", come ha detto nel suo discorso il premier Johnson, "un incredibile
momento di speranza e opportunità per ogni angolo del Regno Unito. Un inizio e
non una fine. La ripresa del controllo dell'immigrazione. Ci saranno
contraccolpi", avverte Boris, "ma sarà un successo. Abbiamo obbedito al popolo.
Ora il nostro Paese tornerà unito". Chissà. Gli europeisti intanto fuggono da
Parliament Square. Qualcuno manifesta a Europe House, sede dell'Ue a Londra,
poco dietro Westminster. Altri, come l'associazione "The 3 million", si
riuniscono in una birreria tedesca, nella City, per dei "commiseration drinks".
Il sindaco di Londra Sadiq Khan apre invece le porte del municipio agli europei,
perché "comunque saremo sempre una città aperta". Oxford organizza veglie
funebri, a Edimburgo scendono in strada gli indipendentisti, europeisti,
scozzesi. "Hey EU", sussurrano parafrasando i Beatles, "see EU", ci vediamo
Unione Europea! O forse a mai più? Alla fine, quel referendum, quel sogno di una
notte di mezza estate 2016, è diventato realtà. O incubo? Lo sapremo tra molti
mesi, perché fino a fine anno Albione rimarrà ancorata alle norme Ue per il
periodo di transizione e i negoziati tra Europa e Uk, cruciali per il futuro di
tutto l'Occidente. Perché questo è uno scisma inappellabile, epocale, come
quello di Enrico VIII nel 1532, la prima grande Brexit di un Regno sempre più
insulare. Da oggi, sarà un lungo addio. O, per rimanere nel crepuscolo creativo
di Chandler, un grande sonno?
Brexit, l'addio del Regno Unito all'Europa. Johnson: "È il
momento di cambiare". A Londra scendono in piazza
brexiter e nostalgici europeisti. La Gran Bretagna celebra lo storico giorno con
party, manifestazioni e proteste. Katia Riccardi il 31 gennaio 2020 su La
Repubblica. A mezzanotte, come nelle favole, svaniscono stelline d'oro e vestito
azzurro. L'isola alza orli e confini, si stacca da un abbraccio in cui si
sentiva troppo stretta. Chiusa e protetta dal mare intorno, esce dall'Europa
senza inchino. "L'Unione europea si è evoluta in una direzione che non andava
bene", dice il premier britannico Boris Johnson. Lascia uno spiraglio troppo
lieve: "Inizia un'era di amicizia e cooperazione con Ue". Nonostante tutto
"abbiamo obbedito al popolo". Il momento di cambiare "è arrivato". Allo scoccare
delle lancette aggiunge, "sorge l'alba e la tenda si alza su un nuovo atto della
nostra grande storia nazionale". Quaranta mesi di negoziati e tre proroghe, un
travaglio politico che dal referendum del 2016 ha 'bruciato' due primi ministri
come David Cameron e Theresa May, e ha diviso la società britannica, in questa
notte che cambia la storia il Regno Unito indossa gli abiti di uno Stato terzo,
ed esce dall'Ue dopo 47 anni. L'union Jack è stato già rimosso dalle sedi del
Consiglio europeo. I 28 sono diventati 27. Le bandiere britanniche devono essere
rimosse anche dalle tre sedi del Parlamento, a Bruxelles, Lussemburgo e
Strasburgo. Una sarà consegnata alla Casa della Storia Europea, un museo nato su
iniziativa dell'Aula, a Bruxelles. Fuori da palazzo Berlaymont, sede della
Commissione Europea, invece, sventolano solamente bandiere dell'Ue. "Una notte
storica e triste. Che il risveglio porti più forza e fiducia a chi vuol bene
all'Europa", scrive su Twitter il commissario europeo all'Economia, Paolo
Gentiloni. Ora "dobbiamo proteggere le nostre imprese da eventuali accordi degli
amici inglesi con Paesi terzi", aggiunge il premier italiano Giuseppe Conte.
L'uscita dall'unione per mesi è stata una danza sgraziata fatta di discussioni e
giravolte. Nelle strade di Londra stanotte c'è chi fa festa, chi resta a casa,
chi non protesta neanche più se non con giochi di parole e messaggi. Come quello
apparso nella metropolitana di Londra in mattinata, su uno dei pannelli
informativi: "Londra è aperta, oggi e sempre".
La festa in città. Di fronte a Westminster sono riuniti i
sostenitori del divorzio. Sono decine di migliaia di persone, strette e
sorridenti, sotto scrosci di pioggia. Una folla che intona a squarciagola Land
of Hope and Glory (Terra di Speranza e di Gloria), l'inno patriottico britannico
del 1902, che applaude quando Johnson parla, proiettato sul grande schermo. È
"un momento incredibile", urla arrossato Nigel Farage, leader del Brexit Party,
arringando la folla. "Per tutti questi anni - tuona esaltato - l'intero
establishment ha sostenuto la permanenza nell'Ue e siamo stati io e pochi altri,
con l'appoggio di queste migliaia di persone, semplici attivisti, a imporre la
questione Brexit sul tavolo". "Siamo stati noi - ha rivendicato - a terrorizzare
(l'ex premier conservatore) David Cameron fino a concederci il referendum" e
"siamo andati avanti fino alla vittoria". Non tutti si arrendono. I “remainers”
portano bandiere blu stellate dell'Ue e cartelli che recitano "Never in My Name"
(mai in mio nome). Giochi di parole, Eu e You: "Missing Eu already" (ci manca
già l'Ue) o "Sorry from Me to Eu". Ma quella di stasera, non è la loro festa.
La transizione. Un anno di aggiustamento, fino 31 dicembre 2020,
quando finirà il periodo di transizione salvo proroghe. Per un anno quindi non
cambierà nulla, in pratica, il Regno sarà trattato come uno Stato membro (con
alcune eccezioni), ma non avrà alcun diritto di intervento nel processo
decisionale Ue e alcun diritto di rappresentanza.
Le reazioni. Un addio pesante. I maggiori leader europei, tra cui
il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il capo dell'Eliseo Emmanuel
Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel parlano di momento di svolta.
Insistono sul fatto che il Regno Unito "rimanga un partner strategico". "Quando
il sole sorgerà domani si aprirà un nuovo capitolo per l'Ue. Domani quasi mezzo
secolo si chiude", dice la presidente della Commissione europea Ursula von der
Leyen. "Il Regno Unito rimarrà un partner fondamentale" dichiara il
responsabile della politica estera e di sicurezza della Ue, Josep Borrell.
"Londrà è una citta aperta. Lo sarà sempre", twitta il sindaco della capitale
britannica, Sadiq Khan. "Il governo tedesco punta anche per il futuro sul fatto
che la Gran Bretagna rimarrà un partner stretto ed un amico", sono state le
parole del portavoce di Angela Merkel, Steffen Seibert, in conferenza stampa a
Berlino. "È un giorno emotivo. Unità, trasparenza. Rispetto: il nostro lavoro va
avanti". Così il capo negoziatore dell'Ue sulla Brexit, Michel Barnier,
su Twitter. Ma da Washington non aspettano. Subito dopo la Brexit, arriva la
promessa a Londra di rafforzare i legami bilaterali. Gli Stati Uniti
"continueranno a potenziare la forte, produttiva e prospera relazione con il
Regno Unito mentre loro iniziano questo nuovo capitolo" commenta il segretario
di Stato americano Mike Pompeo, "sono contento" la Brexit "onora la volontà del
popolo britannico".
Giorgia Pacione Di Bello per “la Verità” il 31 gennaio 2020. L'
addio del Regno Unito all' Unione europea darà non pochi problemi agli Stati
membri in termini di bilancio Ue. Se infatti per il 2020 la Gran Bretagna
continuerà a versare i suoi 16 miliardi di euro nelle casse dell' Unione, dal
2021 la situazione cambierà. Non solo si dovrà trovare un nuovo accordo politico
per il budget 2021-2027, ma si dovrà anche capire come andrà gestito il buco di
bilancio lasciato dalla Gran Bretagna. Al momento, per il 2020, il budget
stanziato è stato di 168,7 miliardi di euro. L' Italia versa circa 15-17
miliardi, il che corrisponde al 9-10% del budget Ue. La Gran Bretagna, in linea
con il nostro Paese, versa 16 miliardi (9,5%). Da ricordare che la somma totale
del budget Ue è spalmato in percentuali diverse tra i vari stati membri. L'
Italia risulta essere uno dei maggiori contributori, posizionandosi al quarto
posto. Davanti a lei solo Germania, Francia e Gran Bretagna. Ma visto che uno
dei più importanti stati contributori, la Gran Bretagna, lascerà l' Unione
europea, come saranno coperti i 16 miliardi di euro che versava l' anno? La
risposta la si trova nei 27 Stati membri rimanenti. Ma attenzione, perché la
questione non è delle più semplici. Chi subirà le maggiori conseguenze saranno
probabilmente la Germania, la Francia e l' Italia, ovvero i Paesi che
contribuiscono maggiormente al bilancio dell' Ue. Secondo lo studio The impact
of Brexit in the Eu budget, pubblicato dal Ceps policy brief, centro di ricerca
specializzato sugli affari europei, che ha fatto la sua simulazione sul budget
Ue del 2014 (più basso rispetto a quello del 2020), per coprire il gap inglese
la Germania vedrà un aumento di 2,56 miliardi di euro (+9%), la Francia di 1,47
miliardi di euro (7%) e l' Italia di 791 milioni di euro (+5,22%). Se si
considera il budget 2020 l' Italia vede questa somma alzarsi a 1,44 miliardi
euro. C' è però da dire che queste somme sono variabili e non definitive, per
due motivi. In primis bisogna capire dal punto di vista del mercato unico a
livello commerciale cosa si deciderà. E i prossimi mesi saranno fondamentali. La
Gran Bretagna potrebbe infatti decidere di entrare a far parte di alcuni
progetti Ue, dunque di mettere del budget. In questo caso il suo buco economico
diminuirebbe. Altro aspetto da non sottovalutare è un' ulteriore proroga che gli
inglesi potrebbero chiedere (31 dicembre 2020). E infine altra incognita è che
non si conosce ancora quanto ambizioso o meno vorrà essere il budget per il
2021-2027, che verrà deciso entro fine anno. Al momento la Commissione e il
Parlamento sono due strade diametralmente opposte, ma dovranno trovare un
accordo politico per dar vita alle nuove risorse da stanziare in Ue. E dunque da
una parte c' è il Parlamento europeo, che spinge per ottenere un progetto di
bilancio ambizioso. L' obiettivo è quindi ottenere un budget pari all' 1,3% del
reddito nazionale lordo dei Paesi membri (al momento siamo all' 1,16%). Il
budget stimato sarebbe dunque di 1.324 miliardi di euro. Dall' altra parte la
Commissione gioca a ribasso e spinge per un 1,11% del reddito nazionale lordo,
con previsioni di bilancio attorno ai 1.279 miliardi di euro. I singoli Stati
membri spingono ovviamente per abbassare ulteriormente la cifra per dare meno
contributi possibili all' Ue. Il 20 febbraio si terrà una riunione per cercare
di raggiungere un accordo o un primo compromesso tra le due posizioni dominanti,
ma la strada è ancora lunga. Queste percentuali, che giocano sui decimali, sono
di fondamentale importanza per gli Stati membri. Se infatti dovesse prevalere la
proposta del Parlamento europeo, e dunque si desse vita a un budget più
ambizioso, gli Stati membri non solo dovranno aumentare i loro contributi
nazionali (adeguati all' inflazione e della crescita economia nazionale) ma
dovranno pensare anche a colmare il buco di bilancio di 16 miliardi lasciati
dalla Gran Bretagna. E dunque l' Italia potrebbe arrivare a dare all' Ue più di
17 miliardi di euro, compresi il lascito inglese. Da non dimenticare che in
questa ipotesi l' Italia potrebbe ricevere anche una maggiore quota di
finanziamenti da parte dell' Unione europea (nel 2017 ne ha ricevuto 9,8
miliardi), dato che ci saranno maggiori stanziamenti a programmi Ue. Questo
potrebbe andare dunque a colmare, in minima parte, il maggior contributo che l'
Italia dovrà dare per l' uscita inglese. Nel caso invece in cui la Commissione
riesca ad avere la meglio si avrebbe un budget meno ambizioso (che significa,
per esempio, tagli a progetti) e minore risorse da parte degli stati membri. A
questo si potrebbe aggiungere anche il fatto che il gap del Regno Unito potrebbe
essere coperto in parte dalle risorse proprie dell' Ue (l' Iva, un prelievo in
percentuale sul reddito nazionale lordo degli Stati membri eccetera) e dunque
gravare in maniera inferiore sulle casse dei singoli stati membri. L' Italia
darebbe dunque sempre come il suo contributo nazionale, ma non dovrebbe
garantire anche gli 1,44 miliardi di euro per l' uscita del Regno Unito dall'
Ue.
Marco Palombi per "il Fatto quotidiano” l'1 febbraio 2020. Così
stasera, a tre anni e mezzo dal referendum, ci sarà la Brexit, anche se da ieri
- dopo aver letto i giornali - non pare essere 'sta gran cosa: pagine interne,
toni moderati Repubblica ha una pagina "Brexit. Cosa cambia". Il CorSera,
invece, ci spiega che "non sono mai stati europei" (e allora?). Il Messaggero:
"Bruxelles: addio agli inglesi, nuovi equilibri in Parlamento". Il Sole:
"Brexit, il terremoto che cambia i rapporti di forza nella Ue". La Stampa è
l'unica un po' battagliera: "Effetto Brexit: Londra vieta il suo mare alla pesca
Ue". Per carità, se vogliono metterla così va bene, ma a noi piaceva di più la
fase psichedelica: "Brexit svuota la tavola degli inglesi", "Carenza di
medicine", "Brexodus: aziende e banche in fuga", "le banche via: choc da 1.300
miliardi". Questa cosa delle banche, un classico da oltre tre anni, fu l'
occasione della mitica missione londinese Alfano-Padoan-Maroni-Sala per invitare
la "City" a spostarsi a Milano insieme all' Agenzia del farmaco (vabbè). Citiamo
su questo, per puro dovere di cronaca, un pezzo di Reuters di qualche giorno fa:
"Un migliaio di società finanziarie Ue pianificano l' apertura di una sede nel
Regno Unito dopo la Brexit". Ora, la vita è difficile, la geopolitica di più, il
destino incerto e la cazzata sempre in agguato, ma non è questo il punto. Noi
siamo stilisti e - diceva il grande Contini - "in quanto tali a-tematici": il
merito non ci interessa, solo la coerenza artistica. Quindi domani speriamo di
leggere da qualche parte il titolo: "La Gran Bretagna è affondata nell'
Atlantico".
Daniele Capezzone per “la Verità” l'1 febbraio 2020. Con l' ok
anche del Consiglio Ue, Brexit è ormai realtà. E ci vorrebbe un Requiem per i
cosiddetti «competenti» ed «esperti». Avevano detto, all' epoca del referendum
(giugno 2016) che il remain avrebbe agevolmente vinto: e invece trionfò il
leave. Più di recente, avevano pronosticato che Boris Johnson non sarebbe mai
diventato leader conservatore: è invece il più acceso sostenitore dell' uscita
del Regno Unito dall' Ue ha vinto alcuni mesi fa il leadership contest per
aggiudicarsi la guida del partito e conseguentemente è divenuto primo ministro.
Poi avevano detto che Johnson, con i suoi modi fiammeggianti, non avrebbe mai
strappato ai negoziatori di Bruxelles un' intesa più forte di quella -
striminzita e infatti rigettata dal Parlamento britannico - ottenuta dalla
debole Theresa May: e invece Johnson, minacciando la carta del no deal, cioè un'
uscita senza alcun accordo, ha smontato le trincee di Bruxelles. Poi avevano
detto che il primo ministro britannico non avrebbe mai ottenuto la convocazione
di nuove elezioni: e invece Johnson ci è riuscito e le ha pure stravinte,
conducendo in porto l' uscita dello United Kingdom dalla gabbia di Bruxelles. Un
trionfo per lui, un caso da manuale di rispetto della volontà popolare, e
insieme una débâcle per la vecchia politica e i mainstream media. Del resto, già
il 23 giugno 2016 in Italia si era capito molto. La notte televisiva del
referendum su Brexit andrà conservata e ristudiata, con tesi di laurea da
assegnare agli studenti del futuro per capire come non si fa informazione. Fino
alla mezzanotte (con il remain in vantaggio), giaculatorie di elogio alla grande
democrazia britannica; dopo la mezzanotte, essendo passato in vantaggio il
leave, insulti alla Perfida Albione, contumelie contro gli elettori anziani,
dubbi sul suffragio universale. Ed era solo l'antipasto di ciò a cui avremmo
assistito nei mesi successivi in tv e sui giornali (con poche e pregevoli
eccezioni): e cioè essenzialmente servizi ansiogeni sulla sorte degli italiani
in Inghilterra, in genere piuttosto esterrefatti nel sentirsi rivolgere domande
dagli intervistatori come se il governo di Londra stesse per programmare
espulsioni o purghe di massa. Più profezie di sciagura che è il caso di
ripercorrere. L' ufficio in Uk di Amnesty International, ancora nel settembre
scorso, si è aggiudicato la medaglia d' oro delle ipotesi di sventura,
ovviamente smentite dai fatti: «L' addio britannico pone serie preoccupazioni
per i diritti umani». Fino a paventare un' emergenza sanitaria: «Non ci devono
essere interruzioni nelle forniture di medicinali, che sono cruciali per
garantire che tutti godano del loro diritto alla salute». Non scherzarono
nemmeno diversi settori delle burocrazie britanniche. Un rapporto governativo
riservato, poi sbattuto in prima pagina dal Sunday Times, in caso di no deal
preconizzava scenari nefasti: problemi con cibo e carburante, file inenarrabili
di camion francesi, rischio di disordini. Ma le previsioni all' insegna del
terrore erano cominciate già a cavallo del referendum. Si potrebbe
maramaldeggiare sull' 81% tra sondaggisti e bookmaker inglesi che scommettevano
contro il risultato elettorale pro Brexit, e soprattutto sul 71% di economisti
britannici che promettevano, in quel caso, sciagure e recessioni. Ha avuto
onestà intellettuale, molti mesi dopo, il capo economista della Banca d'
Inghilterra, Andrew Haldane, riconoscendo un eccesso di pessimismo e di
catastrofismo nelle previsioni sue e di buona parte degli «esperti». Un report
della Bank of England si spinse a preconizzare un calo del Pil dell' 8%, il
crollo della sterlina, un deprezzamento degli immobili: tutte ipotesi poi
smentite dai fatti. «Abbiamo avuto il nostro momento Michael Fish», ha
spiritosamente ammesso Haldane, alludendo al leggendario infortunio del
meteorologo della Bbc nel 1987, che aveva categoricamente escluso un uragano che
invece si verificò puntualmente. Trent' anni dopo, Fish, sentendosi chiamato in
causa, è stato anche più spiritoso di Haldane, replicando di aver fatto a suo
tempo meno danni di economisti e banchieri. Naturalmente, solo il tempo darà un
giudizio definitivo su questa scelta. Ma, a chiunque esamini la volontà dei
britannici senza pregiudizi, la loro decisione appare perfettamente razionale.
Hanno la sterlina; sono un membro permanente del Consiglio di sicurezza Onu;
sono una potenza militare anche nucleare; la loro economia va a gonfie vele (nel
recente quinquennio, hanno quasi prodotto più posti di lavoro degli altri paesi
Ue messi insieme). Ora, uscendo, saranno liberi di negoziare accordi commerciali
a 360 gradi: con gli Usa, con i Paesi legati al Commonwealth, con la stessa Ue,
con i giganti asiatici. E senza dover chiedere il permesso ai burocrati di
Bruxelles.
Ecco perché Londra ha staccato la spina all’Europa.
Lorenzo Vita su Inside Over l'1 febbraio 2020. Il Regno Unito
lascia ufficialmente l’Unione europea ed entra in una nuova era ripartendo dal
suo passato. Niente più costola atlantica dell’Europa né “serpe in seno” come
definita da molti del sistema voluto da Bruxelles. Londra esce dall’Europa e
torna a pensare se stessa come potenza in grado di gestire la propria strategia
senza essere parte in un sistema politico continentale. E la Brexit rappresenta
il primo step per una riscoperta del mondo da parte dei britannici dopo che per
qualche decennio avevano creduto (senza troppe illusioni) di poter essere anche
parte dell’Unione europea. I cittadini britannici, ma soprattutto gli strateghi
di Downing Street, non hanno mai avuto una grande percezione di se stessi come
europei. E la Brexit, che sancisce il divorzio tra Londra e Bruxelles, è solo la
presa di coscienza di un ruolo che il Regno Unito non ha mai voluto condividere
con le potenze europee. Paese votato al mare contro un blocco terrestre, Stato
indipendenti per natura contro un blocco multilaterale che ha sempre ritenuto
distante, alla ricerca dell’Atlantico e sempre meno della Manica, il Regno Unito
ha fatto una scelta difficile, pericolosa e non certo semplice consapevole che
in fondo la sua strategia è sempre stata questa: non essere parte dell’Europa ma
evitare che qualcuno prendesse il sopravvento nel Vecchio continente. Ci è
riuscita per 47 anni dentro l’Ue. Ci è riuscita adesso con la Brexit, dal
momento che il terremoto che ha colpito l’Europa ha comunque inferto un colpo
durissimo ai piani dell’asse franco-tedesco e in particolare della Germania. E
ha posto certamente una pietra tombale sulle certezze oniriche di chi ha creduto
che l’Europa potesse solo crescere ed espandersi. Una doccia gelata che vede
dall’altra parte il cambiamento del mondo. Perché quello che ha fatto la Gran
Bretagna è in realtà parte di un’evoluzione molto più grande che include tutti
gli angoli del mondo: Europa compresa. Londra non va via da un’Europa che conta,
ma da un’Unione europea sempre più debole e instabile e su cui si sono posti gli
occhi inflessibili delle superpotenze che per decenni hanno voluto mantenere lo
status quo. Oggi l’Ue non serve e gli Stati Uniti, che per molto tempo hanno
tollerato (o benedetto) l’Unione come espressione europea della Nato, oggi non
hanno più interesse a questo blocco di Stati guidato da Bruxelles ma in realtà
da Berlino e Parigi e che compete con Washington. E Donald Trump, punta di
diamante di questa strategia americana, è arrivato non a caso mentre il Regno
decideva per la Brexit. I due fenomeni non sono così distanti come sembrano. E
le due sponde dell’Atlantico hanno deciso una via sovranista ante litteram quasi
insieme, come a voler confermare che l’Atlantico avrebbe staccato la spina
all’Europa. Così è stato. E proprio a porre il sigillo su questa dinamica
atlantica, Boris Johnson ha visto da subito in Trump il suo interlocutore
privilegiato, sin dai tempi della sua carica di ministro degli Esteri. Sia
chiaro: non senza divergenze. L’ultima mossa di Londra di aprire a Huawei nel 5G
britannico è un messaggio chiarissimo nei confronti dell’alleato statunitense.
Ma è chiaro che la special relationship atlantica ne uscirà comunque rafforzata,
come confermato anche dalle parole di Mike Pompeo pochi minuti dopo lo scoccare
della mezzanotte del primo febbraio. Ma la decisione sul 5G da parte del governo
conservatore indica anche dell’altro. L’apertura verso Huawei non è soltanto
un’operazione di “rivolta” contro le decisione imposte dal Pentagono e dalla Cia
ma anche il segnale di come a Londra vogliano il dialogo con Pechino. La Cina ha
subito fatto intendere di essere particolarmente interessata al Regno
post-Brexit. Ed è chiaro che adesso Johnson guarda al gigante asiatico come un
Paese in grado di investire molto più liberamente sul territorio inglese pur con
le cautele imposte dalla relazione con Washington. In questo senso, il pericolo
che la City diventi una sorta di paradiso fiscale o che si costruisca un asse
finanziario tra Shanghai, Hong Kong e la capitale britannica preoccupa (e molto)
Francoforte. E gli investitori cinesi sanno di poter fare affari in un Paese che
ha nel commercio e nella globalizzazione il suo punto di forza. Global Britain
ripetono a Londra. Ed è questo l’obiettivo del governo che sa di avere dalla sua
gli Stati Uniti, e di poter contare sulla Cina. Non potrà certo contare sulla
Russia, di cui Londra continua a essere un rivale strategico. Ma in questo
momento al Regno Unito interessa prendere la sua posizione di forza
nell’Anglosfera, ricucendo con il Commonwealth, ribadendo ile sue linee sul
controllo dei mari, riprendendo i dossier sulle ex colonie ma senza sganciarsi
definitivamente dall’Europa, in particolare nel campo della Difesa e del
commercio, con cui il Regno Unito ha troppo interscambio per sfuggire. Una
strategia complessa ma che parte da un dato: niente ha avuto inizio soltanto con
la Brexit, ma sarà proprio l’uscita dall’Ue a segnare il cambio di passo. Non è
detto che Londra torni, ma di sicuro l’obiettivo è uno: mollare l’ancora
dell’Europa per navigare (certamente a vista) verso gli Oceani. Global Britain,
appunto.
Brexit, gli inglesi se ne vanno dall'Unione europea ma con il
malloppo in tasca. Beati loro due volte. Carlo
Nicolato su Libero Quotidiano l'1 Febbraio 2020. Nigel Farage, senza possibilità
di dubbio l' uomo che meglio rappresenta la Brexit e tra quelli che più hanno
fatto per ottenerla, sostiene che dei soldi che gli spettano dall' Europa «non
prenderà un penny». Il generoso Europarlamento calcola la buona uscita dell' ex
parlamentare moltiplicando uno stipendio mensile per il numero di anni di
permanenza, e quindi all' ex leader dell' Ukip, per vent' anni (1999) seduto di
malavoglia nell' emiciclo comunitario, dovrebbero spettare qualcosa come 178mila
euro. Due anni fa, in pieno marasma Brexit, disse che invece quei soldi li
avrebbe presi e che comunque l' Europa non glieli avrebbe mai dati, ma
evidentemente in questi due anni ha guadagnato abbastanza, lo scorso anno
360mila euro solo in consulenze, per poter farne a meno. La pattuglia - Quei
soldi invece farebbero comodo agli altri parlamentari inglesi che rimarranno a
bocca asciutta in quanto eletti da troppo poco tempo, ovvero meno di quell' anno
stabilito dalle regole parlamentari per avanzare qualsiasi pretesa. Gli ormai ex
eurodeputati inglesi, eroici 73 rimasti dopo 47 anni di avventura sul
continente, dovranno senza eccezioni restituire entro il 7 di febbraio badge di
accesso, lasciapassare Ue, schede di voto, chiavi dell' ufficio, iPad e laptop,
nonché i pass che consentono di viaggiare gratuitamente sulla rete ferroviaria
belga SNCB. Alla maggior parte di loro, cioè a tutti i nuovi, non spetta neanche
la pensione, che invece Farage intascherà a iniziare dal 2030, cioè da quando
avrà compiuto 65 anni. Seimila euro mensili cui ben difficilmente dirà di no.
Ieri è stato l' ultimo giorno di lavoro anche per tutto il personale inglese con
sede a Bruxelles che se n' è andato come previsto senza alcun festeggiamento. L'
Europa dovrà pagare loro indennità e pensioni, secondo le regole. In fin dei
conti da questo punto di vista dunque la Comunità non pagherà niente di più di
quanto non fosse già previsto e anzi avrà di che risparmiare, venendo a mancare
diversi stipendi. Non è una novità invece che il problema per l' Europa inizierà
dal prossimo anno, quando non entreranno più nelle casse quei 16 miliardi che la
Gran Bretagna versa ogni anno come quota comunitaria. Ovviamente, siccome nel
frattempo il budget europeo non è cambiato, anzi è cresciuto a 168 miliardi,
bisognerà coprire il "buco" spalmando la cifra sui rimanenti Stati. Un'
operazione che verrà fatta secondo gli stessi criteri di ricchezza e produzione
utilizzati per calcolare l' attuale quota di ciascun Paese. Tocca a noi
saldare - Alla Germania, la Francia e l' Italia, i tre membri che già pagano di
più, toccherà quindi pagare la fetta più grande. Secondo i primi calcoli il
nostro contributo che attualmente è di 16 miliardi circa, potrebbe salire di
circa 800 milioni. Qualche tempo fa Boris Johnson, prima di diventare premier,
sostenne che che l' Inghilterra avrebbe potuto anche pretendere la restituzione
di 9 miliardi di sterline (10,6 miliardi di euro) dalla Banca europea di
investimenti (Bei) e di altri 14 miliardi di sterline, in liquidità e beni
immobiliari, ma d' altra parte anche Bruxelles aveva fissato il conto per Londra
a circa 60 miliardi di euro. Tutte queste cifre sono ancora da definire con
esattezza nel corso dell' anno, il che significa che la Brexit è fatta, ma in
realtà non si sa ancora se è hard o soft. Carlo Nicolato
Brexit, Farage: Odiamo Ue, ce ne andremo e non torneremo.
(LaPresse il 30 gennaio 2020) - "Quello che accadrà il 31 gennaio 2020 a
mezzanotte segna un punto di non ritorno. Una volta che lasceremo, non torneremo
mai. Voglio che la Brexit avvii un dibattito nel resto dell'Europa. Che cosa
vogliamo dall'Europa? Se vogliamo amicizia, collaborazione, reciprocità. Non
abbiamo bisogno della Commissione europea, di una Corte europea, di queste
istituzioni e di tutto questo potere. E vi giuro: nell'Ukip e nel Brexit Party
amiamo l'Europa, semplicemente odiamo l'Unione europea. Spero che questo sia
l'inizio della fine di un cattivo progetto, non solo non democratico, ma
antidemocratico". Così l'europarlamentare britannico Nigel Farage, intervenendo
a Bruxelles in vista dell'uscita del Regno Unito dall'Unione europea. Il suo
discorso è stato interrotto quando gli è stato spento il microfono, mentre gli
eurodeputati attorno a lui sventolavano bandierine britanniche e la vice
presidente dell'Eurocamera, Mairead McGuinness, chiedeva che le bandierine
fossero ritirate. "So che volete bandire le nostre bandiere, ma sventoleremo il
nostro addio", ha detto Farage.
Bruxelles, addio agli inglesi: nuovi equilibri in parlamento.
Antonio Pollio Salimbeni per “il Messaggero” il 30 gennaio 2020. Subito dopo il
voto gli eurodeputati, tranne i coriacei brexiteers, mano nella mano hanno
cominciato a cantare una famosa aria scozzese, Auld Lang Syne, nota come Valzer
delle candele. Nella tradizione scout Canto dell'addio. Di solito viene cantata
l'ultimo giorno dell'anno. O negli addii, appunto: tra compagni di classe,
commilitoni, colleghi di lavoro. Questa volta è stato tra parlamentari, quelli
dei Ventisette e quelli pro-Ue del Regno Unito ormai in partenza. Momento di
grande emozione. Non è stata una novità il voto: 621 a favore dell'accordo a suo
tempo raggiunto tra i Ventisette e il Regno Unito per una Brexit ordinata, 49
contrari, 13 astenuti. Oggi tocca al Consiglio adottare il tutto e le formalità
saranno finite: domani a mezzanotte scatta la Brexit e comincia il periodo di
transizione fino al 31 dicembre per dar tempo al Regno Unito e all'Unione
europea di negoziare le condizioni delle future relazioni commerciali. Un
negoziato irto di mille difficoltà tanto che a Bruxelles c'è molto scetticismo
sulla possibilità di farcela in undici mesi. Per un paio d'ore nell'emiciclo
dell'Europarlamento si è sgranato l'ultimo rito di un dibattito sul vero addio.
Con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen che dice: «Faremo il
massimo, 24 ore su 24, per avere dei risultati nel negoziato, vi ameremo sempre
e non saremo mai lontani». E il presidente del parlamento David Sassoli che cita
la deputata laburista Jo Cox uccisa a coltellate duranta la campagna per il
referendum sulla Brexit: «Abbiamo moltodi più in comune di quanto ci divide». E
il leader dei brexiteers Nigel Farage che non rinuncia al solito show: «Adoriamo
l'Europa ma odiamo la Ue». Sipario. Che cosa cambierà dal punto di vista degli
schieramenti una volta usciti i 73 britannici? Non molto in realtà per quanto
riguarda la composizione (o la scomposizione) di maggioranza e minoranze, che
nel corso ordinario della legislatura sono per definizione assai variabili
perché condizionate più dagli interessi nazionali che dalle posizioni delle
varie famiglie politiche. Attualmente gli eurodeputati sono 751, dopo la Brexit
scenderanno a 705 perché solo 27 seggi saranno redistribuiti: i restanti 46
restano disponibili per i futuri allargamenti dell'Unione ad altri stati e/o per
l'eventuale creazione di liste transnazionali. Della redistribuzione il partito
popolare guadagna 5 seggi; i socialisti&democratici ne perdono 6; Renew Europe
(liberali e macroniani) ne perde 11; Identità e democrazia di cui fanno parte
Lega e Rassemblement National di Le Pen ne guadagna 3; i Verdi ne perdono 7; i
conservatori e riformisti europei ne perdono 3 (del gruppo fa parte Fratelli
d'Italia); la sinistra unita ne perde uno; i non iscritti ne perdono 26 (pesa
l'uscita del gruppo di Nigel Farage). Quanto ai movimenti agli italiani entrano
Vincenzo Sofo per la Lega, Sergio Berlato per Fratelli d'Italia, Salvatore De
Meo per Forza Italia. Ed entra pure Sandro Gozi del Pd, ma eletto in Francia
nella lista di Macron. Non una rivoluzione. Tuttavia potrebbero esserci delle
novità. Una potrebbe riguardare i Verdi, che diventano il quinto partito dopo i
sovranisti di Identità e democrazia ed erano il quarto. Hanno sempre chiuso la
porta ai Cinque Stelle sempre in disperata ricerca di affiliazione in un gruppo:
l'accettazione del sistema Rousseau per i Verdi è uno scoglio risultato finora
insormontabile. Può darsi che la perdita di seggi possa produrre nuovi scenari.
Alfonso Bianchi per “la Stampa” il 30 gennaio 2020. Quando sabato
il Regno Unito smetterà di essere uno Stato membro dell' Ue a festeggiare
saranno sicuramente i pescatori del Paese, stanchi della concorrenza nei loro
mari, delle quote e delle regole imposte da Bruxelles. «Fishing for Leave» è
stata una delle principali organizzazioni a spingere per la Brexit e quello
della riappropriazione del controllo delle proprie acque territoriali è stato
uno dei temi centrali nella campagna per il referendum del 2016. Il premier
Boris Johnson non lo ha certo dimenticato e così ieri, nel giorno il cui l'
Europarlamento fra applausi e lacrime ha approvato l' accordo di recesso, ha
presentato ai Comuni il disegno di legge che stabilisce con la Brexit le navi
europee perderanno il loro diritto automatico di accesso alle acque britanniche.
Nonostante la pesca e la lavorazione del pesce del Regno Unito diano lavoro
soltanto a circa 24 mila persone, e un contributo lordo al Prodotto interno
lordo di un misero 0,12 per cento, il tema dello sfruttamento dei mari
britannici è stato centrale nella propaganda del «Take back control». In effetti
i numeri mostrano una forte sproporzione nell' utilizzo dei mari inglesi. Grazie
alla Politica comune della pesca, secondo cui i pescherecci dei Paesi Ue hanno
pieno accesso alle reciproche acque ad eccezione delle prime 12 miglia nautiche
dalla costa, ben il 57% di quanto è stato pescato nelle acque britanniche è
stato catturato da pescherecci appartenenti ad aziende europee e solo il 43% da
quelli di imprese locali. Sono stati soprattutto Danimarca, Paesi Bassi e
Francia ad approfittare delle acque dell' isola (che sono più ricche,
soprattutto quelle dell' Atlantico nord-orientale) di cui hanno catturato
rispettivamente il 18%, 14% e 9% del pescato totale. A queste percentuali vanno
poi aggiunte quelle delle aziende europee che con il trucco di registrarsi a
Londra, hanno accesso anche alle acque riservate alle aziende locali. Il governo
conservatore ha promesso di porre fine a tutto questo e sul tema ha fatto la
voce grossa. Ma al di là della propaganda la questione finirà inevitabilmente
sul tavolo dei negoziati per le relazioni future e sul punto Londra dovrà
necessariamente fare delle concessioni, se non vuole perdere il suo principale
mercato. Se è vero infatti che gli europei sfruttano abbondantemente i mari
locali, è vero anche che sono sempre gli europei i principali acquirenti del
pesce inglese e che i britannici sono dipendenti dai mercati esteri per i loro
consumi. Circa l' 83% del merluzzo mangiato nel Regno Unito, utilizzato per il
piatto nazionale per eccellenza, il fish and chips, è importato mentre il 93%
delle aringhe pescate dalle flotte locali, e che ai britannici non piacciono,
viene esportato, principalmente nei Paesi Bassi. Nel complesso il Regno Unito
importa il 70% del pesce che mangia ed esporta l' 80% di ciò che cattura, e il
66% delle esportazioni finisce proprio nei mercati dell' Ue, principalmente in
Francia, Paesi Bassi, Irlanda e Spagna. Bisogna ricordare inoltre che altri
mercati mondiali sono aperti al Paese grazie ad accordi commerciali europei che
per la Gran Bretagna con la Brexit non saranno più validi. Sul tema dei diritti
di sfruttamento delle acque territoriali quindi Londra non ha alcun interesse ad
irrigidirsi nei negoziati con Bruxelles, perché la risposta europea potrebbero
essere i dazi. Tu non mi lasci pescare nei tuoi mari? Io non ti lascio vendere
nei miei mercati. E non solo. La pesca non sarà certo oggetto di negoziati
separati ma parte di quelli complessivi, che riguarderanno anche questioni
centrali come i servizi finanziari che, quelli sì, hanno un forte impatto sull'
economia britannica.
Brexit, perché in Gran Bretagna non sono mai stati europei.
Pubblicato mercoledì, 29 gennaio 2020 su Corriere.it
da Luigi Ippolito. Prima di tutto, ricordarsi di portare l’adattatore. Perché la
mini-brexit quotidiana comincia dalle prese di corrente: che, come tutti sanno,
qui si ostinano a mantenere diverse da quelle europee. Ma non è solo questione
di carica del telefonino: sono tutte le categorie mentali che bisogna riadattare
una volta in Gran Bretagna. Tanto per cominciare, i numeri sui cartelli stradali
non indicano i chilometri bensì le miglia: e bisogna fare un po’ di calcoli per
capire. Scordatevi metri e centimetri: se vi dicono che uno è alto «sei piede
cinque» vuol dire che è a livello di cestista, mentre un «cinque piede due» è
chiaramente un tizio brachilineo. E in cucina son dolori: mia moglie (inglese)
ancora non ha capito cosa sia un chilo di pasta, lei ragiona solo in libbre e
once. Insomma, dalla quotidianità spicciola alla grande Storia, questo resta un
Paese a parte: e a esaminarlo da vicino si capisce che la Brexit non è una
bizzarria, ma qualcosa iscritta nelle sue radici e nella sua cultura. Ricordo
ancora distintamente quella strana sensazione, più di venticinque anni fa,
sbucando per la prima volta dalla metropolitana a Piccadilly Circus: ero
chiaramente finito da qualche altra parte. La prima impresa era riuscire a non
farsi mettere sotto attraversando la strada: perché qui guidano dall’altra parte
rispetto a noi (e agli incroci ancora oggi non mi raccapezzo). Il traffico, poi,
restituisce subito un colpo d’occhio inusuale: se in Europa taxi e autobus più o
meno si assomigliano ovunque, qui le strade sono affollate di quelle ingombranti
carrozze nere senza cavalli che chiamano black cab (i taxi neri) e di palazzine
rosse che si muovono su quattro ruote (gli autobus a due piani). Alzando lo
sguardo, il panorama urbano è di nuovo un unicum. L’architettura londinese è
rimasta sostanzialmente quella vittoriana, con le casette a due piani al posto
dei palazzi di appartamenti che dominano in Europa: e dietro c’è l’immancabile
back garden, il giardino sul retro dove l’inglese ricrea la campagna in città.
Anche la folla ha un aspetto diverso. Soprattutto a Londra, ma anche nelle altre
città maggiori, è un carosello multicolore, un crogiuolo di etnie, un
caleidoscopio di abiti di fogge diverse, dai sari ai turbanti ai niqab. In Gran
Bretagna il 17 per cento della popolazione è di colore (e a Londra siamo oltre
il 40 per cento): una società multietnica che per la sua composizione si
avvicina più a quella americana che non al resto d’Europa. Una mescolanza che
produce un incontro di culture e religioni diverse. Ma a proposito di fede,
anche qui la Gran Bretagna si differenzia dal resto d’Europa: ormai più del 50
per cento della popolazione è non credente e la Chiesa anglicana è ridotta al
rango di minoranza. Una situazione opposta rispetto a quella che si riscontra in
molti Paesi europei, soprattutto se si pensa a posti come l’Italia o la Polonia.
A Londra il Natale è una festa molto sentita e celebrata: ma è totalmente
secolarizzata, priva di ogni riferimento religioso. E parlando di religione, è
questo il terreno dove si è verificata la prima Brexit. Perché lo scisma di
Enrico VIII è stata la separazione dall’autorità europea (incarnata dal Papato)
e l’affermazione che non vi può essere alcuna istanza superiore alle leggi
britanniche: non Roma, non Bruxelles. È quel principio di sovranità (che non va
confuso col sovranismo) che sta al cuore del sistema costituzionale britannico.
Da allora le isole al di là della Manica (altra distinzione, la geografia) hanno
avuto una storia diversa dal Continente. Laddove la Gran Bretagna è stata sempre
potenza ordinante rispetto all’Europa, impegnata a forgiarne gli equilibri, ma
non a farne parte. E mentre sul Continente si succedevano le rivoluzioni, qui le
istituzioni conoscevano una lenta ma costante evoluzione: innovare per
conservare, era il principio di fondo. E niente lo illustra meglio come il
permanere della monarchia. Una storia che è stata spesso vissuta in opposizione
al Continente: la mitologia nazionale è forgiata dalle guerre contro Napoleone e
contro Hitler. Ogni volta, era dall’Europa che arrivava la minaccia alla libertà
britannica: e lo spirito che ha animato questa lotta è sintetizzato dalla
celebre vignetta della Seconda Guerra mondiale, quella che raffigura il soldato
inglese, in piedi sulle scogliere di Dover, che scruta gli aerei tedeschi che si
avvicinano in cielo ed esclama «Very well, alone!», molto bene, da soli! A fare
compagnia, semmai, c’erano i Paesi dell’Impero (e oggi del Commonwealth): un
orizzonte che spiega perché ai britannici l’Europa sia sempre andata stretta,
visto che il loro sguardo abbracciava i cinque continenti. Anche adesso gli
inglesi, quando vanno in vacanza in Francia o in Spagna, dicono: andiamo in
Europa. Perché loro mentalmente si collocano da un’altra parte. E così la loro
appartenenza alla Ue si è sempre basata su un equivoco di fondo. Per gli europei
si trattava di un ideale da perseguire, di costruire l’unione politica, rispetto
alla quale la moneta e i commerci erano lo strumento; i britannici non si sono
mai sognati nulla di simile, per loro era un’area di libero scambio da cui
trarre dei vantaggi economici (e guai a parlare di cessione di sovranità). Per
questo la Gran Bretagna è sempre stata un membro riluttante dell’Unione: e a
Londra anche i più ferventi filo-europei hanno sempre e solo fatto un calcolo
costi-benefici, senza nessuna implicazione più alta. Alla fine, i nodi irrisolti
sono venuti al pettine: e la Brexit è stata una conseguenza forse necessaria di
un rapporto sempre ambiguo. «We are with Europe, but non of it», diceva
Churchill: siamo con l’Europa, ma non parte di essa. Non aveva torto.
UNION JACK
= LIBERTA’.
Antonio Angelini su Il Giornale l'1 febbraio 2020. Ringrazio l’ amico Marco
Campomenosi che con un suo post su Twitter, mi ha suggerito il titolo dell’
articolo che stavo scrivendo. Nigel Farage ha vinto . 26 anni di lotte
DEMOCRATICHE ed ha messo sulla graticola i potenti , le lobbyes e tutti i grandi
burocrati della UE. Oltretutto Farage ha vinto con le sole armi della DEMOCRAZIA
e della pazienza. Armi sconosciute a Bruxelles e Strasburgo. NO MORE
BULLY. Questa il leit motiv del discorso di Nigel Farage che ha battuto un
sistema da dentro. Si è fatto eleggere al parlamento UE e da lì ha iniziato a
farsi conoscere e e lanciare i suoi j’ accuse alla stessa UE . L’ Unione Europea
sino a poco tempo fa andava avanti a minacce contro l’ Inghilterra. Un popolo
spesso povero quello inglese , ma fiero e con grande senso di appartenenza.
Basti vedere la seconda guerra mondiale. La Francia cadde in pochi giorni e
invece Inghilterra e Russia venderono cara la pelle. Lezione: Mai stuzzicare l’
orgoglio nazionale russo o inglese. E questo ci dice molte altre cose:
1 le nazioni
esistono
2 le nazioni
danno un senso di appartenenza che la UE non può dare per vari motivi tra cui
quello linguistico.
3 la storia
dei paesi non si cancella
4 i confini
esistono e sono utili.
5 quando un
organismo sovranazionale entra troppo nella vita delle persone , pensiamo ai
pescatori in UK o agli allevatori con il latte in Italia o ancora i produttori
di arance e olio sempre in Italia, accade che i lavoratori odiano questa
sovrastruttura di ricchi burocrati che non capiscono i loro problemi e o
scendono in piazza (Francia e Spagna) o votano chi è contrario alla UE (Italia-
UK ). Ma questa storia ci dice anche un’ altra cosa. La volontà popolare ogni
tanto ancora vince. E’ accaduto con Trump ed è accaduto con il referendum della
Brexit. Non è accaduto in Italia e Spagna. E quale sarà la grande differenza?
Semplice , Italia e Spagna hanno un vincolo in più che si chiama EURO. Avere una
moneta che non controlli ti vincola al ricatto dei mercati e diventa molto molto
più diffile uscire dal cappio della dittatura dei mercati e dei burocrati.
Quando Trump è stato eletto non hanno potuto ricattare gli USA con lo spread e
così è accaduto quando vinse la Brexit e quando poi ha rivinto Boris Johnson. E
nemmeno quando Boris ha sospeso i poteri del parlamento. Certo le hanno provate
tutte contro la Brexit, dal tentativo di un nuovo referendum, al passaggio di
parlamentari da una parte all’ altra , alle minacce e ricatti della UE fino
alla tempesta di bufale mediatiche . Il Corsera raccontava di aumenti di infarti
in UK per mancanza di insalata e verdura …!! Ma nulla rispetto al ricatto dei
MERCATI. Il mondo si divide in Globalisti e Populisti (patrioti io direi) ha
deto Nigel Farage. Questa è una grande sconfitta per i globalisti , ed ha
aggiunto Farage , il populismo sta diventando sempre più popolare. Non
dimentichiamo che Farage è stato vittima di un attentato. God save the Queen.
P.S. Non sarà la stessa Inghilterra senza.
Nicol Degli
Innocenti per “il Sole 24 Ore” l'1 febbraio 2020. Tre anni, sette mesi e otto
giorni dopo il referendum che ha portato a Brexit, la Gran Bretagna ha
formalmente lasciato l' Unione Europea. Ne aveva fatto parte per 47 anni. Un
evento di grande importanza storica, politica, costituzionale e simbolica che
cambia il destino del Paese, apre una lunga serie di incognite sul suo futuro e
lascia un vuoto difficile da colmare nella Ue. «La cosa più importante da dire è
che questa non è una fine ma un inizio -, ha detto il premier Boris Johnson nel
suo discorso alla nazione poco prima dell' ora fatidica -. Questo è il momento
in cui arriva l'alba e il sipario si alza su un nuovo atto, un momento di vero
cambiamento e rinnovamento nazionale». In tutto il Paese l' arrivo del Brexit
Day è stato festeggiato da molti e accolto con mestizia da molti. Ci sono state
manifestazioni pro-Ue con lacrime e grande sventolìo di bandiere stellate e ci
sono state celebrazioni anti-Ue con canti di gioia e tante Union Jack. Un Paese
spaccato Ieri, come ai tempi del referendum nel 2016, la Gran Bretagna resta
divisa, spaccata quasi esattamente a metà tra chi vede l' uscita dalla Ue come
una liberazione che aprirà il Paese al mondo intero e chi la considera una mossa
autolesionistica e controproducente che porterà a un isolamento e impoverimento
del Regno Unito. Per Johnson, che aveva guidato il fronte anti-Ue nella campagna
del 2016 e che ha conquistato una maggioranza schiacciante alle elezioni del
dicembre scorso, è un momento di trionfo. Il premier ha però evitato toni
trionfalistici in pubblico, anche se in privato ieri sera ha ospitato a Downing
Street ministri, consiglieri e amici per una festa con un menù rigorosamente
British e un brindisi con vino spumante inglese. Fuori, nelle strade di
Whitehall, ministeri e palazzi del Governo sono stati illuminati a giorno con i
colori della bandiera - rosso, bianco e blu - mentre un orologio digitale
proiettato su Downing Street ha scandito il conto alla rovescia fino all' ora
dell' uscita. In Piazza del Parlamento e sul Mall, la via che porta a Buckingham
Palace, invece del consueto arcobaleno di bandiere, su tutti i pennoni è stata
issata una Union Jack. Il Governo pensa al Nord Nel pomeriggio Johnson aveva
trascinato tutti i suoi ministri verso il ventoso nord dell' Inghilterra per
tenere una riunione di Governo a Sunderland, che era stata la prima città a
votare a favore di Brexit nel referendum del 2016. Un gesto simbolico, per
ribadire il messaggio che il Governo intende essere meno focalizzato su Londra e
sanare le divisioni emerse durante il tormentato percorso di uscita dalla Ue.
Due leader politici donna hanno però ricordato a Johnson che il Regno Unito
resta profondamente diviso e che il premier ha di fronte un percorso arduo. A
Edimburgo la premier Nicola Sturgeon ha dipinto Brexit come un' imposizione di
Londra sulla Scozia, che viene «trascinata fuori dalla Ue contro la volontà
della stragrande maggioranza dei cittadini». Due terzi degli scozzesi avevano
votato a favore di restare nella Ue. È un momento di grande tristezza ma anche
di rabbia, ha detto la leader dello Scottish Nationalist Party, che vuole un
altro referendum sull' indipendenza in modo che la Scozia possa tornare a essere
Paese membro della Ue. Nel frattempo la bandiera della Ue continuerà a
sventolare sul Parlamento scozzese come gesto di sfida a Londra e di solidarietà
con i cittadini europei residenti nel Paese. In Irlanda del Nord, altro Stato
del Regno Unito che aveva votato a favore di restare nella Ue, la leader di Sinn
Féin ha ricordato ieri che l' opposizione a Brexit accomuna cattolici e
protestanti. «C' è una grande e giustificabile rabbia tra la gente che non ha
acconsentito all' uscita dalla Ue -, ha detto Mary Lou McDonald -. La Ue è stata
una forza di pace in Irlanda e ha portato gli aiuti finanziari e il sostegno
politico che hanno facilitato il progresso sociale». Londra città aperta Anche
la capitale ha preso le distanze da Brexit, ieri come sempre. Il sindaco
laburista Sadiq Khan ha dichiarato Londra "città aperta". Il municipio ha aperto
le sue porte per tutto il giorno ai cittadini curiosi, preoccupati o
semplicemente depressi, che hanno avuto accesso gratuito alla consulenza di
esperti legali e anche di psicologi. La piazza del Parlamento è stata occupata
fin dalle prime ore del pomeriggio dai sostenitori di Brexit con le loro
bandiere che attendevano l' inizio della festa organizzata da Nigel Farage,
leader del Brexit Party e vero artefice del divorzio dalla Ue, che si è conclusa
con fuochi d' artificio alle 23 esatte. Un manifestante ha bruciato la bandiera
europea. La bandiera stellata è invece apparsa proiettata sulle celebri
scogliere di Dover. A sfatare il luogo comune che solo i giovani sono
filo-europei, ieri due veterani della seconda guerra mondiale, entrambi
ultranovantenni, hanno inviato una "lettera d' amore" alla Ue in un video
proiettato sulle celebri scogliere di Dover, nel quale hanno espresso il loro
rammarico per Brexit e la speranza che la Gran Bretagna torni ad avvicinarsi
all' Europa. Tutto cambia, tutto resta uguale A partire da oggi Johnson vuole
bandire la parola Brexit, per voltare pagina dopo tre anni e mezzo di divisioni,
polemiche e contrasti. In realtà a finire è solo il primo capitolo di Brexit e
la parte forse più difficile, i negoziati bilaterali che dovranno definire i
rapporti di lungo termine e arrivare a un accordo commerciale, deve ancora
cominciare. Oggi tutto cambia ma tutto resta uguale. Nella vita quotidiana dei
cittadini nulla cambierà fino al 31 dicembre, dato che la Gran Bretagna è
entrata in un periodo di transizione che mantiene lo status quo. Pur essendo
Paese terzo continuerà a essere nel mercato unico e nell' unione doganale.
Restano in vigore quindi per altri undici mesi le quattro libertà fondamentali
di circolazione delle persone, dei beni, dei capitali e dei servizi.
Boris non
cerca il trattato con l’Ue: sarà Brexit senza libero scambio.
Pubblicato lunedì, 03 febbraio 2020 su Corriere.it da Luigi Ippolito. La cornice
non è stata scelta a caso. Per svelare quello che sarà il vero volto della
Brexit, ieri mattina Boris Johnson è andato a piazzarsi sotto le arcate e gli
affreschi del Museo Nazionale Marittimo, a Greenwich: un modo per evocare una
Gran Bretagna potenza navale che solca incontrastata gli oceani del libero
commercio, svincolata da obblighi e legami. E sono le regole europee quelle che
Londra non ha più intenzione di assecondare: anche a costo di rinunciare a
concludere un vero Trattato commerciale e accettare il ritorno a dazi e dogane.
Boris ha elencato i settori in cui non subiranno più diktat da Bruxelles:
«Concorrenza, aiuti di Stato, protezione sociale, ambiente, o ogni altra cosa
simile». La Gran Bretagna, ha argomentato, applica regole più stringenti in
molti settori, ma non chiede alla Ue di adeguarsi «per poter esportare le Alfa
Romeo o il vino tedesco». Dunque Bruxelles deve smetterla di minacciare la
chiusura dei mercati europei se i britannici rifiutano di sottostare alle
direttive Ue. Perché questa, in realtà, è la posizione articolata ieri dal capo
negoziatore europeo, Michel Barnier: un «ambizioso» trattato commerciale, ha
detto, presuppone un «level playing field», ossia condizioni paritarie, per
evitare che Londra si lanci in una deregulation che le dia un vantaggio
competitivo sleale. Non abbiamo intenzione di scatenare «una corsa al ribasso»,
ha replicato Johnson. Ma allo stesso tempo ha messo in conto la possibilità che
non ri raggiunga entro la fine dell’anno un accordo di libero commercio sul
modello canadese, che elimina praticamente tutti i dazi sulle merci:
l’alternativa evocata esplicitamente è allora uno scenario «australiano», ossia
pochi, scarni accordi di settore e tutto il resto lasciato alle regole del Wto,
l’Organizzazione Mondiale del Commercio. Uno scenario che è solo un altro modo
per rinominare il famigerato no deal, la Brexit senza un accordo-quadro che
vedrebbe il ritorno dei dazi. D’altra parte, sembra davvero difficile che di qui
alla fine dell’anno, quando scadrà il periodo di transizione, si riesca davvero
a trovare il tempo di negoziare un trattato di libero scambio: quello col Canada
aveva richiesto ben sette anni. E allora la sensazione è che il governo Johnson
stia puntando fin da ora la barra della nave verso la Brexit più radicale
possibile, incarnata da una rottura netta con la Ue, costi quel che costi. E i
mercati sembrano aver fiutato subito il vento, vista la flessione che la
sterlina ha subìto ieri. Da Downing Street fanno capire che loro da ieri si
considerano a tutti gli effetti un Paese terzo, il cui obiettivo è stabilire un
rapporto con la Ue come tra entità sovrane ed eguali. La meta da raggiungere, a
fine 2020, è riguadagnare per Londra la completa indipendenza economica e
politica (e anche per questa ragione escludono categoricamente una proroga della
transizione oltre quest’anno). La Gran Bretagna, spiegano, è già pronta ad
accettare le conseguenze di un accordo commerciale «alla canadese», ossia
controlli doganali e minore accesso ai mercati: ma è disposta a spingersi anche
oltre e a contemplare un rapporto con la Ue basato sul semplice Wto. Il «level
playing field» gli europei se lo possono scordare, è l’approccio di Downing
Street. E i britannici chiedono agli europei un cambio di prospettiva
filosofica: perché secondo loro la Ue sembra dimenticare che da oggi negozia con
un Paese indipendente e democratico, che non è più disposto a prendere lezioni.
Il rapporto ora è come quello con un qualsiasi Paese fuori dall’Unione, tipo gli
Stati Uniti.Posizioni chiare, da un parte e dall’altra: scontro probabilmente
inevitabile.
Johnson: «Con Ue pronto a rottura commerciale». Cosa cambierebbe
per noi?
Pubblicato domenica, 02 febbraio 2020 su Corriere.it da Luigi Ippolito. Dicono
che Boris sia «infuriato»: e domani mattina scaricherà la sua ira sugli
ambasciatori europei, davanti ai quali pronuncerà un discorso sulle future
relazioni tra Gran Bretagna e Ue. Non ci sarà «nessuna concessione, nessun
allineamento, nessuna giurisdizione della Corte europea», dirà: perché Londra
vuole essere trattata da «eguale». Il nodo del contendere è quanto i britannici
potranno divergere dai regolamenti europei dopo la Brexit: sarà questo il
nocciolo delle trattative che si svolgeranno nei prossimi 11 mesi. Bruxelles ha
fatto capire che non ha nessuna intenzione di veder sorgere alle sue porte un
concorrente che approfitti della deregulation per fare competizione sleale: ma
Londra d’altra parte non ha nessuna voglia di fare la parte del Paese-satellite,
tipo la Norvegia. E allora si profila un nuovo scontro, la cui salva d’inizio
sarà il discorso di Johnson domani mattina. Il governo britannico non si sente
più obbligato a perseguire un trattato di libero scambio sul modello canadese,
che elimina i dazi sulla quasi totalità delle merci: potrebbe puntare in egual
misura a un accordo “debole” sul modello di quello con l’Australia, dove ci si
accorda solo su alcuni settori chiave e il resto delle transazioni si svolge
sulla base delle regole dell’Organizzazione mondiale del Commercio. Quest’ultimo
scenario è di fatto un no deal che implica il ritorno a controlli doganali e
dazi sulle merci (ma anche un trattato “canadese” non eliminerebbe i controlli
doganali). Le conseguenze sugli scambi fra Europa e Gran Bretagna sarebbero
pesanti. E l’Italia sarebbe fra i Paesi più colpiti: l’anno scorso
l’interscambio è stato di oltre 30 miliardi di euro e le nostre esportazioni
Oltremanica sono continuate a crescere, superando i 20 miliardi di euro. Siamo
l’ottavo Paese fornitore del Regno Unito (dopo Germania, Stati Uniti, Cina,
Olanda, Francia, Belgio e Svizzera) e vantiamo un saldo attivo di oltre 10
miliardi (in crescita del 9% rispetto all’anno precedente). In particolare, i
britannici hanno intenzione di divergere dai regolamenti europei in materia
agro-alimentare e questo introdurrebbe un forte elemento di “attrito doganale”
per le nostre esportazioni, in cui giocano buona parte il cibo e le bevande:
vedremo le forme di Parmigiano bloccate nel porto di Dover?
Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera”l'11 febbraio 2020.
Una guerra sotterranea è in corso a Downing Street: una battaglia dietro le
quinte, combattuta senza esclusione di colpi, che ha come obiettivo quello di
conquistare la mente e il cuore di Boris Johnson. Perché i protagonisti dello
scontro, stando ai giornali inglesi, sono le due persone più vicine al primo
ministro britannico, i suoi due consiglieri più potenti e influenti: Dominic
Cummings, l' architetto della Brexit, e Carrie Symonds, la fidanzata del
premier. In queste ore il terreno del conflitto è l' annunciato rimpasto di
governo, che sarà svelato giovedì: sia Carrie che Dominic hanno i loro alleati e
i loro protetti in seno all' esecutivo e la loro sorte è diventata una partita a
scacchi. Cummings avrebbe chiesto a Boris di far fuori due ministri-chiave,
quello del Tesoro, Sajid Javid, e quello della Difesa, Ben Wallace. Ma la
Symonds, che ha stretti rapporti con entrambi, si è schierata a loro difesa:
Javid sarebbe ormai in salvo, mentre è ancora incerto il destino di Wallace.
Cummings però avrebbe intenzione di licenziare anche tutta una lista di
consiglieri speciali del governo, alcuni dei quali della cerchia di Carrie. Lo
scontro in atto è prima di tutto un conflitto di personalità, fra due individui
che sanno benissimo cosa vogliono e come ottenerlo: ma il rischio è che Johnson
venga preso tra due fuochi e sia costretto a prendere decisioni sbagliate. Fra i
due, il più pericoloso è Cummings: «Uno psicopatico di carriera», lo aveva
definito a suo tempo l' ex premier conservatore David Cameron. Un ritratto
efficace quanto inquietante lo ha fornito l' attore Benedict Cumberbatch, che lo
ha impersonato l' anno scorso in un film tv per la Bbc : si vede «Cummings» che
mette l' orecchio sull' asfalto per strada per captare l' umore della nazione o
che si chiude a meditare nel ripostiglio delle scope. Esagerazioni
cinematografiche, probabilmente: ma è vera la scena in cui, all' annuncio dei
risultati del referendum sulla Brexit, «Dom» sale su un tavolo e sfonda il
soffitto con un pugno per la gioia: perché era stato lui l' architetto di quella
campagna, lui l' artefice dello slogan vincente « Take back control »,
riprendiamo il controllo, lui che ha coniato il nuovo slogan « Get Brexit done
», portiamo a termine la Brexit, che ha fruttato la vittoria a Johnson nel voto
di dicembre. Boris gli deve tantissimo: ma ora rischia di essere trascinato via
dalla sua hybris . Cummings è l' uomo più potente a Downing Street, quello che è
sceso in guerra con i media escludendo i giornali sgraditi dalle conferenze
stampa e annunciando di voler ridimensionare la Bbc . Ed è lui che ha esortato i
giovani ad andare a lavorare con lui, facendo appello a tutti i «disadattati»:
cioè gente a sua immagine e somiglianza, essendo uno che posta deliranti
proclami sul suo blog e che veste sempre come una specie di barbone. Carrie è
molto più suadente e fascinosa e conta sulla persuasione come arma principale:
ma non è certo da sottovalutare, visto che per lei Boris, che pure aveva
attraversato tante relazioni, ha lasciato la moglie dopo vent' anni di
matrimonio. La Symonds è una che nel 2017, a soli 29 anni, era stata nominata
direttrice della comunicazione del partito conservatore e indicata come una
delle Pr più influenti del Regno Unito. A lei si deve lo stile più
«presidenziale» di Boris, che è pure riuscita a mettere a dieta. Adesso ha
incrociato il pugnale con Dom: e alla fine tra i due duellanti potrebbe restarne
uno solo.
Stefano Zurlo per “il Giornale” il 31 gennaio 2020. Pronunci la parola Brexit e
lui sospira: «Per l' Italia sarà un bel guaio». Antonio Martino, ministro degli
Esteri e poi della Difesa con Berlusconi, parlamentare per sei legislature,
scandisce le parole: «Gli inglesi bilanciavano in qualche modo l' asse (...)
(...) franco-tedesco».
Adesso?
«Ora saremo più deboli davanti allo strapotere di Berlino».
Che cosa ha spinto la Gran Bretagna ad andarsene?
«Il grande errore di questa Europa».
Quale?
«Confondere l' unità con l' uniformità».
In pratica?
«Negli Usa a nessuno viene in mente che tutte le macchine debbano avere targhe
uguali».
Ogni Stato fa come gli pare?
«Esatto. Da noi, invece, la Ue ha imposto regole comuni rigidissime. Una
follia».
Ma Londra era già fuori dall' euro e dal trattato di Maastricht. Non era
sufficiente?
«Gli inglesi hanno un'identità molto marcata e non sopportano che dei signori in
poltrona a Bruxelles decidano come devono comportarsi a casa loro».
Ma così non finisce l'Europa?
«Al contrario. L' Europa avrà un senso quando si occuperà delle tre cose
fondamentali per tenere insieme un Paese: politica estera, difesa, libertà nel
commercio interno».
Tutto il resto?
«Non è decisivo. Negli Usa, ci sono Stati che hanno la pena di morte e altri che
l' hanno bandita, Stati virtuosi e altri che hanno bilanci zoppicanti, ma
nessuno si sogna di imporre da Washington un fiscal compact».
La Gran Bretagna non aveva sulla testa i vincoli fiscali che ingabbiano
l'Italia.
«Non importa. Io credo che gli inglesi ora si sentano più liberi. E poi
attenzione a non sottovalutare il loro nazionalismo».
Più radicale di quello francese?
«Quello francese è più esibito, ostentato, gridato, ma gli inglesi dietro le
loro facce impassibili hanno convinzioni incrollabili. Ancora di più se, come è
successo, i tedeschi trattano l'Europa come una loro colonia».
Addirittura?
«Sa cosa disse un giorno mio padre Gaetano, che fu ministro degli Esteri negli
anni Cinquanta con Scelba, al leader liberale Giovanni Malagodi?».
Ce lo sveli.
«Papà gli spiegò che i tedeschi hanno molte virtù e pochi difetti, ma un paio di
volte in un secolo mettono le virtù al servizio dei difetti».
Un vero complimento.
«Un leader della sinistra tedesca, non italiana o inglese, Joschka Fischer, è
andato anche oltre: Due volte in un secolo i tedeschi hanno distrutto l' Europa,
ora si apprestano a farlo per la terza volta».
Si riferiva alla Grecia.
«Per salvare le banche tedesche e francesi, che avevano in pancia montagne di
titoli greci, hanno spolpato Atene».
Per questo servivano gli inglesi?
«Londra bilanciava l'egemonia franco tedesca. Ma la diffidenza inglese viene da
lontano».
Dalla storia e dalla geografia.
«Mio padre invitò anche gli inglesi alla conferenza di Taormina nel 1954. Si
studiava un'Europa della difesa comune che poi fu bocciata da Parigi su
pressione dei socialisti. E che infatti non si è mai fatta, perché sul punto
nessuno vuole cedere: col risultato che i Paesi europei spendono la metà degli
Usa in armamenti ma hanno una potenza militare che è forse il 10 per cento di
quella americana».
Gli inglesi?
«L'ambasciatore venne a Taormina con un' auto che lasciò me, bambino, a bocca
aperta».
In conclusione?
«Gli inglesi si sfilarono».
L'Europa è sempre stata una costruzione difficile.
«I padri fondatori capirono che il continente non era pronto per l' unità
politica e iniziarono dall' economia. Consapevoli che gli scambi commerciali
avrebbero favorito la pace. Dove non passano le merci passano le armi».
Poi?
«Purtroppo l' Europa si è avvitata in questa mania regolatoria».
Qualcun altro seguirà gli inglesi?
«La breccia è aperta. Altri potrebbero infilarsi nel varco».
Da dove ripartirà l' Europa?
«Gli americani hanno una Costituzione chiara e semplice che sta su un foglio A4,
fronte e retro».
Noi?
«Abbiamo la Carta di Lisbona, migliaia di pagine piene di farneticazioni che
nessuno ha letto. È arrivato il momento di scrivere una Costituzione dell'
Europa. Pochi articoli e un pugno di concetti per non darla vinta agli
euroscettici e attribuire finalmente un' anima a un' Unione in ritardo sulla
storia».
Viva gli inglesi. Ma andarcene non fa per noi.
Alessandro Sallusti, Domenica 02/02/2020, su Il Giornale. «I turisti sono il
vero problema di Londra, sono loro a bloccare il traffico. Se potessimo bloccare
il turismo avremmo risolto il problema della congestione». La bizzarra profezia
di qualche anno fa del Principe consorte Filippo di Edimburgo, marito di Sua
Altezza la regina Elisabetta, in un certo senso si è avverata ieri e forse
neppure lui osava immaginare tanto. Il Regno Unito è fuori dalla Comunità
Europea, gli europei a Londra entreranno solo se accettati, eccetera. Non
sappiamo quanto questo inciderà sul traffico di Londra, ma nell'apparente
stupida massima del Principe c'è più british pensiero, e pure sostanza, di
quanto non ce ne sia in tutto Shakespeare. Gli inglesi non sono europei e mai
avrebbero potuto esserlo, sono inglesi e basta, sia nel bene che nel male.
Conoscete un altro popolo che nelle urne manda a casa - successe nel 1945 - un
primo ministro, Winston Churchill, che aveva fatto vincere loro contro ogni
logica previsione una guerra mondiale? Eppure lì è successo, per cui non c'è
nulla da stupirsi per la Brexit. Stupisce invece che in Italia qualcuno pensi di
essere inglese e di seguirne le orme. Se funziona lì - sostengono questi signori
- perché non dovrebbe andare bene anche per noi abbandonare l'Europa? I motivi
per cui il paragone è improponibile sono tanti, ma riassumibili in uno: gli
inglesi hanno resistito e respinto Napoleone e Hitler, noi all'imperatore
francese e al dittatore del Terzo Reich abbiamo spalancato le porte di casa e
ancora oggi c'è chi li celebra e rimpiange nonostante gli accertati danni che ci
hanno provocato. Direi che la differenza non è di poco conto. Lo stesso
Churchill, del resto, pur ammirando i nostri difetti, ci aveva ben inquadrato:
«Gli italiani - disse - sono gente strana: vanno in guerra come se andassero a
una partita di calcio e vanno a una partita di calcio come se si andasse in
guerra». Agli inglesi - come sostiene il Principe consorte - i turisti danno
fastidio. Noi sui turisti ci campiamo, il più delle volte coccolandoli e a volte
truffandoli, ma guai a limitarne il flusso. Auguriamo lunga vita al Regno Unito,
ma siccome auguriamo altrettanto all'Italia evitiamo stupide semplificazioni. E
diciamo orgogliosi: siamo italiani, non inglesi. E ci va bene così.
Brexit, dopo l’addio parte la riscossa autonomista.
Antonella Rampino su Il Dubbio l'1 Febbraio 2020. Il parallelismo tra la
separazione del Paese dal Vecchio Continente e quella di Harry e Megan dalla
Casa reale britannica è una plastica metafora di questa fase storica. È successo
davvero. Se ne sono andati. La Gran Bretagna ha lasciato l’Unione Europea, e
Harry e Meghan si sono trasferiti a vivere in Canada come ( quasi) dei commoners
di alto rango. Alla mezzanotte di ieri il premier Boris Johnson ha annunciato
alla nazione che «si apre una nuova era», e solo pochi giorni prima con uno
statement ufficiale Elisabetta II di Windsor – come dai tempi della Prima guerra
mondiale si è autodenominato il ramo inglese degli Hannover- Sassonia Coburgo-
ha dato l’addio ai duchi di Sussex. Entrambi, come si sa, travagliatissimi
eventi. Non suoni eterodosso o irrispettoso mettere sullo stesso piano le due
cose, pure avvenute in una qualche contemporaneità. L’eccezionalismo britannico,
l’Impero costruito nei secoli grazie al dominio sui mari a partire da un’isola,
sta pure nel modello Westminster, con una corona nel ruolo di garanzia e di
rappresentanza dell’unità nazionale che altrove ( in Italia, ad esempio) è
assolto da un capo dello Stato. Ma molto più che per un secolare presidente
repubblicano, ogni accadimento anche personale che riguardi la Royal Family ha
ripercussioni politiche ampie sulla nazione, anche perché chi occupa il trono di
San Giacomo è pure capo della Chiesa anglicana. Ma se le parole con le quali
Elisabetta II ha acconsentito alla richiesta di Harry e Meghan di vivere le loro
vite da ( non) ordinary people e dunque senza obblighi di corte chiudono in
bellezza un tormentone di variopinte invidie e gelosie narrate da tabloid e
programmi tv che a Londra esistono solo in quanto royal watcher, la partita
della Brexit è assai lontana dal traguardo. Harry duca di Sussex mantiene il suo
posto come sesto nella linea di successione al trono, e la regina ha precisato
di essere «orgogliosa di Meghan» e che i duchi restano «membri amatissimi della
famiglia» : è il segnale che chiude un’altra, lontana e ben più dolorosa e
politicamente squassante controversia, quella dell’abdicazione alla quale fu
costretto re Edward VII al fine di poter sposare la divorziata americana Wallis
Simpson. Il segnale che The Firm ( sí, in Inghilterra chiamano la famiglia reale
come Bersani chiamava il Pd, La Ditta) sta al passo coi tempi, si evolve con la
società che regalmente guida, e lo spartiacque in questo senso fu dato da Tony
Blair e Alastair Campbell, quando spiegarono a Sua Maestà che non scendere ai
cancelli di Buckingham Palace dove da giorni stazionavano milioni di britannici
in gramaglie per la morte di Lady D avrebbe messo a rischio la stabilità della
nazione. La lezione è stata bene appresa, e quando i Sussexes hanno brutalmente
accelerato i tempi annunciando via social media il loro imminente trasferimento
in Canada, il tempo per accogliere la decisione e definirli “amatissimi” è stato
un lampo: la notizia politica era che la Regina capisce e modernamente accetta
il to-MeghanMarkle, il verbo che dal quel giorno è stato creato nella lingua
inglese per definire «il tenere alla propria salute mentale tanto da scegliere
di lasciare una situazione in cui la tua vera natura non è accettata», come
documentato sul Corriere della Sera da Gianna Fregonara. Intanto, è probabile
che Harry e Meghan resteranno al centro dell’attenzione dei tabloid britannici
perfino più di quando erano sul suolo patrio e in prima linea nei royal duty: è
di questi giorni la deflagrante “notizia” del loro divorzio, previsto per il
2025. Soprattutto, Brexit è per ora solo l’addio dei parlamentari inglesi a
Bruxelles, tra pianti e abbracci al suono del Valzer delle Candele, che altro
non è che l’Auld lang syne tardo settecentesco, con parole del poeta ( scozzese)
Robert Burns. Le condizioni alle quali, dopo aver avuto il generico via libera
di Westminster, la Brexit avverrà davvero sono ancora tutte da negoziare. Entro
il 31 dicembre 2020, ma in realtà solo a partire da marzo prossimo, e sempre con
Michel Barnier in prima linea. Torna ad aleggiare insomma lo spettro di una
possibile hard Ma la Megxit non basterà a mettere Buckhingham Palace al riparo
Brexit, rischiosa e nociva per entrambe le parti, mentre sono ebidenti già ora i
rischi politici per UK. L’Irlanda del Nord, secondo quanto fissato dal negoziato
condotto da Boris Johnson, si trova ad essere uno spazio giuridico ed economico
diverso da tutti gli altri Stati che compongono il Regno Unito: nel suo mare
adesso passa il confine con l’Unione europea. In Scozia, il partito al governo,
lo Scottish National Party di Nicholas Sturgeon, chiede insistentemente un
secondo referendum per l’indipendenza : e questo perché i nazionalisti scozzesi
vorrebbero entrare nella Ue, pur mantenendo la sterlina. «È indispensabile per
la nostra economia, e l’Europa è il futuro», ha già dichiarato Sturgeon «noi
siamo progressisti, purtroppo la parola “nazionalisti” oggi indica solo
politiche di destra». Per lo SNP quel referendum lo si deve agli scozzesi, che
faranno di tutto per averlo. E se una rottura formale con l’Irlanda del Nord
rinfocolerebbe il terrorismo, la cui sanguinosissima e secolare stagione si è
chiusa solo da troppo poco, quella con la Scozia negando – come Johnson ha già
fatto- il referendum non farebbe che spingere ancora di più Edimburgo su quella
via. Del resto, come diceva Stephen Zweig che pure li amava, «gli scozzesi sono
italiani senza buona cucina», ovvero testardi e litigiosi. È per questo che
l’avvio della Brexit è stata salutata dal Guardian – uno dei più antichi e
autorevoli quotidiani del mondocon il titolo “Small Island”. Perché nessuno ha
veramente capito quale sia il motivo per cui si vuole la Brexit, che non è
ancora attuata ma già pare sia costata 200 miliardi di sterline, oltre al crollo
dell’amata moneta. Nessuno sa veramente indicare quale sia il fattore scatenante
dell’incredibile e anche rocambolesca serie di strani eventi per i quali il
Regno Unito ha finito per alzare, nelle acque dei propri mari, una barriera col
resto degli europei. Tutto quel che si capisce, come ha scritto Timothy Garton
Ash, è che «adesso che non c’è più un’Inghilterra in Europa si apre la sfida per
un’Inghilterra europea». E il rischio, che neanche la moderna gestione della
casa regnante avutasi con la Megxit può aiutare a fronteggiare, è che a furia di
coltivare britanniche nostalgie dell’Impero, Elisabetta II si trovi a regnare
sulla small island dalla quale Elisabetta I era riuscita a gettare, grazie alla
supremazia sui mari, proprio le basi dell’Impero.
Il Regno
Unito del dopo Brexit ha già un grosso problema: la Scozia che vuole
l’indipendenza.
Per tornare in Europa. Tommaso Bedini Crescimanni su it.businessinsider.com il 4
gennaio 2020. “La Scozia sta subendo la decisione di altri. Il nostro paese si
appresta a lasciare l’Unione Europea dopo che gli scozzesi hanno votato in massa
per il remain nel 2016 e a favore dello Scottish National Party nelle elezioni
di dicembre, il mio partito, che ha un unico grande proposito: rendere la Scozia
finalmente indipendente da Londra e riportarla in Europa, la nostra casa”. Sono
le parole di Patrick Grady, parlamentare britannico e membro di punta dello SNP,
partito guidato dalla First Minister Nicola Sturgeon, durante la conferenza sul
regionalismo promossa dall’Italian Society del King’s College di Londra. A poche
ore dalla Brexit, gli animi degli scozzesi si sono fatti più accesi e
irrequieti, tanto che Sturgeon ha invitato tutti a “mantenere la calma, perché
lo sapevamo che il cammino verso l’indipendenza della Scozia sarebbe stato
difficile, se fosse stato facile l’avremmo già portato a termine”. “La Scozia
potrebbe non avere più una regina – ha aggiunto Grady – non perché siamo
particolarmente avversi alla monarchia, ma perché il popolo scozzese deve e
vuole avere il diritto di scegliere cosa sia meglio per se stesso. Certo è che
il governo Johnson non è stato scelto dal popolo scozzese, in questo momento ci
sentiamo defraudati, stiamo pagando le conseguenze di scelte non nostre, anzi,
del tutto contrarie a quelle che erano le volontà degli elettori scozzesi”. Un
problema che rischia di diventare serio per il Regno Unito post Brexit quello
delle spinte indipendentiste della Scozia. Il premier Boris Johnson, consapevole
delle profonde divisioni nella Gran Bretagna, ha voluto ricordare proprio questo
nel suo statement del 31 gennaio, “adesso è il momento di riunire il paese e
portarlo verso una nuova alba”. E mentre a Parliament Square, proprio sotto il
palazzo del parlamento a Londra, andava in scena il trionfo dei leavers che
hanno osannato l’intervento di Nigel Farage comparso sul palco allestito per
l’occasione, a Edimburgo migliaia di scozzesi si sono riuniti in piazza avvolti
in bandiere europee per una veglia che aveva più il sapore di un lutto, con
tanto di occhi lucidi e lacrime. “La forte spinta indipendentista della Scozia è
diventato un problema potenzialmente molto serio per Londra – spiega Leila
Simona Talani, docente italo-britannica di International Political Economy
presso il King’s College London che è stata anche visiting professor alla
Harvard Kennedy School – e se non è affatto scontato che la Scozia riesca
effettivamente a ottenere l’agognata indipendenza, è molto probabile che riesca
a strappare accordi ancora più vantaggiosi al governo di Londra, dal momento che
il potere contrattuale degli scozzesi è aumentato moltissimo dopo l’ultimo voto
di dicembre che ha visto l’SNP stravincere”. E per quanto riguarda gli effetti
della Brexit che molti analisti hanno dichiarato si riveleranno disastrosi per
l’economia britannica, Talani afferma: “Soprattutto per il settore della finanza
non vedo un futuro così negativo. Nella City inizialmente c’era molta
preoccupazione perché questa ha sempre guadagnato dal fatto di essere un po’
dentro e un po’ fuori dall’Unione Europea. Il settore finanziario inglese, però,
ha la grande capacità di adattarsi, ciò di cui ha bisogno, fondamentalmente, è
il minimo indispensabile dal punto di vista della regolamentazione. Il governo
Johnson è già partito con questa idea di una regolamentazione ad hoc”. Leggi
anche: Dopo il 31 gennaio vale ancora la carta d’identità per entrare in Gran
Bretagna? E altri effetti della Brexit sugli stranieri. Brexit, anzi, potrebbe
offrire l’opportunità per uno sviluppo proficuo dell’apparato finanziario
britannico, grazie soprattutto alle nuove tecnologie. “Il FinTech sarà il futuro
della finanza, lo vediamo già oggi. Questo nuovo settore, però, ha bisogno di
tempi molto rapidi per essere integrato ed è qui che la riconquistata autonomia
da Bruxelles potrebbe rivelarsi vincente per il Regno Unito. La burocrazia
europea, anche se ha intuito l’enorme potenziale del FinTech, è ancora troppo
farraginosa e lenta, la Cina e gli Stati Uniti viaggiano a velocità al momento
impossibili per l’UE mentre Londra dal 2016 è il terzo hub dopo Shanghai e New
York per quanto riguarda questa tecnologia, grazie a enormi investimenti di
miliardi di sterline”. Ma c’è un altro problema che la Brexit porta con sé,
quello, cioè, della tutela dei cittadini europei che vivono, studiano, lavorano
nel Regno Unito e che adesso attraverseranno un periodo di grande incertezza. E
anche se alcuni affermano che “non abbiamo niente contro gli europei ma siamo
contro l’unione europea”, altri hanno bruciato le bandiere blu con le stelle
gialle in pubblica piazza al grido di “fuck EU!”. “Agli italiani che vogliono
continuare a rimanere nel Regno Unito dobbiamo garantire che i loro diritti
vengano tutelati – ha affermato Emanuela Rossini, deputata trentina del gruppo
misto-minoranze linguistiche, intervenuta alla conferenza – per questo dobbiamo
avviare trattati con il Regno Unito tenendo ben presente il fatto che tantissimi
europei vivono e operano nel paese d’oltremanica. È il momento di essere saggi”.
“La cosa che colpisce – ha proseguito – è che anche se regioni come la Scozia o
come il Trentino Alto Adige-Sudtirol vogliono rivendicare una propria autonomia
e libertà decisionale e di gestione delle risorse indipendentemente dai governi
centrali, queste sono profondamente europeiste e non vedono il loro futuro fuori
dall’Unione Europea”. Ma la Brexit, secondo Rossini, potrebbe essere anche
un’occasione, “vorrei che i giovani che si sono formati, che hanno lavorato non
solo nel Regno Unito ma anche nel resto dell’Europa, potessero tornare a casa e
trovare le stesse opportunità che hanno trovato altrove. È il momento di puntare
tutto sui di loro, sulle loro competenze, le nuove generazioni sono molto più
preparate, molto più consapevoli. Il vero tema da affrontare, adesso, è come far
tornare questi ragazzi che sono l’unico vero motore per il rilancio del nostro
paese”.
Il prezzo della Brexit un Regno Unito che va in frantumi.
Lanfranco Caminiti su Il Dubbio il 2 Febbraio 2020. L’emblema dei problemi che
attendono Londra è la premier scozzese Sturgeon che ha dichiarato: «Sono triste
e arrabbiata, ma certa che torneremo in Europa». Ottomila anni fa eravamo ancora
tutta una cosa – noi, l’Europa continentale, il nord e l’est Europa e la Gran
Bretagna. A piedi, partendo da Pachino, potevo arrivare fino in Irlanda e anche
più lontano. Poi, la fine dell’ultima glaciazione ci separò: si sciolsero i
ghiacci e venne fuori la Manica, e tutto il resto. Nell’Ottocento a qualcuno era
venuto in mente di ricollegare le sponde di Calais e di Dover – ma l’impresa era
davvero troppo aldilà delle tecnologie del tempo, benché l’intuizione fosse
giusta. Bisognava scavare, e fare un tunnel. Ci misero tre anni precisi per
bucare dando l’avvio ai lavori in contemporanea da una parte e dall’altra:
iniziarono l’ 1 dicembre 1987 e si ricongiunsero l’ 1 dicembre 1990: tra i due
scavi, c’era una differenza di 58 millimetri, un’inezia. Poi, ci vollero altri
anni per completare l’opera e nel 1994 la regina Elisabetta e il presidente
Mitterrand inaugurarono il Channel Tunnel – che comunemente chiamiamo
Eurotunnel. Già, eurotunnel: una cosa che solo a nominarla oggi suona come una
bestemmia. Perché oggi è il primo giorno della fine di una nuova glaciazione, la
Brexit, e la Manica sembra più larga che mai. Chi mai proporrebbe oggi
un’impresa come il Channel Tunnel? La più infuriata, triste ma infuriata – sad,
overwhelmingly, angry – è Nicola Sturgeon, primo ministro scozzese e leader
dello Scottish National Party, perché gli scozzesi si trovano coinvolti e
travolti da qualcosa che non volevano e contro la quale hanno votato
ripetutamente: al tempo del referendum il Remain fu più elevato del Leave e alle
ultime votazioni, che hanno consacrato la pervicacia di Boris Johnson e il suo
percorso di addio all’Europa, l’unico posto in cui ai Tories le hanno suonate è
stato proprio la Scozia, e in modo evidente, visto che l’SNP ha preso qualcosa
come il 45 percento dei voti. Ma la decisione del voto e di Westminster è
vincolante anche per gli scozzesi. A meno che. Dice ancora la Sturgeon: « We’re
determined that there should come some hope for Scotland to have the choice to
go down this path to one day – hopefully in the not too distant future – to get
back to the heart of Europe / siamo convinti che ci sarà per la Scozia la
possibilità di rifare questo percorso e tornare nel cuore dell’Europa». E
aggiunge: « As an independent country ». La Sturgeon da tempo chiede la
possibilità di indire un nuovo referendum – quello precedente nel 2014 finì con
la vittoria del No, ma – argomentano gli indipendentisti – al tempo si votò in
una condizione completamente diversa da adesso, perché eravamo dentro l’Europa e
il Si poteva essere inteso come un distacco dall’Europa, ma ora è tutto
cambiato. Solo che per indire il referendum ci vuole il consenso del parlamento
di Westminster, dato che non sta nei poteri e nelle autonomie del governo
scozzese, e Boris Johnson ha già detto, che non se ne parla proprio. Tra le
fibrillazioni scozzesi, e l’inizio di analoghe questioni nel Galles, e,
soprattutto, quelle irlandesi, perché da oggi la frontiera più vicina e reale
tra la Gran Bretagna e l’Europa è quella che passa tra l’Irlanda del Nord (
sotto il governo inglese) e la Repubblica d’Irlanda e una dinamica che porrà con
più forza la logica della riunificazione – la Brexit corre il rischio d’essere
l’inizio di un processo di frantumazione politica del Regno unito. E tutto
iniziò con David Cameron – un tempo neppure troppo lontano – il leader dei
tories che, dopo aver vinto, appunto, il referendum scozzese nel 2014, si
convinse che poteva vincerne un altro, quello sulla permanenza o meno in Europa.
Nella sua campagna di rielezione, nel 2013, aveva fatto largo uso di formule
euro- scettiche – magari era solo l’eredità delle trattative thatcheriane. Il
nodo era soprattutto quello dell’immigrazione, anche perché intanto Nigel Farage
soffiava sul fuoco. Cameron promise ai suoi elettori che se l’Europa non avesse
voluto trattare avrebbe indetto un referendum. Al referendum, la sua posizione
era per il Remain, ma intanto s’era scoperchiato il vaso di Pandora e la
propaganda anti- euro ebbe la meglio: Farage, che non è mai riuscito a
conquistare un seggio a Westminster per sé e il suo Ukip, ebbe la meglio. Poi
Cameron si dimise e arrivò Theresa May, anche lei in una posizione difficile, a
capo di un governo che doveva trattare la Brexit ma intimamente convinta del
Remain. E poi arrivò Boris Johnson. « We want you to stay » – ripete come un
mantra Jill Morris, l’ambasciatrice britannica. Vogliamo che restiate. Ci sono
circa 700mila italiani in Gran Bretagna, che lavorano, creano ricchezza. Ci sono
migliaia di studenti nelle università britanniche. «Non cambierà nulla»,
assicura la Morris, e di certo questo è vero fino al 31 dicembre di quest’anno –
che è la data definitiva della separazione. Anzi, fino a giugno, perché gli
accordi dovrebbero essere ratificati entro giugno ( si parla di accordi
commerciali, sulla sicurezza, sulla scienza e l’istruzione). E dopo? Dopo, c’è
lo spettro del “No deal” – una separazione burrascosa, senza uno straccio di
accordo. Boris Johnson già parla di un “sistema a punti” per gli ingressi, sul
modello australiano. Tu sì, tu no. Beh, potremmo sempre emigrare in Scozia o in
Irlanda, appena che saranno indipendenti.
L. Del. per
“la Verità” il 5 febbraio 2020. Non solo i gioielli imprenditoriali. Anche il
patrimonio immobiliare di lusso e con valore storico-artistico sta passando in
mani straniere. Magnati americani, ricchi cinesi, paperoni asiatici, inglesi
pronti a fuggire a causa della Brexit, imprenditori del Nord Europa, oligarchi
russi: sono tutti a caccia di dimore di pregio italiane, favoriti da una
tassazione che invece penalizza i proprietari del nostro Paese. Il meccanismo
fiscale è tale che gli acquirenti stranieri sono incentivati ad acquistare
mentre chi possiede tali beni non vede l' ora di disfarsene perché strangolato
dalle imposte e senza alcun aiuto da parte dello Stato. Negli ultimi dieci anni
gli immobili di lusso hanno subito una perdita del valore pari al 30% e questo
ha intensificato gli appetiti di facoltosi stranieri che anche per poche
centinaia di migliaia di euro riescono ad aggiudicarsi dimore storiche. Una
corsa all' acquisto a cui il governo dà una mano. Nel 2017 è stata introdotta
una tassazione forfettaria da 100.000 euro, una sorta di flat tax, proprio con
l' obiettivo di attirare i miliardari stranieri e far entrare capitali. Chi ha
un alto livello economico e vuole trasferire nel Bel Paese la residenza fiscale
può usufruire di un' imposta sostitutiva sui redditi prodotti all' estero con un
forfait di 1000.000 euro per ciascun periodo d' imposta per cui viene
esercitata. Questo regime impositivo può essere trasmesso anche ai familiari che
così godono di un' imposta pari a 25.000 euro. Non a caso le richieste di
acquisti immobiliari, secondo gli operatori del settore, stanno crescendo a un
ritmo del 30% l' anno. Alessia Giammello, responsabile della sede di Milano
dell' agenzia Dimore italiane, specializzata in real estate di lusso, dice: «La
spinta a vendere è dovuta essenzialmente alla combinazione di alte tasse e alti
costi di manutenzione. Anche se è un' abitazione principale, l' Imu si paga
ugualmente ed è onerosa. Le spese per le ristrutturazioni sono pesanti specie se
c' è un vincolo artistico e ottenere finanziamenti è complicato». E fa alcuni
esempi di recenti cessioni, come una villa del 1800 con vista sul lago Maggiore
acquistata da un austriaco per 700.000 euro ma «che aveva bisogno di interventi
edili importanti». Le richieste, spiega Giammello, si concentrano soprattutto
tra la Toscana e Milano. Per il capoluogo lombardo «non riusciamo a star dietro
alle richieste. Si va da interi stabili storici, alle ville liberty del 1900».
Francesco Tesi, responsabile del settore internazionale di Lionard luxury real
estate, con sedi a Milano, Firenze e Roma, che tratta immobili di un valore
superiore ai 2 milioni di euro, spiega che gli acquisti di dimore storiche e
immobili di extra lusso in locazioni uniche al mondo sono accelerati. «Riceviamo
circa 5.000 richieste l' anno e una buona percentuale per beni di importante
valore storico artistico. Mentre fino a qualche anno fa gli acquirenti erano
soprattutto americani, russi e arabi, ora il mercato si è aperto. A noi si
rivolgono ricchi australiani, africani e asiatici». Nel sito dell' agenzia
compare la vendita di uno chalet a Cortina per circa 10 milioni e recentemente è
stata acquistata da una famiglia di industriali tedeschi la nota Villa Capponi a
Firenze. Un imprenditore cinese si è aggiudicato per 30 milioni una villa a
Portofino che domina una delle calette più desiderate d' Italia mentre un
miliardario texano ha acquistato una villa nel Senese e ne ha fatto un punto d'
incontro per artisti. A spingere le vendite, spiega Tesi, ci sono varie
motivazioni. «Ma indubbiamente il peso delle tasse e i costi di manutenzione
sono una spinta decisiva a mettere il bene sul mercato. Un tempo gli immobili
storici non pagavano le tasse di proprietà, ora devono versare l' Imu anche se
al 50%. Pesano poi i lavori di ristrutturazione. Mentre negli anni Settanta e
Ottanta il ministero interveniva con fondi pubblici, ora, tranne piccole
partecipazioni statali, è tutto a carico del proprietario. Inoltre lo Stato non
è più nelle condizioni di esercitare il diritto di prelazione». Le vendite
corrono anche online. Secondo il portale Hello Italy, specializzato in vendite
agli stranieri, sono circa 3 milioni i cittadini d' Oltralpe alla ricerca di
immobili di pregio nel Belpaese. «Negli ultimi due anni, grazie alla flat tax,
oltre 200 clienti ultra ricchi si sono rivolti a noi per acquistare una dimora
di lusso. Sempre in questo arco di tempo le compravendite di fascia alta sono
aumentate del 50%», dice Diletta Giorgolo, responsabile delle vendite per il
Centro e Sud Italia di Italy Sotheby' s international realty. «L'euro ha
dimezzato i patrimoni e i giovani hanno ereditato beni che non sono più in grado
di mantenere con i redditi attuali. In più le tasse sono cresciute. La Brexit
sta spingendo numerosi facoltosi a lasciare Londra. Scelgono l' Italia per il
life style e le meraviglie artistiche. Un olandese ha comprato un appartamento
di 800 metri quadrati in un palazzo del Settecento a Roma e ha voluto restaurare
la facciata per restituire qualcosa alla città, ci ha detto. Alcune località
hanno avuto un vero e proprio boom dopo anni di stasi. A Capri dopo un blocco di
5 anni il mercato è ripreso. Ultimamente un francese ha acquistato una villa per
13 milioni con affaccio mozzafiato sul mare. La Sicilia è tra le più richieste».
Navigando tra i maggiori siti internet specializzati in compravendite
immobiliari di lusso, compaiono decine e decine di inserzioni. Numerose quelle
sopra al milione di euro, con punte che arrivano anche a 20 milioni. A muoversi
non sono solo i privati. Il mercato immobiliare italiano è al centro dell'
attenzione di fondi sovrani dei Paesi arabi, private equity americani, compagnie
assicurative francesi e tedesche e finanziarie cinesi. Si stima che gli
investimenti effettuati da questi colossi superino i 25 miliardi di euro. I
fondi del Qatar hanno comprato l' hotel Baglioni e l' Excelsior a Roma, lo
Starwood a Firenze, il Gritti a Venezia, il palazzo di Piazza di Spagna dell'
American Express in cui hanno piazzato la sede della maison Valentino.
“Ora Londra restituisca i marmi del partenone alla Grecia”.
Il Dubbio il 3 febbraio 2020. La proposta del direttore degli Uffizi, Eike
Schmidt. E Boris Johnson annuncia: “Saremo i Superman del libero commercio”.
«Sarebbe un bel gesto se tutti i paesi europei si mostrassero solidali con la
Grecia, e per la Brexit alla Gran Bretagna, invece che miliardi di sterline
chiedessero indietro i marmi del Partenone». Sono le parole del direttore delle
Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, il quale ha citato la richiesta, da parte
della Grecia al British museum di Londra di restituire ad Atene le parti del
celeberrimo tempio custodite a Londra. «Questo perchè l’Europa è una realtà
unita a livello culturale, innanzitutto, e non solo di commercio», ha aggiunto.
«Qualche anno fa- ha poi ricordato Schmidt – ci fu sondaggio da cui emerse che
la grande maggioranza degli inglesi era favorevole alla restituzione, ancora più
di quanti non siano stati favorevoli alla Brexit. Ora, il punto è che la Brexit
da qualche giorno è avvenuta. E il problema dei marmi del Partenone è per certi
versi un pò lo stesso che ha adesso l’Unione Europea con la Gran Bretagna: in
questo anno di negoziati che ci attende, troppo spesso al centro delle
trattative ci saranno le cifre economiche. Anche per questo sarebbe bello vedere
tutti i paesi Ue insieme per la battaglia del ritorno dei marmi ad Atene, invece
che a discutere solo di sterline». Nelle stesse ore Boris Johnson pronunciava un
discorso di fuoco sul negoziato con l’Ue del post Brexit immaginando il Regno
Unito come Superman che smette le vesti di Clark Kent. Insomma, il premier
britannico guarda al futuro del suo paese come a quello di un supereroe che –
subita la trasformazione -diventa «campione potenziato» del libero commercio e
non ha bisogno di accettare le norme Ue in sede di negoziato sui suoi futuri
rapporti con Bruxelles.
Effetto Brexit, appare il volantino razzista: “Parlate inglese
o tornate a casa, così non infettate il Paese”.
Redazione de Il Riformista il 3 Febbraio 2020. “Qui da oggi si parlerà solo
inglese. Altrimenti tornatevene a casa vostra, così non infetterete più il
nostro Paese”. Queste parole sono apparse su volantini affissi in tutti i piani
di un condominio popolare di Norwich, in Inghilterra. Sono passati solo pochi
giorni dall’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea eppure gli effetti si
fanno già sentire. A poche ore dall’ufficialità della Brexit, infatti, basta un
messaggio razzista a scatenare polemiche già accese. La lettera scritta
nell’edificio “Winchester Tower” si chiama “Happy Brexit Day”, felice giorno
della Brexit. A riportare la notizia e l’Indipendent, che ha raccolto lo scatto
divenuto subito virale sui social. Il consiglio comunale a nord-est di Londra si
è espresso sulla vincendo commentando la loro indignazione e intolleranza nei
confronti di questi messaggi discriminatori: “La nostra città è stata sempre
accogliente e generosa e non permetteremo simili messaggi di intolleranza”. “Qui
da oggi si parlerà l’inglese della Corona”, recita il testo, “finalmente
torneremo un gran Paese. Una regola che dovrà essere chiara d’ora in poi: è che
si dovrà parlare inglese in questo condominio. Se invece vorrete continuare a
parlare la vostra lingua madre, quella del Paese da dove venite, potete allora
tornarvene a casa e restituire l’appartamento al Comune che così potrà
concederlo alle famiglie britanniche e potremo tornare alla normalità prima che
voi infettaste la nostra grande nazione”. La polizia britannica è subito
intervenuta in merito classificando il messaggio come un “crimine ignoto” e si è
messa a caccia dell’autore. Lo sdegno delle autorità di Norwich si è unito a
quello dei social, con alcuni utenti che accusano la Brexit di liberare, sempre
di più, istinti razzisti e xenofobi. Secondo i media locali, nel condominio
abitano diverse famiglie dell’Est Europa.
Da repubblica.it il 3 febbraio 2020. Qui da oggi si parlerà solo inglese.
Altrimenti tornatevene a casa vostra, così non infetterete più il nostro Paese".
A poche ore dall'ufficialità della Brexit, un messaggio razzista scuote il Regno
Unito. Da venerdì, ultimo giorno della Gran Bretagna nella Ue, in un condominio
popolare di Norwich, in Inghilterra, sono iniziati a spuntare dei fogli A4
appesi a tutti i piani dell'edificio "Winchester Tower". La "lettera aperta" si
chiama "Happy Brexit Day", "felice giorno della Brexit". E il testo sotto il
titolo è inquietante. "Qui da oggi si parlerà l'inglese della Corona", recita il
messaggio anonimo presumibilmente postato da un residente del condominio,
"finalmente torneremo un gran Paese. Una regola che dovrà essere chiara d'ora in
poi", continua il testo, "è che si dovrà parlare inglese in questo condominio.
Se invece vorrete continuare a parlare la vostra lingua madre, quella del Paese
da dove venite, potete allora tornarvene a casa e restituire l'appartamento al
Comune che così potrà concederlo alle famiglie britanniche e potremo tornare
alla normalità prima che voi infettaste la nostra grande nazione". Subito è
intervenuta la polizia britannica, che ha classificato il messaggio come un
"crimine ignoto" e si è messa a caccia dell'autore, che resta per ora anonimo.
Sdegno delle autorità di Norwich. Il Comune ha detto che "la nostra città è
stata sempre accogliente e generosa e non permetteremo simili messaggi di
intolleranza". Indignazione sui social network, con alcuni utenti che accusano
la Brexit di liberare, sempre di più, istinti razzisti e xenofobi. Secondo i
media locali, nel condominio abitano diverse famiglie dell'Est Europa.
Antonello Guerrera per repubblica.it il 29 ottobre 2020. Il
Labour di Jeremy Corbyn è stato responsabile "di discriminazione e vessazione"
nei confronti di membri ed iscritti al partito ebrei. "C'era una cultura nel
partito laburista che, nel migliore dei casi, non ha fatto abbastanza per
prevenire l'antisemitismo e, nel peggiore, sembrava accettarlo". È il verdetto,
pesante come un macigno, della Commissione dei Diritti Umani britannica sul
Labour governato dall'anziano leader socialista, dimessosi sei mesi fa, che
getta nuove profonde ombre dopo le tante accuse negli anni scorsi e che
stamattina ha già provocato un terremoto: il nuovo capo del Labour Sir Keir
Starmer ha infatti deciso di silurare il suo predecessore, sospendendolo,
umiliandolo pubblicamente e praticamente addossandogli tutte le responsabilità.
Ma l'ex leader, 71 anni, ha risposto subito su Twitter: "Mi opporrò duramente
alla mia sospensione. Ho sempre criticato chiunque negasse ci fosse un problema
di antisemitismo nel partito. Non ho mai tollerato e mai tollererò ogni forma di
razzismo". Una vicenda esplosiva. Dopo molti mesi di lavoro, le denunce per
"antisemitismo" di decine di attivisti laburisti ebrei e l'abbandono di diversi
deputati di religione ebraica "disgustati da ciò che avveniva nel partito" come
Luciana Berger, la Commissione stamani ha stabilito che il Labour ha infranto
tre punti della legge "Equality Act", che difende i diritti umani. Il primo:
"harassment", ossia vessazione e creazione di un ambiente ostile, in questo caso
per diversi membri del partito di religione ebraica. Secondo: interferenze
politiche nelle denunce interne per antisemitismo, ossia, per la Commissione,
l'ufficio dello stesso leader Corbyn e altre massime autorità del partito
avrebbero cercato di insabbiare i casi sospetti o comunque prendere decisioni
prima di un'inchiesta interna. Terzo: coloro che si sono occupati delle
inchieste interne per antisemitismo non erano stati sufficientemente istruiti
dal partito per poter gestire casi simili. Ne viene fuori un ritratto
disarmante. Secondo la Commissione, il partito, nella migliore delle ipotesi, ha
commesso perlomeno "numerosi errori" nella gestione interna delle accuse di
antisemitismo. Ora il Labour, dopo la "condotta illegale" delineata
dall'organismo anti-discriminazioni, ha sei settimane di tempo per presentare
pubblicamente un piano per rimediare. "È il nostro giorno della vergogna. Chiedo
vivamente scusa per il dolore che il mio partito ha causato", è stato il
commento a caldo dell'attuale leader laburista Sir Keir Starmer, ex ministro
ombra della Brexit con Corbyn ma che sin dall'inizio della sua "reggenza" ha
cercato di ricucire i rapporti con la comunità ebraica, andandola a visitare
poche ore dopo la sua elezione. "Le conclusioni del rapporto sono chiare e
nette", ha aggiunto Starmer, "ci sono stati errori da parte della leadership",
riferendosi a Corbyn, "che hanno provocato una cesura tra il partito e la
comunità ebraica. Sono costernato per tutto ciò che questo ha provocato. Abbiamo
profondamente deluso la comunità ebraica". "Mi riterrò soddisfatto solo il
giorno in cui il Labour non sarà più associato alla parola antisemitismo: ma la
strada è lunga. Chi ha negato questo problema, è parte del problema" ha poi
dichiarato Starmer, riferendosi ancora evidentemente al suo predecessore Jeremy
Corbyn, il quale subito dopo la sentenza aveva pubblicato nel frattempo un post
su Facebook che stava già facendo discutere: "L'antisemitismo è una cosa orrenda
e responsabile dei peggiori crimini dell'umanità. Certo che l'antisemitismo c'è
stato nel partito come in ogni fetta della società, ma come leader del partito
laburista ho sempre lottato contro ogni forma di razzismo e per estirpare il
cancro antisemita. Le "interferenze" di cui parla il rapporto erano per
accelerare le inchieste interne sui presunti casi di discriminazione, non per
insabbiarle". Corbyn ha poi affondato il colpo: "La misura del problema è stata
fortemente esagerata da oppositori all'interno e all'esterno del partito, nonché
dai media, per ragioni politiche". Poco dopo, Starmer ha sospeso Corbyn.
Inizialmente, durante una breve conferenza stampa, l'attuale leader aveva sviato
tutte le domande a tema: "La Commissione si concentra su comportamenti
collettivi nel partito, non individuali". In realtà non è affatto così, perché
per prassi l'organismo non si occupa delle singole persone all'interno di
un'organizzazione politica, ed è quest'ultima che deve decidere i provvedimenti
personali nei confronti dei suoi membri. Anche per questo, poi Starmer ha fatto
dietrofront e ha deciso di defenestrare, fino a una nuova inchiesta interna, il
suo ex leader. Come era intuibile, il rapporto e la sospensione di Corbyn ora
potrebbero scatenare una nuova battaglia nel partito. Molti "corbyniani", e non
sono certo pochi nel partito, da tempo credono che lo scandalo antisemitismo sia
in realtà un complotto ordito dall'ala centrista-blairiana del Labour che non ha
mai digerito un leader socialista, vecchio stampo e controverso
(sull'antisemitismo ma anche sulla politica estera) come Corbyn. Ora Starmer
dovrà cercare una complicatissima, forse impossibile, sintesi tra le anime dei
laburisti. "È un verdetto schiacciante che dimostra come gli ebrei britannici
fossero a disagio", hanno dichiarato le associazioni ebraiche "Board of Deputies
of British Jews" e "Jewish Leadership Council", "la nostra comunità non sarebbe
mai voluta arrivare a questo scontro con il Labour: ma ci siamo dovuti difendere
e siamo orgogliosi di averlo fatto. Ringraziamo tutti coloro che ci sono stati
vicini, nonostante le offese e le minacce ricevute. Jeremy Corbyn è stato
giustamente incolpato per ciò che ha fatto al Labour e agli ebrei, ma la verità
è forse più scioccante: Corbyn è stato più di un volto di facciata di nuove e
vecchi attitudini antisemite. Apprezziamo gli sforzi del nuovo leader Starmer,
ma la sfida che ha di fronte è notevole". Mentre il Jewish Labour Movement parla
di "un capitolo sordido, vergognoso nella storia del nostro partito, di cui è
pienamente responsabile la leadership" di Corbyn. Le accuse di antisemitismo nel
partito laburista sono esplose nel 2016, quando l'ex sindaco di Londra Ken
Livingstone "il rosso" (dell'ala socialista radicale) in un'intervista citò il
post su Facebook di un'altra collega del Labour, la deputata Naz Shah, che
auspicava la "ricollocazione di Israele negli Stati Uniti d'America" per
"risolvere il problema in Medio Oriente". Da allora, sono emersi sempre più casi
di sospetto o palese antisemitismo che hanno travolto il partito allora guidato
da Corbyn, spesso accusato di negligenza se non complicità, fino a un
documentario della Bbc nel luglio 2019 in cui otto ex impiegati del partito
parlarono di sistematici insabbiamenti di casi sospetti antisemiti e di "un
clima irrespirabile per gli ebrei". Macchie sul Labour che, in ogni caso,
rimarranno visibili per ancora molto tempo.
Il rapper
Stormzy: "La Gran Bretagna è razzista al 100 percento". Ma il governo: si
sbaglia.
Stormzy e Ghali insieme per la prima volta per "Il Venerdì" di
Repubblica. Rimbalza sui giornali londinesi la dichiarazione al Venerdì di
Repubblica del cantante britannico. Che dà la colpa al premier Johnson:
"Incoraggia l'odio". La Repubblica il 21 dicembre 2019. "La Gran Bretagna resta
ed è sempre più un paese razzista". Questa dichiarazione del famoso rapper
Stormzy, al corrispondente da Londra di Repubblica, Antonello Guerrera,
nell'intervista pubblicata questa settimana dal Venerdì, è rimbalzata con grande
risalto sui maggiori quotidiani britannici di stamani. "I commenti razzisti di
Boris Johnson hanno incoraggiato la gente all'odio etnico", scrive
il Guardian citando l'articolo di Repubblica. "L'attivista laburista Stormzy
lancia un nuovo attacco sostenendo che il Regno Unito è assolutamente razzista",
titola il Daily Mail, tabloid che ha appoggiato i conservatori nelle recenti
elezioni e la Brexit. Anche il Sun, l'Independent, la rete televisiva Sky e il
sito di news Politico, fra gli altri, riportano ampi stralci dell'intervista.
"La Gran Bretagna è razzista al 100 percento, anche se è un razzismo nascosto",
afferma Stormzy nella parte del servizio apparso sul Venerdì di Repubblica e
riportato dal Guardian. "La gente dice: oh no, non siamo razzisti. Ma in realtà
c'è un sacco di razzismo nel nostro paese. La differenza è che in Italia è un
problema evidente, mentre è estremamente difficile provare a spiegare che anche
la Gran Bretagna è razzista. Molti dicono: non è vero. Stormzy ha successo. A
Londra ci sono un mucchio di neri". Il quotidiano londinese cita poi il cantante
quando dice che il premier Johnson, con le parole che ha spesso usato nei
confronti dei neri, ha reso più accettabile per l'opinione pubblica esprimere
sentimenti razzisti. "Se l'uomo al comando può dire che le donne musulmane
sembrano cassette della posta per le lettere, incoraggia gli altri all'odio
(razziale, ndr.). Prima la gente si sentiva obbligata a nasconderlo, ora non
più". Il Guardian ricorda che nei giorni scorsi Stormzy è stato criticato dal
conduttore televisivo Piers Morgan per avere detto a un gruppo di scolaretti che
Boris Johnson è "un uomo cattivo". Lui ha risposto: "Un bambino mi ha fatto una
domanda sul premier e io ho detto quello che penso, non mi pare ci sia niente di
male".
Da ilfattoquotidiano.it il 23 febbraio 2020. Molti si chiedono se il processo di
uscita dalla Gran Bretagna dall’Ue sia un “bluff” di un governo di destra
conservatore. Molti di noi, europei residenti in Inghilterra, si sono già resi
conto che invece si tratta di un definitivo verdetto: un paese che
stabilisce regole severe per gli stranieri ma che decide di essere molto più
indulgente nei confronti di merci e capitali. Per comprendere fino in fondo
l’annuncio degli scorsi giorni riguardo la nuova gestione delle frontiere con il
sistema a punti è necessario fare riferimento alle dichiarazioni del premier
britannico dell’inizio del mese di febbraio: “Il Regno Unito sarà il Superman
del libero scambio". Infatti, questo governo rivendica la liberazione dai
trattati e dalle leggi europee come la più grande conquista degli ultimi anni.
Questa narrazione si dimostra però ipocrita nella realtà: per fare un esempio,
il Financial Times riporta che il governo inglese ha fatto richiesta per
un finanziamento dal “solidarity fund” dell’Unione europea per far fronte ai
danni dovuti alle alluvioni dello scorso dicembre (una soluzione “last minute”
per beneficiare fino all’ultimo della membership europea tanto ostracizzata).
Dunque, se con la Brexit il Regno Unito si riappropria del controllo dei propri
confini (a un punto tale che l’attuale ministra dell’Interno Priti Pratel ha
ammesso che i suoi genitori indiani non sarebbero potuti entrare nel paese con
questo nuovo sistema), allo stesso tempo intende accelerare un processo di
‘de-regulation’ del mercato interno. Un’apertura asimmetrica che potrebbe far
diventare la Gran Bretagna un paradiso fiscale nell’ambito dell’enclave europea.
E allora questa Brexit più che ripresa della sovranità nazionale sembra sia
stata una brillante occasione colta dal vento maggioritario sovranista per
perseguire un progetto di società basata sul privilegio, l’esclusività, sul mito
dei consumi fini a se stessi e su una sempre maggiore sperequazione delle
risorse. Progetto che in realtà, indipendentemente dalla Brexit, si sta
realizzando da decenni nel paese. Per fare qualche esempio, il
sindacato “University and College Union” (UCU) ha organizzato per il terzo anno
di fila un massiccio sciopero contro la precarizzazione del lavoro e
l’abbassamento delle pensioni del corpo docenti. Decine di università nel paese
hanno bloccato l’attività didattica e l’accesso agli istituti con picchetti
all’ingresso. Contemporaneamente, da anni il sistema nazionale sanitario è in
crisi per mancanza di posti letto e personale – situazione che la Brexit ha
certamente peggiorato. Durante la scorsa campagna elettorale Jeremy Corbyn ha
reso pubblici documenti ufficiali che provavano il piano di Boris Johnson
post-Brexit sul tema sanità: la privatizzazione della settore con la vendita del
“National Healthcare System” a delle multi nazionali americane. L’idea di
società proposta dal governo conservatore ha una coerenza interna molto chiara e
la Brexit ne rappresenta il lasciapassare per realizzarla. La ripresa della
sovranità nazionale è fittizia ed è evidente che la stessa democrazia è in
crisi. In questo contesto storico le giovani generazioni hanno il diritto e il
dovere di reagire, opponendosi a questo modello di società proposto dal partito
conservatore. La chiusura dei confini per i migranti porterà a
conseguenze disastrose per la vita di milioni di europei (e non europei) che
hanno costruito (o vorrebbero costruire) la propria vita nel Regno Unito.
Brexit, il conto è salato: al Regno Unito è già costata 200
miliardi di sterline. Le stime di Bloomberg: ancora
prima di essere definitivamente fuori dall'Europa, Londra avrebbe già bruciato
l'equivalente dei contributi versati a Bruxelles nei 47 anni di appartenenza
all'Ue. Antonello Guerrera il 28 febbraio 2020 su La Repubblica. Premesso che
nessuno sa come andrà a finire la Brexit oppure se sarà benefica o malefica per
il Regno Unito (e per l'Ue), c'è già chi ha calcolato il costo dell'uscita
dall'Ue per il Regno Unito: secondo un'analisi di Bloomberg Economics, il conto
sarebbe di almeno 200 miliardi di sterline. In pratica, Londra avrebbe già
bruciato più o meno l'equivalente dei contributi versati a Bruxelles nei 47 anni
di appartenenza all'Ue (1973-2020): una cifra che, secondo i calcoli dalla
Biblioteca della Camera dei Comuni di Londra, sarebbe di 215 miliardi. Lo studio
di Bloomberg che risale al mese scorso ma che oggi è stato "riesumato" da un
paio di giornalisti parlamentari britannici sostiene che, per colpa della
Brexit, negli ultimi anni il Regno Unito ha perso il 3% del Prodotto interno
lordo, per un totale di 130 miliardi di sterline. Per la precisione: 451 milioni
nel 2016, l'anno del referendum che ha sancito l'uscita dall'Ue, 21,7 miliardi
l'anno successivo, 47,2 miliardi nel 2018 e 63,3 miliardi nel 2019. Ma non è
finita: la stima di Bloomberg per il 2020 parla di almeno 70,3 miliardi di
perdite per il Regno Unito, per un totale, dal 2016, di circa 200 miliardi. E le
cose potrebbero addirittura peggiorare nel 2021, anno in cui Londra
sarà definitivamente fuori dall'Ue (ora è in un periodo di transizione in cui si
applicano ancora le norme europee): perché, perlomeno a breve termine, ci
potrebbero essere ripercussioni produttive e commerciali nell'addio - non si sa
ancora quanto duro - al sistema economico europeo. Il problema,
secondo Bloomberg Economics e l'autore dello studio Dan Hanson, è l'incertezza
di questi ultimi anni oltremanica che avrebbe generato "molti meno investimenti
di quanto vi sarebbero stati in caso di appartenenza all'Ue", oltre alla fuga di
vari imprenditori spaventati dal limbo, come ha dimostrato qualche tempo fa
anche uno studio di Ernst e Young che ha addirittura quantificato in
un triliardo di sterline la perdita potenziale e totale di asset in Regno Unito.
Secondo Bloomberg, queste circostanze avrebbero abbassato la crescita britannica
dal circa 2% all'anno all'1%, ovvero la metà. E la forbice potrebbe continuare.
Per il prossimo trimestre, infatti, la stima dell'agenzia di stampa anglosassone
è di 525 miliardi di Pil prodotti da Uk contro i 541 calcolati in caso di
permanenza in Ue. Tuttavia, secondo un recente studio del Fondo monetario
internazionale, il Regno Unito potrebbe crescere comunque di più di Francia
e Germania nonostante la Brexit, qualora dovesse strappare un accordo favorevole
nelle prossime trattative con l'Ue. Ecco perché ora siamo a un punto decisivo.
Dal 1 marzo, infatti, inizieranno i delicatissimi negoziati tra Regno Unito ed
Unione Europea sui rapporti futuri tra i due blocchi, che decideranno il destino
economico e geopolitico di buona parte dell'Occidente. Sinora, ci sono grosse
divergenze tra Ue e Uk soprattutto su concorrenza, standard ambientali e
lavorativi, finanza e pesca. Due giorni fa il governo del premier britannico
Boris Johnson ha assicurato che il Regno Unito mollerà i negoziati già in giugno
(la scadenza è dicembre 2020) qualora Londra non dovesse riscontrare progressi
nelle trattative. A quel punto sarebbe certo un "No Deal", una uscita "senza
accordo" di Uk dall'Ue, che potrebbe avere conseguenze economiche gravissime per
la Gran Bretagna ma anche per l'Europa.
Antonello Guerrera per repubblica.it il 29 marzo 2020. Premesso
che nessuno sa come andrà a finire la Brexit oppure se sarà benefica o malefica
per il Regno Unito (e per l'Ue), c'è già chi ha calcolato il costo dell'uscita
dall'Ue per il Regno Unito: secondo un'analisi di Bloomberg Economics, il conto
sarebbe di almeno 200 miliardi di sterline. In pratica, Londra avrebbe già
bruciato più o meno l'equivalente dei contributi versati a Bruxelles nei 47 anni
di appartenenza all'Ue (1973-2020): una cifra che, secondo i calcoli dalla
Biblioteca della Camera dei Comuni di Londra, sarebbe di 215 miliardi. Lo studio
di Bloomberg che risale al mese scorso ma che oggi è stato "riesumato" da un
paio di giornalisti parlamentari britannici sostiene che, per colpa della
Brexit, negli ultimi anni il Regno Unito ha perso il 3% del Prodotto interno
lordo, per un totale di 130 miliardi di sterline. Per la precisione: 451 milioni
nel 2016, l'anno del referendum che ha sancito l'uscita dall'Ue, 21,7 miliardi
l'anno successivo, 47,2 miliardi nel 2018 e 63,3 miliardi nel 2019. Ma non è
finita: la stima di Bloomberg per il 2020 parla di almeno 70,3 miliardi di
perdite per il Regno Unito, per un totale, dal 2016, di circa 200 miliardi. E le
cose potrebbero addirittura peggiorare nel 2021, anno in cui Londra sarà
definitivamente fuori dall'Ue (ora è in un periodo di transizione in cui si
applicano ancora le norme europee): perché, perlomeno a breve termine, ci
potrebbero essere ripercussioni produttive e commerciali nell'addio - non si sa
ancora quanto duro - al sistema economico europeo. Il problema, secondo
Bloomberg Economics e l'autore dello studio Dan Hanson, è l'incertezza di questi
ultimi anni oltremanica che avrebbe generato "molti meno investimenti di quanto
vi sarebbero stati in caso di appartenenza all'Ue", oltre alla fuga di vari
imprenditori spaventati dal limbo, come ha dimostrato qualche tempo fa anche uno
studio di Ernst e Young che ha addirittura quantificato in un triliardo di
sterline la perdita potenziale e totale di asset in Regno Unito. Secondo
Bloomberg, queste circostanze avrebbero abbassato la crescita britannica dal
circa 2% all'anno all'1%, ovvero la metà. E la forbice potrebbe continuare. Per
il prossimo trimestre, infatti, la stima dell'agenzia di stampa anglosassone è
di 525 miliardi di Pil prodotti da Uk contro i 541 calcolati in caso di
permanenza in Ue. Tuttavia, secondo un recente studio del Fondo monetario
internazionale, il Regno Unito potrebbe crescere comunque di più di Francia e
Germania nonostante la Brexit, qualora dovesse strappare un accordo favorevole
nelle prossime trattative con l'Ue. Ecco perché ora siamo a un punto decisivo.
Dal 1 marzo, infatti, inizieranno i delicatissimi negoziati tra Regno Unito ed
Unione Europea sui rapporti futuri tra i due blocchi, che decideranno il destino
economico e geopolitico di buona parte dell'Occidente. Sinora, ci sono grosse
divergenze tra Ue e Uk soprattutto su concorrenza, standard ambientali e
lavorativi, finanza e pesca. Due giorni fa il governo del premier britannico
Boris Johnson ha assicurato che il Regno Unito mollerà i negoziati già in giugno
(la scadenza è dicembre 2020) qualora Londra non dovesse riscontrare progressi
nelle trattative. A quel punto sarebbe certo un "No Deal", una uscita "senza
accordo" di Uk dall'Ue, che potrebbe avere conseguenze economiche gravissime per
la Gran Bretagna ma anche per l'Europa.
Da ilmessaggero.it il 19 febbraio 2020. Stop ai nuovi immigrati «a bassa
qualificazione». Il Regno Unito si prepara dal 2021 a sbarrare gli ingressi,
dopo la fine della transizione post Brexit, ai nuovi immigrati non a loro agio
con la lingua inglese: inclusi quelli che dall'anno prossimo busseranno alle
porte dell'isola dai Paesi dell'Ue. È l'obiettivo del modello a punti di tipo
«australiano» annunciato da tempo dal governo di Boris Johnson, secondo i
dettagli illustrati dalla ministra dell'Interno, Priti Patel, falco della destra
Tory appena confermata nell'incarico. Stando ai piani governativi, il visto di
lavoro destinato ad essere introdotto a regime dopo la Brexit potrà essere
concesso solo ai richiedenti - europei e non - che abbiano un minimo di 70
punti. E i punti verranno attribuiti (10 o 20 per voce) soltanto a chi avrà già
in mano offerte di lavoro da 25.000 sterline l'anno in su, titoli di studio
specifici (come Phd), qualificazione per settori con carenza occupazionale nel
Regno Unito e conoscenza dell'inglese. Le opposizioni hanno contestato questa
strategia, sostenendo che il modello australiano filtra ma incoraggia
l'immigrazione, mentre questa versione minaccia di scoraggiarla tout court. Il
Labour ha chiesto di assicurare almeno delle eccezioni in settori strategici
quali la sanità, dove i ruoli infermieristici sono coperti attualmente in buona
parte da stranieri. Mentre i Liberaldemocratici hanno accusato il governo di
«xenofobia». La Confindustria britannica, a nome degli imprenditori, ha da parte
sua elogiato alcuni aspetti dell'annunciata riforma ma non senza riserve sui
rischi di limitazione nel reperimento della forza lavoro da parte del business.
Patel ha però replicato che il mondo dell'impresa potrà contare ancora sugli
oltre 3 milioni di cittadini Ue che già lavorano nel Regno (non toccati dalle
nuove regole); e per il resto dovranno «abbandonare la ricerca del lavoro a
basso costo» degli immigrati, investendo piuttosto nello sviluppo di «tecnologie
per l'automazione».
Brexit,
stretta sui visti di lavoro. È crisi sui marmi del Partenone: Gb non li
restituirà alla Grecia.
Redazione de Il Riformista il 19 Febbraio 2020. Arrivano le novità della Brexit.
Tra le più temute le strette sui lavoratori immigrati in Gran Bretagna. I primi
ad essere colpiti dal nuovo sistema per l’immigrazione sono “I lavoratori poco
qualificati” a scapito delle “menti brillanti”. Verranno attribuiti dei punti in
base alle competenze linguistiche, alle qualifiche e ai livelli salariali di
ciascun lavoratore. I visti di lavoro, dunque, non saranno più accordati a
coloro che non ottengono punti sufficienti che per ora hanno una soglia fissata
a 70 punti. Lavoratori altamente qualificati non avranno problemi ad
accaparrarsi il punteggio necessario per ottenere il visto. Più complicato sarà
averlo per la migiaia di baristi, camerieri e lavoratori meno qualificati che
fin ora hanno popolato l’Inghilterra, magari anche solo con l’idea di imparare
la lingua e fare un’esperienza. Il nuovo sistema dovrebbe entrare in vigore
il primo gennaio 2021, dopo il periodo di transizione iniziato il 31 gennaio di
quest’anno. L’ Inghilterra è decisa a chiudere con l’Europa. E delle opere
d’arte confluite negli anni in Gran Bretagna da tutta Europa cosa ne sarà? Il
caso si è creato sui marmi del Partenone contenuti nel British Museum. Una
disputa che dura da anni tra Grecia, che vorrebbe riaverli e Gran Bretagna che
da quando Lord Elgin li rimosse dall’Acropoli nel XIX secolo non vuole più
restituirli. Sull’argomento spunta una bozza di un mandato negoziale dell’Unione
Europea sottoscritto da autorevoli diplomatici europei. Una clausola afferma
che “le Parti, coerentemente con le norme dell’Unione, affrontano le questioni
relative al ritorno o alla restituzione di oggetti culturali rimossi
illegalmente nei propri Paesi di origine”. Ma il British Museum non ne vuole
sapere e il governo inglese lo appoggia: è responsabilità legale del Museo e non
è argomento discutibile nel contesto di negoziati commerciali. La faccenda ha
sempre bruciato ai greci e il ministro della Cultura greco ha già intensificato
la sua campagna per il ritorno dei Marmi del Partenone da Londra, aspettandosi
l’appoggio dell’Europa sulla questione. Il British Museum afferma che i marmi
furono acquisiti da Lord Elgin con un contratto legale con l’impero ottomano. La
Grecia dice che sono stati rubati.
Una Brexit
estrema: entra solo chi parla inglese e mano d’opera qualificata.
Il Dubbio il 19 febbraio 2020. Il piano del governo Johnson in vigore nel 2021.
Per entrare bisogna avere un lavoro da almeno 26mila sterline l’anno. Non
verranno più accettate carte di identità. Addio giovani lavapiatti e camerieri
che sbarcano a Londra con la loro valigia piena di sogni e di olio di gomito.
La Gran Bretagna post Brexit chiuderà le porte ai lavoratori non qualificati e a
chi non parla inglese, chiudendo oltre alle proprie porte anche un era. Sono
queste le nuove linee sull’immigrazione presentate dal governo di Boris
Johnson, basate su un sistema a punti simile a quello australiano. Fra le misure
elencate sul sito del Guardian viene anche specificato che alla frontiera non
verranno più accettate carte d’identità di paesi come Francia e Italia. Secondo
il quotidiano il motivo è di evitare che lavoratori extra Ue ingannino il
sistema con carte d’identità falsificate. Nel presentare il nuovo sistema per i
visti dei lavoratori stranieri che entrerà in vigore a gennaio 2021 dopo la fine
dell’attuale periodo transitorio, il governo conservatore ha voluto sottolineare
che si tratta di una opportunità unica per prendere «il pieno controllo» dei
confini britannici «per la prima volta in decenni» ed eliminare «le distorsioni»
delle regole europee di libertà di movimento. Ma la scelta di aprire le porte
solo a lavoratori qualificati, scrive il Guardian, non piace agli industriali
che avvertono del rischio di conseguenze «disastrose» con perdite di posti di
lavoro e chiusura di fabbriche, bar e ristoranti. Condanne sono giunte anche
dall’opposizione laburista e liberal democratica, mentre il sindacato Unison
parla di «disastro totale» per il settore della cura delle persone. Il documento
di dieci pagine diffuso dal governo sottolinea che la Gran Bretagna post Brexit
chiuderà le porte ai lavoratori non qualificati e a chi non parla inglese. Per
venire nel Regno Unito bisognerà avere un’offerta di lavoro con un salario
minimo di 25.600 sterline, anche se saranno possibili eccezioni per un salario
fino a 20.480 sterline nei casi in cui ci sia carenza di lavoratori, come per
gli infermieri. Artisti, sportivi e musicisti potranno continuare a venire per
spettacoli, gare o audizioni.
Brexit, dal
2021 problemi per i tanti italiani che lavorano e vivono in GB.
Vittorio Ferla de Il Riformista il 20 Febbraio 2020. «Non appena il nuovo
sistema di regole dell’immigrazione comincerà a chiedere ai lavoratori stranieri
maggiori qualifiche e la capacità di parlare inglese le aziende dovranno formare
più lavoratori britannici per occupare i posti vacanti». Sa tanto di sovranismo
l’annuncio di Priti Patel, la ministra dell’Interno britannica, nata a Londra da
una famiglia di origini indiane e ugandesi, considerata uno dei falchi
dell’amministrazione Johnson. Proprio ieri la Patel, in una serie di interviste
televisive e radiofoniche, ha affermato che in Gran Bretagna «ci sono otto
milioni di persone di età compresa tra i 16 e i 64 anni che sono “economicamente
inattive” e che in futuro potranno ricevere le competenze per svolgere lavori in
tutti quei settori in cui potrebbero emergere delle carenze a causa del nuovo
sistema di regolamentazione dell’immigrazione basato sui punti». I piani del
governo annunciati dalla Patel prevedono, infatti, che il visto di lavoro che
entrerà a regime dopo la Brexit potrà essere concesso solo ai richiedenti –
europei e non – che abbiano un minimo di 70 punti. E i punti verranno attribuiti
(10 o 20 per voce) soltanto a chi avrà già in mano offerte di lavoro da 25 mila
sterline all’anno in su, titoli di studio specifici (come Phd), qualificazione
per settori con carenza occupazionale nel Regno Unito e conoscenza dell’inglese.
Il modello a punti di tipo “australiano”, promesso da tempo dal governo di Boris
Johnson, crea però molti allarmi. Le opposizioni contestano la strategia,
sostenendo che il modello australiano filtra sì, ma pure incoraggia
l’immigrazione, mentre questa versione minaccia di scoraggiarla tout court. La
Confindustria britannica e gli enti di categoria – agricoltura, ospitalità,
assistenza – temono che il nuovo sistema possa causare carenza di manodopera.
Che cosa prevede in concreto la nuova politica di immigrazione? Il documento del
governo non si limita ad affermare che i confini del Regno Unito saranno chiusi
ai lavoratori non qualificati e che tutti i migranti dovranno parlare inglese.
In più, gli stranieri che verranno a lavorare nel Regno Unito potranno farlo
soltanto sulla base di un’offerta di lavoro con una soglia salariale di 25.600
sterline. Sarà accettabile un “piano” salariale più basso – pari a di 20.480
sterline – solo in pochi casi speciali in cui potrebbe esserci una carenza di
manodopera, come, per esempio, nelle cure infermieristiche. Divieto di ingresso,
viceversa, per i lavoratori autonomi: non ci sarà più spazio, pertanto, nel
Regno Unito, per gli idraulici polacchi o i muratori rumeni che arrivano senza
un contratto di lavoro regolare. Aumenteranno i controlli di frontiera sulle
carte d’identità da paesi come Francia e Italia allo scopo di reprimere quei
lavoratori extracomunitari che cercano di superare il sistema di sbarramento con
documenti contraffatti o rubati. L’unica notizia positiva è che il limite al
numero di lavoratori qualificati viene demolito e un piccolo numero di
lavoratori altamente qualificati potrà entrare senza lavoro. «Lavori che il
governo considera poco qualificati sono fondamentali per il benessere e la
crescita delle imprese», dice Tom Hadley, direttore della Recruitment and
Employment Confederation. «L’annuncio minaccia di escludere lavoratori di cui
abbiamo bisogno per fornire servizi di pubblica utilità, per prenderci cura
degli anziani, costruire case e mantenere forte l’economia». Anche per questi
motivi, il Labour ha chiesto di assicurare almeno delle eccezioni in settori
strategici quali la sanità, dove i ruoli infermieristici sono coperti
attualmente in buona parte da stranieri. Kate Nicholls, amministratore delegato
di Uk Hospitality, aggiunge che «escludere una via di ingresso per i lavoratori
migranti scarsamente qualificati in soli 10 mesi sarebbe disastroso per il
settore dell’ospitalità e per il popolo britannico e, in più, potrebbe
scoraggiare gli investimenti». La direttrice generale della Confindustria
britannica, Carolyn Fairbairn, se, da un lato, apprezza la rimozione dei limiti
all’accoglienza di lavoratori qualificati, dall’altro vede rischi in altri
settori: «Con una disoccupazione già bassa, le aziende che si occupano di
assistenza, edilizia, ospitalità, cibo e bevande potrebbero essere le più
colpite». Anche il settore dell’ospitalità sarà regolato con il cosiddetto
“visto da barista” per le caffetterie, nonostante già da due anni l’impresa Pret
A Manger avverte che, per quella posizione, solo un candidato su 50 è
britannico. Nel corso di una intervista in diretta alla ministra dell’Interno, i
giornalisti di Bbc Radio 5 hanno cercato di far notare che la fattibilità di un
piano di formazione di otto milioni di persone inattive è molto complicato visto
che si parla principalmente di studenti, disoccupati di lunga durata, pensionati
e persone con responsabilità di cura. Ma Patel ha risposto seccamente: «Le
aziende dovrebbero puntare di più sui potenziali lavoratori britannici,
aiutandoli a migliorare le loro competenze e rendere le loro competenze
rilevanti per il mercato del lavoro». Inoltre, per la ministra, «il 20% delle
persone in età lavorativa disponibili sono inattive e possono essere
incoraggiate a lavorare». Così, il governo conferma, tra le altre cose, che i
camerieri, le cameriere e i lavori “elementari” in agricoltura e pesca saranno
spostati dall’elenco dei lavoratori specializzati e quello dei non qualificati
in linea con le raccomandazioni del Comitato consultivo per le migrazioni. Per i
tanti giovani italiani in cerca di fortuna in Gran Bretagna si prospettano tempi
difficili.
Finisce
un’era per i ragazzi che sperimentavano Londra. Gli inglesi li sostituiranno?
Pubblicato mercoledì, 19 febbraio 2020 da Corriere.it. Possiamo chiamarlo il
gioco dell’oca britannica. Si torna al punto di partenza, dopo molti anni: back
to square one. Dal 1° gennaio 2021 i lavoratori stranieri — anche quelli che
provengono dalla Ue — dovranno conoscere l‘inglese ed essere in possesso di un
contratto di lavoro, per entrare nel Regno Unito. Come negli anni 60. Sono
appena rientrato dall’Inghilterra, e ho scritto un «diario post Brexit» che
uscirà su 7 Corriere il 27 febbraio. Parte dall’incontro con Sergio Poletti,
classe 1940, che possiede tre ristoranti a Chester. Era arrivato a Liverpool
come cameriere a 22 anni, dalla Lunigiana; si è presentato all’Hotel Adelphi,
intimorito davanti alle porte girevoli. Aveva un contratto di lavoro; se
l’avesse perso, sarebbe dovuto rientrare in Italia. Tutto come un tempo. Come se
47 anni nella Comunità/Unione Europea fossero un colpo di vento. Era
prevedibile: l’idea di «riprendere il controllo dei confini» stava al cuore
della propaganda di Brexit, e ha portato alla vittoria nel referendum del 2016
(e in misura minore al successo elettorale di Boris Johnson del 2019). Le nuove
regole prevedono corsie preferenziali per scienziati e talenti. Ma per i milioni
di ragazzi italiani ed europei che in questi anni hanno sperimentato Londra — la
metropoli più vitale d’Europa, anche grazie a loro — tra dieci mesi cambierà
tutto. Non potranno più riempire un trolley, salutare i genitori e partire.
Tutto sarà regolamentato. Il nuovo sistema rischia di avere conseguenze pesanti
anche sul Regno Unito: la sanità, l’edilizia e la ristorazione britannica sono
vissute — e fiorite — anche grazie ai giovani europei. Così i servizi, finanza
compresa. Non c’è cantiere senza un polacco; gli italiani lavorano con successo
in ristoranti, bar, negozi. Al Reform Club, di cui sono socio dal 1986, nei
giorni scorsi mi è capitato di conversare con chi lavora lì: una russa, un
bulgaro, due italiani, due marocchini. Al bar, una ventiduenne tedesca con i
capelli corti, appena arrivata e felice di conoscere Londra da dentro. Accade lo
stesso in tutto il Regno Unito. L’immigrazione europea ha sostituito quella
proveniente dall’Impero. Spesso ai nuovi arrivati si offrono contratti e salari
modesti. Ma dentro quell’offerta sta una cosa importante: la possibilità di
conoscere altri ragazzi e ragazze, la lingua inglese, la prima casa da soli.
Londra ha finito per diventare la scuola di formazione d’Europa, un’ironia che i
Brexiters, presi dalle proprie nostalgie, non hanno mai saputo cogliere.
L’esercito dei giovani lavapiatti stranieri che ha lavorato nei ristoranti della
capitale — non sempre scuole di generosità e pulizia — mostrava una sua nobiltà.
Come verranno rimpiazzati tutti i lavoratori europei non qualificati? Se i
giovani europei perderanno molto, la Gran Bretagna rischia di perdere di più. La
libera circolazione delle persone ha garantito finora manodopera duttile,
giovane, spesso di talento, a costi competitivi. Dove sono gli inglesi che
possono fare tutto questo? Good luck, Britain: ne avrai bisogno.
Antonio, 95
anni (da 68 nel Regno Unito) ora deve provare la sua residenza.
Pubblicato lunedì, 17 febbraio 2020 su Corriere.it da Monica Ricci Sargentini.
Un italiano di 95 anni, Antonio Finelli, da 68 residente nel Regno Unito, ha
dovuto dimostrare al ministero degli Affari Interni di essere nel Paese da
almeno 5 anni per poter restare dopo la Brexit. E questo nonostante l’uomo
percepisca una pensione da ben 32 anni. A dare notizia della singolare richiesta
è il quotidiano britannico il Guardian: «Non penso che sia giusto farmi fare
tutto questo dopo che ho vissuto qui così a lungo» si lamenta in un
video.Antonio è arrivato in Gran Bretagna nel 1952 rispondendo a un bando per
lavorare alla ricostruzione dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale.
All’arrivo nel porto di Folkestone fu accolto con un mese di stipendio in
anticipo e un panino. Ora l’atteggiamento dello Stato, però, sembra meno
amichevole se si pensa che Finelli ha dovuto fornire 80 pagine di estratti conto
bancari per dimostrare il suo diritto a rimanere nella sua casa a Londra dove
vive solo dopo che la moglie e l’unico figlio sono morti: «Ho lavorato tutta la
mia vita non capisco perché devo produrre questi documenti». Dopo l’entrata in
vigore della Brexit, sono molte le persone anziane sottoposte a questo tipo di
richiesta. Dimitri Scarlato, un volontario a Inca Cgil, un centro di aiuto per i
cittadini italiani, ha raccontato al Guardian che una donna era così agitata che
si è sentita male: «Quello che trovo inaccettabile — ha spiegato — è che il
signor Finelli ha vissuto qui per 70 anni, cioè tutta la sua vita. Ne ha
lavorati 40 e da 32 riceve la pensione. È una brava persona e un buon cittadino.
Perché fargli questo?».
Da "leggo.it"
il 13 febbraio 2020. Si chiama Giovanni Palmiero, è italiano e ha 101 anni. Vive
a Londra dal 1966 e l'Home Office chiede che i suoi genitori confermino la sua
identità affinché possa restare in Gran Bretagna dopo la Brexit. L'uomo si è
recato in un centro di consulenza a Islington, nel nord di Londra, per
richiedere lo status di residente. Ma quando un volontario ha scannerizzato il
suo passaporto usando l'app dall'Home Office nell'UE, ha interpretato
erroneamente il suo anno di nascita: invece che 1919 ha letto 2019. Il motivo?
Il sistema elabora solo le ultime due cifre. Poiché l'app credeva che il
bisnonno fosse solo un bambino, gli ha chiesto di inserire i dettagli di
residenza di suo padre per completare la domanda. Londra Italia ha incontrato
l'uomo nella sua casa insieme al figlio Assuntino. «Siamo andati all’Inca-Cgil
qua vicino - racconta Assuntino a Londra Italia - dove papà e mamma,
accompagnati da mia sorella e da mia moglie hanno fatto l’application per
formalizzare la richiesta di rimanere in UK. Ma la richiesta è pendente a causa
dell’età di papà». Giovanni Palmiero ha lavorato in un ristorante a Piccadilly e
in un negozio di fish and chips fino all'età di 94 anni. È sposato con sua
moglie Lucia, 92 anni, da 75 anni, è padre di quattro figli, ha otto nipoti e 11
pronipoti. Il figlio Assuntino Palmiero ha sostenuto come fosse
«un'umiliazione» perché suo padre ha vissuto nel Regno Unito per 56 anni. «Mi
sono accorto subito che qualcosa non quadrasse perchè, parimenti alle
applicazioni degli under 12, saltava il passaggio della scansione del volto,
portando direttamente alla pagina in cui devi scattare la foto», racconta a
Londra Italia Dimitri Scarlato, consulente per le questioni della Brexit per
l`Inca-Cgil. «A questo punto - spiega Scarlato - ho preferito interrompere la
procedura a favore di un consulto con l’Home Office. Il funzionario che ha
raccolto la nostra segnalazione mi ha suggerito di proseguire per poi risolvere
successivamente il problema». Il volontario che ha aiutato il signor Palmiero,
ha ammesso che il signor Palmiero ha ricevuto scuse dal Ministero degli Interni
ma è ancora in attesa di ottenere l'approvazione del suo statuto. Il Ministero
ha dichiarato di aver contattato l'uomo e che la sua domanda era in fase di
elaborazione.
Brexit, dal
2021 gli artisti dovranno avere il visto per esibirsi nel Regno Unito.
Martino Grassi 20/02/2020 su Notizie.it. Da gennaio 2021 gli artisti provenienti
dall'Europa, dovranno essere in possesso del visto per potersi esibire nel Regno
Unito. Gli artisti provenienti dall’Unione Europea avranno bisogno del visto per
potersi esibirsi nel Regno Unito a partire dal gennaio 2021. La notizia arriva
dal Ministero dell’Interno Britannico. Martedì 18 febbraio il dipartimento ha
annunciato che gli artisti e i giocatori sportivi dell’UE saranno soggetti alle
stesse regole che si applicano attualmente ai loro colleghi extracomunitari una
volta terminata la transizione di Brexit a dicembre. Attualmente non vi sono
limitazioni per gli artisti itineranti, che possono ancora viaggiare liberamente
tra il Regno unito e l’Europa. Una volta concluse le procedure che
ufficializzeranno la brexit, gli artisti provenienti dall’Europa, così come
quelli extra-UE avranno bisogno di un visto Tier 5 per potersi esibire nel Regno
Unito, partecipare a concorsi o audizioni, attività promozionali, workshop,
tenere discorsi sul loro lavoro e partecipare a eventi culturali o festival.
L’amministratore delegato della Incorporated Society of Musicians, Deborah
Annetts, ha dichiarato di essere “profondamente delusa” dal fatto che la libera
circolazione dei musicisti e degli altri artisti dell’UE sia stata esclusa.
“Chiederemmo al governo del Regno Unito di riconsiderare la nostra richiesta di
un visto di due anni per più ingressi. Qualsiasi futuro sistema di immigrazione
non esiste in modo isolato e ha enormi implicazioni per la negoziazione di
accordi commerciali e di accordi reciproci tra l’UE e gli Stati Uniti” ha
aggiunto. ed ha concluso sostenendo che: “Un tale sviluppo andrebbe a scapito
del settore culturale del Regno Unito e rappresenterebbe una perdita
significativa per il pubblico che gode nel vedere i talenti di tutta Europa
esibirsi nel Regno Unito”.
Il mistero
di Boris Johnson che non sa leggere i discorsi troppo lunghi.
Il premier
britannico non sarebbe in grado di tenere l’attenzione per più di qualche
minuto, soprattutto per quanto riguarda i documenti governativi. E tutti i suoi
"autori" sarebbero stati avvertiti. Antonello Guerrera il 24 febbraio 2020 su La
Repubblica. A Westminster, c’è chi dice che a Downing Street oramai comandi la
"sindrome da deficit di attenzione". Perché Boris Johnson pare proprio come
Donald Trump. Secondo il Sunday Times, non riuscirebbe a tenere l’attenzione per
più di qualche minuto, soprattutto per quanto riguarda i documenti governativi
più importanti e molto spesso noiosi. Eppure il premier britannico ha studiato a
Eton, si è laureato a Oxford, sa l’Iliade a memoria in greco antico, come
dimostra un video virale su Twitter risalente a quando era sindaco. Tuttavia, a
leggere le minute e i messaggi articolati e riservatissimi governativi, Johnson
proprio non sembra farcela. Ecco perché, secondo il quotidiano londinese, lo
staff del premier ha imposto a tutti i collaboratori e adviser di non scrivere
testi più lunghi di quattro pagine destinati a Boris. Anzi, la misura ideale è
due pagine A4, scritte peraltro nella maniera più semplice possibile.
Altrimenti, Dominic Cummings si arrabbia: il “rasputin” o “Bannon” di Boris già
avrebbe fatto delle scenate terribili a tutti gli scriventi autori di testi
troppo complessi per il “Re Boris”. Testi che poi vanno a finire nella
canonica “red box”, la “cassetta rossa” dell’allora premier liberale William
Gladstone nel 1853 e poi contenitore prezioso dei documenti più importanti del
Cancelliere dello Scacchiere (il ministro delle Finanze) e del premier, tanto
che oggi sono letteralmente a prova di bomba e costano oltre 1000 euro l’una.
Celebri erano le notti di Margaret Thatcher, che ha preceduto Johnson a Downing
Street, a studiare faldoni di carte e report da parte dei suoi collaboratori,
con la luce al numero dieci (quasi) sempre accesa. Ma Boris non è come lei.
Boris è come il suo amico Donald. Boris Johnson intanto è nella sua residenza di
campagna di Chevening, pare da una settimana, dopo una lunga latitanza che ha
attirato molte critiche: il premier infatti non si è fatto vedere neppure
durante le gravissime alluvioni nello Yorkshire e in gran parte del Nord
dell’Inghilterra, afflitto da varie tempeste nelle ultime settimane, né è andato
a confortare le popolazioni colpite (è dovuto andarci il Principe Carlo). Tanto
che negli ultimi giorni ha impazzato su Twitter l’hashtag “Where Is Boris?”. Che
fine ha fatto Boris?
Luigi Ippolito per il “Corriere della Sera” il 24 febbraio 2020.
Lo hanno già soprannominato «il governo col deficit di attenzione»: e il
colpevole è lui, Boris Johnson. Che non riesce a leggere documenti che non siano
brevi e coincisi: se no, si perde per strada. Il retroscena è stato rivelato
ieri dal Sunday Times ed è emerso alla fine della settimana che il primo
ministro britannico ha appena trascorso nella residenza di campagna di Chevening
(detto per inciso: quella è la residenza del ministro degli Esteri, ma quella
del premier, Chequers, è in ristutturazione. E allora Boris, nel suo stile
irruente e pigliatutto, non si è fatto problemi a far sloggiare il povero
Dominic Raab e a insediarsi al suo posto, con fidanzata al seguito. Hic
manebimus optime , direbbe lui). Ad ogni modo, Johnson si è portato il lavoro da
casa, ossia da Downing Street. Ma ai funzionari del governo è stato intimato di
non sottoporre documenti troppo lunghi, «se no, non li legge». «È stato detto
loro - ha fatto sapere una fonte anonima - che devono essere di facile lettura:
non più di quattro pagine, ma due è preferibile». E un tetto è stato messo pure
alla quantità di roba che finisce nella mitica valigetta rossa, quella che
contiene le carte riservate al premier: l' editto è arrivato dall' onnipotente
Dominic Cummings, il super-consigliere di Boris. Che rimanda indietro «con
commenti selvaggi i documenti troppo lunghi e complessi». È uno stile di lavoro
che ricorda in maniera inquietante quello di Donald Trump, noto per avere l'
intervallo d' attenzione di un piccione, e in netto contrasto con Margaret
Thatcher, che faceva notte fonda in compagnia della valigetta rossa e del suo
contenuto. Ma cosa ci racconta di Boris tutto ciò? Certo, la storia coincide con
l' immagine di arruffone che l' attuale premier britannico si porta dietro da
sempre: l' anno scorso, per esempio, erano venute fuori le foto dell' interno
della sua macchina, più simile a una discarica che a un mezzo di trasporto. Per
non parlare dell' insieme della sua vita privata, trascorsa saltabeccando da un
letto all' altro e disseminando il mondo di figli illegittimi. Ma quanto è
maschera e quanto è carattere vero? Dopo tutto, Boris si scompiglia apposta i
capelli prima di apparire in pubblico, perché così vuole il suo personaggio. Ma
il suo modus operandi lo ha raccontato qualche settimana fa Fraser Nelson, il
direttore della rivista politica The Spectator , che aveva chiesto a Boris di
scrivere un pezzo subito dopo le elezioni di dicembre. Ebbene, la sera prima di
andare in stampa Johnson fa sapere di non riuscire più a consegnare l' articolo:
e Nelson si rassegna. Ma il giorno dopo, con la rivista che va in stampa alle
10.30 del mattino, Boris si alza alle 4.45 e si mette a vergare il pezzo. Alle
7.00 il direttore riceve un messaggio dal premier: «Ho scritto l' articolo, lo
sto finendo adesso». Alle 10.20 un altro messaggio: «È fatto». E qualche minuto
dopo: «Sono ancora in macchina». Alle 10.28, due minuti alla stampa, Nelson
perde le speranze: non ce la faranno mai. Ma alle 10.29 arriva il pezzo di
Boris: ed è perfetto. Morale della favola: «Non vi fate ingannare: giudicatelo
da cosa conclude, non da come lo fa». Perché Johnson è quello che ha portato a
casa l' accordo con la Ue, nonostante le aspettative contrarie, che ha ottenuto
la più larga maggioranza dai tempi della Thatcher e che ha portato a termine la
Brexit dopo tre anni e messo di indugi. Fa casino, ma poi mette la palla in
rete.
ANTONELLO
GUERRERA per repubblica.it il 18 febbraio 2020. Andrew Sabisky, chi era costui?
Ricordate i bizzarri annunci di Dominic Cummings, il folle e geniale "Rasputin"
di Boris Johnson, per alcuni commentatori il vero padrone del governo
conservatore, che cercava aiutanti "strambi" e "disadattati", ma intelligenti e
brillanti per il suo lavoro quotidiano a Downing Street? Ebbene, il primo dei
neo-assunti dal consigliere supremo del premier britannico, nella sua utopia del
Regno Unito come nuova "techno-polis" mondiale, ha provocato un terremoto
politico al "Numero 10". Tanto che ha dovuto dimettersi dopo poche ore, lunedì
sera. Questo perché lo "strambo" Andrew Sabisky, 27 anni, laureato a Cambridge,
autodefinitosi "super-veggente" sul suo profilo Twitter e commentatore assiduo
del distopico blog di Cummings, si era distinto in passato per frasi e commenti
razzisti e sessisti, disseminati negli anni su Internet e sui social network, e
che poi lunedì sono riemersi inquietanti. Sabisky, per esempio, aveva evocato
spesso l'eugenetica di massa, inclusa la "sterilizzazione" di Stato per alcune
donne "di bassa classe sociale" in caso di natalità troppo elevata. Sempre
contro le donne, più di una volta su Twitter ha paragonato gli sport femminili
alle "Paraolimpiadi". Non solo: per quanto riguarda l'utilizzo massiccio - da
lui sognato - di sostanze chimiche per migliorare le performance cerebrali dei
britannici (un po' come nel "Mondo nuovo" di Aldous Huxley), una volta aveva
scritto che simili esperimenti "valgono bene un bambino morto ogni tanto".
Infine, per quanto riguarda gli afroamericani invece, Sabisky aveva tenuto
pubblicamente a precisare che secondo lui "hanno un quoziente intellettivo
inferiore. Ci sono differenze a livello razziale". Tutto questo ha ovviamente
creato enorme imbarazzo a Downing Street. Lunedì mattina, alle domande
di Repubblica e dei giornalisti parlamentari britannici, i portavoce del premier
Johnson avevano risposto più volte con un "no comment". Ma la rivolta a
Whitehall e nell'esecutivo è cresciuta ora dopo ora: molti impiegati e
consiglieri avevano fatto sapere che non avrebbero risposto alle mail di
Sabisky, né collaborato con lui. E così, alla fine, il primo "strambo" protégé
di Cummings è stato costretto a dimettersi, nonostante il suo mentore abbia
cercato di difenderlo fino all'ultimo. Lo ha annunciato lo stesso Sabisky su
Twitter lunedì sera: "L'isteria dei media è davvero folle. Volevo solo aiutare
il governo, non creare problemi. Quindi ho deciso di dimettermi. Spero che un
giorno i media la smetteranno di citare solo quello che piace a loro". E che non
piaceva a Andrew Sabisky.
Da “la Stampa” l'1 marzo 2020. Quanti figli ha il primo ministro
britannico? La domanda, cui pochi possono dare risposta certa, tornerà
certamente a circolare tra i corridoi di Westminster e sui social media adesso
che Boris Johnson ha annunciato che sposerà la fidanzata e che la coppia aspetta
il primo figlio. Nascerà quest' estate. «Ci sentiamo incredibilmente fortunati»,
ha detto la futura moglie Carrie Symonds. La notizia, di per sè non
particolarmente degna di nota, porta però alla ribalta la tumultuosa vita
privata di Johnson, ma soprattutto la sua capacità di sopravvivere agli scandali
e piegare le regole a suo vantaggio, nel pubblico come nel privato. La vita del
premier Il premier ha sempre mantenuto il riserbo sulla sua vita personale. Ha
due matrimoni alle spalle; quattro figli nati dalla seconda moglie; una figlia
da un rapporto con una consulente d' arte anni fa; e, si vocifera, un sesto
figlio da un' altra relazione extra-coniugale, notizia mai confermata. Durante
l' ultima campagna elettorale, a chi gli ha chiesto quanti figli avesse, ha
risposto: "Amo i miei figli, ma non sono loro ad essere in corsa in queste
elezioni. " Un atteggiamento perfettamente legittimo in un Paese più interessato
all'" accountability" , cioè all' obbligo dei politici di render conto delle
loro azioni pubbliche, che ad altro. Ma per i suoi oppositori l' esuberanza
sentimentale è sintomo di una mancanza di disciplina e controllo imperdonabile
per che si occupa della cosa pubblica. Una prova di come Boris ritenga che le
regole per lui non valgano. Dopotutto, da giornalista prima è stato beccato ad
inventarsi una dichiarazione e poi è diventato famoso con improbabili (e
alquanto dubbie) cronache da Bruxelles. Da capo della campagna per la Brexit ha
ripetuto slogan del tutto fuorvianti; da primo ministro ha cercato di chiudere
il parlamento, si fa vedere poco in giro e in generale ignora la prassi, nel
bene e nel male. E continua ad avere successo. Il premier 55 anni, e Symonds,
31, ex capo della comunicazione del Partito Conservatore, sono stati la prima
coppia non sposata ad entrare a Downing Street, una decisione che certamente li
ha messi in linea con una società dove le coppie di fatto sono sempre di più.
Come Trump e, Berlusconi prima di lui, Johnson sopravvive a tutto, o a molto,
perché come loro rompe tutti.
Johnson e Macron hanno deciso: entrano solo i più “utili”.
Fulvio Scaglione su Inside Over il 2 marzo 2020. Fresco di Brexit, il premier
inglese Boris Johnson, tre settimane fa, ha presentato un progetto di legge per
la riforma dell’immigrazione che ha raccolto, in Europa, soprattutto critiche e
ironie. Anche perché l’ha accompagnato con il proposito di “riprendere dopo
decenni il controllo delle frontiere” che è parso, agli occhi dei più, un
tantino esagerato. Pochi, però, nemmeno noi italiani che avremmo dovuto farlo
per primi, hanno provato a mettere quel progetto in un contesto più ampio, per
provare a misurarne le conseguenze sul piano internazionale. Proviamo quindi a
ricapitolare. Johnson chiederà al Parlamento di approvare un sistema che,
ovviamente, mira a ridurre gli ingressi nel Regno Unito per ragioni di lavoro.
Chi vorrà farcela, dovrà raggiungere quota 70 punti mostrando una buona
conoscenza della lingua inglese oppure dimostrando di aver già ottenuto un posto
di lavoro che prevede un salario di almeno 26.600 sterline l’anno (poco più di
30 mila euro). I veri balzi in graduatoria, però, li faranno due categorie di
persone: quelli che avranno titoli di “chiara fama (accademici, scienziati e
affini) e quelli che potranno vantare competenze professionali di cui nel Regno
Unito, in quel momento, si avverte scarsità. Mancano gli idraulici a Londra? Via
libera a chi conosce il mestiere dell’idraulico e strada bloccata, per fare un
esempio, ai falegnami. Penalizzati, ovviamente, i lavoratori generici e non
specializzati o, peggio, quelli che vorrebbero arrivare nel Regno Unito per
farsi una strada. Come si vede, tutto questo riguarda solo l’immigrazione
legale e non ha nulla a che vedere con quella irregolare o clandestina. Comunque
sia, la proposta di Johnson ricorda da vicino la legislazione già in vigore in
Australia. Anche lì, per l’immigrazione lavorativa, vige una classifica a punti
che privilegia i candidati sponsorizzati da un’azienda australiana (quindi,
quelli che hanno già trovato un lavoro) o quelli che possono vantare una
specializzazione accademica o professionale. Stesso sistema anche in Canada:
classifica a punti, accesso privilegiato per chi abbia già trovato un posto di
lavoro o per chi abbia un solido bagaglio professionale o accademico. Stiamo
parlando di Paesi lontani e, soprattutto, ricchi di spazi liberi. Per dare
un’idea: la densità abitativa in Europa è di più di 200 persone per chilometro
quadrato, negli Usa di 32, in Canada di 3,9. Il fatto è, però, che prima di
Johnson le stesse teorie erano state abbracciate da qualcuno che è molto vicino
a noi, ovvero da Emmanuel Macron. All’inizio del novembre scorso, il presidente
francese aveva illustrato una riforma dell’immigrazione per lavoro basata
proprio su quei criteri: porte aperte solo per chi potrà vantare titoli di alto
livello o per quei lavoratori di cui, attraverso un complesso sistema di
raccolta dati, l’economia francese mostrerà di aver bisogno. Un indizio è un
indizio, ma tre o quattro fanno una prova. La realtà è che i Paesi destinatari
di immigrazione si stanno organizzando tutti più o meno allo stesso modo.
Ovvero, si propongono di selezionare gli arrivi e, in sostanza, di far entrare
solo coloro che potranno dimostrare di essere utili al loro sistema economico.
Cosa che, per fare un altro esempio, anche la Germania ha deciso di fare nel
2018, per reclutare quei professionisti e lavoratori specializzati che ormai
mancano nel Paese europeo che soffre della maggiore denatalità. L’Italia, più di
ogni altro, dovrebbe monitorare tutto questo e preoccuparsene. Per due ragioni
fondamentali. La prima è questa: se i sistemi immaginati da Regno Unito e
Francia entreranno in vigore, si scatenerà una caccia all’eccellenza (accademica
o professionale) che, con questi chiari di luna, ci vedrà sicuramente
penalizzati. Ciò vuol dire che sempre più l’Italia diventerà l’approdo più
desiderato dell’altra immigrazione, quella dei lavoratori generici o delle
persone che fuggono in cerca di un futuro qualunque, purché migliore del loro
presente. La seconda ragione, invece, riguarda i Paesi (asiatici, africani o
mediorientali) in cui l’emigrazione si origina. Le norme inglesi, francesi o
tedesche potrebbero privarli delle energie migliori, ovvero delle eccellenze
professionali o lavorative, attratte dalle regole di maggior favore
sull’immigrazione nei Paesi dell’Unione europea che offrono buone prospettive di
lavoro, finendo così con l’impoverirli ancor più. Questo richiederebbe sforzi
ancora maggiori nella cooperazione internazionale allo sviluppo, per evitare
flussi migratori che potrebbero essere ancora più massicci e disperati. E, di
nuovo, potrebbe porre un problema serio all’Italia. Che, almeno per quanto
riguarda l’Africa, è il primo punto d’approdo per chi vuole raggiungere
l’Europa.
Londra è pronta ad implementare la sua deterrenza nucleare.
Davide Bartoccini su Inside Over il 2 marzo 2020. La
Difesa britannica ha confermato le notizie riguardo il suo programma per
sviluppare una nuova testata nucleare da affidare ai suoi sottomarini
missilistici. A riferirlo prima del del tempo erano stati gli americani che,
sbadatamente, lo hanno reso noto prima che il parlamento britannico – impegnato
nella delicata fase Brexit e Post-Brexit – ne venisse edotto. Il segretario alla
Difesa Ben Wallace ha confermato pochi giorni fa le indiscrezioni riguardanti il
programma che Regno Unito sta realmente portando avanti per lo sviluppo di
una nuova testata nucleare da schierare sulla flotta di sottomarini della Royal
Navy. Quale componente focale della triade nucleare al servizio di sua maestà, i
sottomarini lanciamissili – attualmente rappresentati dalla classe
Vanguard armati con i missili balistici “Trident” – imbarcheranno quindi una
nuova arma per “garantire il mantenimento di un efficace deterrente”. Almeno
fino a quanto i nuovi sottomarini lanciamissili balistici classe Dreadnought non
saranno operativi. “Stiamo sostituendo le nostre testate nucleare per rispondere
alle minacce future e mantenere la sicurezza del nostro Paese”, ha dichiarato il
capo di Whitehall. Secondo quanto dichiarato dalla Difesa britannica questo
programma doveva rimanere segreto, almeno fino a quanto non sarebbe state prese
in esame la revisione delle attività inerenti la difesa, la sicurezza e la
politica estera, tutte previste per la fine di questo 2020. Intenzione che non è
stata resa possibile da due alti funzionari statunitensi dell’apparato di Difesa
statunitense, che la scorsa settimana hanno rivelato come tale programma fosse
già in auge. Una fuga di informazioni di un certo rilievo dunque, che ha
suscitato immediatamente scalpore nel Regno Unito, poiché i programmi di alto
profilo come quelli che riguardando la deterrenza nucleare sono solitamente
annunciati prima a Westminster e poi al resto del mondo. “La decisione è
sostanzialmente già presa, ma l’annuncio è arrivato prima del previsto.
Probabilmente stavamo guardando all’anno prossimo, ma sicuramente non prima
della revisione della difesa e della sicurezza che sarebbe stata rilasciata
verso la fine dell’anno”, ha affermato David Cullen, direttore dello Nuclear
Information Service del Regno Unito, organizzazione indipendente che si occupa
della materia. A svelare il “segreto inglese” sono stati, involontariamente,
l’ammiraglio Charles Richard, comandante del Comando Strategico statunitense, e
Alan Shaffer, vice-sottosegretario alla difesa del Pentagono, che in due
occasioni diverse e separate hanno dichiarato come il Regno Unito stesse
perseguendo lo sviluppo della “propria versione della testata W93“: armamento
che è in fase di valutazione anche per la sostituzione della testata W76
attualmente in forza all’Us Navy. “È meraviglioso che il Regno Unito stia
lavorando su una nuova testata allo stesso tempo e penso che avremo discussioni
e saremo in grado di condividere le tecnologie”, ha detto il funzionario
del Pentagono, che non immaginava di “rompere le uova del paniere” agli inglesi
che tenevano ancora nascosti nel cassetto di qualche scrivania ai piani alti i
Whitehall i report da presentare al parlamento fresco di Brexit. Shaffer ha
affermato che la testata W93 e la sua versione britannica “saranno due sistemi
di sviluppo indipendenti”, e che la suddette arma “supporterà un programma
parallelo di testate sostitutive nel Regno Unito”. Il ministro britannico
Wallace ha dichiarato che “l’organizzazione nucleare della difesa del Ministero
della Difesa sta lavorando con lo stabilimento di armi atomiche”. Lo scopo della
Marina è costruire squadre altamente qualificate e mettere in atto le strutture
e le capacità necessarie per consegnare la testata sostitutiva, sostenendo anche
l’attuale testata fino a quando non viene ritirata dal servizio. Continueremo a
lavorare a stretto contatto con gli Stati Uniti per garantire che la nostra
testata rimanga compatibile con il Trident”. La nuova testata britannica infatti
mira ad aggiornare i missili che armano i sottomarini della Royal Navy, ossia i
16 missili balistici Trident-II D5, pari a duecento testate termonucleari a
rientro multiplo indipendente, che sono trasportati da ognuno dei 4 sottomarini
classe Vangard: l’Hms Vanguard (capofila), l’Hms Victorious, l’Hms Vigilant e
l’Hms Vengeance. I sottomarini di classe Vanguard sono i principali incaricati
di fornire la capacità di deterrenza nucleare britannica, e verranno sostituiti
a partire dal 2028 con i nuovi sottomarini classe Dreadnought. Benché molto
simili tra loro, le testate inglesi sembrano avere delle piccole “differenze”,
rispetto a quelle americane. Sembra che la Atomic Weapons Establishment nel
Regno Unito stia considerando un “programma di estensione della vita del suo
stock di testate”, inclusa la “sostituzione di alcuni componenti elettronici e
sistemi per migliorare l’accuratezza e fornire vantaggi in termini di
prestazioni”. I Trident britannici, chiamati “Holbrook”, sono entrati in
servizio insieme ai sottomarini di classe Vanguard a metà degli anni 1990 quali
sostituti dei missili Polaris, trasportanti dai precedenti sottomarini
strategici classe Resolution. Secondo le stime di Londra, i nuovi sottomarini di
classe Dreadnought – per i quali saranno stanziati 31 miliardi di sterline –
dovrebbero essere completamente operativi nel 2030, e dovranno trasportare delle
armi “Made in Uk”: armi che dimostrino al mondo ancora una volta come la potenza
britannica collabori sì con gli Stati Uniti – che hanno sempre sviluppo
“insieme” a Londra armi nucleari per decenni e che hanno firmato nel 1958 il
noto “Accordo di mutua difesa” – ma che all’occorrenza è pronta a difendersi da
sola, con i propri sottomarini nucleari e con le proprie armi atomiche. Sembra
quasi di sentir riecheggiare ancora una volta le parole del ministro degli
Esteri Ernerst Bevin, quando agli albori della Guerra Fredda il governo inglese
era indeciso se dotarsi di una propria deterrenza nucleare o rimanere sotto
l’ombrello difensivo dell’alleato statunitense; e insistente pronunciò la nota
frase : “We’ve got to have this thin.. whatever it costs. We’ve got to have the
bloody union jack on top of it.”. Si riferiva, ovviamente, a una testata
nucleare tutta inglese.
·
Quei razzisti come
gli Statunitensi.
Giulia Zonca per “la Stampa” il 14 novembre 2020. Un album di
nozze che diventa un pezzo di storia resiste anche al divorzio, alla morte di
lui, agli 87 anni di lei, al tempo che è passato lasciando tutte le tracce che
doveva, per fortuna. Seguendole a ritroso si torna al 13 novembre 1960, data del
matrimonio tra May Britt, attrice svedese, e Sammy Davis Jr, showman americano e
simbolo della comunità nera, attivista per i diritti civili, star assoluta di
anni esaltanti e turbolenti. In mezzo ai quei magnifici Sessanta c' è una coppia
che butta giù porte sprangate. Quando si sposano, le unioni miste sono illegali
in 31 Stati degli Usa, in 15 vengono perseguite con la massima pena e solo sette
anni dopo la Corte Suprema renderà la legge finalmente valida in tutto il Paese,
solo sette anni dopo il cinema e la società riconosceranno l' ipotesi
ammissibile con Indovina chi viene a cena. Ma in quel novembre fa solo un gran
freddo, persino a Hollywood, persino con due persone innamorate e un concentrato
di passione che sarebbe dovuto valere per una vita insieme e avrebbe dovuto
cambiare la testa altrui. Quell' amore centra una sola casella. Il flirt è
brevissimo. Lei incontra lui sul set del non troppo fortunato remake dell'
Angelo azzurro. Sammy è lì per parlare con il suo agente, resta abbagliato e
tutti i presenti si preoccupano. Non gli credono neanche troppo perché in quel
momento l' attore è uno dei performer più richiesti, è famosissimo e ha da poco
terminato un fidanzamento clandestino con Kim Novak. Pensano che stia giocando.
Sperano che sia solo una fantasia. La storia con Kim ha già dato i suoi
problemi: anche se i due non si sono mai fatti vedere in pubblico, i giornali li
hanno stanati, le case di produzione sgridati. L' enigmatica donna che visse due
volte, l' algida bionda hitchcockiana, con il piccoletto del Rat Pack, «un
afroamericano con origini portoricane e un occhio solo». La definizione è sua e
la relazione dà così tanto fastidio che lei litiga con gli studios «non mi
possedete» e lui riceve minacce di morte. Vengono separati, si lasciano
dividere. Difficile dirlo, ma tutti intorno restano terrorizzati per quei mesi
di pressione. Poi Sammy vede May e l' America perde la testa. Dopo essersi
incrociati la prima volta si rivedono al ristorante, basta qualche serata e sono
fidanzati, qualche mese e lui telefona da Las Vegas per la proposta. Secca.
«Vuoi sposarmi?», «sarebbe meraviglioso». Non c' è nessuna domanda su quello che
li aspetta, nessun confronto sugli inevitabili fastidi, in due si sentono di
battere il pregiudizio semplicemente mostrandosi insieme. Funzionerà, solo non
subito. Nell' immediato devono cambiare la data del sì perché Sammy, con gli
amici Frank Sinatra, Dean Martin e Peter Lawford, è impegnato nella campagna a
favore di Kennedy e i democratici non vogliono associare la corsa alla Casa
Bianca a un matrimonio che in metà degli Stati Uniti non sarebbe neanche
riconosciuto. Però la botta di squallida realtà arriva subito dopo la rapida
cerimonia e il party in casa. Kennedy è già Presidente e Davis è tra gli
invitati alla festa per l' insediamento, peccato che non possa portare sua
moglie. Troppa tensione in circolo per sbattere una coppia mista in faccia a una
nazione divisa. Jfk per ben due volte rifiuta di avere al suo tavolo ufficiale
una bianca e un nero sposati: dopo qualche mese, stessa situazione con il Rat
Pack chiamato a cantare per il presidente. Davis ci resta così male che non
reagisce, accetta le scuse senza ascoltarle e incassa la solidarietà di Martin,
che boicotta entrambe le cerimonie. Sinatra presenzia e dice al suo socio che
deve solo fregarsene, persino Martin Luther King, amico di Davis, non ha
risposte. In un celebre dialogo tra i due Davis gli chiede: «Martin, ce la si fa
con questa integrazione?» e l' altro risponde «posso solo dirti che ti parlo dal
telefono di una meravigliosa suite da cui non posso uscire perché la gente fuori
mi aggredirebbe». Sammy decide di continuare a dare spallate insieme con May,
pure se per stare insieme devono girare con la scorta. Hanno una figlia, Tracy,
e adottano due bambini, Mark e Jeff. Lei smette di lavorare e lui inizia a bere
troppo e a esserci sempre meno. Restano uniti da sentimenti profondi e dalla
voglia di dimostrare che la loro vita insieme non è un capriccio, però iniziano
ad allontanarsi. Nel 1968 Luther King viene assassinato e Sammy Davis va in
pezzi, il matrimonio fa la stessa fine, anche se i due restano sempre amici. E
c' è la legge, un' altra sensibilità. Sessant' anni dopo il concetto di coppia
mista ha preso così tante sfumature da aver perso il senso. Ma da qualche parte
lo stupore ancora resiste e ogni volta che due innamorati come Sammy e May
ricevono qualche sguardo di troppo, si torna a quell' album e a quella storia.
La nostra.
L'America di Biden. Massimo Teodori
su Il Quotidiano del Sud l'8 novembre 2020. Joe Biden è il 46esimo presidente
degli Stati Uniti d’America, il primo che nell’ultimo quarto di secolo batte un
presidente in carica, Donald Trump, aggressivamente presente sulla scena
elettorale per ottenere un secondo mandato. La vittoria del democratico è stata
annunziata dai grandi quotidiani americani, dalle maggiori reti televisive
nazionali e internazionali, tutti media autorevoli dopo aver preso visione dei
risultati di due Stati decisivi, Pennsylvania e Nevada, che hanno concluso lo
spoglio delle schede anche postali. Negli Stati Uniti non esiste un ufficio
federale che legittima i risultati elettorali, ma sono i singoli Stati che li
annunziano insieme agli organi di stampa e televisivi che li diffondono. Il
segno che si tratta di una vittoria certa viene dalle misure prese dalle
autorità di sicurezza di Washington: è stato chiuso lo spazio aereo sopra la
residenza di Biden a cui è stata assegnata una scorta da presidente. Trump non
si è rassegnato, e non si rassegna per ora, ai risultati che negli ultimi giorni
hanno decretato in maniera inequivocabile la vittoria dell’avversario. Farà
ricorso ad ogni sorta di espediente, legale e illegale, per fermare l’ingresso
di Biden alla Casa bianca. Le regole dicono che entro il 14 dicembre i Grandi
elettori devono nominare il Presidente il quale entra in carica il 20 gennaio
dopo avere messo a punto i vertici dell’Amministrazione. Biden trova un’America
divisa, frustrata e avvilita da una pandemia che non è stata affrontata con
serietà, e un’economia che, pur in lieve ripresa, ha subito un tracollo negli
ultimi sei mesi. Il suo compito non sarà facile in presenza di un Senato che
probabilmente rimarrà a lieve maggioranza repubblicana dopo i ballottaggi
d’inizio gennaio. All’anziano presidente democratico che dividerà il comando con
la vice Kamala Harris, si presentano molti difficili problemi se intende
invertire con efficacia la rotta del suo predecessore: all’interno la sanità,
l’immigrazione, la fiscalità, le regole istituzionali e il sistema giudiziario
in cui è stato esercitata un’azione spregiudicata e, all’estero, i rapporti
internazionali specialmente con l’Europa e la Cina oltre all’ambiente e il
clima.
Da repubblica.it il 7 novembre 2020. Joe Biden ha saputo di aver
vinto la Casa Bianca dai nipoti. Lo scrive la Cnn mentre la nipote Naomi Biden
ha pubblicato una foto del presidente eletto, che ha passato la giornata a casa,
mentre viene abbracciato dai più giovani membri della famiglia non appena ha
appreso del trionfo. La foto è diventata immediatamente virale sul web.
Usa 2020, Biden acclamato dalla folla: "L'America ha parlato e
ci ha scelto: domani sarà un giorno migliore. Adesso basta toni aspri".
Anna Lombardi su La Repubblica l'08 novembre 2020. "E' venuto
il momento di debellare la pandemia e sconfiggere il razzismo" dice il
presidente eletto. Ovazione per Kamala Harris: "Abbiamo il dovere di costruire
un nuovo futuro". “Lasciamoci alle spalle la cupa era di demonizzazione
reciproca. Finiamola, qui e ora. Mi impegno a essere un presidente unitario: non
divisivo. Torniamo a essere Stati Uniti d’America”. La rivoluzione di Joe Biden
inizia anche dal vocabolario. Con i tre aggettivi che componevano i discorsi di
Donald Trump – “Huge, Best, Fantastic” (enorme, migliore, fantastico) spazzati
via in un istante, da un discorso teso a “restaurare l’anima dell’America”:
secondo il suo slogan della prima ora. “Datemi una possibilità anche se non
avete votato per me. Non ci sono più stati rossi o blu, sarò il presidente di
tutti” afferma infatti il 46esimo presidente degli Stati Uniti. E pure il più
anziano: compirà 78 anni il prossimo 20 novembre. Promette infatti di
riunificare il paese, “restaurandone l’anima” secondo il suo slogan della prima
ora: superando ogni partigianerie. Sì, in America sono passate da poco le otto e
trenta di sera, quando sul palco eretto davanti al Chase Center, il cento
congresso alla periferia di Wilmington, nel “suo” stato del Delaware, sotto il
cartellone luminoso che recita: “Il popolo ha scelto: scienza, verità, unità...”
sale per prima Kamala Harris, in tailleur a pantalone bianco: il colore delle
suffragette. Tocca proprio all’ormai ex senatrice della California ringraziare
gli elettori. Harris, 54 anni, è la nuova vice da record: prima vicepresidente
donna, prima afroamericana, prima indo-americana e, dopo Barack Obama, pure
seconda biracial alla Casa Bianca. Emozionatissima, ripete quattro volte
«Buonasera». Ma poi pronuncia un discorso destinato a fare la storia: “Prima di
morire, l’icona dei diritti civili John Lewis ha detto: “La democrazia non è uno
stato, è un atto”. Voleva dire che la democrazia americana non va data per
scontata. È forte quanto la vostra volontà di combattere per difenderla». La
piccola folla invitata al comizio drive-in, sventola dalle auto cartelli e
bandiere: ma poi, pur indossando le mascherine, per l’entusiasmo dimentica di
mantenere la distanza sociale. È a loro e a tutto il mondo sintonizzato in tv
che ricorda: «In questa elezioni era in ballo la sopravvivenza della democrazia.
Ma noi, il popolo, sappiamo quali sacrifici richiede. È un nuovo giorno per
l’America», esulta. “È il momento di Joe, l’uomo scelto. Un unificatore. Ha
avuto l’audacità di rompere ogni barriera e scegliere una donna come sua vice.
Ma vi assicuro. Non sarò l’ultima”. Per poi concludere: “Ci aiuterà a ritrovarci
come nazione. L’America è pronta. E anche noi”. Solo allora anche Jospeh
Robinette Biden sale sul palco illuminato di blu. Il completo scuro, i capelli a
spazzola, l’immancabile mascherina nera, con 72 milioni di preferenze è il
candidato più votato candidato della Storia. Il suo trionfo arriva al terzo
tentativo della sua lunga carriera (ci provò nel 1988 e nel 2008) e al culmine
di una vita tormentata dai lutti: prima la morte della moglie Nailia con la
figlia Naomi in un incidente stradale del 1972, poco dopo la sua prima elezione
in Senato. Poi il figlio Beau, per un tumore al cervello nel 2015, quando era
già alla Casa Bianca come vice di Obama. Indica amici e parenti fra la folla:
«da qualche parte c’è mia cognata. E pure mia sorella Valery». E poi riparte col
nuovo mantra che sta già incantando il paese: “Non ci sono più stati rossi o
blu. Solo Stati Uniti d’America. Riporteremo il nostro paese a essere rispettato
nel mondo”. Non fa nessun riferimento esplicito al Presidente sconfitto (e
ammusonito) Donald Trump: che ancora non ha concesso la vittoria. Ma si rivolge
ai suoi fan: “So che sarete delusi. Ma proviamoci insieme. Raffreddiamo gli
umori, trattiamoci come avversari e non nemici. Siamo tutti americani”. E ha
perfino parole d’empatia verso il rivale sconfitto: “Ho perso anche io un paio
di elezioni”. La sua, spiega, è una coalizione dove c’è davvero posto per tutti:
“Democratici, repubblicani, campagnoli e cittadini, gay ed etero, bianchi,
latini. E quegli aforamericani che si sono battuti per me”, enfatizza battendo
addirittura una mano sul podio. Tutto ha una stagione. Questa è la stagione
della cura». Il suo è un inno all’unità, certo. Ma soprattutto un inno
all’America: «Questa nazione, è la patria delle possibilità. Tutti ne hanno in
questo paese». Cita le radici culturali e politiche del suo percorso: Abraham
Lincoln il liberatore degli schiavi, Franklin Delano Roosevelt e il suo new
deal, la rivoluzione di John Fitzgerald Kennedy, l’America della speranza di
Barack Obama. “Mio nonno mi diceva, mantieni la fede. Mia nonna, interveniva:
“No, Joey: diffondila”. Sul palco si riversa l’intera famiglia allargata di
Biden ed Harris. La moglie di lui Jill “sarà una fantastica first lady”. Il
marito di lei, Doug Emohff. I fuochi d’artificio colorano il cielo di bianco,
rossso e blu, come i colori della immensa bandiera sollevata con due gru. La
gente balla al ritmo di Sky full of stars dei Coldplay: la band preferita del
figlio defunto Beau Biden. La nuova America comincia da qui. Un nuovo
vocabolario. E tutta un’altra musica.
Biden eletto presidente degli Usa, il suo discorso: «Io qui
per unire». Massimo Gaggi da Wilmington su Il Corriere
della Sera l'8/11/2020. Il discorso della vittoria di Joe Biden e Kamala Harris
al Chase Center di Wilmington, la città dove vive il vicepresidente. Il discorso
della vittoria di Joe Biden e Kamala Harris al Chase Center di Wilmington, la
città dove vive il vicepresidente eletto. Ad ascoltarlo e ad applaudirlo alcune
centinaia di persone all’interno dalle loro auto, parcheggiate in stile drive-in
in un grande piazzale, e alcune migliaia di persone con mascherine però
assiepate nell’adiacente zona di sicurezza, anche con sedie da picnic. L’evento
su due maxischermi, collegati con i network americani. «Noi la gente ora abbiamo
il potere di costruire un futuro migliore»: le parole di Kamala Harris. «Non
dobbiamo dare mai la democrazia per scontata», ha aggiunto. «Sono la prima donna
vicepresidente ma non sarò l’ultima. Questo è un paese delle opportunità».
Rivolgendosi alla bambine dice: «Sognate con ambizioni». Poi lascia la parola al
presidente-eletto Biden che rivendica la volontà di rappresentare tutti gli
americani: «Non vedo Stati blu o rossi ma uniti. Voglio essere presidente che
unisce, domani giorno migliore». Il ringraziamento alla moglie: «Sono il marito
di Jill, e non sarei qui senza di lei. Senza la mia famiglia. Jill sarà una
fantastica First Lady». Lancia un ramoscello d’ulivo al termine di una campagna
elettorale durissima: «Basta trattare gli avversari come nemici». «So che sarete
delusi ma datemi un’opportunità», ha detto Biden si è rivolto così agli elettori
americani che non hanno votato per lui. «Sono un democratico orgoglioso ma
governerò da presidente degli Stati Uniti», ha assicurato. La folla resta
variegata, molti i bambini, tutti con bandiere americane e i gadget della
campagna. Ci sono anche tre ragazzi messicani che studiano in Delaware e
sventolano la bandiera del loro Paese: «È una vittoria anche per noi. Trump ci
aveva definito criminali, trafficanti e stupratori, Biden invece sarà un
presidente che rispetta tutti». Una volta insediato alla Casa Bianca, Joe Biden,
firmerà una serie di ordini esecutivi per cancellare alcune eredità del
predecessore Donald Trump. L’ex vice presidente ha già annunciato che riporterà
gli Usa nell’accordo sul clima di Parigi. Secondo il Washington Post, Biden
firmerà decreti anche per riportare Washington nell’Organizzazione mondiale
della sanità e abolirà il «travel ban», il bando sull’immigrazione in Usa da
paesi a maggioranza musulmana.
Massimo Gaggi per corriere.it il 7 novembre 2020. Joe Biden e
Kamala Harris celebrano il loro trionfo nella notte di Wilmington, tra fuochi
d’artificio e pattuglie di droni governati da computer che disegnano nel cielo
l’America la sua bandiera e i nomi dei futuri inquilini della Casa Bianca. È una
grande festa popolare drive-in con la gente fuori dalle auto, soprattutto
americanissimi fuoristrada, in piedi sui cofani o appollaiata sui tetti, che da
ore sta festeggiando. Tante mascherine ma di dubbia utilità, dato che ci sono
anche tante bottiglie di champagne che passano di bocca in bocca. Un’esplosione
di gioia dopo una settimana sulle montagne russe: dalla vittoria democratica a
valanga annunciata dai sondaggisti al timore di una sconfitta totale fino al
lento recupero e alla conquista dei 270 fatidici Grandi elettori, mentre un
Trump furibondo denuncia frodi delle quali, per ora, mancano indizi concreti.
Joe arriva sul podio di corsa e pronuncia, con insolito vigore, un discorso che
sulla Fox, la rete vicina al presidente, Karl Rove, lo stratega delle vittorie
elettorali di George Bush, definisce «semplicemente perfetto: quello che
l’America voleva sentire, un momento di potenziale riunificazione del Paese». La
battaglia per l’anima dell’America. Un discorso breve ma netto, per il quale
sceglie un linguaggio popolare. Se quattro anni Trump aveva scelto toni duri, un
linguaggio minaccioso e aveva eccitato le paure degli americani, Biden punta
sulla riunificazione, il superamento, pur nella diversità, delle
contrapposizioni più devastanti: si pone come il leader capace di curare le
ferite del Paese. La chiama la battaglia per l’anima dell’America: chiudere una
stagione di contrapposizioni devastanti: «L’oppositore non deve essere un
nemico, siamo tutti americani». Nessuna accusa a Trump che non cita mai
direttamente salvo un accenno alla delusione dello sconfitto: «Lo capisco, è
successo anche a me un paio di volte» (in passato Biden ha fallito due volte
nella corsa alla Casa Bianca, ndr). Biden si definisce un ponte verso il futuro
(un riferimento alla sua età avanzata e un omaggio a Kamala Harris, la prima
donna — e una donna di colore — ad entrare nell’ufficio di presidenza degli
Stati Uniti) e l’erede di gloriose tradizioni politiche che vanno da Abramo
Lincoln a John Kennedy all’Obama di Yes we can. Speranza e una fiducia che Biden
vuole non solo ribadire ma anche diffondere tra la gente, secondo l’insegnamento
di sua nonna. È il richiamo alle sue origini popolari, nato e cresciuto nella
Scranton operaia. Sulle Ali delle Aquile. Il residente eletto promette di
risollevare il ceto medio, ma intanto la priorità è combattere l’epidemia di
coronavirus che continua a dilagare e a uccidere in America: “Per tornare a
crescere dobbiamo assolutamente metterla sotto controllo”. Annuncia la
costituzione di una task force di esperti per preparare una nuova strategia anti
Covid, rende omaggio alle 230 mila famiglie che hanno perso loro cari
nell’epidemia e dedica loro un inno religioso, Sulle Ali delle Aquile che era
particolarmente caro al figlio Beau: l’amatissimo primogenito che avrebbe dovuto
essere il suo erede politico e che, invece, è stato ucciso cinque anni fa da un
cancro al cervello. Il ricordo di Beau torna alla fine quando l’insolitamente
calda notte di Wilmington viene illuminata da fuochi d’artificio mente gli
altoparlanti sparano The Best di Tina Turner e poi Sky Full of Stars, un cielo
pieno di stelle, dei Coldplay, la band preferita dal figlio scomparso. È una
grande festa, ma Biden già guarda avanti. Sa che deve correre e che non avrà
vita facile, stretto com’è su tre fronti: un presidente che seminerà di trappole
i due mesi e mezzo dell’interregno e poi gli farà la guerra dall’opposizione; un
Senato rimasto in mani repubblicane il cui leader, Mitch McConnell, un vecchio
notabile politico del Sud, condizionerà Biden tanto nella formazione del governo
quanto nei suoi programmi che, tradotti in leggi dovranno essere approvati dalle
Camere; la sinistra radicale il cui peso nel partito è molto cresciuto negli
ultimi anni e il cui appoggio — consistente, anche se non straordinario — ha
consentito a Biden di spuntarla negli Stati industriali persi nel 2016 da
Hillary Clinton. Riunificare: riuscire dove Obama ha fallito. Per questo lui
insiste sulla necessità di una riconciliazione nazionale dopo decenni di
spaccature radicali nel Paese e chiede di abbassare i toni della discussione
pubblica: un ritorno alla ragionevolezza, sia pure su posizioni contrapposte.
Anche Obama voleva essere un riunificatore e invece la sua America fu più
spaccata che mai. Biden sa che, con un Trump scatenato, rischia di fare una fine
anche peggiore, ma non è detto: Trump ha cambiato l’America e ha un seguito
enorme, ma ha anche lui le sue fragilità e in questi quattro anni si è fatto
un’infinità di nemici nel mondo conservatore che ora cercheranno vendetta.
Biden, esperto navigatore della politica di Washington, spera anche per questo
di trovare un terreno d’intesa con la vecchia guardia repubblicana che, con
l’eclisse di The Donald, potrebbe riprendere fiato. I rapporti con McConnell
sono difficili fin dai tempi del varo della riforma sanitaria di Obama, ma i due
sono vecchi politici pragmatici: potrebbero trovare terreni d’intesa. Del resto,
quando era presidente della Commissione Esteri del Senato, Biden riuscì ad
andare d’accordo anche con Jesse Helms, il «superfalco» repubblicano. La
strategia di governo. Biden governerà ricorrendo massicciamente agli ordini
esecutivi presidenziali come ha fatto Trump (lui ne varò 24 nei primi 100
giorni, Joe ne sta preparando anche di più), revocherà molte misure del suo
predecessore (come quelle più dure contro gli immigrati), riporterà gli Usa
negli accordi Parigi sul clima e nell’Organizzazione mondiale per la Sanità,
tenderà una mano all’Iran per provare a riattivare l’accordo nucleare,
rinsalderà di nuovo i rapporti con gli alleati europei: tutte cose che non
richiedono di passare dal Congresso. Con McConnell negozierà un pacchetto di
misure a sostegno dell’economia e dei lavoratori colpiti dalla pandemia. I
repubblicani probabilmente metteranno veti su nomi di personaggi molto
caratterizzati a sinistra della lista di ministri che Biden ha in mente. Ma non
detto che per il leader democratico, che è sempre stato un centrista, questo sia
un fatto totalmente negativo: giustificherà, davanti alla sinistra del suo
partito, l’adozione di una linea più moderata e anche l’impossibilità di
ottenere la ratifica della nomina di campioni liberal: al Tesoro, ad esempio,
invece di Elizabeth Warren, potrebbe arrivare l’economista Lael Brainard. Ma,
prima di tutto, Biden dichiarerà guerra al coronavirus che devasta l’America ma
che con la fine dell’inverno e l’arrivo dei vaccini potrebbe arretrare proprio
quando Biden entrerà in carica. Kamala Harris. Prima donna ad entrare
nell’ufficio di presidenza degli Stati Uniti, Kamala promette che non sarà
l’ultima: rivendica la candidatura di Biden e la sua come un modo, in primo
luogo, di difendere le libertà e la democrazia che non è, dice citando il leader
nero John Lewis recentemente scomparso, uno status garantito, ma ua realtà
mobile che va continuamente difesa e rinnovata. Harris guarda al futuro ma rende
omaggio alle battaglie combattute, decennio dopo decennio, dalle donne, da
quelle che un secolo fa si batterono per l’estensione del voto alla popolazione
femminile col 19esimo Emendamento della Costituzione americana, votato nel 1920,
a sua madre, scienziata immigrata dall’India: «Io sono seduta sulle loro
spalle».
Viviana Mazza per Corriere.it l'8 novembre 2020. «Ce l’abbiamo
fatta, Joe! Sarai il prossimo presidente degli Stati Uniti». Kamala Harris ride
di sollievo, al telefono con Biden. Quando arriva la notizia della vittoria, è
in tuta, a passeggio col marito Doug, che pubblica il video su Twitter. Harris
sarà la prima vicepresidente donna, la prima nera e la prima indiana-americana
nella storia degli Stati Uniti d’America. Cinquantacinque anni dopo che il
Voting Rights Act rimosse le barriere che (soprattutto nel Sud) ostacolavano il
voto degli afroamericani. Trentasei anni dopo che la prima donna (Geraldine
Ferraro) corse per la vicepresidenza. E quattro anni dopo la sconfitta di
Hillary contro Donald Trump. C’è chi piange di sollievo qui ad Atlanta, «mecca»
nera dell’America, proprio come si è commosso in tv il commentatore
afroamericano Van Jones, spiegando che «I can’t breathe» — la frase pronunciata
da George Floyd, morto soffocato sotto il ginocchio di un poliziotto bianco a
Minneapolis — «descrive come molti si sentivano: non riuscivamo a respirare».
Tanti sono in strada a festeggiare, tra clacson e applausi; altri al lavoro come
Rickie Bailey, afroamericana, veterana di guerra. «Piango di gioia. Mia nonna ha
vissuto fino a 110 anni e mi diceva che per gran parte della sua vita non aveva
potuto votare. In quest’elezione io non ho solo votato, ma sono stata una
volontaria e un’osservatrice alle urne, nonostante avessi un figlio in ospedale.
Ora al potere c’è una donna che ha il mio aspetto, in cui posso riconoscermi.
Per ogni ragazzina sarà un’ispirazione. E’ successo grazie alle donne delle
minoranze, abbiamo fatto la differenza: il razzismo c’è ancora, ma abbiamo
abbracciato la nostra storia e siamo arrivate ai vertici». Ad Atlanta altre due
afroamericane ambivano al posto di Kamala, ma hanno lavorato per lei: la sindaca
Keisha Lance Bottoms e soprattutto Stacey Abrams, il volto delle battaglie per
la registrazione degli elettori e contro la soppressione del voto, che tutti in
queste ore ringraziano per la vittoria del partito democratico in Georgia. Tante
altre, lontano dai riflettori, hanno fatto la loro parte: da Rickie Bailey che
aspetta la sera per festeggiare a casa, fino a una signora che attendeva con
ansia la notizia alla Ebenezer Church, la chiesa battista del reverendo King,
vestita nei colori verde e rosa dell’Alpha Kappa Alpha, la più antica «sorority»
di studentesse nere (di cui fa parte Kamala). «Madam Vice President non è più
solo fiction», ha scritto su Twitter l’attrice Julia Louis-Dreyfus, protagonista
della serie «Vice». Alla fine, in tv la vice diventa presidente. Anche Harris
mirava allo Studio Ovale. Sarà la numero due di un presidente che compirà 78
anni prima dell’insediamento e non è detto corra per un secondo mandato. E’ il
nuovo volto del partito, e forse il suo futuro. Non tutti sono d’accordo con le
sue passate scelte politiche, specialmente quando prima di entrare al Senato era
procuratrice della California, ma sperano che con Biden e lei almeno ci sia
qualcuno a cui chiedere conto alla Casa Bianca. E poi l’identificazione con un
leader passa anche dal livello emotivo. Alla guida della nazione ci sarà una
famiglia moderna, come se ne vedono tante a San Francisco ma anche ad Atlanta.
Se l’inno di Trump ai comizi era «Macho Man», la canzone di Kamala è «Work That»
di Mary J. Blige, cioé «Sii te stessa, usa quel che hai». Kamala ha rifiutato di
incastrarsi in nette categorie razziali di creazione altrui: «Sono quello che
sono, e mi va bene così. Sono americana». Lei e la sorella Maya sono
bi-razziali, indiane e giamaicane, cresciute andando al tempio hindu ma anche
immerse nella cultura afroamericana: la madre, anche dopo la separazione dal
marito giamaicano, sapeva che in America sarebbero state etichettate come donne
nere, e voleva che ne fossero fiere. Doug Elmhoff, il marito bianco ed ebreo
(già padre di due figli), sarà il primo «Second Gentleman» alla Casa Bianca. E’
scoppiato in lacrime alla chiusura delle urne, raccontano i volontari. Per tutto
il tempo era stato «entusiasta, a volte inspiegabilmente» ma anche preoccupato.
Scrutava tra la folla ai comizi, attento alla sicurezza della moglie. Gli
attacchi misogini contro Kamala non cesseranno: da Trump che l’ha definita «un
mostro» e «una pazza» al commentatore Rush Limbaugh con la battuta «Joe and the
Hoe» (Joe e la puttana). Calzando le sue Converse, continuerà a rispondere
tranquilla: «Sono solo distrazioni». Il suo primo tweet da
vicepresidente-eletta: «Quest’elezione riguarda molto di più che Joe Biden o me…
Abbiamo tanto lavoro da fare. Cominciamo».
Angelo Zinetti per “Libero quotidiano” il 13 novembre 2020. Mr.
Harris va a Washington, per parafrasare il celebre film di Frank Capra. Il
marito di Kamala Harris, la vice-Biden, noto avvocato, ha dichiarato la sua
intenzione di rinunciare, momentaneamente, al suo redditizio lavoro per dare una
mano alla consorte, attesa, riconteggi trumpiani permettendo, dall' incarico
prestigioso di vicepresidente degli Stati Uniti. La notizia ha mandato in
visibilio i media di entrambe le sponde dell' Atlantico. Per quale motivo?
Sarebbe la prima volta che, a così alto livello, il maschio mette da parte le
sue ambizioni personali per assecondare quelle, in questo caso ancora più
importanti, della propria femmina. Tutto bellissimo. Sorge però un dubbio:
perché quando Donald Trump si circondò dei più stretti familiari come
collaboratori si parlò di favoritismo? Quando scelse la figlia Ivanka quale
consigliere della Casa Bianca si gridò al nepotismo. E nessuno si intenerì
allorchè il marito della figlia prediletta dal tycoon, Jared Kushner, cominciò
ad aiutarla nel suo lavoro politico. L' entrourage di Trump è chiamato, con
disprezzo, la "family".
RACCOMANDATI o santi. Eppure è stato proprio Jared, ebreo
(quindi ascoltato da molti a Gerusalemme) e ricco (quindi ben accetto dai
governanti arabi) a tessere la tela che ha portato agli storici - e
misconosciuti almeno in Europa - Accordi di Abramo. Cioè la pace e la
collaborazione fra Israele e molti Stati del fronte musulmano che l' hanno
avversato a partire dal 1948. Anche Mr. Harris è ebreo. Douglas Emhoff è un
avvocato di successo e ha 56 anni. Probabilmente il nonno sbarcato dall' Europa,
stanco di sentirsi apostrofare come "Aimhoff" ha cambiato la "I" iniziale del
suo cognome in "E". Come Aigor di "Frankenstein Junior". Doug, ormai un pezzo
grosso dello studio legale DLA Piper, ha sposato Kamala, giudice (ex procuratore
generale della California), in seconde nozze sei anni fa. Il passo indietro di
Doug non ha solo un valore simbolico nella questione della parità dei sessi;
dietro si cela anche una precauzione per salvare la faccia alla Presidenza
Biden: mentre Emhoff pare non svolgesse nemmeno in passato attività di lobbying,
il suo Studio legale (di cui Emhoff è manager e socio) tutela i diritti e gli
interessi di importanti gruppi, come la Comcast, Raytheon o il Governo del
Portorico. Il taglio di ogni legame con il suo lavoro era stato indicato dall'
avvocato di affari come un imperativo morale. Decisione opposta invece ha preso
la moglie di Joe, Jill, la quale ha infatti annunciato che non lascerà il suo
posto di insegnante delle scuole superiori.
Stefano Graziosi per “la Verità” il 13 novembre 2020. Che tra i
numerosi potentati economici che quest' anno hanno ampiamente foraggiato il
Partito democratico americano ci fosse la Silicon Valley, non è una novità.
Guardando tuttavia da vicino i finanziamenti effettuati, si nota che la potenza
di fuoco dei colossi tecnologici sia stata veramente impressionante. Secondo
quanto riportato da Open secrets (sito dell' istituto di ricerca apartitico di
Washington, Center for responsive politics), il comparto
«Communications/Electronics» ha donato, nel ciclo elettorale del 2020, 259,3
milioni di dollari ai democratici, a fronte dei 58,3 milioni elargiti ai
repubblicani. Certo, è pur vero che storicamente le grandi aziende tecnologiche
abbiano sempre mostrato di preferire l' asinello all' elefantino. Ma quest' anno
il loro impegno è cresciuto sensibilmente: si pensi che nel 2016 diedero
«appena» 162 milioni di dollari ai dem, mentre nel 2012 il contributo fu di 106
milioni. Entrando poi nello specifico dei singoli candidati presidenziali di
quest'anno, Open secrets riporta che il settore abbia principalmente sostenuto
Joe Biden, con oltre 48.700.000 dollari: una cifra considerevole, soprattutto se
confrontata con i circa 8 milioni incassati dal presidente in carica. Numeri
comunque ben differenti dal 2016, quando l' allora candidata Hillary Clinton
ottenne 31 milioni di dollari, a fronte dei due ricevuti dallo stesso Donald
Trump. Anche a livello di bacini legati a singole aziende, la maggior parte dei
contributi è confluita nell' area dem. Alphabet ha versato circa 11.373.000
dollari, di cui il 92.9% è andato all' asinello. Microsoft ha invece messo in
campo circa 8.847.000 dollari, di cui l' 88,5% è stato convogliato nella
galassia dem. Anche l' 89,7% dei circa 3.600.000 dollari elargiti da Facebook è
stato indirizzato verso il Partito democratico. Discorso analogo vale per Amazon
che ha donato l' 84% dei suoi 6.187.000 dollari complessivi all' asinello. Anche
dei circa 3.864.000 dollari totali sborsati da Apple, il 90,1% sono andati ai
dem. La stessa Oracle, considerata maggiormente vicina a Trump, ha indirizzato
ai democratici il 74,4% delle proprie donazioni complessive (circa 2.400.000
dollari). Open secrets riporta inoltre come tra i finanziatori del super Pac
progressista, Priorities Usa Action, figurino svariati dipendenti di Apple,
Google e Amazon. In tutto questo, non va neppure trascurato che - subito dopo l'
assegnazione della Pennsylvania a Biden da parte della Cnn - siano fioccate le
congratulazioni al ticket dem da parte di alcuni importanti esponenti dei
colossi tecnologici: dal Ceo di Amazon Jeff Bezos al fondatore di Microsoft Bill
Gates, passando per Priscilla Chan (moglie di Mark Zuckerbeg) e Sheryl Sandberg
(direttrice operativa di Facebook). D' altronde, lo scorso agosto il sito
progressista Vox sottolineò le strette connessioni di Kamala Harris con la
Silicon Valley, oltre al fatto che, ai tempi della sua campagna per il Senato,
la vicepresidentessa in pectore avesse ricevuto finanziamenti ed endorsement
proprio da alcuni alti funzionari dei colossi tecnologici (a partire dalla
stessa Sandberg). Insomma, lo sforzo poderoso che la Silicon Valley ha attuato
per sostenere l' universo democratico è abbastanza evidente. Un elemento che
offre lo spunto per due considerazioni di natura politica. Innanzitutto ciò
rende maggiormente evidente il fatto che i principali social network abbiano
portato avanti una battaglia strumentale (e non una difesa della verità),
censurando gli articoli del New York Post sulla famiglia Biden. D' altronde, se
la motivazione per bloccare la condivisione di quelle inchieste era che non
fossero verificate, allora non si spiega per quale ragione Facebook e Twitter
non abbiano censurato - nel gennaio del 2017 - l' altrettanto infondato dossier
di Christopher Steele, pubblicato da BuzzFeed: documento che, guarda caso,
accusava Trump di essere sotto ricatto dei russi. In secondo luogo, è bene fare
attenzione alla politica commerciale. La Silicon Valley ha sempre guardato con
fastidio alla guerra tariffaria, avviata dal presidente in carica nei confronti
di Pechino: per le aziende dell' area quelle tensioni hanno infatti significato
meno investimenti cinesi e maggiori problemi per delocalizzare la produzione
nella Repubblica popolare. Non dimentichiamo che proprio questo fattore abbia
costituito una delle principali cause di attrito tra l' attuale inquilino della
Casa Bianca e Apple negli ultimi anni: era il gennaio del 2019, quando Trump
dichiarò: «Apple produce i suoi prodotti in Cina. Ho detto a Tim Cook, che è un
mio amico: "Fai i tuoi prodotti negli Stati Uniti" [] La Cina è il principale
beneficiario di Apple, non noi». Non sarà allora forse un caso che, durante il
dibattito tra i candidati alla vicepresidenza dello scorso ottobre, Kamala
Harris abbia duramente criticato proprio la guerra commerciale, portata avanti
dal presidente in carica verso Pechino: tutto questo con buona pace dei colletti
blu della Rust Belt che, soprattutto nell' ultimo decennio, della
delocalizzazione della produzione e della concorrenza sleale cinese sono stati
le prime vittime. E pensare che, sabato scorso, Biden ha dichiarato che la sua è
stata una «vittoria del popolo»! Per carità, può anche essere. Resta tuttavia da
capire che cosa intenda per «popolo». Perché come riuscirà a far convergere gli
interessi dei colossi tecnologici con quelli della working class, non è
esattamente chiaro.
La dedica di Kamala alle donne: «Sognate con grande
ambizione». Il Dubbio l'8 novembre 2020. Il ricordo
della madre: «Quando è arrivata qui a 19 anni dall’India non immaginava questo
momento, ma credeva in un’America dove questi momenti sono possibili». Nel suo
discorso Kamala Harris, prima donna, prima donna nera e prima donna di origine
indiana ad essere eletta vicepresidente, ha parlato di «un nuovo giorno per
l’America», ringraziando gli americani per aver fatto sentire la loro voce. In
un breve discorso pronunciato dopo che lei e Joseph R. Biden Jr. sono stati
dichiarati vincitori delle elezioni presidenziali del 2020, Harris ha ricordato
sua madre, un’immigrata arrivata in California da adolescente. Ecco il discorso
completo della neo eletta vicepresidente degli Usa. John Lewis, prima di
lasciarci, ha scritto che la democrazia non è uno stato, è un atto e quello che
intendeva dire è che la democrazia non è garantita: dobbiamo avere una forte
volontà di difenderla, salvaguardarla, non darla mai per scontata. Questo
richiede una battaglia, dei sacrifici, ma anche gioia, perché noi, il popolo,
abbiamo il potere di costruire un futuro migliore. Quando l’essenza della nostra
democrazia era in gioco durante queste elezioni e il mondo ci guardava, voi
avete dato vita ad un nuovo giorno, una nuova alba per l’America. Ringrazio i
volontari della nostra campagna, questo grandioso team, a loro va il nostro
grazie per aver coinvolto il più alto numero di persone che si sia mai
registrato e per avere reso possibile questo vittoria; ringrazio gli scrutatori,
le autorità che hanno lavorato senza sosta per garantire che ogni voto venisse
contato: il nostro paese vi è grato, avete promosso e difeso l’identità della
nostra democrazia e dei cittadini americani che rendono questo paese quello che
è. Grazie per l’affluenza. So che siamo in un momento difficile, soprattutto gli
ultimi mesi, con la sofferenza, il dolore, le preoccupazioni, le battaglie
quotidiane; siamo testimoni del vostro coraggio, della vostra resilienza e
generosità. Per quattro anni avete marciato, organizzato manifestazioni per
l’uguaglianza, la giustizia, le nostre vite, il pianeta. Siete riusciti a
consegnare un messaggio molto chiaro: avete scelto speranza, onestà, scienza,
verità. Avete scelto Joe Biden come prossimo presidente degli Stati Uniti
d’America. Joe è una persona che sa guarire, unire, ha una mano ferma,
esperienza, è una persona che ha vissuto sulla sua pelle cosa significa la
perdita e questo gli ha dato uno scopo; è un uomo con un cuore grande che ama
tutti quelli che sono intorno a lui, la moglie Jill, i figli Hunter e Ashley, i
sui nipoti, la famiglia. Io l’ho conosciuto quando era vicepresidente e l’ho
conosciuto come padre di Beau, che vogliamo ricordare. Mio marito Doug, i nostri
figli, mia sorella, la nostra famiglia, siamo davvero grati a Joe e Jill per
averci accolto nella loro famiglia; ringrazio mia madre, che è sempre nei nostri
cuori. Quando è arrivata qui a 19 anni dall’India non immaginava questo momento,
ma credeva in un’America dove questi momenti sono possibili. Penso alle donne,
alle donne nere, asiatiche, bianche, ispaniche, nativo americane, che nel corso
della storia di questo paese hanno aperto la strada per questo momento, si sono
sacrificate per l’uguaglianza, la libertà e la giustizia per tutti noi; penso
alle donne nere che troppo spesso non sono considerate, ma sono la spina dorsale
della nostra democrazia. Penso a tutte le donne che hanno lavorato per garantire
il diritto di voto e che ora nel 2020 con una nuova generazione hanno votato e
continuano a lottare per farsi ascoltare. Stasera voglio riflettere sulle loro
battaglie, la loro determinazione, la loro capacità di vedere cioè che sarà a
prescindere da quello che è stato. E questa è una testimonianza della
personalità di Joe, che ha avuto il coraggio di buttare giù uno dei muri che
continuavano a resistere nel nostro paese scegliendo una donna come
vicepresidente. Anche se sono la prima a ricoprire questa carica, non sarò
l’ultima. Ogni bambina, ragazza che stasera ci guarda vede che questo è un paese
pieno di possibilità. Il nostro paese vi manda un messaggio: sognate con grande
ambizione, guidate con cognizione, guardatevi in un modo in cui gli altri
potrebbero non vedervi. Noi saremo lì con voi. Mi rivolgo ai cittadini
americani, a prescindere dal loro voto: io lotterò per essere per Joe quello che
lui è stato per Obama, leale, preparato, pensando sempre a voi. Ora comincia il
lavoro duro, necessario, essenziale per salvare le vite e combattere l’epidemia,
ricostruire l’economa, eliminare il razzismo sistemico, affrontare la crisi
climatica e far guarire l’anima di questa nazione. La strada non è facile, ma
l’America è pronta. E lo siamo io e Joe. Abbiamo eletto un presidente che
rappresenta il meglio di noi, che il mondo rispetterà e che i figli ammireranno,
un comandante che rispetta i soldati e ci terrà al sicuro, un presidente per
tutti agli americani.
Donne come noi. Federica Bianchi su
L'Espresso il 12 agosto 2020. Kamala Harris: candidata non per caso.
Implacabile. Lo spirito della senatrice Kamala Harris, appena scelta da Joe
Biden come sua vice-presidente nella corsa elezioni presidenziali americane del
3 novembre, può essere riassunto in questo unico aggettivo. Che finalmente non è
inteso in modo negativo, pur caratterizzando una donna e non un uomo, ma come un
pregio, una caratteristica personale fondamentale per potere sconfiggere il
prossimo 3 novembre Donald Trump. Implacabile come pubblica accusa, implacabile
con i criminali di ogni colore, implacabile in senato con i politici bugiardi e
irresponsabili. Harris prende la parola con il sorriso ma non molla mai la
presa. «Il sistema penale americano è imperfetto e va riformato», rispondeva lei
ai critici del suo operato duro come procuratore distrettuale della California:
«Ma non vogliamo che chi compie gesti gravi non subisca le conseguenze, anche
gravi». La chiamano “killer”, e c'è una parte dell'estrema sinistra americana –
ma non Bernie Sanders che su Twitter l'ha subito appoggiata – che la definisce
traditrice dei valori progressisti. Che dice si rifiuterà di votarla nel ticket
con Joe Biden perché anche questi due candidati presidenziali, aldilà del colore
della pelle, come le coppie che li hanno preceduti, sono figli delle élite
liberiste. Non abbastanza a sinistra. Eppure Harris incarna alla perfezione lo
spirito americano originale, in versione contemporanea. Lo spirito di chi
l'"America" l'ha costruita pezzo dopo pezzo. Prima generazione di americani
(inaudito per una persona candidata alla vicepresidenza), figlia di una
ricercatrice indiana trasferitasi da sola in California per studiare a 19 anni e
di un padre giamaicano che, dopo il master, è stato professore di Economia a
Stanford per oltre 20 anni, è diventata bambina mangiando pane e lotta per un
mondo migliore. I genitori si sono incontrati durante una delle storiche marce
degli anni Settanta e, anche dopo il loro divorzio quando lei aveva solo quattro
anni, la madre, scienziata e ricercatrice nella lotta contro il cancro, a
Oakland, la sorella povera di san Francisco, ha continuato a crescere lei e la
sorella minore con l'ambizione che servissero la società e costruissero un mondo
migliore. Senza filtri. Senza dubbi. Kamala e Maya si sono entrambe laureate in
legge nelle migliori università americane e hanno preso a lavorare l'una come
pubblico ministero, l'altra come professore e consulente politica, fino ad
arrivare ai vertici della loro carriera, sempre al servizio della causa
democratica. Ma la scelta di Harris è anche il miracolo ottenuto
dall'incrociarsi di due storiche battaglie per i diritti civili contemporanei
che hanno coinvolto milioni di americani: #metoo e #BlackLivesMatter. Gli ultimi
quattro anni di presidenza Trump non sono stati invano. Hanno accelerato quel
processo già in corso da anni per cui le minoranze etniche degli Stati Uniti, le
nuove generazione di immigrati, ormai ben lontani dalle radici europee e in
maggioranza non bianchi, e le donne, quella seconda metà del cielo a cui
Washington non garantisce ancora una maternità pagata, hanno lasciato il fondo
della società professionale per avanzare in primo piano. Il disprezzo dimostrato
dall'attuale presidente americano verso il sesso femminile fin dal primo giorno
in carica e poi verso le vite dei cittadini di colore ha rafforzato, non solo
sul suolo americano ma, come trent'anni fa, in tutto l'Occidente, la lotta per
la conquista di ruoli di primo piano nella società, nell'economia e nella
politica. Con l'obiettivo di cambiarle dall'interno e di renderle, se non più
giuste, almeno più eque. In questo senso Kamala Harris è il prodotto di questi
quattro anni di regime trumpista. Ma la sua nomina molto deve anche alle donne
più anziane che le hanno tracciato il sentiero su cui camminare: Hillary
Clinton, ostacolata più che aiutata nelle sue ambizioni da un marito presidente
popolarissimo, e Elizabeth Warren, paladina anziana e forte di quella sinistra
che nell'America moderna non ha ancora trovato posto o riconoscimento e che è
stata protagonista della “rivoluzione dai cappelli di lana rosa”, in cui più
generazioni e etnie di donne si sono ritrovate insieme a rivendicare spazio e
voce. E a centinaia, quattro anni fa, hanno deciso che fosse arrivato il
momento di fare politica sul serio. Harris in realtà parte perdente. Ha perso la
battaglia alla nomination come presidente democratico, esattamente come Warren.
Ma il giorno in cui sul palcoscenico democratico rimasero solo due vecchi,
uomini bianchi, Sanders e Biden, è stato anche il momento in cui i democratici
americani si sono resi conto che quella fotografia non avrebbe mai più potuto
rappresentare il futuro che raccontavano. È stato il momento in cui mesi e anni
di lotta si sono concretizzati in un'assenza ingombrante. Le donne non potevano
più essere escluse. Non più essere stigmatizzate perché troppo volitive, troppo
forti, troppo presenti. E se, nonostante tutto, entrare dalla porta principale
anche negli Stati Uniti non è ancora accettato, allora ben venga l'entrata
laterale che sta facendo Harris: la corsa come vicepresidente giovane di un
presidente vecchio. Certamente un cliché ma accettabile per la maggioranza della
popolazione. E, soprattutto, se vincente, il viatico tanto sospirato per una
futura presidenza americana al femminile. Sarà mai che l'eredità potente di
Angela Merkel potrà un giorno essere raccolta da Kamala Harris, dall'altra parte
dell'Oceano?
Giuseppe Sarcina per il "Corriere della Sera" il 13 agosto 2020.
«Donald Trump ha distrutto tutto quello che ha ereditato dalle precedenti
amministrazioni. È colpa sua se gli Stati Uniti sono il Paese più colpito dalla
pandemia nel mondo. È sua la responsabilità se stiamo attraversando la crisi
economica peggiore dalla Grande depressione». Kamala Harris si presenta con un
concetto semplice: Trump «pensa solo a se stesso» e intanto «rade al suolo
l'America». La senatrice californiana, 55 anni, ha tenuto ieri pomeriggio il
primo discorso, a fianco di Joe Biden, in una scuola di Wilmington, in Delaware.
Il ticket «storico», con l'esordio assoluto di una donna
afro-asiatico-americana, ha poi partecipato a una raccolta di fondi online.
Biden, il candidato presidente, è rimasto sul solito registro, etico-morale: «Se
io e Kamala saremo eletti erediteremo numerose crisi, una nazione divisa e un
mondo nel caos. Non avremo un minuto da perdere. È esattamente questo il motivo
per cui l'ho scelta: è pronta a guidare fin dal primo minuto». Nel corso della
giornata Harris aveva postato un video condito con un po' di retorica e qualche
slogan: «Ora l'America ha bisogno di azione. Nel mezzo dell'epidemia, il
presidente sta cercando di distruggere il sistema sanitario. Le piccole imprese
chiudono e lui premia i suoi ricchi finanziatori. La gente chiede aiuto e lui
risponde con i gas lacrimogeni». Ma al debutto non si sono sentite nuove
proposte su come, nel concreto, fronteggiare l'emergenza. Evidentemente i due
hanno bisogno di tempo. Il processo di selezione della vice è risultato
estenuante e ha consumato energie preziose. Biden ha cercato un punto di sintesi
tra la spinta (vincente) degli afroamericani, l'esigenza di tenere il centro per
recuperare i trumpiani delusi, le istanze «rivoluzionarie» della ala più
radicale. Ne è risultato un tandem moderato, che guarda a sinistra. Per il
momento Harris ha fatto il pieno di complimenti sul versante democratico,
compresi quelli di Barack Obama, che sollecita un cambio di passo: «Adesso,
però, cerchiamo di vincere». I «democratico-socialisti» hanno reagito con
tiepida cortesia. Bernie Sanders, naturalmente, si è unito al coro di elogi per
le «qualità» di Kamala, ricordando, maliziosamente, che la figlia di un
immigrato giamaicano e di un'indiana-tamil, «sta dalla parte dei lavoratori».
Interessante anche notare come Alexandria Ocasio-Cortez, la deputata star della
sinistra, si sia limitata a rilanciare i commenti di Sanders e di Elizabeth
Warren su Kamala Harris. Nel partito è in corso da settimane un intenso
negoziato su almeno cinque punti chiave: sanità, fisco, scuola, energia, riforma
della polizia. Su nessuno di questi Kamala Harris ha dimostrato di avere un'idea
forte e riconoscibile. Nel corso delle primarie ha ondeggiato tra posizioni
sandersiane e schemi moderati più tradizionali. Anche per questo la sua
candidatura è miseramente naufragata. Quella oggettiva debolezza adesso può
diventare un valore aggiunto, perché Harris può rappresentare una garanzia per
tutti. C'è, però, un'altra considerazione: siamo sicuri che la campagna
elettorale si giocherà su contenuti specifici, come vorrebbero Sanders, Warren,
Ocasio-Cortez? Forse è ancora presto per dirlo, ma certo il Covid-19 ha cambiato
lo scenario. Il voto di novembre potrebbe diventare semplicemente un referendum
sulla adeguatezza di Trump. Il presidente, per altro, ha già spostato lo scontro
sul piano personale, accogliendo Kamala con un insulto-soprannome: «phony»,
fasulla, ipocrita. I democratici si aspettano una risposta a tono. Una scossa
alla campagna. Più visibilità sul territorio, più grinta. Alla prima uscita, la
senatrice ha confermato di avere le qualità caratteriali e l'esperienza per
mettere in difficoltà Trump, senza farsi intimidire dalle volgarità sessiste o
dai colpi bassi di Fox News.
Quello che
non vi dicono su Kamala Harris.
Francesco
Giubilei, 9 novembre 2020 su Nicolaporro.it. Stiamo già leggendo fiumi di parole
per elogiare Kamala Harris, giornalisti e commentatori che si sperticano nelle
lodi del nuovo vicepresidente degli Stati Uniti, articoli dai toni trionfali,
titoli elogiatovi. Quasi assenti le analisi sulle sue posizioni e il suo credo
politico, proviamo a farlo noi partendo dal presupposto che una persona andrebbe
valutata nei contenuti a prescindere dal suo sesso, dal colore della pelle o
dalla sua origine (solo così può esistere una vera parità tra uomo e donna, tra
bianchi e neri).
Progressista
intollerante. Il problema è che le posizioni di Kamala Harris sono preoccupanti.
In un articolo intitolato Kamala Harris, the cancel culture pop, il Washington
Examiner afferma che la sua “carriera politica e giudiziaria è stata costruita
sulla punizione di coloro che trova deplorevoli” aggiungendo “non è una semplice
demagoga. È una demagoga che userà il potere del governo federale per punire
‘l’altra parte’”. E l’altra parte, neanche a dirlo, sono i conservatori a cui
spettano anni difficili in particolare sui temi etici e il diritto alla vita.
Kamala Harris ha dichiarato pubblicamente che “il governo federale dovrebbe
trattare i sostenitori pro-life come i segregazionisti”, una frase inquietante.
Al tempo stesso ha etichettato alcune importanti organizzazioni cattoliche
americane di solidarietà come “estremiste”. “La campagna presidenziale di Harris
si è concentrata sulla divisione del paese” e i sostenitori della vita “avranno
tutti motivo di temere la persecuzione in un’amministrazione in cui Harris ha il
potere”. Un’opinione sostenuta da un’altra importante testata come The American
Conservative “sembra pensare che il suo lavoro come senatore sia quello di
tormentare i conservatori alle udienze con tutta la presunzione di colpevolezza
fino a prova contraria di un inquisitore”. Non è un caso che Rod Dreher, voce di
spicco del mondo conservatore americano, scriva: “di tutte le persone che
avrebbe potuto scegliere, penso che Kamala Harris sia la più pericolosa, da un
punto di vista sociale conservatore”.
Ambientalista
radicale. Ci sono poi le posizioni della Harris sul tema dell’ambiente che
rappresentano l’emblema dell’ambientalismo ideologizzato di stampo globalista
rappresentato da Greta Thunberg. Una visione radicale e fanatica della battaglia
ambientale che dimentica le esigenze delle comunità locali e il concetto di
identità e tradizione. Nonostante le sue posizioni in campo economico più vicine
a un approccio socialista (pur riferito al contesto americano) che potrebbero
portare a un aumento della pressione fiscale negli Stati Uniti, la Harris è
tutt’altro che una donna del popolo avendo alle spalle il sostegno di una parte
importante del mondo finanziario e dei big tech. Un esempio su tutti? Le parole
riportate dal New York Times: “Wall Street è felice dei segnali che ha mandato”,
la “Silicon Valley è felice di vedere una faccia famigliare”. In Italia si è
subito diffuso il mito di Kamala Harris paladina dei democratici e del mondo
afroamericano, la realtà è ben altra, basti pensare che la sua candidatura alle
primarie democratiche si è conclusa con un nulla di fatto e un crollo di
popolarità nei sondaggi in particolare nel secondo dibattito tra i candidati
(nel primo aveva attaccato duramente Biden con una velata accusa di razzismo,
per capire il grado di spregiudicatezza). Nella composizione della futura
amministrazione Biden, preoccupa molto di più il ruolo che assumerà la Harris
rispetto a quello ricoperto dal Presidente, il rischio è che possa influenzare
la presidenza con una linea più radicale.
Chi è Kamala Harris, la prima donna nera candidata
vicepresidente con Biden. Redazione su Il Riformista
il 12 Agosto 2020. Afroamericana, 55 anni, senatrice della California e ambisce
ancora più in alto: Kamala Harris è la prescelta di Joe Biden ad affiancarlo
come vicepresidente degli Stati Uniti alle elezioni 2020. E’ la prima donna nera
ad essere proposta in quel ruolo e ha già dato prova di che pasta è fatta. Di
origini giamaicane si è sempre detta “una donna di colore”, rappresentante degli
afroamericani e delle altre minoranze. Studi giuridici e un curriculum di
battaglie fatte in difesa delle donne e dei migranti, Kamala Harris si è detta
onorata per essere stata scelta. Biden può unire gli americani perché ha
trascorso la sua vita combattendo per noi”. Trump non ha colto di buon grado la
nomina e ha subito commentato con un tweet: “Slow Joe (Joe il tardo) e Phony
Kamala (Kamala l’ipocrita) sono perfetti insieme ma sbagliati per l’America”, ha
scritto in un tweet. Il presidente ha poi rincarato la dose, dichiarando:
“Harris vuole aumentare le tasse, è contro il fracking, vuole togliere la
copertura sanitaria a milioni di americani. Sono rimasto sorpreso che sia stata
scelta, ha fatto molto male nelle primarie democratiche”. Obama, dal canto suo,
ha reagito alla notizia con entusiasmo: “È un gran giorno per l’America”.
Tuttavia nel 2014 proprio Trump, insieme alla figlia Ivanka aveva finanziato la
campagna elettorale di Harris come procuratore della California. Harris in
seguito ha dato quei soldi a un’organizzazione no profit che difende i diritti
civili e umani per i centroamericani. Harris ha cominciato come sostituto
procuratore a San Francisco. Nel 2010 è stata eletta Procuratore Generale della
California. Nel 2016 è approdata al Congresso. Figlia di una scienziata Tamil e
di un professore di economia giamaicano, si considera “una donna di colore”. Che
Kamala piaccia lo dimostra la folla dei suoi sostenitori: il 27 gennaio 2019 in
un comizio-evento radunò circa ventimila persone a Oakland, la sua città natale.
Pare che Kamala sia una buona carta giocata da Biden per le presidenziali 2020
di novembre: Fra le 16 e le 20 ora locale, ovvero nel bel mezzo dell’annuncio di
Joe Biden, ActBlue – la maggiore piattaforma che si occupa delle donazioni per i
democratici – ha riportato 10,8 milioni di dollari in donazioni. Il giorno
precedente, nello stesso arco temporale, erano risultate pari a 2,3 milioni
indicando quindi un balzo di 8,5 milioni. Probabilmente è l’effetto Kamala che
ha convinto e spinto le donazioni dei democratici.
Kamala Harris, il nuovo sogno americano: è la figlia di una
tamil e di un jamaicano la candidata vice alla Casa Bianca.
Vittorio Ferla su Il Riformista il 13 Agosto 2020. Tutti quelli –
ed erano tanti – che pensavano che Barack Obama, primo presidente nero nella
storia degli Stati Uniti, rappresentasse la vetta delle aspettative dei
democratici di tutto il mondo dovranno ricredersi. Alla realizzazione del sogno
dell’integrazione e dell’eguaglianza manca ancora qualcosa. O, meglio, qualcuno.
Per esempio, una donna nera, magari di origini indiane, alla Casa Bianca. Se Joe
Biden dovesse vincere le elezioni presidenziali di novembre, questo nuovo sogno
americano diventerebbe realtà. Martedì scorso, il candidato democratico ha fatto
la sua scelta. La senatrice Kamala Harris è diventata la prima donna americana
nera e asiatica candidata alla vicepresidenza degli Stati Uniti. In caso di
vittoria, inoltre, Kamala Harris diventerebbe la prima donna eletta per
ricoprire quel ruolo. Prima di lei avevano gareggiato per l’incarico soltanto
due altre donne: la democratica Geraldine Ferraro nel 1984 e la
repubblicana Sarah Palin nel 2008. La corsa di entrambe fu interrotta però dalla
vittoria di due presidenti-icona: rispettivamente, Ronald Reagan per i
repubblicani e Barack Obama per i democratici. Ma questo sarebbe solo l’ultimo
dei record conquistati dalla neoindicata running mate di Biden. Come ricordano,
infatti, Gregory Krieg e Jasmine Wright della Cnn, Kamala Harris, 55 anni, “ha
passato la sua carriera ad abbattere le barriere”. In California, è stata la
prima donna, e la prima donna nera, a ricoprire un ruolo apicale
nell’amministrazione giudiziaria, prima come procuratore distrettuale di San
Francisco e poi come procuratore generale del Golden State affacciato sul
Pacifico. È la prima donna di colore della California eletta nel Senato
degli Stati Uniti e la seconda d’America, subito dopo Carol Moseley
Braun dell’Illinois. Harris è anche la prima persona di origine indiana a far
parte del ticket di candidati presidenziali: nessuno ne parla, ma in quello che
viene definito da molti come il “secolo asiatico” e in un momento storico di
gravi frizioni con la Cina (che vedono coinvolta anche l’India) una persona come
Kamala – nome indiano, profonda conoscitrice della potente ex colonia britannica
nel sud dell’Asia, dove vive un pezzo della sua famiglia – potrebbe svolgere un
ruolo cruciale. In più, Kamala Harris riunisce diverse caratteristiche che
potrebbero intercettare i consensi dell’elettorato democratico, composto da
minoranze etniche e ceti intellettuali urbani. Ha trascorso la sua infanzia
nella culla americana dell’attivismo di sinistra: Berkeley e Oakland, dove è
nata nel 1964. E’ figlia di una donna indiana di stirpe Tamil (ha detto di lei:
“mia madre non la presero mai sul serio, la guardavano dall’alto in basso per il
suo accento, per questo io mi presento”) e di un nero di origine giamaicana,
entrambi coinvolti nel movimento per i diritti civili. Dopo la separazione dei
genitori ha studiato prima a Montreal e poi a Washington. Come donna e come
professionista si è affermata negli ambienti del progressismo liberal della West
Coast finché è stata eletta al Senato nelle fila dei dem. Nonostante questa
biografia, la sua candidatura in proprio alle primarie presidenziali è durata
davvero poco. Harris non è riuscita a sfondare il soffitto di cristallo più
duro, quello del voto, e la sua partita presidenziale non è mai neppure
cominciata. Un difetto di consenso che potrebbe creare qualche preoccupazione in
vista del 3 novembre, quando si chiuderà la partita contro Trump. Inoltre,
l’attività della Harris come procuratore è oggetto di critiche incrociate. Poco
dopo essere entrata in carica a San Francisco, Harris ha annunciato che non
avrebbe chiesto la pena di morte contro un sospetto accusato di aver ucciso un
agente di polizia. Questa posizione liberal le ha inimicato i rappresentanti
della polizia locale. Viceversa, nel 2015, diventata nel frattempo procuratore
generale della California, scelse di non appoggiare le richieste di indagine
sulla polizia per le sparatorie mortali in cui erano coinvolti degli
afroamericani. Nonostante tutto, però, il profilo della Harris resta il migliore
possibile. Prima di tutto perché ha sempre incarnato il ruolo di feroce
avversario del presidente Donald Trump, facendo a pezzi i suoi candidati al
Congresso con la spietatezza tipica del procuratore. E poi perché resta una
donna nera carismatica che può parlare in prima persona delle ingiustizie
razziali che oggi sconvolgono la coscienza americana. Ma c’è di più. Come
spiega Maeve Reston della Cnn, “per Biden, che ha svolto un ruolo centrale al
fianco di Barack Obama e ora si presenta agli elettori come una figura di
transizione, scegliere Harris è anche un modo per plasmare il futuro del Partito
Democratico. Selezionando una donna nera – il cui background come figlia di
immigrati giamaicani e indiani incarna la nuova storia americana – Biden
riformula la struttura del potere democratico per gli anni a venire”. La storia
delle elezioni presidenziali è fatta di vicepresidenti che si candidano poi a
fare il presidente: come George Bush senior dopo Reagan. Non sempre ci riescono,
ovviamente: Al Gore, per esempio, non riuscì a raccogliere l’eredità di Bill
Clinton. Ma quel ruolo resta un investimento di lungo periodo. L’idea di una
donna presidente è stato un sogno per molte donne ai tempi della candidatura
di Hillary Clinton. Biden conosce bene la delusione che le donne democratiche
provano ancora oggi a quasi quattro anni di distanza. In più, nelle primarie
recenti le donne non sono mai state dei rivali significativi e il duello finale
ha visto Biden contro Sanders. Tutto ciò in un momento in cui il machismo
volgare di Donald Trump e la campagna del #metoo hanno riacceso l’attivismo
femminile nel Paese. Con Kamala Harris, le donne democratiche e le donne di
colore, che sono poi il motore del partito, si vedranno rappresentate sulla
scena nazionale. Così Biden si affida alla Harris per guadagnare la fiducia
delle donne afroamericane che sono il nucleo del Partito Democratico, e – perché
no? – dei giovani neri: categorie di elettori che nel 2016 restarono freddi
verso la Clinton e disertarono le urne. Non si può sottovalutare poi il problema
della carta anagrafica del candidato. Con Harris, Biden non spera soltanto di
attrarre più voti dai giovani. In caso di vittoria a novembre, avrà bisogno di
una vicepresidente energica, pronta a sostituirlo in numerose occasioni.
Inoltre, sa che non potrà fare un secondo mandato. Quando lui lascerà, però, la
Harris avrà dalla sua quattro anni di esperienza di governo e potrebbe diventare
un’ottima candidata a raccoglierne l’eredità. Si potrebbe sorridere di questo
rapporto quasi filiale. Ma proprio qui val la pena ricordare un aspetto
importante, benché poco noto, del rapporto tra i due. Beau, il figlio di Biden
che fu procuratore generale del Delaware – e che morì nel 2015 all’età di 46
anni per un cancro al cervello – era un amico intimo di Kamala Harris. “Ai tempi
in cui Kamala era procuratore generale, lavorava a stretto contatto con Beau”,
ha scritto Biden in uno dei due tweet che annunciavano la scelta. “Li ho
guardati mentre sfidavano le grandi banche, aiutavano i lavoratori e
proteggevano donne e bambini dagli abusi. Ero orgoglioso allora, e sono
orgoglioso adesso di averla come mia partner in questa campagna”.
Kamala Harris come Obama. "Lei eletta? Non è americana".
Falsa teoria sulla candidata. Trump non la smentisce:
«Sarebbe grave». E i Dem si scatenano: «Ripugnante». Valeria Robecco, Sabato
15/08/2020 su Il Giornale. New York Donald Trump flirta di nuovo con
l'irresistibile tentazione dei «birther», questa volta applicata al «caso»
Kamala Harris. È la nuova accusa mossa dai detrattori al presidente americano a
48 ore dall'inizio della convention democratica di Milwaukee, dove Joe Biden e
la sua neo aspirante vice accetteranno la nomination dell'Asinello per Usa 2020.
La stessa che il tycoon accetterà dalla Casa Bianca il 27 agosto. A innescare
l'ennesima polemica sul Comandante in Capo sono state le reazioni alle parole
del professore di diritto della Chapman University John Estman, il quale ha
sollevato la questione dell'eleggibilità della senatrice. In un articolo su
Newsweek ha sostenuto che Harris non si può candidare perché entrambi i genitori
non erano cittadini americani quando il 20 ottobre del 1964 è venuta al mondo la
figlia. Kamala, però, è nata ad Oakland, California, è quindi secondo la legge
Usa, che prevede lo ius soli, è cittadina statunitense. Il 14esimo Emendamento
della Costituzione afferma infatti che per servire come presidente o vice
presidente un candidato deve essere cittadino di origine naturale, avere almeno
35 anni ed essere residente in Usa da almeno 14 anni. Requisiti che lei
soddisfa, e il fatto che il padre fosse immigrato dalla Giamaica e la madre
dall'India non cambia lo stato delle cose. «Ho sentito oggi che Kamala non
rispetterebbe i requisiti», ha detto Trump nel corso di una conferenza stampa:
«Non ho idea se sia vero. Penso che i democratici abbiano verificato prima di
sceglierla. In ogni caso è una questione molto seria». Insomma, di certo non ha
sposato direttamente la teoria del «birther», ma non l'ha neanche seccamente
smentita. E così la campagna elettorale di Biden ha colto l'occasione per
lanciare un'altra stoccata a The Donald, bollando le sue parole come
«ripugnanti» e «patetiche». Il portavoce del candidato dem, Andrew Bates, ha
definito Trump «il leader nazionale del movimento grottesco e razzista dei
Birther riguardo Barack Obama», e colui che «ha cercato di alimentare il
razzismo e lacerare la nostra nazione in ogni singolo giorno della sua
presidenza». L'attuale inquilino della Casa Bianca, anni fa, è stato tra i
principali promotori del movimento che negava la nascita in Usa del suo
predecessore. Nel 2011, stanco delle teorie cospirazioniste (soprattutto degli
ultraconservatori) secondo cui era nato in Kenya e non negli Stati Uniti, Obama
diffuse la copia dettagliata del suo certificato di nascita. «Sono nato a
Honolulu, nelle Hawaii, il 4 agosto 1961. Non abbiamo tempo per queste
stupidaggini, ho tante cose migliori da fare», disse. Tra i primi a commentare
ci fu proprio Trump: «Spero che il certificato sia autentico, voglio vederlo di
persona. Detto questo mi chiedo, perché non l'ha mostrato prima? Comunque sono
contento perché ora possiamo parlare di tanti problemi seri che affliggono il
paese». Nel frattempo, mentre la campagna elettorale sta entrando nel vivo con
l'inizio, lunedì, della kermesse democratica (seppur azzoppata dal coronavirus),
Trump ha confermato che intende tenere il suo discorso di accettazione della
nomination di fronte al South Lawn della Casa Bianca. Una scelta su cui i suoi
avversari hanno già sollevato questioni etiche e legali, ma che lui preferisce
rispetto all'ipotesi dello storico campo di battaglia della guerra civile a
Gettysburg, in Pennsylvania. La Casa Bianca «è un grande posto», ha spiegato, e
inoltre è più economico e più conveniente dal punto di vista organizzativo.
Flavio Pompetti per il Messaggero il 6 novembre 2020. Ci vogliono
nervi saldi per aspettare un'ora dopo l'altra, giorno dopo giorno, il verdetto
finale di un voto che ti trasforma nella persona più importante della terra. Joe
Biden ha mostrato di averli: negli ultimi due giorni ha lanciato messaggi di
moderazione all' elettorato, ha citato a più riprese i padri fondatori dell'
Unione, ha rispettato la solennità del processo istituzionale che si stava
svolgendo. Biden ha esibito la fermezza di carattere che ha levigato nel corso
degli anni. Una serie di cadute e di risalite dal basso; una sequenza di sfide
che hanno ispessito la fibra della sua personalità, e che hanno scolpito l'
immagine serena e amichevole che oggi sorprende chiunque abbia la ventura di
incontrarlo.
LA FEDE. «Ho avuto l' impressione che Dio non fosse dalla mia
parte, e che mi avesse assegnato prove dure da affrontare nella vita» racconta
Joe, cresciuto in seno ad una famiglia cattolica e irlandese, tra la periferia
mineraria della Pennsylvania e i quartieri della classe lavoratrice in Delaware.
Suo padre aveva goduto di momenti di benessere, ma negli anni dell' adolescenza
del primo figlio ebbe a che fare con l' instabilità cronica del lavoro, e con
difficoltà economiche che lo costrinsero a cercare ospitalità per anni insieme
al resto della famiglia nella casa dei suoceri. Joe parla spesso delle lezioni
che ha imparato nel vedere un adulto battuto, sconfitto nell' obiettivo
fondamentale di garantire la sicurezza dei suoi cari, ma sempre disposto a
svegliarsi con nuova energia per ricominciare a lottare. L' esperienza gli è
tornata utile già a partire da quegli anni, quando lottava per sopravvivere alla
crudeltà dei compagni di scuola che lo vedevano balbettare per un vizio di
nascita che lo ha afflitto per tutta la vita, e galleggiare appena al livello
della sufficienza tra i banchi di scuola. A dispetto dell' handicap Biden si è
laureato in legge alla selettiva università di Syracuse, si è sposato con la
prima moglie Neilia e aveva avuto da lei già tre figli all' inizio del 1972, l'
anno più difficile della sua vita. Nell' arco di dodici mesi il trentenne ex
repubblicano convertito al partito democratico affrontò la sfida che nessun
altro suo collega di partito riteneva possibile: affrontare una campagna
elettorale, contando solo sui suoi esigui risparmi, contro il conservatore Caleb
Boggs, un veterano della seconda guerra che sedeva da dodici anni nel senato
dopo essere stato governatore del Delaware. Biden rimontò quell' anno uno
svantaggio di 30 punti nei sondaggi per vincere con il 50,5% dei voti, ed
entrare al congresso come il sesto tra i più giovani senatori della storia
statunitense. Era al culmine della giovane carriera, ed è lì che la disgrazia lo
colpì, con la forza di un camion che in un incrocio stradale portò via la vita
di Neilia e della figlioletta Noemi Christina di appena un anno, e ferì i due
fratelli maschi che erano sul sedile posteriore della vettura: Beau e Hunter.
Distrutto dal dolore, Biden pensò di rassegnare le dimissioni. Fu convinto da un
collega repubblicano a onorare la carica istituzionale, e prestò giuramento a
fianco del letto di ospedale nel quale il primogenito Beau sedeva con la gamba
fratturata in trazione. La vita gli ha offerto una seconda possibilità cinque
anni dopo con il secondo matrimonio con Jill, l' attuale moglie che ha partorito
la sua quarta figlia Ashley. In quei cinque anni da padre solo, il senatore
aveva preso ogni giorno il treno dopo il lavoro a Washington, per accudire i
figli nella casa in Delaware dove ha vissuto fino a sei anni fa. Poi, ogni
mattina, risaliva sul treno in direzione opposta per tornare nella capitale. Nel
frattempo è sopravvissuto a due operazioni per un aneurisma al cervello (nel
1988) e ad un embolo polmonare. Il pendolarismo di Joe è durato quarantatré
anni, fino alla nuova tegola che l' ha colpito cinque anni fa con la morte per
un tumore al cervello del prediletto Beau, il figlio gioiello, volontario di
guerra per l' esercito e avvocato-attivista politico. Il dolore è raddoppiato
con la disintegrazione del secondogenito Hunter, assuefatto all' alcol e alle
droghe, e coinvolto in affari che puzzano di corruzione in Ucraina, sulla base
dei quali i repubblicani hanno cercato di far saltare la candidatura del
padre. Joe si è rialzato ancora una volta e a 77 anni ha affrontato la maratona
delle presidenziali. A sostenerlo nei momenti più difficili è stata Jill, che lo
ha accompagnarlo (a distanza di sicurezza e sempre con la mascherina sul volto)
per tutta la durata della campagna elettorale. A ben vedere, con un simile
bagaglio di esperienze e di sofferenze da portare sulle spalle, l' attesa per l'
esito del voto non deve essere stata poi per Biden motivo di grande
palpitazione.
Da liberoquotidiano.it l'8 novembre 2020. Ha colpito ancora,
Piero Fassino. L'ex sindaco di Torino e segretario dei Ds è noto per le sue
profezie improvvide e clamorosamente smentite dai fatti. Dopo Beppe Grillo e
Chiara Appendino, ora forse godrà Donald Trump. Fassino partecipa al coro della
sinistra in solluchero per la vittoria di Joe Biden nelle presidenziali Usa.
Ora, assicura Fassino su Twitter, "si apre una nuova pagina per gli Stati Uniti
e per il mondo. Coesione, non lacerazione. Integrazione, non razzismo.
Solidarietà, non egoismo. Multilateralismo, non arrogante solitudine. Con lui i
democratici di tutto il mondo". Tutto molto bello, ma i followers si
sbizzarriscono negli sfottò: Terza Guerra mondiale in vista o ritorno di Donald?
Questo è il dilemma dopo la involontaria "gufata" del mite Piero.
Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera l'8 novembre 2020. E se
contro Trump avesse corso un candidato fresco, giovane, ma radicale e
socialisteggiante? Forse sarebbe andato molto peggio di Biden. Manca la
controprova; ma c' è un indizio. Prima della vittoria di Trump, il 2016 aveva
riservato lo choc della Brexit. Un verdetto confermato dalle elezioni del
dicembre 2019, affrontate - e stravinte - da Boris Johnson con lo slogan «Get
Brexit down», togliamoci l' Europa di torno. I laburisti avevano un candidato né
fresco né giovane, ma molto radicale e molto socialista, Jeremy Corbyn; che li
ha condotti alla peggiore sconfitta di sempre. Perché contrapporre a un
populista di destra un populista di sinistra è rischioso, e può rivelarsi
controproducente. I democratici americani non hanno commesso il medesimo errore.
La macchina del partito - guidata ancora da Obama - ha manovrato fin dall'
inizio per Joe Biden, che pure aveva iniziato malissimo il percorso delle
primarie. Prima sono stati indotti al ritiro i moderati che potevano erodere i
voti centristi: Amy Klobuchar, Pete Buttigieg - ora probabilmente ricompensato
con un ministero -, Kamala Harris, che ha avuto la vicepresidenza. Poi, quando
il prescelto è rimasto solo contro Sanders, il candidato socialista si è trovato
in svantaggio, ed è stato convinto a desistere, anche con il pretesto della
pandemia. La campagna presidenziale di Biden è stata giocata tutta al centro. È
stata rivolta ai repubblicani perplessi dalla svolta impressa da Trump. Ha
parlato in primo luogo ai ceti popolari del Mid-West, che chiedono protezione
economica ma tendono a essere conservatori in tema di diritti civili. Certo,
Biden ha avuto e avrà bisogno anche dell' ala sinistra del suo partito, che è
stata fedele più a lui che a Hillary quattro anni fa. Allora quasi nessuno
pensava seriamente che Trump potesse vincere; e non tutte le componenti della
base democratica si erano mobilitate, come hanno fatto stavolta. Ma, da politico
esperto, Biden si è guardato dal farsi travolgere dall' onda emotiva degli
scontri di piazza, delle statue abbattute, della contrapposizione anche violenta
ai sedicenti miliziani di Trump. Se fosse entrato nel vortice dello scontro
radicale, se avesse risposto al linguaggio estremo del presidente, il candidato
democratico avrebbe accettato battaglia su un terreno sfavorevole, dove sarebbe
stato battuto in partenza. Con i ritmi lenti, il tono sommesso, le parole d'
ordine a volte scontate però mai incendiarie del moderato ha intrapreso un
percorso non esaltante ma sicuro, che gli consente ora di dire: missione
compiuta. Questo non cancella una notte di passione, e questi giorni di
incertezza. Trump si è confermato un lottatore, capace di tenere quasi tutti i
voti repubblicani e di battersi anche negli Stati democratici. Ma la caduta
dell' Arizona, lo Stato di Barry Goldwater e John McCain, brucia. La sconfitta
che si profila in Georgia apre una prima crepa nel muro rosso del Sud. I
repubblicani restano fondamentalmente il partito dei maschi bianchi: categoria
dominante per secoli, ma che ora da sola non garantisce più l' egemonia; non a
caso è dal 1988 (con la sola eccezione di Bush figlio nel 2004) che il Grand Old
Party non ottiene alle presidenziali la maggioranza dei voti popolari. Un
dettaglio ininfluente per il meccanismo elettorale, ma politicamente non così
privo di significato; perché le congiunzioni astrali possono riuscire una volta
(Bush jr nel 2000), due volte (Trump nel 2016), ma non sempre. Il sovranismo non
finisce certo oggi. È una tendenza mondiale, che alla lunga la pandemia -
generando impoverimento e rabbia - può persino rafforzare. Questo vale in
particolare per l' Italia, dove la destra (storicamente maggioritaria) è guidata
da tifosi di Trump. Il fatto che sia stato eletto il secondo presidente
cattolico nella storia americana non autorizza paragoni con le nostre vicende.
Ma l'altro ieri la Merkel, ieri Macron, oggi Biden ci ricordano che nella
politica mondiale il centro non è morto; e non è detto che sia un male.
Alberto Flores d'Arcais per repubblica.it l'8 novembre 2020. Gli
è stata sempre accanto per 45 anni, adesso diventerà la padrona della Casa
Bianca. Jill Tracy Jacob Biden era sposata con un ex giocatore di football
(americano), quando in un blind date (organizzato dal fratello di Joe, suo
compagno di college) nel marzo 1975 vide per la prima volta il nuovo presidente
degli Stati Uniti. «Ho finalmente incontrato un gentleman», disse alla madre,
perplessa per la differenza d' età, il matrimonio in frantumi e quel giovane
senatore con alle spalle un dramma familiare e due figli a carico. Aveva visto
giusto lei, ottimista e cocciuta, insegnante nelle scuole pubbliche (ha un
master in letteratura inglese e un PhD in scienza dell' istruzione), pronta a
fare da mamma a due bambini non suoi (poi nascerà la figlia Ashley). Gli è stata
sempre vicino, nella campagne al Congresso vittoriose e in quelle perse, fino
alla Casa Bianca vissuta per otto anni come "Second Lady", inevitabilmente
oscurata dal fascino mediatico di Michelle Obama. Sempre al suo fianco anche
nelle primarie, con Biden che ai comizi amava presentarsi come "il marito di
Jill Biden". In seconda fila quando era necessario, energica se era il momento
di difendere Joe, come quando respinse un manifestante che si era avvicinato
pericolosamente al marito durante un comizio a Los Angeles. Impegnata sul lavoro
(insegna ancora in un college in Virginia), ma per lei la famiglia viene prima
di tutto, soprattutto ora che i figli le hanno regalato quattro nipotine. Merito
dell' origine italiana, ha raccontato nelle sue memorie, dell' adolescenza
vissuta tra gli italo-americani di Philadelphia. «Sono una Philly girl , ne vado
orgogliosa », ha raccontato durante un recente comizio "virtuale" ricordando che
i bisnonni arrivati dalla Sicilia si chiamavano Giacobba, che la domenica si
mangiavano «spaghetti, polpette, braciole e la casa profumava di origano,
basilico, pomodori freschi e aglio». Porterà questa tradizione anche alla Casa
Bianca, dove ha già in mente di rivitalizzare l' orto di Michelle, in disuso da
quando è arrivato The Donald. E porterà anche i due cani, i due pastori
tedeschi, Major e Champ. La sua energia e il suo ottimismo hanno sedotto lo
staff di Biden, dove sono tutti convinti che a 69 anni di età Jill saprà
convincere molti americani di quanto sia importante, oggi più che mai, l' essere
uniti. «Porterà l' ufficio di First Lady nel 21esimo secolo», raccontano le
amiche che la conoscono bene, «perché la maggior parte delle donne americane
sono come lei: devono bilanciare il lavoro e la vita familiare».
Biden: l’incidente nel quale sono morte prima moglie e figlia.
Notizie.it il 07/11/2020. Prima di sposare in seconde
nozze la moglie Jill nel 1977, Joe Biden aveva sposato nel 1966 Neilia. Ecco
com’è morta. Molto si è detto sulla moglie di Joe Biden Jill con la quale il neo
Presidente degli Stati Uniti è sposato dal 1977 e da cui ha avuto la figlia
Ashley. Tuttavia, non tutti sanno che prima di Jill Biden, il presidente Biden è
stato sposato dal 1966 al 1972 con Neilia Hunter da cui ha avuto 3 figli. Una
storia quella di Neilia triste come poche e la cui vita è stata stroncata troppo
presto, all’età di appena 30 anni. La prima moglie Neilia è morta in seguito ad
un incidente stradale nel quale morì anche la figlia più piccola della coppia
Naomi (detta Amy) di solo un anno. A bordo dell’auto si trovavano anche gli
altri due figli di Biden Hunter e Beau, che sono tuttavia sopravvissuti. Anche
la storia di Beau sarà legata ad un retroscena tragico in quanto il primogenito
è deceduto all’età di 46 anni per un tumore al cervello nel 2015.
Biden, la morte della prima moglie. “Mentre io ero a Washington,
mi è arrivata una telefonata. Mia moglie e tre bambini stavano andando a fare
shopping di Natale e un camion merci li ha colpiti in pieno, uccidendo mia
moglie e mia figlia”. Queste le parole del presidente neo-eletto degli Stati
Uniti Joe Biden a proposito dell’incidente mortale durante il quale perse oltre
che la moglie, anche la figlia più piccola Naomi di soli 13 mesi in quel lontano
1972. All’epoca Joe Biden era stato appena eletto senatore del Delaware ed era
ancora in attesa di entrare in carica. Una vita dunque la sua fatta di sacrifici
e sofferenza, tra gli impegni di padre e quelli della carica politica allora
appena iniziata. Ad ogni modo le memorie della prima moglie di Biden Neilia sono
state tenute vive dalla seconda moglie Jill e della quale ne ha parlato nella
sua autobiografia.
Joe Biden, la moglie Jill e la sorella Valerie: le sue rocce .
Con la moglie, insegnante che non ha mai smesso di
lavorare neanche negli anni della vicepresidenza, il neoeletto presidente Biden
ha ritrovato un centro dopo la tragedia che gli portò via la prima consorte e la
figlia. La sorella Valerie, tre anni più giovane, è la sua migliore amica e più
stretta consigliera. Marilisa Palumbo su Il Corriere della Sera il 7 novembre
2020. Il 18 dicembre 1972 Valerie Biden era in un ufficio del Congresso di
Washington con il fratello a esaminare pile di curriculum. Joe aveva appena
vinto contro ogni pronostico, a trent’anni non ancora compiuti, la corsa per un
seggio senatoriale in Delaware, diventando da un giorno all’altro la giovane
promessa del Partito democratico. Tutti volevano lavorare con lui. «Ricevetti
una telefonata da Jimmy (l’ultimo dei quattro fratelli Biden) – racconta Valerie
–. Mi disse: “tornate subito a casa, c’è stato un incidente”».
Un lutto devastante. L’auto della moglie di Biden, Neilia, che
era uscita a comprare l’albero di Natale con i tre figli — la piccola Naomi, un
anno, Beau, tre, e Hunter, due — era stata travolta da un camion: solo Beau e
Hunter erano sopravvissuti. Valerie — Val, la chiamano i suoi — era sempre stata
accanto al fratello maggiore, per esempio incoraggiandolo mentre si esercitava a
recitare allo specchio le poesie di Yeats per battere la balbuzie. Le sembrò
naturale sistemarsi da lui con il marito e aiutarlo a crescere i bambini.
«Eravamo già una famiglia molto unita — racconterà Beau Biden, che sarebbe poi
morto tragicamente di cancro a 46 anni nel 2015 — lo diventammo ancora di più.
In gran parte fu merito di mia zia».
Joe e Jill: le chiesi cinque volte di sposarmi. Nel 1976 la vita
di Joe cambiò di nuovo. Accettando un appuntamento al buio organizzatogli
dall’altro fratello Biden, Frank, bussò alla porta di Jill Jacobs, papà di
origini italiane, nove anni più giovane di lui, già sposata e divorziata,
all’ultimo anno di college. «Uscivo con ragazzi in jeans, zoccoli e t-shirt, lui
si presentò in giacca sportiva e mocassini e pensai: non funzionerà mai», ha
raccontato Jill a Vogue nel 2010. E invece funzionò subito. «Mi ha ridato la
vita. Mi ha fatto cominciare a pensare che la mia famiglia sarebbe potuta essere
di nuovo completa», dice di lei Biden. Dovette però chiederle cinque volte di
sposarla, prima dell’agognato sì: «Nel frattempo avevo conosciuto i bambini, ero
pazza di loro. Avevano già perso la madre, non potevano perderne un’altra.
Dovevo essere sicura al 100 per cento».
Lo «scudo» del marito. Il matrimonio si celebrò il 17 giugno 1977
con Beau e Hunter sull’altare con gli sposi. Nel 1981 nacque Ashley e Jill, che
intanto aveva completato anche il dottorato, lasciò l’insegnamento per due anni
e mezzo. Dopo quella pausa non ha mai più smesso, neanche quando Biden è stato
eletto vicepresidente. Amante delle maratone, sorridente, scherzosa, è uno scudo
per il marito. Letteralmente, come nel video, circolato molto in rete, in cui la
si vede allontanarlo dai giornalisti assicurandosi che rispetti il
distanziamento sociale; o come quando, assieme proprio a Valerie, con un
incredibile scatto ha placcato due donne che protestavano contro di lui in un
comizio a Los Angeles. Ma Jill non ha mai avuto un ruolo ufficiale nelle sue
campagne.
Valerie, la mente dietro tutte le campagne del fratello. A
differenza di Valerie, che le ha gestite (quasi) tutte, compresa quella
sfortunata del 1988, finita male per le accuse di plagio (Biden aveva copiato
brani dei discorsi del leader laburista britannico Neil Kinnock). «Col senno di
poi penso sia stata una benedizione perché se fosse rimasto in corsa sarebbe
probabilmente morto — ha raccontato lei facendo riferimento al doppio aneurisma
che colpì Biden quell’anno —. Si sarebbe sentito male in Iowa, e non avrebbe
potuto avere le cure eccellenti che ha avuto a Washington». Durante la
convalescenza Jill fu inflessibile nel proteggerlo vietandogli lavoro e
telefonate, comprese le due dell’allora presidente Ronald Reagan. Biden
riproverà a correre per la presidenza nel 2008, ma troverà sulla sua strada un
certo Barack Obama. Lo stesso Obama che poi lo ha scelto come vice e gli ha
tirato la volata negli ultimi giorni di questa campagna 2020. Una campagna che
per la prima volta non è stata Valerie a dirigere. Non ufficialmente almeno,
perché lei c’è sempre. «Dov’è Val?», chiede il 46esimo presidente, smarrito
quando non la vede. Da sorella protettiva, Valerie non era convinta della scelta
di Kamala, perché ancora offesa per come la senatrice aveva attaccato Joe
durante le primarie democratiche. C’è voluto un pranzo a tre, per saldare
l’accordo. Ha sempre viaggiato con il candidato, era nella stanza quando si
preparava ai dibattiti, ha approvato i suoi spot, ha riguardato tutti i
discorsi. «Qualcuno dice che è capace di completare le mie frasi — dice Biden —
La verità è che ha scritto le mie frasi migliori. Non solo ha creduto in me, ma
mi ha aiutato a credere in me stesso». Fino alla Casa Bianca, il sogno di una
vita.
Marilisa
Palumbo per il “Corriere della Sera” il 9 novembre 2020. La foto più bella degli
ultimi giorni è quella di un abbraccio multiplo, ancora più toccante in tempi di
distanziamento sociale. Si vede Joe Biden guardare sorpreso e felice l'
obiettivo, circondato dall' amore dei nipoti che gli hanno appena dato la
notizia della vittoria in Pennsylvania, e quindi alle elezioni: dopo una corsa
lunga una vita, la Casa Bianca è sua. È stata Naomi a postare la foto,
accompagnata solo dalla data: 7.11.2020. Ventisei anni, figlia maggiore di
Hunter, secondogenito di Biden, porta il nome della zia che non ha mai
conosciuto, morta a tredici mesi nel terribile incidente stradale che uccise a
pochi giorni dal Natale del 1972 anche la prima moglie di Joe, Neilia. Biden era
stato eletto senatore un mese prima, ad appena trent' anni, dritto nel carnet
dei più giovani della Storia. Da poco laureata alla scuola di legge della
Columbia, Naomi è la più grande dei sette nipoti Biden: «Pop», come lo chiamano,
telefona a tutti ogni giorno. «Non rispondo proprio sempre, ma ho un sacco di
messaggi in segreteria», scherzava in un video per la convention Finnegan,
sorella di Naomi, 20 anni. L' ultima ragazza di Hunter, Maisy, diciotto, ha
accompagnato spesso nelle missioni all' estero Biden quando era vicepresidente
ed è molto amica di Sasha Obama, la minore di Barack e Michelle. Natalie è
invece la maggiore di Beau, scomparso nel 2015 per un cancro al cervello, e ha
un fratello 14enne, Robert Hunter. La morte di Beau, veterano di guerra,
procuratore generale del Delaware ed erede anche politico del padre - «È come
me, ma senza i difetti» - anziché essere la fine delle ambizioni presidenziali
ultratrentennali di Biden (primo tentativo nell' 88, poi nel 2008), ha dato loro
un' ultima decisiva spinta. Lo racconta lo stesso Joe in Papà, fammi una
promessa (tradotto in Italia da Nr edizioni): «"Papà, non hai capito niente",
disse Beau in cucina. "Ti devi candidare. Io voglio che ti candidi". [...] A un
certo punto disse ... che era il mio dovere. Dovere era una parola che Beau non
usava con leggerezza». Beau se ne andò nel 2015, Biden dovette abbandonare l'
idea di correre nel 2016, ma sull' onda di quella promessa si è rimesso in corsa
quest' anno, fino alla vittoria. E da Beau è tornato il giorno del voto e poi
ancora ieri, facendo visita al cimitero in cui riposa, affiancato da Robert e
Ashley, la sua quarta figlia, nata nell' 81 dall' unione con l' amatissima Jill.
Tanto quanto Beau era il bravo ragazzo, il fulgido esempio, Hunter è sempre
stato fonte di infinite preoccupazioni, anche in campagna elettorale, quando i
repubblicani hanno provato a usare i suoi affari in Ucraina e Cina per
descrivere il padre, e i democratici tutti, come corrotti. Cinquant' anni,
problemi con alcol e droga, una vita sentimentale travagliata, Hunter nel 2017
divorzia dopo vent' anni dalla moglie che lo accusa di spendere tutto in strip
club e sostanze stupefacenti, poi si fidanza con la vedova di Beau, storia
naufragata durante la quale Hunter ha un figlio da un' altra donna. Oggi è
sposato con una modella sudafricana portata all' altare dieci giorni dopo averla
conosciuta e dalla quale ha avuto un quarto figlio. Il piccolo era sul palco
sabato sera, prima in braccio a lui, poi coccolato dal nonno che tutto guarda e
tutto perdona e tutto cerca di aggiustare. Perché i Biden sono un grande e
affiatatissimo clan, e dopo gli Obama si preparano ad adottare la famiglia
allargata Harris, come ha avvertito giocoso Joe dal palco di Wilmington:
«Kamala, Doug, vi piaccia o no, ora siete famiglia. Siete diventati Biden
onorari». Da quel palco, prima di cominciare il discorso, il presidente eletto
si è messo a salutare vecchi amici che riconosceva tra la folla, poi si è
fermato: «Soprattutto vedo mia sorella Valerie». La sorella minore che l' ha
sempre accompagnato come un' ombra, l' ha aiutato a crescere i figli prima che
arrivasse Jill, ed è stata la sua consigliera più fidata. Biden è il presidente
più anziano della storia e per la prima volta in 28 anni (da Bush padre) non ci
saranno first daughter o son a vivere alla Casa Bianca. Torneranno invece i
cani, spariti con Trump: Jill e Joe ne hanno due, Champ e Major. Quanto alla
first lady, anche lei starà molto poco nella residenza. Come ha sempre fatto,
anche negli anni della vicepresidenza, Jill, che ha quattro lauree, manterrà il
suo lavoro di professore. Si occuperà di istruzione, ma non sarà una consorte
tradizionale: «Educatori di tutta America, questo è un grande giorno per voi -
ha detto Biden nella notte illuminata dai fuochi d' artificio - avrete una dei
vostri alla Casa Bianca».
Mario Ajello per il Messaggero il 10 novembre 2020.
Francesco Rutelli, lei oggi non è più in politica. Ma ha conosciuto Biden. Può
confermare che il nuovo presidente americano ama molto Roma?
«Sì. L' ho incontrato diverse volte. Quando nel 2011, da senatore, ero nella
tribunetta dei Fori Imperiali, per la celebrazione dei 150 anni dell' Unità d'
Italia, abbiamo chiacchierato un po'. Già lo avevo visto a Boston nel 2004, due
volte a Washington e in altri incontri internazionali. A Roma, non posso
dimenticare i suoi commenti sui Fori Imperiali che mi rivolse come ex sindaco.
Il giorno prima, aveva incontrato il presidente Napolitano e gli aveva detto: se
rinasco, voglio rinascere italiano».
Ammirando la bellezza di Roma, lei che cosa disse al futuro presidente degli
Stati Uniti?
«Gli feci la battuta su Marte e Venere. A proposito della differenza tra l'
America considerata Marte perché amante della guerra e l' Europa assimilata a
Venere perché amante dell' amore. Mentre parlavamo, avevamo davanti a noi il
tempio di Marte Ultore, cioè vendicatore, creato da Augusto e alle nostre spalle
c' era il tempio di Venere Genitrice creato da Giulio Cesare in omaggio alla sua
ascendenza. Io gli ho detto: ecco il posto in cui l' antagonismo tra Marte e
Venere è bello che risolto!».
Rutelli, lei sta per pubblicare con Laterza il libro «Tutte le strade partono da
Roma». Anche quelle dell' America di Biden partono da qui?
«Assolutamente, sì. Basta vedere gli uffici dove Biden ha lavorato da senatore.
Sono affrescati da un incredibile e sconosciuto, ai più, artista romano. Si
chiamava Costantino Brumidi, nato a Roma nel 1805, esiliato da Pio IX dopo la
Repubblica romana e morto a Washington nel 1880, che è il pittore di Capitol
Hill, cioè del Campidoglio americano. Era nato nell' edificio dove oggi, qui a
Roma, c' è l' Hotel Forum, affacciato sui Fori Imperiali, proprio dietro al
tempio di Marte Ultore».
Sta dicendo che tutto torna e che Roma è nel destino di Biden?
«Lei lo sa qual è l' espressione più pronunciata nel 2020 da sette miliardi di
umani nel mondo? E' Corona Virus».
Espressione latina.
«Appunto. Noi ci dimentichiamo sempre, anche nella tragedia che stiamo vivendo,
che la forza profonda della lingua e della civiltà occidentale deriva da Roma».
Va bene, ma Biden che cosa c' entra?
«Le dice niente che Biden, una volta eletto, sarebbe il secondo presidente
cattolico romano degli Stati Uniti, dopo Kennedy? Questa è una cosa enorme. Gli
altri presidenti per lo più sono stati cristiani episcopali, presbiteriani,
battisti, metodisti o non affiliati. Ed è così rispettato Biden, nel suo essere
cattolico romano, che nessuno lo ha contestato quando ha celebrato le nozze gay
di due suoi collaboratori».
Lei è amico del nuovo presidente?
«Non esageriamo. Nel 2011 l' ho visto per l' ultima volta. Posso testimoniare
del suo tratto aperto e sensibile, e del fatto che tra i leader americani è uno
dei più favorevoli all' Europa, con un tratto di grande affetto verso l'
Italia».
Ma davvero lei ha rapporti familiari con Biden?
«No. E' solo che mio figlio Giorgio, ora trentottenne, ha studiato a Boston e
conosce bene l' America. Nella sua automobile scassata aveva un adesivo della
campagna di Obama 2008 con Biden come vice presidente. Io ho fotografato quell'
adesivo e dal mio cellulare, mentre eravamo su quella tribunetta per la festa
dei 150 anni dell' Unità d' Italia, ho fatto vedere la foto a Biden. E lui:
chiamiamolo subito, disse. Lo svegliammo di domenica mattina, e Biden lo salutò
così: Hi Giorgio, here the vicepresident of United States of America. Mio figlio
stava per attaccare il telefono perché non ci credeva».
Ma Joe non è un po Sleepy?
«Macché. E' rapido e spiritoso. Certo ha i suoi anni. E l' America che va a
governare è profondamente cambiata con il trumpismo. L' internazionalismo
democratico, di cui lui era uno degli alfieri, non tornerà. Oggi Biden deve fare
i conti con un' agenda sociale americana, più rivolta alle questioni interne
dell' economia e del lavoro». Mario Ajello
F.Bil. per “il
Giornale” il 9 novembre 2020. Il presidente americano eletto, Joe Biden, era un
fan di Tito, il boia degli italiani scaraventati nelle foibe? Sicuramente i
rapporti sono stati diretti e molto cordiali, come risulta da una lettera del
senatore a «Sua Eccellenza, il Maresciallo Josip Broz Tito». Nel 1979 Biden si
era recato a Belgrado con una delegazione Usa per «la triste scomparsa di Edvard
Kardelj», braccio destro di Tito responsabile dell' esodo di 250mila italiani.
Il futuro presidente americano nella lettera del primo marzo 1979 scriveva al
dittatore: «Desidero ringraziarla ancora per la sua preziosa ospitalità». E
sosteneva di avere molto apprezzato «il nostro scambio di opinioni». Il
maresciallo gli aveva risposto garantendo che avrebbe fatto strada... fino alla
Casa Bianca.
Costruzione del consenso. I cani dei presidenti: da Kennedy a
Nixon fino a Biden tutti gli animali domestici della Casa Bianca.
Fulvio Abbate su Il Riformista l'11 Novembre 2020. Innumerevole
l’elenco dei cani nella storia ufficiale, cerimoniale, degli Stati Uniti
d’America. Se fosse un tema, dovremmo dire dell’animale domestico nella
costruzione del consenso, da mostrare accanto al caminetto o sul prato di casa o
piuttosto sotto la stampa d’epoca che, patriotticamente, mostri la leggendaria
sarta Betsy Ross, colei che nel 1776 cucì la prima “Old Glory”, la bandiera a
stelle strisce. Non citeremo adesso Rin Tin Tin, che, sia detto per i curiosi di
spigolature animaliste postume, riposa nel cimitero parigino dei cani e dei
gatti di Asnières, semmai l’ultimo arrivato in ordine di tempo e di narrazioni,
Major, il meticcio di Biden, un lupoide già apparso insieme al suo padrone nei
report semiufficiali in rete. Che non si tratti di un cane “di razza” è già un
messaggio politico in sé, senza però nulla togliere a Champ, pastore tedesco,
quello sì fornito di pedigree, che gli risiede accanto, e non meno caro a Joe e
a sua moglie Jill. I cani nella storia del consenso, dunque. Valga su tutto la
vicenda di Nixon con il cosiddetto storico “discorso di Checkers”, un cocker
spaniel al centro di molte querelle. Era il 1952 quando Nixon, allora candidato
alla vicepresidenza, pronunciò un lungo intervento in televisione per difendersi
dall’accusa di utilizzare un fondo segreto per la sua campagna elettorale. Nel
suo discorso, passato incredibilmente alla storia come il “Checkers
speech”, Nixon disse che mai avrebbe rinunciato al cane che aveva ricevuto in
dono, toccando le corde demagogiche dell’affetto verso il mondo animale, piccolo
capolavoro di manipolazione fino alla salvezza della propria reputazione
pubblica in un paese calvinista. Una volta eletto alla presidenza, lo portò
tuttavia alla Casa Bianca. Trasferendo ogni prospettiva nel mondo felino,
occorre citare poi i Clinton e il loro Socks, il “first cat” morto più che
ventenne. Certamente il più immortalato in foto degli animali domestici
presidenziali della storia. Mantello bianco e nero (un “tuxedo”), la mascherina
di Socks era diventata celebre insieme al muso di Buddy, il “first dog”, a
entrambi verrà dedicato un libro “Dear Socks, Dear Buddy”, firmato da Hillary
così da raccogliere fondi per opere di beneficenza. Resta memorabile lo scatto
di Socks sul leggio nella sala stampa della Casa Bianca. Su questa strada,
facendo marcia indietro, si arriva ai Kennedy e ai loro cocker spaniel. Tornando
al tema del consenso nostrano, occorre pure ricordare il nostro Veltroni, quando
pensò bene di mettere via il ritratto di Palmiro Togliatti per innalzare il
poster di Bob Kennedy, scegliendo appunto l’immagine dove il fratello minore di
JFK, pura dinastia di Camelot, passeggia in un giorno d’inverno sulla spiaggia
di Martha’s Vineyard proprio con il suo cocker. Non è un caso se, dagli anni
Sessanta a metà dei Settanta, non c’era giardinetto frequentato da ragazze che
non vedesse uno spaniel al guinzaglio lì a brucare l’erba, possibilmente fulvo;
molti forse anche quello un lascito quasi morale, di stile, dei Kennedy. Svaniti
i cocker, giungeranno infine i labrador, ma forse non è il caso di eccedere
nell’anagrafe politica canina Made in Usa. Non volendo necessariamente
citare Stubby, il cane da guerra più decorato e l’unico a essere stato promosso
sergente dell’esercito statunitense per meriti in combattimento durante la prima
guerra mondiale, va però ribadito che gli animali hanno sempre accompagnato le
strategie del consenso, e probabilmente, anche adesso, per definire i primi
scatti del passaggio dall’era Trump ai giorni di Biden il muso del
meticcio Major dice già molto. Chi volesse poi interrogarsi se Trump abbia mai
avuto un cane, sappia dell’esistenza di un video realizzato durante un comizio
dove il presidente ancora in carica fino a gennaio dichiara esplicitamente
quanto detesti i cani. Trump è stato infatti il primo a non aver avuto un
animale da compagnia alla Casa Bianca. George Washington, sia detto per
completezza storiografica, addirittura li allevava e sarebbe, secondo certe
fonti, il padre del foxhound americano. Così come Abraham Lincoln aveva Jip, e
perfino un tacchino di nome Jack, che mai venne sacrificato per la cena di
Natale. Talvolta i cani rientrano nelle relazioni diplomatiche, come Pushinka,
figlio di Strelka, prima creatura vivente ad aver viaggiato nello spazio con una
navicella sovietica, divenuta la mascotte della Casa Bianca. Nel giugno del 1961
addirittura John Kennedy scrive così a Nikita Khrushchev: «Caro signor
presidente… La signora Kennedy ed io siamo stati particolarmente lieti di
ricevere Pushinka. Il suo volo dall’Unione Sovietica agli Stati Uniti non è
stato così drammatico come il volo di sua madre. Tuttavia è stato un viaggio
lungo e lo ha affrontato bene». La prossima volta, tornando a noi, narreremo
invece di Lampo, il cane ferroviere di Campiglia Marittima.
Elezioni Usa 2020: "Sleepy" Joe Biden ha licenziato il
licenziatore Donald Trump. Il democratico, 78 anni di
cui 38 passati in politica a Washington, è il presidente numero 46 degli Usa, il
più vecchio della storia. Il suo primo obiettivo, mentre Trump soffia sul fuoco
del complotto, è l'emergenza sanitaria. Gianfranco Turano su L'Espresso il 06
novembre 2020. Joe Biden ce l'ha fatta e non molti ci avrebbero scommesso nel
giorno della sua nomina a candidato democratico il 18 agosto. Donald Trump
lascia la scena in un incendio di polemiche, proteste di piazza e ricorsi ai
tribunali che vorrebbero pregiudicare l'elezione dello sfidante, ma minacciano
la sicurezza di un paese messo a dura prova da un quadriennio di tensioni
razziali. Dopo il rovesciamento del risultato del 2016 compiuto in Wisconsin e
Michigan, nella regione dei Grandi Laghi colpiti dalla crisi industriale, il
nuovo presidente degli Usa (numero 46 della lista storica) ha rimontato e
battuto il rivale in altri due stati vinti dai repubblicani quattro anni fa. Il
margine inferiore allo 0,5% significa riconteggio automatico. In una storia
pubblicata sui suoi social, la prima vicepresidente della storia degli Stati
Uniti, Kamala Harris, parla con il presidente Biden subito dopo la conferma
della sua vittoria: "Ce l'abbiamo fatta, Joe!". Ha deciso la Pennsylvania anche
se Biden è in vantaggio in un altro stato dell'Est, la Georgia, e in due
dell'Ovest, Arizona e Nevada. Nel 2016 Trump aveva perso soltanto in Nevada (sei
voti elettorali) e aveva incassato i 47 voti elettorali complessivi degli altri
tre. Biden è stato costantemente avanti a Ovest. Invece in Pennsylvania è
passato in testa di poche migliaia di voti nella mattinata di venerdì 6 dopo
avere a lungo rincorso il rivale. Lo sfidante è stato impegnato in un lungo
testa a testa anche in Georgia, dove l'ultima vittoria risale ai tempi di Bill
Clinton (1992) quando un altro presidente repubblicano, George Bush, mancò la
rielezione contro lo sfidante arrivato dall'Arkansas.
Per il presidente Joe Biden inizia una missione impossibile. I
ricorsi di Donald Trump, un partito e una base sociale per niente uniti, la
sinistra radicale che vuole contare di più. Dopo quattro anni di populismo al
potere il nuovo inquilino della Casa Bianca deve affrontare sfide ardue Ma la
disfatta di Trump presenta una tale quantità di capi d'accusa, ognuno per sé
sufficiente, che ogni analisi può privilegiarne uno senza temere l'errore. Gli
intrighi con la Russia di Vladimir Putin, un giudizio di impeachment, lo scontro
con ogni organismo transnazionale (Ue, Nato, Wto), il razzismo feroce verso i
migranti messicani, l'aggravamento delle discriminazioni nei confronti degli
afroamericani, la gestione familistica della Casa Bianca unita a una frenesia di
nomine e licenziamenti nello stile del reality “The Apprentice” di cui il
magnate newyorkese è stato fortunato e abile conduttore. Alla ridda di disastri
e gaffe che hanno fatto del 45° presidente la gioia degli imitatori e il cavallo
di battaglia della satira di Alec Baldwin sul Snl (Saturday night live), si è
aggiunto il riduzionismo grottesco nei confronti della pandemia e la guerra alle
mascherine finché il Covid-19 non si è manifestato nello stesso Trump in piena
campagna elettorale e nel suo capo di staff Mark Meadows la notte delle
elezioni. La guarigione rapida non è bastata a recuperare i punti persi nei
consensi a fronte di un'emergenza sanitaria con pochi uguali al mondo. Gli Stati
Uniti sono in testa alle classifiche sia per contagi – a breve sarà superata
quota 10 milioni – sia per morti di Corona virus (241 mila, un quinto delle
vittime globali). Il suo successore, se riuscirà a entrare in carica nei tempi
previsti dalla Costituzione dei quali Trump si fa beffe in conferenza stampa e
nei tweet dove grida al complotto, dovrà affrontare in primo luogo proprio il
tema dell'assistenza sanitaria che Barack Obama aveva tentato di risolvere,
senza grandi risultati, prima che Trump riconsegnasse il diritto alla salute
soltanto a chi ha il denaro per pagarselo. Durante la campagna elettorale Biden
non ha entusiasmato. Con il settantottesimo compleanno in calendario il prossimo
20 novembre, è il presidente più vecchio della storia con un ampio vantaggio sul
secondo classificato, il repubblicano Ronald Reagan, che ha raggiunto i 77 anni
soltanto alla fine del secondo mandato. Sleepy Joe è arrivato alla nomination
democratica dopo avere battuto la concorrenza interna di un altro giovanotto, il
radicale Bernie Sanders, 79 anni, preso in giro per il suo catastrofismo
millenaristico dall'imitazione di Larry David. Rispetto al sinistrorso Sanders,
Biden è un moderato fino al midollo che ha messo a profitto una lunghissima
carriera nell'establishment di Washington tanto odiato dai seguaci di Trump.
Nato a Scranton, Pennsylvania, da una famiglia cattolica di origine irlandese, è
stato senatore dello stato a regime fiscale agevolato del Delaware dal 1972 per
sette mandati consecutivi pari a 36 ani e tredici giorni. Nel 2008 Obama lo ha
preso come vice nel ticket per la Casa Bianca, un ruolo nel quale è difficile
brillare per tutti. Dodici anni dopo, Biden sembrava messo lì per perdere in
attesa di un - o di una - giovane leader democratica da mettere in campo per la
corsa del 2024. Invece ce l'ha fatta, con un po' di fortuna e molto demerito
dell'avversario. Adesso ha un compito non facile e una vice, Kamala Harris, 56
anni, che dovrà fare gli straordinari. Ma questo si vedrà più avanti. Per adesso
il licenziatore Trump è stato licenziato. È già molto.
Con Joe Biden gli Americani tornano alla casa del padre.
Notizie.it l'08/11/2020. Da Mickey Mouse a Kennedy,
l’esito delle elezioni americane 2020 è segno di una riconciliazione profonda:
quella degli Americani con il proprio padre. Tre giorni di spoglio per
decretare, senza se e senza ma, Joseph Biden 46esimo presidente degli Stati
Uniti. Una verità che aveva bisogno di cifre nero su bianco per smontare un
presidente uscente che non ha mai voluto credere ai numeri. Lo ha fatto nei
tempi duri della pandemia: con quasi 10 milioni di casi registrati il giorno
della sua disfatta, il presidente uscente si è opposto alle cifre. Eppure, con
75 milioni di voti, Biden è il presidente più eletto della storia Usa, simbolo
di una rimonta democratica che non è stata uno scatto di velocità, ma
una maratona pacata verso la fiducia, anche in stati impensabili, come le
roccaforti repubblicane di Georgia e Arizona. Ma forse nel voto a Joseph Biden,
che ha richiamato giovanissimi e adulti a votare un 77enne, c’è di più. Forse
quello che stiamo vedendo è il canto di un Paese dove la crisi di fiducia aveva
raggiunto un punto di rottura. L’era Biden – come titola oggi 8 novembre The New
Yorker – è un giro di boa nemmeno troppo sofisticato su una rotta
trumpiana provocatoria e maligna: ci sono voluti quattro anni perché il Paese
dei numeri primi comprendesse che si può salire sul podio senza ostentare le
medaglie dorate, che forse i veri number one americani restano dei falliti che
si oppongono al loro destino. Era appena iniziata la pandemia, quando il
giornalista Tim Elliott comparava Donald Trump a Giulio Cesare, ravvisando in
entrambi l’intenzione palese di soffocare ogni dibattito. Ma in democrazia, si
sa, il dibattito è tutto, anche quando è implicito. Lo abbiamo visto con il flop
del comizio trumpiano a Tulsa in Oklahoma: per la prima volta, si sono espressi
anche i giovanissimi su una piattaforma, TikTok, di certo non nata per
argomentare di politica. Dietro l’elezione di Biden c’è qualcosa di più profondo
e primigenio: con questa scelta, gli Americani scelgono di ritornare alla casa
del padre. Tutta la storia americana può essere interpretata come la ricerca
costante di un rapporto paterno. Mickey Mouse di Walter Disney è un topo senza
padre, ogni icona a stelle strisce, dalla letteratura ai miti pop, esprime in
negativo questo vuoto da sopperire, segno che il mito d’America è una narrazione
ribaltata, dove l’eroe non è Ulisse, ma il figlio Telemaco che si mette sulle
sue tracce. Ecco allora che la vittoria di Joe Biden è il sogno di una catarsi
che si avvera. Quell’uomo anziano, un presidente – diciamocelo – fragile nel
marasma di un virus che minaccia proprio gli anziani, è il padre che gli
Americani cercavano, l’uomo della Pennsylvania a cui due volte il destino – non
Dio, Biden è il secondo presidente cattolico degli Stati Uniti – ha negato la
paternità: una prima volta nel ’72, con la morte della figlioletta di 13 mesi,
una seconda nel 2015, con la tragica scomparsa del figlio Beau. L’elezione di
Biden arriva esattamente 60 anni dopo quella di John Fitzgerald Kennedy,
anch’egli segnato dalla morte del fratello Joe in un bombardamento e della
sorella Kick in un incidente aereo. Anch’egli espressione di crepe insanabili
che solo i padri sanno portare e accogliere. Il suo assassinio, tre anni dopo,
fu l’elegia funebre di un Paese che aveva appena rinsaldato una legame
familiare. In una narrazione apologetica, Joe Biden sarebbe politicamente un
fallito: senatore giovanissimo, ha perso due corse presidenziali per poi
diventare il secondo posto del carismatico Obama in un’era che pareva avere
inciso a caratteri cubitali la rottamazione dei tempi passati. Ora quel passato
bistrattato ai limiti del rifiuto diventa il luogo del conforto: “I nostri
giorni migliori sono ancora davanti” recita lo slogan della corsa presidenziale
scelto da Biden a gennaio scorso: il passato resta l’ancora del futuro, alla
stregua di un padre che resterà il modello per i suoi figli.
Marcello Veneziani per la Verità l'8 novembre 2020. L'unico lato
positivo della controversa sconfitta di Donald Trump è che finalmente non
sentiremo più ululare cassandre e iettatori, sciacalli e malpancisti su quanto è
orrenda l'America dominata dal Maligno col ciuffo biondo. Finalmente cesserà
questo coro assordante di gufi e di cornacchie, non svolazzeranno più gli
avvoltoi mediatici sul corpo lacerato degli States, tutto sembrerà ridente;
compresa la crisi, la disoccupazione e gli uragani. Sarà bello pure il Covid
dopo la sconfitta di Trump. Non sentiremo più in video il solito, quotidiano
fervorino di cantanti, attori, intellettuali contro la Casa Bianca, e la
temeraria sfida di tutti contro uno, per giunta in favore di telecamere, in
mondovisione. Che coraggio, tutti contro Trump. Non vedremo più mobilitarsi gli
antifà, i neri in assetto di guerra, i cortei e gli assalti ai poliziotti, ci
risparmieremo di vedere gli inginocchiati e i loro piagnistei planetari. Non
vedremo più il sorriso cattivo di Anthony Fauci, la jena personale di Trump.Sarà
davvero una liberazione. Non da Trump ma dall'antitrumpismo ringhioso e lagnoso
in servizio permanente. Il mondo tirerà un sospiro di sollievo, tutto andrà
meglio nella narrazione dei media. L'umanità sarà più gioconda senza il padre di
tutti i razzisti-sovranisti, di tutti i torvi populisti, di tutti i
fake-cazzari. Il potere globale avrà la faccia buona di Xi Jinping e della sua
mansueta dittatura cinese che ha il primato mondiale nell'inventare virus da
esportazione e nell'infliggere pene capitali e carcere ai dissidenti. Evviva la
Cina che sforna Covid come involtini primavera. L'America potrà riprendere
persino a far le guerre in santa pace, guerre umanitarie perché fatte da
pacifisti, senza quel disturbatore panciuto che le aveva fermate, quel
guerrafondaio contro le guerre. Certo l'America sarà ancora divisa, spaccata,
tra i due odii; ma quello dei trumpiani o trumpati coverà sotto la cenere,
scorrerà sotto traccia, non disporrà di quel permanente vivavoce planetario di
cui ha disposto l'opinione pubblica antitrumpiana in questi quattro anni. Non ne
sentiremo parlare. Dalla Casa Bianca uscirà Trump e non entrerà nessuno. Quel
nessuno prenderà il nome e la sembianza di un vecchietto, di quelli che fanno le
pubblicità alle dentiere e alle pasticche per la prostata infiammata. Si chiama
Joe Biden, eletto solo in sfregio e in odio a Trump; non un leader, ma un
trumpifugo, un antibiotico, un vaccino contro l'ingombrante Trump Macigno. Il
Bene è ineffabile, può anche non avere un volto, basta che cancelli il Maligno
con le sue fattezze. In realtà, come cambierà il mondo senza Trump? Non cambierà
poi tanto perché Trump non ha voluto essere un leader globale ma è rimasto
saldamente ancorato alla sua America. America first. America alone. Non ha
invaso i mercati, non ha colonizzato il pianeta ma ha protetto i prodotti
americani, è rimasto sulla difensiva. Non ha dato vita a nessuna internazionale
sovranista, ha mantenuto un rapporto ambiguo con Vladimir Putin; in Europa
abbiamo avvertito solo i suoi dazi, non altro. Non ha conteso alla Cina il
controllo dell'Africa, ha avuto con l'Asia solo rapporti di concorrenza. Ma
soprattutto non ha inteso esportare il modello americano nel mondo, si è
limitato a proteggere dal mondo gli Stati Uniti. Per la prima volta l'America
non si è identificata con la globalizzazione ma con la difesa dalla
globalizzazione. Per queste ragioni la caduta di Trump non avrà ripercussioni
sui nostri scenari se non simboliche. Il tifo per Trump di Matteo Salvini e di
Giorgia Meloni non è stato ricambiato da attestazioni e sostegni. Abbiamo
sentito l'effetto Trump solo sul piano commerciale, nell'import/export. L'unica
vistosa ingerenza che Trump ha compiuto sull'Italia è stato il tweet
d'incoraggiamento a «Giuseppi» mentre formava il secondo governo. Non avrà
capito bene di cosa si trattava, magari gli piaceva la pochette nel taschino e
l'abitino da Caraceni del gagà, se lo ricordava scodinzolante e un po' lecchino
con lui, lo riteneva un outsider come lui, un corpo estraneo alla politica...È
stata l'unica influenza di Trump sull'Italia, in favore del presente governo.
Confermando di non capire molto di politica estera e di non volersi intromettere
negli affari altrui. Ma se non è stato Biden, chi ha sconfitto Trump? Dovrei
dire l'Apparato, l'establishment, insomma quel blocco globale che lo ha
avversato su ogni terreno, per mesi, per anni. Con ogni mezzo. Ma Trump alla
fine li avrebbe sconfitti. Lo ha sconfitto invece il Covid, che ha vanificato o
fatto dimenticare il grande balzo in avanti che Trump aveva fatto fare agli Usa.
E che lui ha fronteggiato in modo spavaldo ma non altrettanto efficace, in una
prima fase sottovalutandolo. E i brogli? Può essere, ma una cosa è certa: la
culla della democrazia ha una chiavica di sistema elettorale; aspettano ancora
le diligenze postali come nel Far West...Sarebbe facile dire che con lui c'era
il popolo, con Biden c'erano le élite. Ma è vero fino a un certo punto: diciamo
che gli Usa, come quasi tutto l'occidente, è spaccato in due parti più o meno
equivalenti. E sarei cauto a rovesciare il razzismo progressista e presentare il
popolo di Trump come la parte sana e migliore dell'America. C'è anche tanta
marmaglia, come sempre succede quando i numeri sono grossi. Con questi onesti
distinguo possiamo però dire che Trump e il suo popolo, alla fine, con tutti i
loro difetti, erano preferibili ai loro tanti nemici. Infine, la vergogna della
censura di tv e social a Trump; avevano tutto il diritto di commentare dopo con
asprezza il discorso di Trump ma censurare mentre parla il presidente ancora in
carica, è un'intolleranza e una violenza istituzionale che lascerà conseguenze.
Il fatto è che da quando fu eletto lo considerate un intruso. Poi vi lamentate
se lui ora disconosce il verdetto.
Vince Biden: addio "analfabeti funzionali" e hacker russi.
Con la vittoria di Joe Biden, gli elettori, ignoranti
e stupidi quando votavano per Donald Trump, sono tornati a essere intelligenti e
colti. Gli hacker russi? Un lontano ricordo...Roberto Vivaldelli, Lunedì
09/11/2020 su Il Giornale. Dopo il referendum sulla Brexit e la vittoria
di Donald Trump nel 2016, molti commentatori - rigorosamente progressisti - si
sono domandati se non fosse venuto il momento di dimenticare il suffragio
universale e rivedere il sistema democratico occidentale, magari introducendo un
patentino di idoneità per il voto. La vittoria di The Donald aveva stimolato i
democratici di tutto il mondo a lanciare una poderosa battaglia contro le "fake
news" e le fantomatiche interferenze russe che sovvertirebbero il voto a favore
dei sovranisti. Azzerate tutto: ora che negli Stati Uniti - salvo ricorsi - ha
vinto il democratico Joe Biden, questi problemi che attanagliavano le vite dei
"liberal" di tutto il mondo sono del tutto superati: ora che gli elettori
americani sono tornati a votare come dicono opinionisti e commentatori, sono
tornati a essere intelligenti e gli hacker russi non sembrano essere più quelli
di una volta. Addio, dunque, analfabeti funzionali. Anzi: ora che sono i
repubblicani a denunciare possibili brogli - come ha fatto l'avvocato di Trump,
Rudy Giuliani, non esattamente l'ultimo arrivato - si tratta per forza di cose
di una tesi cospirazionista. Il Russiagate, invece - smentito dai fatti - era il
nuovo Vangelo. Come sottolinea Maria Giovanna Maglie su La Verità, "Biden, anzi
zio Joe, come lo chiamano alcuni giornalisti italiani, un fratello maggiore,
come lo ha salutato Matteo Renzi prima di scoprire di avere altri guai, è un
eterno giovane. Lui può. L'avranno forse votato degli analfabeti funzionali,
perché in democrazia succede così, che gli elettori premiano i cretini? Tutto
dimenticato se si tratta del loro uomo".
Il delirio della stampa progressista per Biden: "Un nuovo 25
aprile". Sarà mancanza di fantasia, ma poteva forse non essere scomodato
l'antifascismo da operetta nelle elezioni americane? Certo che no. Perché c'è
chi, come il direttore de La Stampa Massimo Giannini, arriva a sostenere che la
vittoria di Joe Biden rappresenta una nuova Festa della Liberazione globale:
come se Trump fosse arrivato al potere negli Usa con un colpo di Stato e non
attraverso delle regolari elezioni. In questi quattro anni, dunque, ci sarebbe
stata una dittatura negli Stati Uniti. "La vittoria di #Biden cambia la Storia,
la sconfitta di #Trump è una festa della Liberazione per tutti noi, cittadini
del mondo, e per chiunque abbia a cuore i destini della democrazia" scrive su
Twitter Giannini. Naturalmente, il fatto che alcuni emittenti televisive abbiano
censurato il discorso di Trump in diretta rappresenta una nuova frontiera del
giornalismo libero. Secondo quanto scrive sul Messaggero Maro Simoni, docente
alla Luiss, del "giornalismo mediatore le democrazie non possono fare a meno.
Chiamatelo ristrutturato, ripensato, adattato, ma la funzione del giornalismo di
protezione del terreno comune su cui si muove l'opinionepubblica è lo stesso:
non cambia. Forse in questi giorni l'abbiamo ritrovato". Dello stesso avviso
Luigi Marattin (Italia Viva), che in un tweet commenta: "Pensa se avessimo in
Italia un giornalismo così. Sarebbero quasi solo interruzioni. Avremmo meno
ascolti forse, ma miglior democrazia".
Le bugie le dicono tutti i politici, non solo Trump. Sottointeso
il fatto che i politici di orientamento democratico non mentono mai, a
differenza dei sovranisti e dei populisti di destra, bugiardi seriali. Peccato
che come ha dimostrato uno dei più importanti politologi mondiali, John J.
Mearsheimer, nel suo saggio Verità e bugie nella politica internazionale (Luiss
University Press), le bugie abbiano sempre fatto parte della cassetta degli
attrezzi del leader politico, di ogni fede politica. Il politologo
dell'Università di Chicago spiega, infatti, che i leader più propensi a mentire
sono proprio quelli delle democrazie occidentali, quelli che piacciano tanto ai
commentatori progressisti di tutto il mondo. In effetti, dice Mearsheimer, i
leader tendono a mentire ai propri cittadini più spesso di quanto mentano fra di
loro. Ma per i liberal l'unico a mentire è sempre stato il tycoon della Casa
Bianca, mentre Sleepy Joe non farà altro che dirci la verità.
Lo “zio buono” e la tangente da 900 mila dollari.
Rec News l'8 Novembre 2020. Quasi un milione per un’apparizione avvenuta a
ridosso della candidatura alle presidenziali. Secondo Kamenar, la somma sarebbe
stato frutto di donazioni anonime provenienti dalla Cina uasi un milione di
dollari per un’apparizione avvenuta a ridosso della candidatura alle
presidenziali. E’ questa la cifra che avrebbe intascato Joe Biden, il senatore
democratico, lo “zio buono” d’America (così lo hanno riferito le agenzie
asservite alla causa cinese e alle varie Agende) appena proclamato presidente
dai media. La somma sarebbe stato frutto di donazioni anonime provenienti dalla
Cina, come ha denunciato un funzionario lo scorso 31 ottobre. E’ quanto si
evince da un documento di 13 pagine di cui siamo entrati in possesso in
esclusiva italiana, dove si fa riferimento anche a una somma molto più
consisente di 14,5 milioni riconducibile alla rete che lega i democratici
americani, la Cina, un altro stato estero e il mondo accademico della
Pennsylvania, uno degli Stati che sarebbe al centro dei brogli recentemente
denunciati dai repubblicani. Clicca sul pulsante rosso in basso per leggere
l’inchiesta integrale.
Il funzionario: “Tra i dem esponenti che agiscono per conti di
paesi stranieri”. Rec News l'8 Novembre 2020. Le
ingerenze denunciate lo scorso 31 ottobre all’Assistente Procuratore Generale
per la sicurezza nazionale: “Donazioni e tornaconti economici”. Il 31 ottobre
scorso – poco più di una settimana fa – Paul D. Kamenar della NLPD denunciava a
John C. Demers, Assistente Procuratore Generale per la sicurezza nazionale, una
serie di ingerenze tra il partito democratico americano e alcuni Stati esteri.
Secondo le rivelazioni del funzionario, Joe Biden, suo figlio Hunter e suo
fratello James avrebbero svolto attività politiche per conto di potenze
straniere in grado di turbare “l’equilibrio democratico”. Tra le accuse figurano
violazioni penali della legge federale, cospirazione, riciclaggio di denaro e
frode telematica. E’ quanto si legge in un’inchiesta esclusiva pubblicata da Rec
News. Una rete di finanziamenti anonimi, pesanti infiltrazioni nel mondo
accademico di uno Stato al centro dei presunti brogli elettorali e un enigmatico
progetto avrebbero caratterizzato l’attività politica del senatore dem e della
sua famiglia una ragnatela di finanziamenti anonimi provenienti dalla Cina, il
tentativo di “turbare gli equilibri democratici”, pesanti infiltrazioni nel
mondo accademico della Pennsylvania – Stato ora al centro dei presunti brogli
elettorali – e un enigmatico “progetto Truman” avrebbero caratterizzato
l’attività politica del senatore dem proclamato presidente dai media, del figlio
Hunter e perno del fratello James, socio in aari col nipote. E’ quanto si desume
da un’articolata denuncia inoltrata da un organismo di vigilanza americano – il
National Legal and Policy Center – firmata dal Senior Fellow della Conferenza
Amministrativa degli Stati Uniti Paul D. Kamenar e indirizzata alla Divisione
Sicurezza Nazionale del FARA, che tra le altre gestisce l’archivio degli agenti
che operano sul territorio americano per conto di altri Stati. “I Biden sono
agenti che agiscono per conto di un Paese straniero” Il 31 ottobre scorso – poco
più di una settimana fa – Kamenar denunciava a John C. Demers, Assistente
Procuratore Generale per la sicurezza nazionale, una serie di problematiche e
ingerenze politiche che dopo la proclamazione da parte dei media della
“vittoria” di Biden, non possono che assumere contorni inquietanti. “Caro Signor
Demers – scrive Kamenar – il National Legal and Policy Center (NLPC) presenta
questa denuncia contro Hunter Biden, il Truman National Security Project,
l’Università della Pennsylvania e la sua Penn Biden Center for Diplomacy and
Global Engagement, perché c’è ragione di credere che uno o più di loro o dei
loro agenti potrebbero non essere riusciti a registrarsi come agente straniero
sotto il Foreign Agent Registration Act per quanto riguarda le loro attività
politiche per conto di un paese straniero”. I Biden avrebbero cioè svolto
attività di “cospirazione”, si legge più avanti, per conto della Cina e
dell’Ucraina di Poroshenko e contro l’equilibrio democratico degli Stati Uniti,
intascando somme importanti e focalizzandosi sull’obiettivo di una elezione alle
presidenziali che doveva avvenire a tutti i costi per conto dei padroni di
Pechino e nell’interesse specifico dei magnati ucraini del gas legati a doppio
lo ad Hunter Biden . Voti o non voti. Il Senior Fellow della Conferenza
Amministrativa degli Stati Uniti Paul D. Kamenar (AP Photo/Susan Walsh) Il
“cachet” di quasi un milione per l’apparizione di Joe Biden e i reati contestati
ad Hunter e soci “NLPC – prosegue il funzionario – richiede perciò un’indagine
completa di questa materia, che riteniamo possa portare ad altre violazioni
civili o penali della legge federale, tra cui cospirazione, riciclaggio di
denaro, evasione scale e frode telematica , che potrebbe essere state commesse
da Hunter Biden e dai suoi soci, compreso suo zio James Biden, e suo padre Joe
Biden”. Buona parte del tutto – riferisce il documento di 13 pagine di cui siamo
entrati in possesso – circostanziato in un denuncia al Dipartimento della
Pubblica Riservatezza.
La Cina, l'Università di Pennsylvania e la denuncia che
inguaia Hunter e Joe Biden. Il direttore Zaira
Bartucca su Rec News l'8/11/2020. Istruzione datata 25 maggio, in cui veniva
chiesta un’indagine sulla ricezione di 67 milioni in donazioni anonime
provenienti dalla Cina, indirizzate all’Università della Pennsylvania e avvenute
dal 2017 al 2019″. Una, la più cospicua, di 14,5 milioni, del 29 maggio 2018.
“Alcuni fondi – scrive ancora Kamenar – sono stati probabilmente incanalati al
suo Penn Biden Center for Diplomacy & Global Engagement per pagare Joe Biden
circa 900.000 dollari per alcune apparizioni che ha fatto prima di annunciare la
suo candidatura alla presidenza il 25 aprile 2019″. Burisma, Hunter Biden e
China Energy, il conglomerato che teneva in piedi i rapporti tra i dem il regime
di Xi Jinping “Ci sono prove – scrive ancora Kamenar – che Hunter Biden ha
tentato di influenzare suo padre, poi vicepresidente, Joe Biden e altri
funzionari federali, per promuovere direttamente o indirettamente la politica o
gli interessi pubblici di entità straniere, tra cui Burisma in Ucraina e CEFC
China Energy Co., un conglomerato cinese il cui presidente aveva legami con il
regime comunista di Pechino e in cui Hunter Biden aveva una quota finanziaria
lucrativa . La denuncia del funzionario si basa sulle prove trovate nel disco
rigido del laptop di Hunter Biden, che è stato nelle mani dell’FBI da dicembre
2019. Qui sono state trovate mail incriminanti e messaggi di testo, come
riportato dal New York Post. Kamenar prosegue menzionando il rapporto del
Dipartimento della Sicurezza Nazionale del Senato e delle Commissioni Finanze
che evidenziano i rapporti commerciali esteri di Hunter Biden con persone vicine
a Ye Jianming, già ufficiale di un gruppo che fa parte del PCC. Sleepy Joe era
nascosto dietro il soprannome di “Big Guy”. A lui il 10 per cento di una
tangente milionaria La denuncia di Kamenar si interseca anche con la vicenda di
Tony Bobulinsky, il nebbioso consulente e socio in affari di Hunter Biden spesso
menzionato in concomitanza dei le incriminati trovati sul pc del figlio di
Biden. Secondo lui” il ragazzone”, “il mio ragazzo”, o “il presidente”, erano i
vezzeggiativi che Hunter usava per chiamare il padre. “Lo chiamava così – scrive
Bobulinsky – quando chiedeva consigli o informazioni su offerte che dovevamo
discutere”. L’identità viene confermata grazie a un messaggio del 17 maggio del
2017, che gura tra quelli resi noti dal NYP. E’ la stessa mail a raccontare di
un’offerta di “3 milioni all’anno”, frutto di un contratto informale tra i
democratici e un Ye “con profondi legami con il Partito Comunista Cinese” . Il
regime si sarebbe infiltrato – analizza NLPC – grazie alla tangente milionaria
che prevedeva una quota per Joe Biden. “Il 10% – scrive Kamenar – era stato
contrassegnato per essere messo da parte per lui. Joe Biden non ha negato di
aver ricevuto denaro dalle offerte relative agli affari esteri di suo figlio,
solo che non ha ricevuto alcun denaro direttamente da fonti estere. La campagna
di Biden ha semplicemente detto che le sue dichiarazioni dei redditi non
mostrano che ha ricevuto fondi da suo figlio. In primo luogo, l’omissione sulle
dichiarazioni dei redditi di qualcuno non è una prova che non c’è stato
guadagno. Ciò costituirebbe evasione scale. Inoltre, se i fondi o azioni degli
interessi finanziari di Hunter a suo padre erano regali, non sono reddito
dichiarabile dal destinatario. Invece, il donatore è soggetto a imposta regalo a
seconda della quantità. Insomma, le dichiarazioni dei redditi di Biden sono
egoistiche. Di conseguenza, vi è motivo di credere che Hunter Biden non sia
riuscito a registrarsi come agente estero sotto il FARA, segnalando i suoi
rapporti con Burisma e CEFC China Energy”. I 67 milioni provenienti dalla Cina
ricevuti dall’Università di Pennsylvania “Dal 2013 al 2019, inoltre – evidenzia
ancora Kamenar – l’Università della Pennsylvania ha ricevuto più di 67 milioni
dalla Cina. Più significativamente, dopo che il Penn Biden Center ha aperto le
porte qui a Washington, D. C., il febbraio 2018, i regali della Cina si sono
fatti ancora più frequenti, tra cui un singolo anonimo regalo pochi mesi dopo il
25 maggio 2018 per un’enorme cifra di 14.5 milioni di dollari. I regali sono
continuati dopo che Biden ha annunciato la sua candidatura alla presidenza il 25
aprile 2019″. A questo punto il funzionario riporta la seguente tabella
riassuntiva: 2017: Totale :7 7,734,790 Anonimo: $500,000 2018: Totale:
$27,104,246 Anonimo: $15,800,000 2019: Totale: $26,947,074 Anonimo: $6,004,975
Riservatezza. “L’Università della Pennsylvania – continua Kamenar – ha rifiutato
di rivelare la fonte di queste donazioni anonime, o qualsiasi documento
associato a questi doni o contratti. Sia Penn che il Penn Biden Center sono
particolarmente vulnerabili alle influenze cinesi a causa di queste grandi
quantità di donazioni e contratti . Ad esempio, Penn Global ha sponsorizzato il
quarto simposio annuale del Penn China Research il 31 gennaio 2020. Il simposio
ha incluso le osservazioni di apertura dell’Ambasciatore Huang Ping, Console
Generale della Repubblica Popolare Cinese a New York. Almeno uno dei relatori al
simposio era del Penn Biden Center. Non ci può essere dubbio – rileva il
firmatario della denuncia contro Biden e soci – che le fonti cinesi hanno
finanziato il simposio”. Il summit sul Covid che svela la linea lo-cinese del
mondo accademico vicino ai Biden Il summit avveniva inoltre “al culmine della
copertura della Cina come fonte della pandemia di Covid”, con un paradosso di
fondo: “Mentre il Penn Biden Center attaccava pubblicamente l’Ungheria e la
Polonia, alleati NATO degli Stati Uniti, per la loro gestione del virus
tacciando i loro interventi come antidemocratici, né Penn né il Penn Biden
dicevano una sola parola sulla Cina. La Cina comunista è tutt’altro che
democratica, poiché punisce il dissenso nel suo paese e ad Hong Kong, e
incarcera no a un milione dei suoi cittadini che fanno parte della minoranza
uigura. In breve, l’unità FARA del Dipartimento di giustizia dovrebbe indagare
su Penn e il Penn Biden Center per determinare se ci sono state condizioni
esplicite o implicite associate ai 67 milioni in donazioni e ai contratti dalla
Cina , o un’intesa generale, o entrambi, riconducibili alla rinuncia di critiche
nei confronti della Cina e delle sue politiche, o riconducibili allo sposare
certe opinioni su quel paese. Se è così – conclude Kamenar – questo
costituirebbe attività politiche ai sensi della sezione 611(o) del FARA, vale a
dire, qualsiasi attività che in qualsiasi modo influenza qualsiasi sezione del
pubblico negli Stati Uniti con riferimento a (…) interessi politici o pubblici,
alle politiche o le relazioni di un governo di un Paese straniero o a un partito
politico straniero. Qualsiasi sezione del pubblico all’interno degli Stati,
includerebbero ovviamente anche gli studenti e la facoltà della comunità
accademica di Penn come la più grande comunità di politica estera”.
Elezioni Usa: Biden eletto nuovo presidente, Trump non
riconosce la vittoria. Le iene News il 7 novembre
2020. Quattro giorni dopo il voto, arriva il risultato dalle urne: Joe Biden ha
vinto le elezioni e sarà il 46° presidente degli Stati Uniti. Decisiva la fine
del conteggio dei voti in Pennsylvania. L'ex vicepresidente di Obama dichiara
subito: "Sono umilmente onorato, è tempo di riunire il paese". Kamala Harris
prima donna vicepresidente. Trump annuncia battaglia legale, non riconosce il
risultato e continua a parlare di brogli. “Sono avanti io di molto" scrive e
viene di nuovo segnalato da Twitter. L'ex vicepresidente di Barack Obama per 8
anni, Joe Biden sarà il 46° presidente degli Stati Uniti. A quattro giorni dal
voto risulta decisivo per la sua elezione il risultato finale dello stato
della Pennsylvania che lo porta a quota 273 Grandi Elettori, sopra i 270
necessari per l’elezione. Democratico, 78 anni il 20 novembre prossimo, nato a
Scrancton proprio in Pennsylvania, Biden ha subito commentato
così: "Sono umilmente onorato dalla fiducia che gli americani hanno riposto in
me e Harris. Ora è tempo di mettere via la rabbia e l'aspra retorica. È tempo di
riunire il Paese". "America, sono onorato di essere stato scelto per guidare il
nostro grande Paese", twitta Biden. "Il lavoro che ci attende sarà duro, ma vi
prometto questo: sarò un presidente per tutti gli americani, indipendentemente
dal fatto che abbiate votato per me o no. Manterrò la fiducia che avete riposto
in me". Al suo fianco avrà la prima donna eletta vicepresidente nella storia
americana, Kamala Harris, nata a Oakland (California, baia di San Francisco) 56
anni fa da madre di origine indiana e padre di origine giamaicana. Le tv
americane sulla base delle proiezioni concordi di Ap, Cnn, Msnbc arrivate
hanno proclamato attorno alle 18 ,dopo quattro lunghi giorni di attesa dei
risultati dopo il voto, Biden "eletto 46° presidente degli Stati Uniti".
Continua intanto lo spoglio: Biden ha vinto poi anche in Nevada arrivando a 290
voti elettorali, sarebbe il presidente più votato della storia degli Stati Uniti
con oltre 75 milioni di consensi alle urne. Lo sconfitto, il presidente
repubblicano ancora in carica, Donald Trump non riconosce la vittoria di Biden,
continua a insistere sulle accuse di brogli e annuncia, come già promesso,
battaglia legale. "Sappiamo tutti perché Joe Biden si stia affrettando a
fingersi vincitore e perché i suoi alleati sui media stiano cercando di
aiutarlo: non vogliono che la verità sia rivelata”, recita una nota. "Il fatto è
che le elezioni sono ben lontane dall'essere concluse. A partire da lunedì i
responsabili della campagna presidenziale porteranno il nostro caso in tribunale
perché si possa garantire il pieno rispetto delle leggi elettorali e che si
riconosca il legittimo vincitore". "Non mi fermerò finché il popolo americano
non avrà il numero di voti onesti che merita e che la democrazia richiede"
dichiara Trump. “Sono avanti io di molto" aveva scritto poco prima su Twitter.
"Sono accadute cose brutte nelle ore in cui la trasparenza legale è stata
brutalmente e crudamente negata". Il social network continua
a censurarlo sistematicamente con la scritta "contenuto fuorviante". Anche
la Commissione elettorale statunitense lo smentisce: "Non c'è alcuna prova che
ci siano stati brogli o voti illegali alle elezioni americane".
Elezioni Usa 2020, Trump non si smentisce: "Vogliono rubare il
voto agli americani". Gli Stati Uniti attendono il
risultato dei conteggi dei voti postali. Ma mentre Joe Biden spiega che servirà
aspettare, il presidente uscente parte subito all'attacco denunciando brogli e
intestandosi la vittoria. Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni su L'Espresso il
04 novembre 2020. È un Donald Trump furioso quello che si rivolge alla nazione
alle due del mattino passate. "Un gruppo triste di persone vuole rubare il voto
agli americani", dice riferendosi a quegli stati che stanno ancora contando i
voti senza quindi assegnare un vincitore. Ma anche al democratico Joe Biden che
ha tenuto il suo discorso da Wilmington, in Delaware, qualche ora prima di lui.
Dalla Casa Bianca, Trump lancia accuse gravissime, nonostante il rischio di
destabilizzare pesantemente il Paese. E invoca l’intervento della Corte Suprema.
"È un imbroglio, una frode: ci preparavamo a vincere e lo abbiamo fatto. Il
nostro obiettivo adesso è assicurarci che le elezioni siano integre. Momento
importantissimo. Quindi ci rivolgeremo alla corte suprema: vogliamo che tutti i
voti finiscano, non vogliano che trovino schede alle 4 del mattino aggiunte
all'ultimo", queste le prime parole di Donald Trump dopo la chiusura dei seggi
negli Stati Uniti. "È Un momento molto triste per quanto mi riguarda. Ma noi
abbiamo già vinto, ringrazio tutti i miei sostenitori e chi ha lavorato con
noi", ha aggiunto. Forse proprio prevedendo un intervento incendiario del
genere, Joe Biden ha sciolto per primo il silenzio. Nonostante si mostri
fiducioso non proclama vittoria come il suo avversario. “Non spetta a me né a
Donald Trump stabilire chi abbia vinto queste elezioni”. Il candidato
democratico avverte che occorrerà aspettare, ma ostenta ottimismo sull’esito del
voto negli stati ancora in bilico ovvero Pennsylvania, Michigan e Wisconsin.
Nessuna sorpresa: “Sapevamo che ci sarebbe voluto tempo”. Biden però assicura
che “ogni scheda sarà contata”. Anche quelle arrivate per posta. Nessuno dei due
intanto raggiunge il numero magico di 270 grandi elettori, necessario per
dichiarare vittoria. L’America resta quindi con il fiato sospeso. Su tutti un
interrogativo: capire se il “miraggio rosso” di cui si parla da settimane si
concretizzerà. Una cosa è certa, il confronto (e lo scontro) tra le due anime
del paese è serrato, più di quanto ci si aspettasse. A pesare è ora l’incognita
del voto per posta e le battaglie legali che ritarderanno sensibilmente la conta
finale dei voti. Il destino della nazione si gioca negli stati chiave di
Michigan, Wisconsin e soprattutto in Pennsylvania, un terreno scivolosissimo per
entrambi i candidati. Non a caso sia Trump che Biden hanno dedicato a questo
stato ingenti energie negli ultimi giorni di campagna. Si sono rivolti alle
periferie, hanno parlato alle donne dei sobborghi, agli operai. A coloro,
insomma, che nel 2016 regalarono lo stato a Trump. Senza però tralasciare le
minoranze, i giovani, le chiese. Scontato il bottino di Trump in Kentucky,
Carolina del Sud e Oklahoma; Pare che si assestino a destra anche Georgia e
Carolina del Nord. Previsto l’esito in Vermont, Delaware e Maryland, assicurati
da Biden. Trump conferma il Texas e intasca i suoi 38 grandi elettori. Ma per la
prima volta dal 1976 – quando cioè si aggiudicò la vittoria il democratico Jimmy
Carter – scricchiola la roccaforte repubblicana nello stato vista la vittoria
risicata di 52 a 46. Si tingono di rosso anche l’Ohio e Florida, dove entrambi i
partiti avevano investito tempo ed energie, per conquistare l’elettorato
ispanico e quello degli over sessanta. Inutile la sortita di Barack Obama,
arrivato nel “Sunshine State” per tentare di convincere gli indecisi. Nonostante
tutto, sembra comunque che Biden abbia raccolto meglio di Hillary Clinton nel
2016. In compenso, però, Biden espugna l'Arizona, uno Stato di tradizione
repubblicana. Una sfida tutt’altro che sonnacchiosa, insomma, quella tra i
“vecchi” Donald, 74 anni, e Joe, 78 tra un mese. Il duello dei record.
Innanzitutto per le mostruose iniezioni di denaro nelle rispettive campagne:
attorno ai 3 miliardi di dollari; ma anche per la straordinaria affluenza e
partecipazione popolare. Sono stati 102 i milioni di americani che hanno
espresso la loro preferenza con voto anticipato o per posta prima della chiusura
ufficiale dei seggi. A giocare un ruolo fondamentale, il timore di contagio da
Covid19. Gli americani hanno in massa optato per il voto per posta. Nel
complesso, gli esperti si aspettano di registrare una cifra complessiva di 160
milioni di americani, ovvero circa il 67% degli aventi diritto. Non accadeva da
oltre un secolo. Due campagne elettorali completamente diverse. Quella di Trump,
concentrata a “mantenere l’America grande”; quella di Biden in “lotta per
l'anima della nazione”, dilaniata da divisioni razziali, economiche, sociali.
Una nazione flagellata innanzitutto dalla piaga del coronavirus che ha lasciato
sul campo oltre 232mila persone, contagiandone quasi 10 milioni. Una catastrofe
che ha colpito in maniera spropositata le minoranze e gli indigenti. Senza
parlare del conseguente disastro economico che ha polverizzato i posti di lavoro
di milioni di persone, distruggendo gran parte dei successi ottenuti dalle
politiche economiche dall’amministrazione Trump. Almeno fino alla pandemia,
difatti, la corsa di Trump alla rielezione sembrava pressoché inarrestabile.
Merito anche e soprattutto dei risultati ottenuti in campo economico, con
livelli di disoccupazione al minimo storico del 3,5%. Una cosa è certa, questo
voto è stato un vero e proprio referendum sull’operato di Donald Trump ed in
particolare sulla sua gestione della pandemia. In un botta e risposta continuo
sui temi più cari a queste elezioni come economia, pandemia, sanità, questioni
razziali, i due candidati hanno raccontato realtà completamente diverse. Biden –
sostenuto dall’ex presidente Barack Obama - spiegava ai supporter che “Donald
Trump sarà il primo presidente a lasciare la Casa Bianca con una percentuale di
occupazione più bassa di quella trovata all’inizio del mandato”; Trump replicava
stizzito “fake news!” davanti a supporter sempre in delirio. Senza bisogno di
snocciolare dati ufficiali, ovviamente: “L’anno scorso per l’economia del Paese
è stato un anno fantastico, quello che verrà sarà ancora meglio”. E ancora, il
repubblicano vantava di aver salvato “due milioni di persone”, arrivando a
sostenere in Michigan, a quattro giorni dal voto, nelle ore in cui gli Stati
Uniti registravano un nuovo picco di contagiati, che la situazione fosse meno
grave di quello che sembrasse perché “i dottori prendono più soldi se qualcuno
muore di Covid”, alludendo al fatto che gonfiassero le cifre per un proprio
tornaconto. Un discorso perverso, secondo Biden perché Trump “non fa nulla se
non per soldi”. E chiude la questione a Filadelfia con uno slogan efficace: “Per
sconfiggere il virus, dobbiamo prima sconfiggere Donald Trump. Lui è il virus”.
Agli opposti anche le scelte dei candidati per l’organizzazione dei comizi: poco
annunciati, drive in con poche decine di persone, quelle di Biden, in rispetto
delle norme anti-covid; plateali quelli di Trump, con centinaia di persone a
seguirlo, per lo più senza mascherina, gesto ormai diventato firma politica. Se
nel 2016 fu messo in croce per aver detto durante un dibattito con la candidata
Hillary Clinton di non esser sicuro di accettare il risultato
elettorale, quest’anno l’allusione a brogli da parte delle amministrazioni
locali a guida democratica di stati chiave come la Pennsylvania è stato il
ritornello vincente di ogni bagno di folla. Che soprattutto negli ultimi giorni
sono stati tanti. Finisce coì la lunga giornata elettorale, iniziata presto per
Joe Biden. Alle 7 del mattino insieme alla moglie Jill e alle due nipotine,
Finnegan e Natalie, era andato a messa nella chiesa di St. Joseph a Wilmington,
la città in cui vive nello stato del Delaware. La famiglia Biden è difatti
cattolica e praticante. Aveva poi visitato la tomba dell’adorato figlio Beau,
scomparso per un tumore al cervello nel 2015. Nello stesso cimitero riposano la
prima moglie e la figlioletta di un anno, morte in un incidente stradale negli
anni ’70. Biden era poi andato nella cittadina di Scranton. Sul muro
dell’abitazione in cui è nato, nel 1942, aveva lasciato la dedica “Da questa
casa, alla Casa Bianca con la grazia di Dio”. La data, quella del 3 novembre
2020. La giornata era continuata a Filadelfia, in Pennsylvania, lo stato chiave
per l’assegnazione della presidenza. “Philly is the key, Philly is the key”,
Filadelfia è la chiave, avea detto il candidato democratico, la chiave verso la
Casa Bianca. In serata era tornato nella sua Wilmington e qui, dopo una visita
al Chase Center, e una chiacchiera con i giornalisti, a casa, ad attendere i
risultati del voto. Biden è apparso sereno, nel giorno più importante della sua
carriera politica. Ha atteso il risultato a casa, circondato dalla sua famiglia.
Insieme a lui la candidata a vicepresidente Kamala Harris, di ritorno da un
comizio a Detroit, in Michigan, altro stato fondamentale. Toni pacati i suoi,
nessun passo più lungo della gamba, parole pacate e misurate, consapevole che le
incognite sono troppe, tante quanti gli stati incerti. Trump invece si era
barricato al terzo piano della Casa Bianca, tv accese. Tante le telefonate. Con
lui la famiglia e i più stretti collaboratori. Dopo aver fatto 14 comizi in tre
giorni, nel giorno del voto il presidente Trump si era spostato da Washington DC
solo per andare nella vicina Arlington, in Virginia, dove si trova il quartier
generale repubblicano. Con l’avvicinarsi delle chiusure delle urne, il tono
sicuro delle prime ore della mattina che gli facevano pronosticare “una vittoria
con più margine di quella del 2016”, aveva iniziato a vacillare, prendendo in
considerazione per la prima volta anche una possibilità di sconfitta. Credo di
vincere, aveva detto al suo staff, poco prima della chiusura dei seggi nei primi
stati, Indiana e Kentucky, “Vincere è facile, perdere non lo è mai”. Ha
aspettato i risultati insieme alla famiglia e membri dello staff. Intanto il
party della notte elettorale, inizialmente previsto al Trump International
Hotel, era stato spostato alla Casa Bianca. Gli inviti ristretti da 400 a 250.
Ma a quanto sembra, occorrerà cambiare ancora i programmi.
Donald Trump insiste sui brogli: "Stanno trovando voti per
Biden ovunque, un male per il Paese”. Libero
Quotidiano il 4 novembre 2020. Donald Trump è implacabile in queste ore su
Twitter, dove sta sfidando la censura pur di continuare a battere sulla strada
dei presunti “brogli” alle elezioni presidenziali americane. “Stanno trovando
voti per Joe Biden ovunque, in Pennsylvania, Wisconsin e Michigan. Un male per
il Paese”, ha denunciato Trump, che poi ha aggiunto il carico contro i
democratici: “Stanno lavorando duramente per far sparire il prima possibile il
vantaggio di 500mila voti in Pennsylvania. Lo stesso sta avvenendo in Michigan e
altrove!”. Insomma, “The Donald” non ha alcuna intenzione di mollare la Casa
Bianca senza combattere, a costo di rivolgersi addirittura alla Corte Suprema:
di certo negli Stati chiave in cui è attualmente proiettato come perdente con
uno scarto inferiore all’1% potrà chiedere di ricontare i voti. Ma ciò non
toglie che Trump ha scelto di utilizzare toni davvero forti: prima ancora degli
ultimi due tweet, aveva condiviso un’altra analisi a dir poco complottista. “La
scorsa notte - ha scritto - ero in testa, spesso in modo solido, in molti Stati
chiave che, in quasi tutti i casi, i democratici governavano e controllavano.
Poi, uno ad uno, i vantaggi hanno iniziato a sparire magicamente mano a mano che
venivano contate montagne di schede a sorpresa. Molto strano - ha chiosato -
come mai ogni volta che contano i voti postali questi si rivelano così
devastanti per percentuale e potere di distruzione?”.
Donald Trump attacca ancora Joe Biden: "Molto strano, alcuni
voti sono magicamente spariti", un'altra accusa di brogli.
Libero Quotidiano il 04 novembre 2020. Joe Biden è passato in
vantaggio nelle elezioni presidenziali americani: se dovesse confermare gli
attuali dati che lo vedono vincente in Nevada, Michigan e Wisconsin, allora
vincerebbe ufficialmente la corsa alla Casa Bianca. Non a caso Donald Trump ha
deciso di aprire il fuoco proprio adesso su Twitter, in cui ha confermato la
linea del “furto” dei democratici e quindi del ricorso alla Corte Suprema, con
le elezioni che finirebbero addirittura in tribunale. “Stanotte ero in
vantaggio, spesso in maniera solida, in diversi Stati chiave - ha scritto Trump
- quasi tutti quelli governati e controllati dai democratici. Poi, uno ad uno,
i vantaggi hanno magicamente iniziato a sparire nel momento in cui sono stati
contati i voti postali. Molto strano (scritto in maiuscolo, ndr), i sondaggisti
hanno sbagliato completamente. Com’è possibile - ha rimarcato - che ogni volta
che contano un voto postale questo è così devastante per percentuali e potere di
distruzione?”. Parole molto pesanti, quelle usate dal presidente in carica, che
ha palesato pubblicamente un disagio che nasce dagli ultimi aggiornamenti che lo
vedono avviato verso la sconfitta. Scenario che però non può essere ancora
confermato con certezza, dato che le percentuali sono molto vicine in Stati
determinanti quali Nevada e Michigan. Di certo c’è che la mattinata americana è
stata una doccia gelida per Trump, che stanotte era andato a dormire convinto di
avere ottime possibilità di essere rieletto: ma non aveva fatto i conti con il
voto postale che, soprattutto nelle grandi città, è decisamente a favore dei
democratici.
Trump: «Stavamo vincendo dappertutto. Poi nella notte si sono
chiusi in segreto con le schede». Edoardo Valci
venerdì 6 Novembre 2020 su Il Secolo d'Italia. Donald Trump reagisce. Troppi
brogli, sondaggi che hanno condizionato le elezioni, una campagna d’odio che
dura da anni. «Non hanno verificato le firme, non hanno controllato se le
persone potessero votare. Vengono calcolati voti senza timbro postale e senza
alcun tipo di identificazione. Stanno accadendo cose pessime. È una situazione
senza precedenti a causa della corrotta macchina democratica».
Trump: «Con i voti illegali vogliono rubarci le elezioni». «Se
contate i voti legali, vinco facilmente. Ma se contate i voti illegali, possono
provare a rubarci le elezioni», afferma in sala stampa. Parla per 16 minuti. E
sono 16 minuti di fuoco. «Stiamo controllando. Molti voti sono arrivati in
ritardo. Mi sono già aggiudicato molti Stati cruciali, anche con vittorie
schiaccianti. Ho ottenuto vittorie storiche. I sondaggi sono stati completamente
sbagliati e hanno costituito un’interferenza nel voto. Sono stati progettati per
tenere a casa i nostri elettori».
La vergogna dei sondaggi: «Ma quale onda dem…» «I sondaggi hanno
cercato di sopprimere il voto. Avevano previsto che avrei perso in Florida,
invece ho vinto. Poi avevano previsto la mia sconfitta per 4 punti in Ohio, ho
vinto di 8 punti. Avevano previsto una mia larga sconfitta in Wisconsin, c’è un
testa a testa. Stanno cercando di rubarci le elezioni, stanno cercando di
truccarle. Non possiamo permetterlo», dice Trump. Ribadisce l’intenzione di
bloccare il conteggio dei voti arrivati tardi: «Non c’è stata alcuna onda blu,
c’è stata un’onda rossa», aggiunge facendo riferimento ai risultati di
democratici e repubblicani.
«Stavamo vincendo ovunque». «Ci sono pochi stati che devono
concludere lo spoglio dei voti. Stavamo vincendo in tutti gli Stati chiave. Poi
miracolosamente i nostri numeri hanno cominciato a calare. Tutto questo in
segreto, non hanno permesso agli osservatori di essere presenti. Ci siamo
rivolti al tribunale, gli osservatori sono entrati ma sono rimasti a distanza.
In questo processo è mancata trasparenza. Avevo già parlato del voto postale, è
un sistema corrotto».
Trump e il mistero della notte. «Nella notte delle elezioni
eravamo nettamente avanti in North Carolina e siamo ancora avanti. Ma con un
margine inferiore perché all’improvviso arrivano le schede per posta, inviate
tutte per una sola parte», dice con una panoramica su una serie di Stati. «Ho
vinto nettamente in Pennsylvania e ora arrivano queste schede: le trovano
ovunque e non vogliono che ci siano gli osservatori, anche se secondo un giudice
dovrebbero esserci. Vogliamo solo che il conteggio delle schede venga osservato.
In Georgia ho vinto nettamente nella notte delle elezioni e anche qui il
vantaggio è sceso e ora potrei anche essere in svantaggio. In Michigan avevamo
vinto, lo stesso in Wisconsin. Siamo vicini alla vittoria in Arizona, le nostre
previsioni sono positive».
LO SCANDALO DELLE POSTE FEDERALI. La
denuncia di Trump: «Seggi con le finestre coperte e porte bloccate. Sono
accadute cose brutte». Redazione sabato 7 Novembre 2020 su Il Secolo d'Italia.
«Decine di migliaia di voti sono stati ricevuti illegalmente dopo le 20 di
martedì, giorno delle elezioni. Cambiando totalmente e facilmente i risultati in
Pennsylvania e in altri Stati sul filo del rasoio». Lo ha dichiarato in
un tweet il presidente americano, Donald Trump, rilanciando, le accuse di brogli
nelle elezioni alla Casa Bianca. Trump ha continuato a sostenere la mancanza di
“trasparenza” durante lo spoglio dei voti in alcuni Stati in bilico, affermando
che “illegalmente” non è stato permesso di osservare lo scrutinio di centinaia
di migliaia di voti. Ciò ha cambiato «il risultato delle elezioni in numerosi
Stati, tra cui la Pennsylvania, che tutti pensavano fossero stati vinti
facilmente la notte delle elezioni». Per poi «vedere sparire un enorme
vantaggio, senza che nessuno potesse osservare per lunghi intervalli di tempo
quanto accaduto», ha scritto Trump in una serie di tweet. In quelle ore, ha
aggiunto il presidente, non c’è stata “trasparenza” in quanto le porte degli
edifici dove si contavano i voti sono state bloccate e le finestre coperte con
cartoni spessi così da impedire agli osservatori di vedere. «All’interno sono
accadute cose brutte, grandi cambiamenti hanno avuto luogo», ha aggiunto.
Le previsioni del Washington Post. Intanto, il Washington
Post, che appoggia Biden, scrive che Trump sarebbe pronto a una “purga” per
cacciare i collaboratori che ritiene non siano stati leali. Secondo il giornale
il ministro della Difesa Mark Esper, il direttore della Cia Gina Haspel e altri
alti funzionari «potrebbero essere messi alla porta». Già due giorni fa, l’Nbc
riferiva che Esper sta preparando la lettera di dimissioni. Per ora Trump ha
destituito ieri sera Bonnie Glick, numero due di Usaid. Trasferendo le sue
competenze a John Barsa, che già guida ad interim questa agenzia del governo per
la cooperazione internazionale. Trump non ha dato nessuna spiegazione alla
Glick. E il Washington post scrive che la sua cacciata «è la prima di un’attesa
vasta purga di funzionari che Trump ritiene non siano stati abbastanza leali».
STATI UNITI / TUTTI IN FILA PER TAROCCARE IL VOTO POSTALE.
Mario Avena su La Voce delle Voci il 6 Novembre 2020.
Tutto e il contrario di tutto nella bolgia post voto per la corsa alla Casa
Bianca. Il voto postale è al centro delle polemiche più infuocate. E spuntano le
tesi più paradossali: ma non si sa fino a che punto. Secondo una voce che sta
correndo in rete negli States, uno dei burattinai del ‘caos organizzato’ sarebbe
nientemeno che Steve Pieczenick, lo 007 a stelle e strisce che venne spedito
da Henry Kissinger allo corte di Francesco Cossiga (all’epoca ministro degli
Interni) affinchè Aldo Moro, rapito dalla Brigate Rosse, non dovesse essere
liberato. Anzi, “Doveva Morire”, come hanno titolato nel 2008 il loro
libro Ferdinando Imposimato e Sandro Provvisionato. Ma che ruolo avrebbe mai
giocato oggi, l’inossidabile spia di tutti i governi americani, e sotto tutti i
presidenti, inamovibile dalla sua super poltrona al Dipartimento di Stato?
Difficile da spiegare, sembra davvero una spy story in piena regola. Leggiamo
una nota che rimbalza sul web a stelle e strisce. Una nota scritta all’indomani
di una inattesa e strabiliante intervista concessa dallo 007 il 5 novembre alla
trasmissione War Room condotta da Owen Shroyer e per la rubrica Infowars. Ecco
il testo: “Secondo Pieczenick, il presidente Donald Trump ha calcolato che
sarebbe stato necessario sfruttare la stupidità dei democratici, che avrebbero
fatto di tutto per impedirgli di assicurarsi un secondo mandato presidenziale
con le elezioni del 2020. Per garantirsi che le elezioni avrebbero resistito al
tentativo di frode elettorale, Trump avrebbe ideato una trappola raffinata.
Filigrane nascoste sarebbero state inserite nelle schede elettorali in modo che
potesse essere verificate se necessario. "Questa è davvero un’operazione sotto
copertura", ha spiegato Pieczenick. "Abbiamo contrassegnato ogni scheda
elettorale con il codice di crittografia blockchain QFS. In altre parole, ora
sappiamo dove si trova ogni scheda, dove è andata e chi ce l’ha, quindi questa
non sarà un’elezione rubata"”. Possibile mai? Dal Dipartimento di Stato sarebbe
partito l’imput di "marcare" e "tracciare" le schede? E’ mai credibile uno
scenario del genere? Ma vediamo un’altra story, sempre sul possibile voto
taroccato via posta, stavolta scritta due mesi e passa fa dal New York Post, che
in queste ultime settimane ne ha tirate fuori di tutti i colori sui business
cinesi e ucraini della Biden Band, capeggiata dal padre Joe e dal figlio Hunter
Biden. Ecco il titolo dell’inchiesta del 29 agosto: “Confessioni di un
truffatore elettorale: ero un maestro nel falsare i voti postali”: in sostanza,
i cittadini ed elettori americani venivano già messi in guardia sulla facilità
con cui i voti postali possono essere truccati. Testimone eccellente dalla
combine era un esponente democratico, al quale il quotidiano ha garantito
l’anonimato. Lui stesso avrebbe per decenni taroccato elezioni comunali e
federali nello stato del New Yersey, attuando un sistema molto semplice. Da
tener presente che in Pennsylvania si stanno verificando non poche anomalie:
dopo le prime ore, con il 75 per cento di voti scrutinati, Trump era saldamente
in testa con il 55,7 per cento, mentre Biden era fermo al 43,6 per cento. Quando
lo scrutinio è proseguito ed è arrivato all’89 per cento, Trump ha perso 5 punti
percentuali e Biden ne ha guadagnati altrettanti. Un po’ strano. Ma torniamo
ad ‘O Sistema descritto nel reportage del New York Post. Il comune di
appartenenza consegna all’elettore che intende votare per posta
il kit necessario in una grande busta, che contiene la scheda elettorale, il
certificato di iscrizione al voto che l’elettore deve firmare e la busta postale
di ritorno, cioè la busta che l’elettore dovrà imbucare sigillando al suo
interno la scheda elettorale con il voto espresso e il certificato elettorale.
E’ in questo momento che i frodatori entrano in azione. La scheda elettorale non
ha caratteristiche di sicurezza specifiche, come un francobollo o una filigrana.
“L’insider ha rivelato – continua il reportage – e dimostrato di essere in grado
di realizzare schede elettorali perfettamente identiche agli originali. La
tecnica per farlo è semplice. Basta mandare in giro per le case diversi agenti
che convincono gli elettori a lasciar loro spedire per posta le buste,
offrendosi come servizio pubblico. Gli agenti o meglio gli scagnozzi portano le
buste sigillate a casa e le aprono con il vapore per allentare la colla. A quel
punto basta la scheda vera, inserire la falsa e risigillare. L’unica accortezza
da seguire è non infilare le schede false in poche cassette postali pubbliche,
ma spargerle in giro per la città”. La descrizione continua. Sembra un po’ la
truffa di Totò e Peppino per falsificare le banconote. Possibile negli States di
oggi? Ma forse tutto è possibile nel più moderno paese al mondo che non è capace
di fornire il risultato elettorale neanche dopo quattro giorni!
STATI UNITI / I SISTEMI INFORMATICI PER TAROCCARE IL VOTO.
Paolo Spiga su La Voce delle Voci il 7 Novembre 2020.
Continuano a divampare negli Stati Uniti le polemiche nel dopo voto
presidenziale. Molte di essere ruotano intorno a brogli, al voto postale e ai
sofisticati sistemi – soprattutto informatici – con i quali è possibile
taroccare le carte, condizionare i risultati e in teoria ribaltare il voto dei
cittadini-elettori americani. Leggiamo cosa scrivono, ad esempio, due reporter a
stelle e strisce, Mary Fanning e Alan Jones, sui sistemi “Scorecard” e “The
Hammer”. Nel febbraio 2009, l’amministrazione Obama ha requisito un potente
sistema di supercomputer noto come THE HAMMER. THE HAMMER include
un’applicazione di exploit nota come SCORECARD che è in grado di hackerare le
elezioni e rubare il voto, secondo Dennis Montgomery, appaltatore della CIA
diventato informatore, che ha progettato e costruito THE HAMMER. THE
WHISTLEBLOWER TAPES, registrazioni audio riservate rilasciate dall’aula del
tribunale del giudice distrettuale degli Stati Uniti G. Murray Snow nel novembre
2015, hanno rivelato che SCORECARD è stato schierato dal team di Obama contro i
computer delle elezioni della Florida per rubare le elezioni presidenziali del
2012 per conto del presidente Barack Obama e del vicepresidente Joe Biden.
SCORECARD viene ora attivato per rubare ancora una volta il voto a nome di Joe
Biden. Biden ha utilizzato THE HAMMER e SCORECARD mentre si candidava alla
carica di Vice Presidente nel 2012. I voti vengono nuovamente rubati per conto
di Joe Biden mentre si candida alla Presidenza degli Stati Uniti nel 2020.
Questa volta, SCORECARD sta rubando voti in Florida, Georgia, Texas,
Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Nevada e Arizona, secondo Montgomery.
SCORECARD ruba le elezioni manomettendo i computer nei punti di trasferimento
dei sistemi informatici delle elezioni statali e al di fuori dei depositi di
dati elettorali di terze parti mentre i voti vengono trasferiti. SCORECARD
utilizza un algoritmo di punteggio prismatico che Montgomery ha creato, per
ottenere i risultati desiderati da coloro che controllano THE HAMMER e
SCORECARD. In Florida, uno dei punti di trasferimento è VR Systems Inc, con sede
a Tallahassee. Il fornitore di software VR Systems opera in otto stati degli
Stati Uniti. I democratici hanno testato la loro tecnologia durante le primarie
del partito democratico. Altrimenti Bernie Sanders avrebbe vinto la nomination
2020. SCORECARD è stato utilizzato per conto di Joe Biden durante le primarie
del 2020 contro Bernie Sanders. Le primarie democratiche sono state rubate a
Bernie Sanders. 7/11/2020 Biden usa SCORECARD e THE HAMMER per rubare un’altra
elezione presidenziale statunitense – proprio come hanno fatto Obama e Biden nel
2012 …L’informatore della CIA Dennis Montgomery ha consegnato un’enorme quantità
di dati di sorveglianza e elezioni raccolti illegalmente nell’agosto 2015 e nel
dicembre 2015 all’FBI e alla CIA in base a due accordi di immunità concessi a
Montgomery dall’assistente procuratore degli Stati Uniti Deborah Curtis e dal
consigliere generale dell’FBI James Baker. Montgomery ha testimoniato riguardo
SCORECARD e THE HAMMER mentre era sotto giuramento e mentre veniva filmato
presso il sicuro Washington DC Field Office SCIF (Sensive Compartmented
Information Facility) dell’FBI. Se l’informatore della CIA Montgomery avesse
mentito su qualcosa, oggi sarebbe in prigione per aver mentito all’FBI.
Montgomery non è in prigione. Gli stessi autori avevano firmato un’altra
inchiesta, dedicata anche ai due registi di quei sistemi, “Scorecard” e “The
Hammer”: ossia l’ex direttore dell’Intelligence nazionale (DNI) James Clapper e
il direttore della CIA John Brennan. Il direttore dell’intelligence nazionale
(DNI) del presidente Obama James Clapper e il direttore della sua agenzia di
intelligence centrale (CIA) John Brennan hanno supervisionato un sistema di
supercomputer segreto noto come “THE HAMMER”, secondo l’ex informatore della NSA
/ CIA diventato informatore Dennis Montgomery.
Clapper e Brennan stavano utilizzando il sistema del
supercomputer per condurre raccolte e intercettazioni di dati governativi
illegali e incostituzionali. THE HAMMER è stato installato su una proprietà
federale a Fort Washington, nel Maryland, in un complesso che alcuni ipotizzano
sia un’operazione segreta della CIA e della NSA che opera in una struttura
navale statunitense. L’affermazione del presidente Trump secondo cui
l’amministrazione Obama lo stava intercettando non è solo supportata dalle
rivelazioni degli informatori di Montgomery sul sistema informatico di Brennan e
Clapper THE HAMMER, ma anche dalle dichiarazioni rese questa settimana
da William Binney , ex direttore tecnico della NSA per l’analisi geopolitica e
militare mondiale Reporting Group, dall’ex funzionario della CIA e del
Dipartimento di Stato Larry Johnson , e dall’avvocato di Montgomery Larry
Klayman. L’esperto di computer Dennis Montgomery ha sviluppato programmi
software in grado di violare i sistemi informatici protetti e raccogliere enormi
quantità di dati. Quel sistema, THE HAMMER, secondo i nastri audio, accedeva
alle telefonate, alle e-mail e ai conti bancari di milioni di normali americani.
I nastri rivelano anche che la Corte di sorveglianza dei servizi segreti esteri
(FISA), il giudice capo della Corte suprema John Roberts, altri 156 giudici,
membri del Congresso e Donald J. Trump sono stati presi di mira dall’HAMMER. Uno
dei nastri audio resi pubblici dal giudice federale G. Murray Snow ha rivelato
che Brennan e Clapper hanno particolarmente preso di mira e intercettato Donald
Trump “un’infinità di volte”. Montgomery sostiene anche che il governo può
piantare file come pornografia infantile o segreti di stato sul computer di un
obiettivo, impostando il proprietario di quel dispositivo per il ricatto o
l’accusa incastrata. L’ex reporter della CBS Sharyl Attkisson ha affermato nel
2013 di essere stata sotto sorveglianza elettronica per almeno due anni e che
tre documenti classificati erano stati inseriti nel suo computer “compromesso”.
Le registrazioni audio sono state rilasciate dal giudice federale G. Murray Snow
nella contea di Maricopa, in Arizona, nel caso di oltraggio civile del
Dipartimento di Giustizia contro lo sceriffo Joseph M. Arpaio. L’avvocato
Klayman, fondatore di Freedom Watch, ha rappresentato Montgomery davanti al
giudice federale Royce C. Lamberth. Klayman, che definisce il suo cliente
Montgomery un “informatore”, ha detto a Fox News che Montgomery “ha consegnato
più di 600 milioni di pagine di informazioni all’FBI”. Il giudice Lamberth era
in precedenza il giudice che presiede il tribunale FISA. Dopo che Montgomery ha
prodotto la sua documentazione, l’FBI gli ha dato due accordi di immunità: uno
nell’area della “produzione” e l’altro riguardante la “testimonianza”. L’FBI ha
quindi preso possesso della documentazione di Montgomery. L’avvocato Klayman
afferma che queste informazioni hanno fatto precipitare le dimissioni di James
Clapper. Clapper era andato davanti al Congresso per testimoniare sotto
giuramento che la NSA e altre agenzie di intelligence, inclusa la CIA, “non
stavano raccogliendo enormi quantità di metadati telefonici e Internet su
centinaia di milioni di cittadini americani innocenti”, secondo Klayman. Le
rivelazioni del whistleblower Edward Snowden hanno dimostrato il contrario.
Clapper è stato successivamente dichiarato mendace e si è dimesso il 17 novembre
2016, a partire dal 20 gennaio 2017, il giorno in cui Donald Trump ha prestato
giuramento. Clapper non è stato perseguito per falsa testimonianza.
Elezioni Usa, il mistero dei 300mila voti scomparsi.
Le schede di cui si è persa traccia sono abbastanza da
influenzare l'esito finale. Marco Valsania su ilsole24ore.com il 6 novembre
2020. Usa 2020, proteste in tutti gli Stati: "Che ogni voto sia conteggiato".
Più di trecentomila voti postali mancano all’appello, forse smarriti nei centri
di distribuzione, e rischiano di non essere mai contati. Oltre 80mila di questi
sono stati spediti in Stati contesi, abbastanza da poter influenzare il
risultato finale nel duello per la Casa Bianca. Le schede via posta negli Stati
Uniti sono state quasi 65 milioni, due terzi di un voto anticipato che ha
superato i cento milioni e ha spinto l’affluenza complessiva alle urne al record
di 160 milioni. Le 300mila schede all’apparenza svanite esistono, sono state
ricevute e scannerizzate nelle sedi dello United States Postal Service. Ma non
esiste traccia della loro uscita e del recapito agli uffici elettorali dove
avrebbero dovuto essere scrutinate. Non è detta l’ultima parola: alcuni Stati
hanno scadenze prolungate, anche di oltre una settimana, per ricevere voti
postali. Altri, 28 su 50, prescrivono però il conteggio solo dei voti arrivati
entro il 3 novembre. Non basta: la Pennsylvania ha sì esteso di tre giorni la
scadenza, fino a oggi, per ricevere schede, ma ha separato i voti arrivati tardi
nel timore di ricorsi legali li squalificassero. A infittire ulteriormente il
mistero è l’ipotesi che una parte di voti svaniti possa esser stata in realtà
consegnata e non registrata.
Poste Usa in difficoltà. Lo scandalo ha scosso le Poste
americane, controllate dal governo federale e sotto assedio perché le loro
carenze potrebbero avere un impatto squilibrato sull’esito delle urne, dato che
il voto “remoto” ha favorito il candidato democratico Joe Biden su Donald Trump.
Da giugno lo USPS è guidato da un controverso finanziatore del partito
repubblicano e fedelissimo di Trump, il Postmaster General Louis DeJoy, che ha
fatto scattare tagli dei costi e frenate nel lavoro, rallentando la gestione dei
crescenti volumi di voti nelle mani dei postini. Le schede processate con
puntualità nel solo giorno delle elezioni sono state stimate al 93,3% contro
obiettivi del 97%, vale a dire che il 7%, oltre ottomila voti, è rimasto
comunque paralizzato troppo a lungo. Nei giorni precedenti simili percentuali di
puntualità erano state anche nettamente inferiori, sotto il 90% e in numerose
regioni attorno all’80 per cento. DeJoy è finito in tribunale per la nuova
debacle. Martedì un giudice federale aveva ordinato a ispettori postali di
perquisire 12 centri che servono 15 Stati a caccia dell’esercito di schede
perdute. DeJoy ha ignorato l’ordine con la protezione del Dipartimento della
Giustizia. Il magistrato, Emmett Sullivan, ha risposto definendo «scioccante» il
comportamento e affermando che «qualcuno dovrà pagare» per quanto avvenuto.
Donald Trump e i brogli, la ricostruzione: il buco negli
scrutini nella notte delle elezioni, poi il primo discorso di Biden.
Paola Tommasi Libero Quotidiano l'8 novembre 2020. «A pensar male
si fa peccato ma spesso ci si indovina», diceva uno che di misteri se ne
intendeva. Ed è così che le elezioni presidenziali americane si tingono di
giallo. Fino all'esito dei riconteggi e delle liti giudiziarie non sapremo con
certezza chi sarà il prossimo Presidente USA. A quattro giorni dall'election day
dello scorso 3 novembre, gli Stati chiave della contesa sono Wisconsin,
Michigan, Pennsylvania e Georgia, dove c'è stato un netto vantaggio di Donald
Trump per tutta la notte elettorale ma un brusco cambiamento di rotta nei giorni
successivi, fino ad assegnare probabilmente la vittoria e l'ingresso alla Casa
Bianca al democratico Joe Biden. I dubbi da sciogliere - Il Presidente uscente
parla di brogli e a questo punto c'è un solo modo di superare lo stallo:
ripassare in rassegna uno ad uno tutti i voti e sottoporre la questione alla
Corte Suprema. Se da un lato è vero che abbiamo sempre apprezzato la democrazia
americana per l'immediatezza con cui storicamente ha dato l'esito del voto, è
altresì vero che se qualcuno, nella fattispecie Trump, nutre dei dubbi, è giusto
fugarli tutti con il livello massimo di trasparenza. Poi magari perderà lo
stesso ma quanto meno saremo certi di come è andata la tornata elettorale. Ad
oggi, avendo osservato minuto per minuto lo spoglio, la narrazione di Donald
Trump trova conferma, come in un thriller: fino alle 6.30 di mattina (ora
italiana) del 4 novembre, in tutti gli Stati in bilico era avanti il candidato
repubblicano, con un buon margine. C'è stato poi un "buco" di qualche ora e
subito dopo la situazione si è ribaltata, con un vantaggio dei democratici
alquanto risicato, ma comunque sufficiente ad aggiudicarsi la vittoria: circa
20mila voti su 3,5 milioni in Wisconsin; 145mila su 5,5 milioni in Michigan;
20mila voti su 6,5 milioni in Pennsylvania e addirittura solo 2mila voti su 5
milioni in Georgia. Proprio durante quel "buco" ha fatto il suo primo intervento
pubblico Joe Biden, stranamente arzillo e ringalluzzito come mai si era visto
nella campagna elettorale, durante la quale ha inanellato solo gaffes. Che tanta
euforia fosse legata al presagio di quello che sarebbe successo dopo?
L'artiglieria pesante - Tra le ricostruzioni più accreditate nello staff di
Trump c'è quella che, pensando di vincere, l'apparato del partito democratico è
stato inerte, sebbene vigile, tutta la notte. Quando, però, ha visto le cose
andare male e il proprio candidato perdere terreno, ha in qualche modo sfoderato
"l'artiglieria pesante", con l'apparizione pubblica di Biden considerata una
sorta di segnale a "scatenare l'inferno". Il tema non si era posto nel 2016
perché Hillary Clinton era talmente convinta di vincere con un largo distacco
che il piano B non era stato neanche preparato. Con questi presupposti, e
proprio perché tutti da verificare, la via del riconteggio e quella giudiziaria
restano le uniche che possono riportare chiarezza. Conviene anche a Joe Biden,
per non passare quattro anni da "clandestino" alla Casa Bianca.
Rudolph Giuliani: “Brogli, hanno votato anche i morti. Da
lunedì partono le azioni legali”. Rec News 7 Novembre
2020. “Gli scrutatori sono stati privati del loro diritto di osservare ogni
passaggio delle procedure elettorali. Se non hai nulla da nascondere, permetti i
controlli” a lunedì avvieremo cause legali. Gli scrutatori sono stati privati
del loro diritto di osservare ogni passaggio delle procedure elettorali. C’era
stato molto scetticismo sulle correttezze delle procedure elettorali. In Gorgia
ci sono stati dei brogli dimostrati, e quindi molti voti vanno esclusi dal
conteggio. Molti funzionari democratici che lavorano qui da oltre dieci anni
hanno esperienza comprovata in brogli elettorali. Non c’è stato alcun tipo di
controllo. Ci sono stati voti che potevano venire da chiunque e dovunque. Anche
quando la Corte della Pennsylvania ci ha dato il permesso di vedere, loro hanno
spostato le scatole per impedirci di vedere”. “E’ molto semplice: se non hai
nulla da nascondere, permetti i controlli. Per i voti in assenza è sempre
necessario un controllo ulteriore. Nessun repubblicano ha avuto la possibilità
di guardare quei voti, c’erano voti abbastanza sospetti. A Pittsburg c’era una
situazione molto simile: non c’è stato nessun osservatore repubblicano, nemmeno
uno. Ci hanno tolto il diritto di ispezionare e controllare. Tutto ciò è
illegale, illecito e incostituzionale. John Fraser è morto cinque anni fa ma
continua a votare. Molti sono nella tomba ma hanno potuto continuare a votare.
E’ un’orribile macchina contorta quella dei democratici, caratterizzata da
oltraggi alla vita e dalla criminalità. Una cinquantina di persone affermano
inoltre di aver ascoltato qualcosa di illegale in Georgia, in Michigan e in
Carolina del Nord”. Lo ha detto questo pomeriggio Rudolf Giuliani in una
conferenza stampa all’aperto cui hanno preso parte anche alcuni testimoni che
affermano di aver assistito a procedure illegali durante le operazioni di
spoglio relative alle ultime presidenziali. Iscriviti alla nostra Newsletter!
Email Iscriviti Procedendo accetti la privacy policy 3.5 Article Rating
Elezioni americane, “schede bianche truccate” (i video) Le schede senza
preferenza relative alle ultime elezioni presidenziali degli Stati Uniti
sarebbero state manipolate. E’ quanto mostrano…
Giovanna
Vitale per “la Repubblica” il 9 novembre 2020. Dopo lo storico annuncio della
Cnn, dalle cancellerie di mezzo mondo si è levato un solo grido: «Gli americani
hanno scelto il loro presidente, congratulazioni a Joe Biden e Kamala Harris».
Lo ha twittato, fra i primi, il francese Macron, seguito da Angela Merkel, Pedro
Sanchez, Justin Trudeau e da leader conservatori come il britannico Johnson e l'
austriaco Kurtz. Unica eccezione, il premier italiano Giuseppe Conte. Che,
anziché complimentarsi col nuovo Commander in Chief , s' è innanzitutto
felicitato col «popolo americano e le sue istituzioni per l' eccezionale
affluenza». Dicendosi, ma solo in seconda battuta, pronto «a lavorare con il
presidente eletto Joe Biden per rafforzare le relazioni transatlantiche».
Incipit che non è passato inosservato. Anche per via della batteria di messaggi
che la Commissione Ue e i paesi membri avevano deciso di diramare tutti alla
stessa ora - le 19 di sabato - per salutare insieme l' elezione del candidato
democratico. Sincronia che ha reso ancor più palese la "difformità" della nota
firmata dal nostro capo del governo: rimasto sino all' ultimo « my friend
Giuseppi », come lo aveva definito Trump in un paio di uscite memorabili. Una
stonatura, rispetto al coro internazionale, subito rilevata «con stupore» dal
Pd: «Non ci si può congratulare con il popolo, ci si congratula con chi ha
vinto», la riflessione di un autorevole esponente dem. «Può darsi che Conte sia
stato frenato dal suo rapporto con l' attuale inquilino della Casa Bianca e da
una certa freddezza del M5S. Ma certo, è un errore politico: tutto il mondo ha
tirato un sospiro di sollievo per la vittoria di Biden e spera che lui possa
aprire una pagina nuova, in virtù della sua vocazione multilaterale. Alimentare
dubbi sull' atteggiamento italiano non ci fa bene». Una lettura che, nel corso
della giornata, prende piede anche sui social e finisce per sorprendere Palazzo
Chigi. «Nessuna freddezza, figurarsi », smentiscono, interpellati da Repubblica
, i collaboratori del premier. «Abbiamo scritto il comunicato in fretta, senza
neanche avere il tempo di leggere quelli delle altre cancellerie, mettendo in
evidenza il record di votanti, che è uno straordinario segnale di vitalità
democratica, non certo per sminuire la vittoria di Biden». Una presa di
posizione che Conte, a sera, sente l' esigenza di rimarcare in una nota affidata
all' Ansa. Con la quale stavolta esprime le sue «vive congratulazioni al
presidente eletto Joe Biden e alla vicepresidente Kamala Harris: non vediamo l'
ora di lavorare fianco a fianco sulle grandi sfide dei nostri tempi ».
Praticamente le stesse parole di Macron, seppure con 24 ore di ritardo. Si
aspetta molto dal nuovo corso americano, l' avvocato. E non ne fa mistero.
Intanto più collaborazione in ambito Nato e commerciale, che dovrà passare per
l' abbassamento dei dazi all' Europa. Poi che gli Usa rinuncino a uscire dall'
Oms e rientrino negli Accordi di Parigi sul climate change, tema centrale per l'
Italia anche in vista della presidenza del G20 in programma l' anno prossimo.
Infine, e soprattutto, una maggiore assunzione di responsabilità nel vicino
Medio Oriente. Su questo Conte è netto: «Mi auguro che Biden inverta il trend di
disimpegno di Trump e Obama».
Ripetete
tutti: Biden ha vinto, Trump non accetta la sconfitta!
Barbara Di l'8 novembre 2020. Il mantra è chiaro e non ammette repliche. Biden
ha vinto, Trump non accetta la sconfitta!
Non importa
che non esistano ancora dati ufficiali e che nessuno Stato abbia proclamato un
vincitore. Biden ha vinto, Trump non accetta la sconfitta!
Non conta che
i voti non siano stati ancora tutti contati e che le differenze siano di poche
migliaia di voti, determinanti per cambiare molti risultati. Biden ha vinto,
Trump non accetta la sconfitta!
È irrilevante
che siano state denunciate innumerevoli violazioni nei seggi, da America latina
anni ’70 più che settentrionale. Biden ha vinto, Trump non accetta la sconfitta!
Non importa
che 65 milioni di schede elettorali siano state inviate per posta, senza alcuna
garanzia di attribuzione al legittimo elettore e di espressione della sua
volontà. Biden ha vinto, Trump non accetta la sconfitta!
Non importa
che sia stato accertato che moltissime schede elettorali siano attribuite a
centenari e morti che risultano aver votato. Biden ha vinto, Trump non accetta
la sconfitta!
È irrilevante
che fino allo scrutinio in massa di queste schede apparse dal nulla e senza
controllo Trump fosse in vantaggio nella maggior parte degli Stati indecisi.
Biden ha vinto, Trump non accetta la sconfitta!
Non conta che
la matematica, la logica e le proiezioni di qualsiasi elezione siano state
stravolte verso la fine dello spoglio, attribuendo quasi il 100% dei voti a un
solo candidato e ribaltando i risultati favorevoli a Trump. Biden ha vinto,
Trump non accetta la sconfitta!
Non conta che
i conteggi siano stati misteriosamente bloccati negli Stati chiave indecisi
quando Trump era in netto vantaggio. Biden ha vinto, Trump non accetta la
sconfitta!
È ininfluente
che non si sia mai visto uno spoglio che viene bloccato più volte e che dopo 5
giorni non sia ancora finito. Biden ha vinto, Trump non accetta la sconfitta!
È irrilevante
che questi stop and go siano avvenuti proprio negli Stati governati dai
Democratici che appoggiavano Biden. Biden ha vinto, Trump non accetta la
sconfitta!
Non importa
che ai controllori Repubblicani sia stato impedito di verificare lo spoglio in
numerosi di questi seggi e che, una volta ripartito, siano comparse dal nulla
decine di migliaia di voti tutti a favore di Biden che hanno ribaltato il
risultato. Biden ha vinto, Trump non accetta la sconfitta!
È irrilevante
che si sia scoperto che il software per il conteggio dei voti in alcune contee
abbia attribuito a Biden migliaia di voti a favore di Trump e che sia stato
usato in 28 Stati, quasi tutti attribuiti a Biden. Biden ha vinto, Trump non
accetta la sconfitta!
Non conta che
sia stato chiesto legittimamente il riconteggio dei voti e che ancora non sia
finito, soprattutto in Stati dove la differenza la fanno poche migliaia di voti.
Biden ha vinto, Trump non accetta la sconfitta!
È indifferente
che siano stati presentati numerosi ricorsi ancora tutti da decidere, in ogni
grado di giudizio fino alla Corte Suprema, prima che sia proclamato un vero
vincitore. Biden ha vinto, Trump non accetta la sconfitta!
Non importa
che i media abbiano oscurato qualsiasi voce, inclusa quella del Presidente in
carica, che denunciava tutte queste anomalie. Biden ha vinto, Trump non accetta
la sconfitta!
Non conta che
i media all’unisono abbiano spacciato per mesi sondaggi palesemente sballati che
davano in netto vantaggio Biden. Biden ha vinto, Trump non accetta la sconfitta!
Non è
influente che questi sondaggi siano stati smentiti dai voti reali, ma questa
narrazione sia servita a rafforzare un esito già deciso a prescindere dalle
reali intenzioni degli elettori. Biden ha vinto, Trump non accetta la sconfitta!
È irrilevante
che tutti i media e i social network abbiano dichiarato apertamente di
appoggiare la candidatura di Biden. Biden ha vinto, Trump non accetta la
sconfitta!
Non conta che
durante lo spoglio per giorni tutti i media e i social network abbiano oscurato
ogni dichiarazione di Trump o dei suoi sostenitori sui probabili esiti
favorevoli con la scusa che mancavano i dati ufficiali. Biden ha vinto, Trump
non accetta la sconfitta!
Non conta che
la proclamazione del vincitore non sia stata fatta da nessuna voce ufficiale in
nessuno Stato coinvolto, ma sia stata spacciata per vera dalla CNN. Biden ha
vinto, Trump non accetta la sconfitta!
Non importa
che questa notizia non ufficiale e non verificata sia stata presa per buona da
tutti i media del mondo e dai loro governanti. Biden ha vinto, Trump non accetta
la sconfitta!
Non conta che
la narrazione unica e la ripetizione di questo mantra serva solo a rendere Trump
un usurpatore agli occhi dell’opinione pubblica, anche se i ricorsi e il
riconteggio dei voti gli dovessero assegnare la vittoria legittima. Biden ha
vinto, Trump non accetta la sconfitta!
È irrilevante
che la bugia diventi così verità perché la verità non conta, conta solo chi
controlla l’informazione unica. Biden ha vinto, Trump non accetta la sconfitta!
Non serve il
dubbio, non conta la logica, non è influente la razionalità, non si usa il
congiuntivo, per sua natura dubitativo, ma prevale solo l’indicativo, assertivo,
senza timore di smentite o di replica. Biden ha vinto, Trump non accetta la
sconfitta!
E voi
credeteci!
“Vuolsi così
colà dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare”.
Biden il
fortunato, arriva il vaccino.
Piccole Note
su Il Giornale il 9 novembre 2020. Avevamo scritto in tante note pregresse che
il vaccino sarebbe arrivato dopo le elezioni americane… et voila, oggi la Pfizer
annuncia che il vaccino al quale sta lavorando da tempo è pronto ed efficace nel
90% dei casi accertati, né presenta controindicazioni di sorta. Si tratta del
noto vaccino di Oxford prodotto dalla Astrazeneca. Donald Trump Junior scrive
un tweet infuriato, accusando l’FDA, che doveva certificarne l’efficacia, di
aver ritardato volutamente i tempi, avendo chiesto ulteriori accertamenti.
D’altronde il Ceo dell’azienda farmaceutica era stato chiaro: nessun vaccino
prima delle elezioni (New York Times). Nessun complotto, o almeno nessuna
evidenza che possa essere provata, dato che siamo nel ristretto e indiscutibile
ambito sanitario. Resta che tale tempistica era palese, e ne avevamo dato conto
ampiamente nelle nostre note: d’altronde nessuna azienda farmaceutica avrebbe
sfidato la sorte entrando a gamba tesa in un processo politico così delicato.
Trump non ha potuto annunciare il vaccino, che ora invece può essere annunciato
dal nuovo presidente, benché ancora non proclamato ufficialmente. Biden,
peraltro, col suo staff ha già predisposto un piano per affrontare la pandemia,
mossa che tende anche ad accelerare il processo di allontanamento di Trump dalla
Casa Bianca: ostacolando il passaggio di consegne, tale il messaggio che
presumibilmente sarà veicolato, metterà a repentaglio vite umane…Le alterne
vicende della pandemia e della politica si sono sviluppate in un intreccio
inestricabile, l’annuncio di oggi non è che una banale conferma postuma. Restano
le problematiche legate alla produzione e alla somministrazione, che non son
poche e che rendono impossibile la chiusura della finestra pandemica prima del
consumarsi della seconda ondata (quella invernale). Ma l’azienda ha
legittimamente dichiarato che è un “grande giorno per la scienza e per
l’umanità“, è stata posta una “pietra miliare” nella lotta alla pandemia.
Mancano le fanfare, ma per il resto c’è tutto. Al di là del pregresso, che pure
conta e sul quale stendiamo un velo pietoso (obbligato perché ci son tanti,
troppi morti di mezzo), aspettiamo nuovi sviluppi, che certo non mancheranno.
Da affaritaliani.it il 9 novembre 2020. Il mondo nel quale ci troviamo a vivere
è, per usare un’espressione evangelica, «in se divisum» (Mt 12, 25). Questa
spaccatura, a mio parere, consiste nella realtà e nella finzione: la realtà
oggettiva da una parte, la finzione mediatica dall’altra. Questo vale per la
pandemia, che il filosofo Giorgio Agamben ha analizzato nella raccolta di
interventi A che punto siamo recentemente pubblicata per i tipi di Quodlibet; ma
vale ancora di più per la surreale situazione politica americana, nella quale
l’evidenza di una colossale truffa elettorale viene impunemente censurata dai
media, dando per acquisita la vittoria di Joe Biden. La realtà del Covid
contrasta palesemente con quello che vogliono farci credere i media mainstream,
ma questo non basta per smontare il grottesco castello di falsità al quale la
maggior parte della popolazione si adegua con rassegnazione. La realtà dei
brogli elettorali, delle palesi violazioni dei regolamenti e la falsificazione
sistematica dei risultati contrasta a sua volta con la narrazione dei colossi
dell’informazione, per i quali Joe Biden è il nuovo Presidente degli Stati
Uniti, punto. E così deve essere: non ci sono alternative né alla presunta furia
devastatrice di un’influenza stagionale che ha causato lo stesso numero di
decessi dello scorso anno, né all’ineluttabilità dell’elezione di un candidato
corrotto e asservito al deep state. Tant’è vero che Biden ha già promesso di
ripristinare i lockdown anche in America. La realtà non conta, non è
assolutamente rilevante, nel momento in cui essa si frappone tra il piano
concepito e la sua realizzazione. Il Covid e Biden sono due ologrammi, due
creazioni artificiali, pronte ad essere adattate di volta in volta alle esigenze
contingenti o sostituite rispettivamente con il Covid-21 o con Kamala Harris. Le
accuse di irresponsabilità per gli assembramenti dei sostenitori di Trump
svaniscono se a riunirsi nelle piazze sono i sostenitori di Biden, come già
avvenne per le manifestazioni dei BLM in America e per le celebrazioni
partigiane del 25 Aprile in Italia. Quello che è criminale per alcuni, è
consentito ad altri: senza spiegazioni, senza logica, senza razionalità. Perché
il semplice fatto di essere di sinistra, di votare per Biden, di mettersi la
mascherina è un lasciapassare assoluto, mentre il solo essere di destra, di
votare per Trump o mettere in discussione l’efficacia dei tamponi è un motivo di
condanna e di esecrazione che non necessita di prove né di processo. Si è ipso
facto fascisti, sovranisti, populisti, negazionisti. Lo stigma sociale dinanzi
al quale si dovrebbero ritirare in silenzio quanti ne sono colpiti. Ritorniamo
così a quella divisione tra buoni e cattivi che viene ridicolizzata quando è
usata da una parte – la nostra – e viceversa eretta a postulato incontestabile
quando vi ricorrono i nostri avversari. Lo abbiamo visto con i commenti
sprezzanti alle mie parole sui «figli della Luce» e «i figli delle tenebre»,
come se i miei «toni apocalittici» fossero il frutto di una mente farneticante e
non la semplice constatazione della realtà. Ma nel respingere con sdegno questa
divisione biblica dell’umanità, costoro l’hanno confermata, limitandosi a
rivendicare a sé il diritto di dare patenti di legittimità sociale, politica e
religiosa. Loro sono i buoni anche se teorizzano l’uccisione degli innocenti e
noi dovremmo farcene una ragione. Loro sono i democratici, anche se per vincere
le elezioni devono sempre ricorrere a brogli e frodi anche platealmente
evidenti. Loro sono i difensori della libertà, anche se ce ne privano giorno
dopo giorno. Loro sono obbiettivi e onesti, anche se la loro corruzione e i loro
delitti sono ormai evidenti anche ai ciechi. Il dogma che essi disprezzano e
deridono negli altri è indiscutibile e inoppugnabile quando sono loro a
promulgarlo. Ma come ho avuto modo di dire in precedenza, costoro dimenticano un
piccolo dettaglio, un particolare che non riescono a comprendere: la Verità è in
sé, esiste a prescindere dal fatto che vi sia chi le presta fede, perché
possiede in se stessa, ontologicamente, la propria ragione di validità. La
Verità non può essere negata perché essa è attributo di Dio, è Dio stesso. E
tutto ciò che è vero partecipa di questo primato sulla menzogna. Possiamo quindi
essere teologicamente e filosoficamente certi che questi inganni hanno le ore
contate, perché basterà far luce su di essi per farli crollare. Luce e tenebre,
appunto. Lasciamo allora che si faccia luce sulle imposture di Biden e dei
Democratici, senza indietreggiare di un passo. La frode che essi hanno ordito
contro Trump e contro l’America non potrà rimanere in piedi a lungo, così come
non rimarranno in piedi la frode mondiale del Covid, le responsabilità della
dittatura cinese, le complicità di corrotti e traditori, l’asservimento
della deep church. In questo panorama di menzogne erette a sistema, propagandate
dai media con un’impudenza sconcertante, l’elezione di Joe Biden non è solo
desiderata, ma considerata ineluttabile e quindi vera e quindi definitiva. Anche
se i conteggi non sono conclusi; anche se i controlli sui voti e le denunce sui
brogli sono appena all’inizio; anche se le denunce sono appena state depositate.
Biden deve essere Presidente, perché così è stato deciso da loro: il voto degli
Americani è valido solo se ratifica questa narrazione, altrimenti si muta in
deriva plebiscitaria, populismo, fascismo. Non stupisce quindi né l’entusiasmo,
sguaiato e violento, con cui i Democratici esultano per il proprio candidato in
pectore, né l’incontenibile soddisfazione dei media e dei commentatori
ufficiali, né l’attestazione di complice e cortigiana sudditanza al deep
state da parte dei leader politici di mezzo mondo. Assistiamo a una gara a chi
arriva prima, sgomitando scompostamente per mettersi in mostra, per far vedere
di aver sempre creduto nella vittoria schiacciante del fantoccio democratico. Ma
se la cortigianeria di capi di Stato e segretari di partito fa parte del trito
copione della Sinistra mondiale, lasciano francamente sconcertati le
dichiarazioni della Conferenza Episcopale Americana, immediatamente rilanciate
da VaticanNews, che con inquietante strabismo si ascrive il merito di aver
sostenuto «il secondo Presidente cattolico della storia degli Stati Uniti»,
dimenticando il non trascurabile dettaglio che Biden è un accanito abortista, un
sostenitore dell’ideologia LGBT e del globalismo anticattolico. L’Arcivescovo di
Los Angeles José H. Gomez, profanando la memoria dei martiri Cristeros del suo
paese natale, sentenzia lapidario: «The American people have spoken», il popolo
americano ha parlato. Poco importano i brogli denunciati e ampiamente provati:
la fastidiosa formalità del voto popolare, ancorché adulterata in mille modi, va
considerata conclusa a favore del portabandiera del pensiero unico. Abbiamo
letto, non senza conati di vomito, i post di James Martin s.j. e di tutta quella
schiera di cortigiani che scalpitano per salire sul carro di Biden per
condividerne l’effimero trionfo. Chi dissente, chi chiede chiarezza, chi ricorre
alla legge per vedere tutelati i propri diritti non ha alcuna legittimazione e
deve tacere, rassegnarsi, scomparire. Anzi: deve unirsi al coro d’esultanza,
applaudire, sorridere. Chi non accetta, attenta alla democrazia e va
ostracizzato. Ancora due schieramenti, come si vede, ma questa volta legittimi e
indiscutibili, perché sono loro a imporli. È indicativo che la Conferenza
Episcopale Americana e Planned Parenthood esprimano la propria soddisfazione per
la presunta vittoria elettorale della stessa persona. Questa unanimità di
consensi ricorda l’appoggio entusiastico delle Logge massoniche in occasione
dell’elezione di Jorge Mario Bergoglio, anch’essa significativamente non scevra
dall’ombra di brogli in seno al Conclave e parimenti voluta dal deep state, come
ben sappiamo dalle mail di John Podesta e dai legami di McCarrick e dei suoi
colleghi con i Dem e con lo stesso Biden. Una bella compagnia, non c’è che dire.
Con queste parole è confermato e suggellato il pactum sceleris tra deep
state e deep church, l’asservimento dei vertici della Gerarchia cattolica al
Nuovo Ordine Mondiale, rinnegando l’insegnamento di Cristo e la dottrina della
Chiesa. Prenderne atto è il primo, impreteribile passo per comprendere la
complessità degli avvenimenti presenti e per considerarli in un’ottica
soprannaturale, escatologica. Noi sappiamo, anzi crediamo fermamente che Cristo,
unica vera Luce del mondo, ha già vinto le tenebre che lo oscurano.
The New
President.
Alessandro Bertirotti il 9 novembre su Il Giornale. È tutta questione
di… realtà. Stiamo a vedere, se avremo la possibilità di sopravvivere a zio
Covid-19, cosa in effetti cambierà, in meglio e in peggio, perché una delle due
possibilità porta con sé l’altra, inevitabilmente. Tutto il mondo si attende un
cambiamento, rispetto al sorpassato Presidente, perché Joe Biden promette bene,
sereno e pacato, almeno a livello di immagine e di stile. Mi direte che non
sarebbe stato difficile dare l’impressione di essere meglio dei tweet di Trump,
e che anche il minimo innalzamento del just noticeable level of
perception avrebbe avuto il suo effetto e ci avrebbe indotto ad un liberatorio
sospiro di sollievo. E così è stato. Eppure, gli Stati Uniti che hanno la
pretesa storica di insegnare al mondo intero cosa è una democrazia matura ho
l’impressione stiano, invece, dimostrando che la maturità forse è ascrivibile a
qualsiasi altro popolo fuorché a loro. E non voglio solo riferirmi ai brogli
presunti, che condurranno comunque il nuovo Presidente verso l’esercizio del
proprio mandato in ambiguità per molto tempo, ma all’immagine che gli
statunitensi forniscono di loro stessi al mondo intero. Veleni, discussioni di
bassissimo livello, scandali sessuali costruiti oppure rinvangati ad hoc,
interessi economici e la solita espressione circense dei programmi elettorali,
etc.. Insomma, non basterà l’eventuale presenza di una donna, la prima, come
Vice Presidente degli Stati Uniti, a farci credere che saremo di fronte ad una
reale novità. In un Paese dilaniato anch’esso dal ben noto zio Covid-19, con
un’assistenza sanitaria capestro, i sindacati che mangiano soldi
dei contribuenti pur di non mandare le persone a lavorare, la burocrazia delle
grandi città governate dai Democratici, gli insegnanti che continuano a
pretendere azioni governative per ottenere un’ulteriore protezione, come non ne
avessero già abbastanza. Per non parlare del livello di povertà urbana in
California, specialmente a San Francisco e lo spaccio diffuso ovunque di droghe
di tutti i tipi. Insomma, non sono certo da prendere come esempio. Ma, ne
abbiamo, a proposito, in questo mondo nazioni da prendere come esempio? Mah…
non saprei.
USA,
FALSIFICAZIONI E MORTI CHE VOTANO: ECCO PERCHÈ TRUMP È ANCORA IN GIOCO.
Monica Camozzi per affaritaliani.it il 9 novembre 2020. L’ex campione dei pesi
massimi Joe Frazier ha votato alle elezioni del 2018. Ma è morto l’11/7/2011. Il
nonno di Will Smith ha votato nel 2018, peccato che sia morto nel 2016. Come
loro, i 14.000 votanti defunti trovati nella contea di Whayne in Michigan?
Quello che si apre ora, in America, è un vero e proprio Election gate. Che tutto
finisca in mano alla Corte Suprema, ormai è certezza. In questo momento sono più
di 19.000, dalla GOP room, i ricorsi per i cosiddetti brogli elettorali nella
disfida fra Donald Trump e Joseph Biden. “Le elezioni americane sono ben lungi
dell’essere finite” ha dichiarato l’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani, uno
dei super legali che Donald Trump ha schierato insieme a Jay Sekulow, o l’ex
procuratore generale della Florida Pam Bondi, Sidney Powell, avvocato dell’ex
consigliere per la sicurezza nazionale Michael T.Flynn. Ma al centro
dell’inchiesta per il cosiddetto Election Gate non c’è solo Joseph Biden. Ci
sono i media americani mainstream e l’indagine parte da Capitol Hill. Per le
strade si sono viste file di americani in macchina, come quelli che hanno
creato una coda di 60 km in Nevada, per andare a manifestare a Phoenix. In
ballo, da qualsiasi parte si “penda”, c’è il senso della parola democrazia. E
quando c’è in ballo la democrazia l’America si compatta. Questa volta lo ha
fatto in cinque giorni. “La modalità fraudolenta di alterare i voti è stata
sistemica, ovvero è avvenuta in dieci stati -ha dichiarato Giuliani ai microfoni
di Maria Bartiromo di Fox News, dicendo che “le elezioni sono ben lungi
dall’essere finite”. Ma quel che avvince, è la mobilitazione popolare per
l’adesione compatta dei media alla causa Dem e per la modalità con cui le
notizie sono state date. Abbiamo chiesto un commento a Flavio Robert
Paltrinieri, membro del partito Repubblicano della Florida e leader di Noi di
Centro.
Lo strano caso
dei morti che votano e del fatal error dei software. Alcune notizie, come quella
dei 14.000 defunti che avrebbero votato in Michigan, nella Contea di Whayne,
hanno fatto il giro del pianeta. “Ma ci sono anche i “fatal error” dei software
che ogni 1.000 voti attribuiti a Trump, ne levavano 300, beccato da un acuto
observer (il funzionario che ai seggi controlla le regolarità delle procedure).
O i 10.000 voti duplicati in Oklahoma”. Pare che agli osservatori dei seggi
repubblicani sia stato impedito di ispezionare i voti per posta. “La Virginia è
stata assegnata a Biden con lo spoglio al 20% e durante l’apertura dei seggi,
questo ha ovviamente condizionato gli elettori che ancora non si erano espressi.
Hanno usato la Fox come agente provocatore ma l’America non è l’Italia, la gente
te la trovi all’uscio. È stata aperta un’inchiesta contro il cartello di tv e
giornali che vede protagonisti Cnn, Abc, perché si capiva che la strategia per
vincere partiva da una compagine di media che per un anno ha montato l’Onda
blu”.
(ANSA il 9
novembre 2020. ) - Sparito da quando è stata ufficializzata l'elezione di Joe
Biden a presidente degli Stati Uniti, Donald Trump sta postando su Twitter brevi
video di Foxnews nei quali giornalisti della rete o rappresentanti repubblicani
contestano l'esito del voto. Sotto a tutte le sei clip postate nell'ultima ora
Twitter ha inserito l'avviso: "Questa dichiarazione su una frode elettorale è
contestata", che negli ultimi giorni è comparsa quasi sotto ogni post dell'ex
presidente. Donald Trump sta pianificando una serie di nuovi comizi in stile
campagna elettorale per rilanciare le accuse di brogli e rivelare alcune delle
prove che ha intenzione di usare nella battaglia legale. Tra queste, i necrologi
di americani deceduti e che risultano aver votato. Non sono ancora state
annunciati luoghi e date degli eventuali comizi, ma secondo il New York Post gli
sforzi si starebbero concentrando sugli Stati in bilico, fondamentali per un
eventuale ribaltamento del risultato: Georgia, Arizona e Pennsylvania. La Cnn
sostiene che dietro l'offensiva in stile campagna elettorale ci sarebbero il
genero di Trump, Jared Kushner, l'avvocato personale Rudy Giuliani e il
consigliere Jason Miller. Nessuno dei tre per ora ha confermato. L'emittente di
Atlanta tra l'altro ieri sosteneva che Kushner era tra coloro che stavano
spingendo il presidente a concedere la vittoria a Biden.
Dagospia l'11
novembre 2020. CORREZIONE: REAL CLEAR POLITICS NON HA TOLTO LA PENNSYLVANIA A
BIDEN, NON GLIEL'AVEVA MAI ASSEGNATA! IERI ABBIAMO RIPRESO IL TWEET DI RUDY
GIULIANI CHE ANNUNCIAVA (L'INESISTENTE) CAMBIAMENTO SUL SITO BIPARTISAN CHE
RACCOGLIE DATI POLITICI. CHE INVECE NON HA MAI DATO PIÙ DI 259 GRANDI ELETTORI
AL DEMOCRATICO. IL CHE RESTA UNA NOTIZIA: AL MOMENTO BIDEN È PRESIDENTE-ELETTO
(CON SITO, SIMBOLO E CARTA INTESTATA) SOLO IN BASE ALL'ASSEGNAZIONE DELLA CNN E
POI DEGLI ALTRI NETWORK
Rudy W.
Giuliani: #FakeNews won’t cover law suit which will invalidate 300,000 or more
crooked democrat votes votes in Philly. Real Clear Politics just took PA away
from Biden and made it a toss up. Only the beginning please look beyond the Big
Media censorship to watch it all change. This claim about election fraud is
disputed 1:51 AM · Nov 10, 2020 from Washington, DC
(ANSA il 10
novembre 2020) - "Vinceremo": lo twitta Donald Trump, parlando di "grandi
progressi" sul fronte del conteggio dei voti. "I risultati cominceranno ad
arrivare la prossima settimana", afferma. Donald Trump non ha ancora concesso la
vittoria a Joe Biden, ma guarda avanti. Il presidente, riporta il New York
Times, sta indirizzando i fondi raccolti durante la sua campagna elettorale al
nuovo political action committee "Save America", un fondo che potrebbe essere
usato per finanziare le sue future attività politiche al di là del riconteggio
dei voti delle elezioni. Joe Biden non esclude di intraprendere azioni legali
contro l'amministrazione Trump accusandola di ostacolare in maniera illegale
l'avvio del processo di transizione. Lo riportano alcuni media Usa citando fonti
del transition team nel presidente eletto che parlano di "diverse opzioni" sul
tavolo.
Alberto
Flores d’Arcais per "notizie.tiscali.it" il 10 novembre 2020. Arriva il vaccino
ed è subito scontro politico. Dopo una giornata in cui è stato relativamente
silenzioso, alle dieci di sera Donald Trump inizia a lanciare messaggi via
Twitter. Quattro post, uno in fila all’altro con pesanti accuse nei confronti
della casa farmaceutica Pfizer e della Fda (Federal Drug Administration),
l’agenzia federale che deve dare il via libera al vaccino anti-Covid: “Come dico
da molto tempo, Pfizer e gli altri hanno finito per annunciare il vaccino solo
dopo le elezioni, perché prima non avevano il coraggio di farlo!”; “Allo stesso
modo, la Fda avrebbe dovuto annunciarlo prima, non per scopi politici, ma per
salvare vite umane!”; “La Fda e i Democratici non volevano che ottenessi il
vaccino della vittoria prima delle elezioni, così è uscito cinque giorni dopo”;
“Se Joe Biden fosse stato presidente, non avreste avuto un vaccino per altri
quattro anni! La burocrazia avrebbe distrutto milioni di vite”.
(ANSA l'11
novembre 2020) "Ci sarà una transizione calma verso una seconda amministrazione
Trump". Lo ha detto il segretario di stato Mike Pompeo, definendo "appropriate"
le azioni legali di Donald Trump sui risultati elettorali.
Giuseppe
Sarcina per il “Corriere della Sera” l'11 novembre 2020. L' escalation non si
ferma. Donald Trump spinge anche il Dipartimento di Giustizia a intervenire
nella guerriglia giudiziaria scatenata per contestare il risultato delle
elezioni presidenziali. Lunedì 9 novembre, l' Attorney General William Barr ha
inviato un memorandum ai procuratori generali federali, ai responsabili di
diverse divisioni del ministero e al direttore dell' Fbi, Christopher Wray.
Oggetto: «Indagini sulle irregolarità post-elettorali». La direttiva di Barr
segna un' altra frattura negli equilibri istituzionali. Il Dipartimento di Stato
dovrebbe essere il garante indipendente della legalità nel Paese. Barr, invece,
chiede ai procuratori federali e perfino all' Fbi di inserirsi in un contenzioso
al momento frammentato nei singoli Stati, se non in alcuni collegi specifici. La
lettera del ministro ha provocato le dimissioni immediate di Richard Pilger,
direttore della sezione che supervisiona le inchieste sulle frodi elettorali. La
manovra parte dalla Casa Bianca e passa per il Congresso. Lunedì pomeriggio Barr
ha incontrato Mitch McConnell, leader dei senatori repubblicani. Il risultato è
un testo acrobatico che prova ad assecondare le pressioni di Trump e, nello
stesso tempo, a salvare la credibilità del Dipartimento e dell' intero sistema
legale. Nella prima parte Barr si dilunga in un' analisi della normativa,
ricavando uno spazio di azione anche per l' Attorney General, «una volta
concluso il processo elettorale». Nel concreto: gli uffici federali e gli agenti
del Federal bureau «sono autorizzati a verificare le accuse sostanziali di
irregolarità nel voto e nella registrazione dei risultati». Parole generiche
che, in teoria, potrebbero innescare verifiche a tappeto, con la conseguente
paralisi delle procedure finali di certificazione delle schede. Ma nella seconda
parte Barr frena, e qui probabilmente si avverte l' influenza di McConnell:
«Queste indagini e revisioni dovranno essere condotte solo nei casi di accuse
chiare e apparentemente credibili che, se dovessero rivelarsi fondate, avrebbero
un impatto potenziale sul risultato finale... È assolutamente imperativo che i
funzionari del Dipartimento esercitino un' appropriata cautela e mantengano l'
impegno per la correttezza, la neutralità e la non faziosità... Le accuse
speciose, le congetture, le rivendicazioni bizzarre o implausibili non potranno
costituire la base per avviare le nostre indagini». I democratici hanno reagito
con durezza. Ma vedremo quale sarà il suo effetto pratico, visto che al momento
il team legale di Trump, con Rudy Giuliani in prima fila, non ha prodotto le
prove di frodi sistematiche e capillari. Barr, 70 anni, ancora una volta ha
forzato il suo ruolo, pur di far da sponda alle rivendicazioni di Trump. Non è
il solo. Ieri il Segretario di Stato, Mike Pompeo, ha dichiarato: «Ci sarà una
transizione senza problemi verso una seconda amministrazione Trump».
Massimo Gaggi
per il “Corriere della Sera” l'11 novembre 2020. Quattro giorni fa Kathryn - la
moglie di James Murdoch, il figlio di Rupert che, dopo aver guidato il gruppo
insieme al padre per poi restare solo come direttore, a luglio si è, infine,
dimesso da tutte le cariche in dissenso con la sua linea politica - ha fatto
notizia con un tweet nel quale condivideva gli inviti alla Fox a riferire del
risultato del voto in modo obiettivo senza sposare le generiche accuse di frode
formulate da Trump. Meno notato, un suo messaggio diffuso nell' Election Day:
«Come racconterete, un giorno, ai vostri figli la parte che avete avuto in
questa storia?». Nella saga dei Murdoch, la famiglia alla quale è ispirato il
serial televisivo Succession , James è ormai fuori, sostituito dal fratello, il
primogenito Lachlan, rientrato nel gruppo dopo una lunga parentesi. Come il
padre, Lachlan pensa alle news in termini di business: più sensibile all'
occupazione degli spazi di mercato che al profilo etico dell' informazione.
Dietro le quinte il patriarca, l' 89enne Rupert, un vecchio conservatore,
continua ad appoggiare Trump ma fiuta il vento. Queste articolazioni nella
proprietà familiare e l' obiettiva situazione di stress informativo prodotto
dalle enormi pressioni di Trump che nega la vittoria elettorale di Biden, hanno
creato una profonda frattura nella macchina informativa della Fox, vero motore
del cambiamento dell' anima conservatrice dell' America nell' era di The Donald:
una macchina che, al di là delle apparenze, monolitica non è mai stata. Da
giorni si è allargata la distanza tra due fronti: da un lato molti giornalisti e
conduttori delle news quotidiane, da Chris Wallace a Bret Baier, da Sandra Smith
a Neil Cavuto, che non criminalizzano Biden, incalzano i personaggi di destra
che parlano di elezioni truccate chiedendo loro prove circostanziate e
trasmettono interviste a magistrati repubblicani come Andrew McCarthy secondo i
quali «anche se fosse provata qualche frode, è dura rimettere in discussione
elezioni perse per decine di migliaia di voti». Dall' altro i fedelissimi del
presidente, radunati attorno ai tre conduttori politici del prime time serale -
Carlson Tucker, Sean Hannity e Laura Ingraham - che hanno, invece, continuato a
sostenere la linea Trump, anche se Ingraham ha detto che i repubblicani non
hanno nulla da rimproverarsi, avendo combattuto battaglie giuste: un' ammissione
che le presidenziali sono perse (con tanto di invito a Trump a farsi da parte,
pur continuando la sua battaglia politica), mentre gli altri due sostengono che
combattere a oltranza per far restare il presidente alla Casa Bianca è un
dovere. L' altra sera il caso più clamoroso: il conduttore pomeridiano Neil
Cavuto ha interrotto un collegamento diretto con la sala stampa della Casa
Bianca mentre la portavoce di Trump, Kayleigh McEnany, stava accusando i
democratici di aver rubato le elezioni: «Sta dicendo cose esplosive, accusa gli
avversari di brogli. A meno che non abbia elementi concreti per sostenere una
simile tesi, non possono continuare a trasmettere questa roba». Un comportamento
simile a quello precedentemente rimproverato dalla stessa Fox a Twitter e
Facebook quando le reti sociali hanno cominciato a segnalare, o addirittura
cancellare, i post di Trump contenenti accuse palesemente false. Tre ore dopo la
replica è arrivata da un' altra star della rete: Carlson Tucker ha stigmatizzato
il comportamento del collega perché «in democrazia non puoi ignorare le domande
oneste dei cittadini: non puoi tagliare quello che non ti piace. Qui la gente
non crede più alle elezioni e questo mette la democrazia in pericolo». Vero,
solo che Cavuto non ha bloccato «domande della gente» ma affermazioni infondate
della Casa Bianca. Se non verranno supportate da fatti, sono queste affermazioni
(infondate fino a prova contraria e amplificate proprio da Carlson) a demolire
la fiducia nella democrazia. E Rupert? Quando Trump si è infuriato perché la Fox
ha assegnato prematuramente l' Arizona a Biden, ha difeso la rete. Ora tace: sa
che sono proprio i controversi Carlson e Hannity a trascinare i suoi ascolti.
Testo di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi il 12 novembre 2020. Il
problema non è se ci sia stata frode elettorale nell’elezione presidenziale,
perché in America è una piccola tradizione nella grandi città controllate dai
Democratici da un secolo, ma se ci sia stata in una misura molto superiore alla
norma. Facciamo un esempio concreto con alcuni dati elettorali. Qui si vede che
in questo distretto Biden ha vinto di circa 8,200 voti, 275 mila contro 267
mila di Trump, anche se il candidato democratico Rashid ha avuto 182 mila voti e
quello repubblicano 257. Ben 93 mila votanti non hanno votato per i democratici,
ma hanno votato per Biden? Oltre 75 mila repubblicani hanno preferito Biden? Se
si guarda a livello nazionale lo stesso fenomeno si è ripetuto in diversi Stati
chiave nei distretti a maggioranza repubblicana (ma non quelli a maggioranza
democratica!) per un totale di quasi mezzo milioni di voti “disgiunti” per
Biden. Questo non era mai successo, o meglio anche in USA ci sono voti
disgiunti, ma questa volta sono stati il triplo del normale. Si può obiettare
che molti che votavano repubblicano non volevano Trump, anche se all’elezione
precedente il fenomeno non si è manifestato. Ma qui c’è il secondo problema
statistico. Questo massiccio spostamento di voti disgiunti è avvenuto solo nei
distretti dove i repubblicani sono in maggioranza. In quelli dove sono in
minoranza, anche nello stesso Stato, hanno votato compatti per Trump. È come se
magicamente ovunque ci fosse una maggioranza nel distretto per i repubblicani,
decine di migliaia di loro in questa elezione votassero Biden. Ma a poche miglia
di distanza, in distretti elettorali a maggioranza democratica, tutti i votanti
per il partito repubblicano hanno votato compatti anche il loro candidato alla
presidenza, Trump. Come mai? Le macchine per le votazioni che sono impiegate in
USA hanno un software che può essere hackerato per produrre un risultato così
sistematico e si possono fare diverse ipotesi. Ad esempio per chi volesse
spostare i voti che il software tabulava era più credibile farlo nei distretti
dove c’erano più voti repubblicani. Non si possono spostare milioni di voti che
è troppo macroscopico, ne devi spostare alcune centinaia di migliaia, ma il
problema è che usi il software non puoi modulare seggio per seggio, devi
inserire alcune righe di codice in fretta quando vedi arrivare i risultati
nazionali e capisci che devi avere un certo numero di voti in più in alcuni
Stati. Quindi può essere che inserisci una modifica che sposta una certa
percentuale di voti presidenziali in base ad un criterio e scegli quello dei
distretti dove votano meno repubblicani così è forse meno evidente all’esterno.
Giustamente voi direte che questa anomalia - di una massa di votanti
repubblicani che solo in questa elezione e nessun’ altra elezione precedente, e
solo nei distretti in cui sono in maggioranza, vota per il candidato Democratico
- può anche essere spiegata con gli umori dell’elettorato. Forse centinaia di
migliaia di votanti repubblicani in questi distretti non lo sopportavano Trump
al punto di andare a votare per Biden. È difficile spiegare perché sia capitato
solo in Stati controllati dai Democratici e in questi Stati solo nei distretti
“rossi” (repubblicani), ad esempio in Florida per niente. Ma tutto è possibile
al mondo, no? Bene, lasciamo aperto il dubbio e parliamo invece di qualcosa che
è storicamente certo. Una tradizione tipica americana, che in Europa e altri
paesi industriali non è molto nota, è la frode elettorale. Gli Stati Uniti per
motivi storici che sarebbe interessare approfondire, hanno una ricca storia di
frodi elettorali sia tramite la manipolazione dei voti postali che con altri
sistemi, a partire da quella ormai in tutti i libri di storia con cui la
famiglia Kennedy spostò centinaia di migliaia di voti rubando l’elezione a
Nixon. Qui ad esempio “Newsweek” di qualche tempo fa, “Le Top Cinque Elezioni
Presidenziali Truccate” (“The Top Five Rigged U.S. Presidential Elections”)
scrive che per eleggere Kennedy “si girava persino per un cimitero per
registrare tutti i nomi sulle tombe e registrarli e farli votare. C’era una casa
ora abbandonata, con nessuno che abitava e vi registrarono 56 votanti per
Kennedy”. Il “New York Times” che all’epoca era meno allineato, condusse una
inchiesta a Chicago sulla massiccia frode elettorale ai danni di Nixon e preparò
un reportage di 12 puntate. Nixon però quando vide che stava uscendo li chiamò e
chiese che la interrompessero perché ci sarebbe stata una crisi istituzionale.
Lo stesso il procuratore dell’Illinois, Morris Wexler incriminò 677 operatori
del Partito Democratico (ma il giudice assegnato gli bloccò l’inchiesta). Oggi
quasi tutti quelli che scrivono dell’elezione di Kennedy, ( Seymour Hersh,
premio Pulitzer, tra i tanti) ammettono che il vincitore sarebbe stato Nixon
senza i brogli, ma Nixon voleva tornare ad essere candidato e non volle
rischiare la crisi istituzionale. Il voto postale in particolare è una
particolarità americana (fatto salvi i casi particolari di chi vive all’estero o
è impossibilitato e muoversi) perché è consentito in larga scala solo negli USA
tra tutte le democrazie moderne. Come è facile immaginare e come conferma la
cronaca, far votare milioni di persone per posta consente frodi massicce perché
è difficile verificare le identità di milioni di persone in base alle loro firme
in pochi giorni. In Europa l’unico paese che lo consente in una certa misura è
il Regno Unito dove nei quartieri musulmani di Birmingham c’è stato ad esempio
nel 2005 uno scandalo di migliaia di voti irregolari e alla fine l’elezione è
stata annullata. Se ne è parlato il meno possibile perché tutti i deputati
laburisti implicati erano pakistani. È una cosa del passato? Non sembra leggendo
un poco su internet, vedi qui sempre a Birmingham. In Francia il voto postale
era consentito fino al 1975 quando si verificò un grosso scandalo di voti
comprati e falsificati in Corsica e dopo è stato vietato. Venendo a casi
recenti, a Chicago nel 1982 furono incriminati e condannati 60 funzionari e
operatori Democratici per aver falsificato oltre 100mila voti, secondo le stime
del giudice che li condannò tutti al carcere. Arrivando all’elezione di Biden e
Trump cosa è successo di più sospetto del solito, nel senso che si dà per
scontato in USA una certa dose fisiologica di frodi elettorali nelle grandi
città controllate dai Democratici? Diverse cose. Il conteggio dei voti è stato
fermato in quattro Stati chiave nel mezzo della notte per diverse ore. Dal
momento in cui ha ripreso sono arrivati valanghe di decine di migliaia di voti
al 90% per Biden e i quattro Stati sono passati dal vantaggio per Trump e quello
per Biden. Ci sono testimoni con affidavit giurati sull’arrivo di camion alle 4
del mattino che scaricavano pacchi. Ma ritorniamo all’esempio concreto citato su
cui ci sono dati obiettivi, cioè circa mezzo milione di voti “disgiunti” tutti a
favore di Biden, mentre nell’ultima elezione il fenomeno era stato di circa
150mila, un terzo. Questo è avvenuto quasi tutto in Stati e Contee in cui si
utilizzano macchine per le votazioni e poi le immagini del tuo voto dovrebbero
essere conservate in formato digitale per controlli per altri 30 giorni, ma
risulta che siano stati distrutti. Per cui usando quelle macchine, è difficile
tornare indietro e contare voti che sono stati immessi. Alcune università anni
fa hanno dimostrato che il software usato è hackerabile e c’è un ampio
discussione sui rischi di questo software. In conclusione, data la secolare
tradizione di frode elettorale del Partito Democratico nelle grandi città che
controlla da praticamente un secolo, e date le anomalie statistiche nella
distribuzione ad esempio di centinaia di migliaia di voti disgiunti, è possibile
che le cause che Trump sta intentando in cinque o sei Stati possano arrivare in
tribunale. In altre parole che dei giudici possano chiedere riconteggi o
invalidare. Oppure che alla fine, se le votazioni in questione sono rilevanti,
si rimandi il tutto alla Corte Suprema. Insomma, come diceva Yogi Berra, “it
‘aint over until is over”, “non è finita fino a quando non è finita”.
L'annuncio su Twitter: "Ci sono state vaste irregolarità e
frodi, inclusi elettori deceduti che hanno votato". La
Repubblica 18 Novembre 2020. Donald Trump ha licenziato Christopher C. Krebs, il
direttore dall'Agenzia per la sicurezza informatica e delle infrastrutture
(Cisa), che la scorsa settimana aveva definito le elezioni del 3 novembre le
"più sicure nella storia americana". E' stato lo stesso Trump ad annunciare
tramite il proprio profilo Twitter il licenziamento del direttore dell'agenzia
alle dipendenze del dipartimento di Sicurezza interna. Nel suo tweet, Trump ha
definito le dichiarazioni di Krebs "profondamente inesatte": una scelta di
parole che suona come una critica anche a Twitter, che ha etichettato come "non
comprovati" o "controversi" molti dei messaggi pubblicati dal presidente sulla
piattaforma prima e dopo le elezioni. "Ci sono state vaste irregolarità e frodi,
inclusi elettori deceduti che hanno votato, osservatori non ammessi ai seggi, ed
'errori di sistemà nelle macchine per il voto, che hanno trasferito voti per
Trump (al candidato democratico) Biden, e molto altro. Per tale ragione, Chris
Krebs è stato licenziato con effetto immediato", ha scritto il presidente
uscente degli Stati Uniti. "Onorato di servire" il Paese, "abbiamo fatto bene,
difendere oggi, assicurare domani", è stata la replica, sempre su Twitter, di
Chris Krebs che ha aggiunto l'hashtag #Protect2020.
Usa, tutti i sospetti di Donald Trump portano al software
elettorale degli amici dei Clinton. Niccolò Silvestri
martedì 17 Novembre 2020 su Il Secolo D'Italia. Mettiamola così: o Donald
Trump è un pazzo che si ostina a tenere sotto scacco la più grande potenza
mondiale oppure c’è del vero in quel che dice. Nel qual caso, bisogna smetterla
con gli anatemi e andare a vedere. Che il presidente Usa (è tale almeno fino al
20 gennaio) sia inviso all’informazione americana e mondiale non è un mistero.
Che questo sia sufficiente a negargli il diritto di ricorrere contro
eventuali brogli, è roba degna della Corea di Ciccio Kim e non certo della
patria di Abramo Lincoln o di Franklin D. Roseevelt. Tanto più che a guidare
Trump in questa battaglia è un legale del calibro di Rudy Giuliani, l’inventore
– da sindaco di New York – della formula “tolleranza zero“. Uno, cioè, che non
mette a repentaglio la propria reputazione in cambio di un onorario, per quanto
lauto possa essere.
Rudy Giuliani: «Abbiamo le prove». Nel mirino
dell’italo-americano è finita la Dominion Voting Systems. È un’azienda canadese
produttrice di software utilizzati per il conteggio elettorale. Li hanno
adottati ben 28 Stati, tra i quali alcuni decisivi per l’esito delle elezioni.
Secondo Giuliani e Trump, il software avrebbe cancellato o dirottato 2,7 milioni
di voti a favore di Joe Biden. Bugie? Si vedrà. Giuliani sostiene di avere
le prove ma di non poterle ancora mostrare.
Nella canadese Dominion i nemici di Trump. La società ha
ovviamente respinto al mittente le accuse e ha negato di avere tra i suoi
proprietari il marito della leader democratica Nancy Pelosi, Paul. Ma non ha
potuto smentire di aver scucito soldi in favore della Fondazione Clinton nel
2014 né di avere assunto come lobbista l’ex-capo di gabinetto della stessa
Pelosi, Nadeam Elshami. E non è tutto. Ancora Giuliani ha infatti evidenziato
che Dominion avrebbe «legami molto stretti» con Venezuela e Cina. Inoltre,
userebbe un’azienda di software venezuelana «già utilizzata per truccare le
elezioni in altri Paesi». Giuliani si riferisce a Smartmatic, compagnia fondata
in Venezuela nel 2000 sotto la presidenza del leader socialista Hugo Chavez.
Dominion sarebbe di sua proprietà. Ma il gruppo ha negato. Nel frattempo, la
società canadese ha incassato la certificazione del Cisa (Cybersecurity and
Infrastructure Security Agency), un’agenzia del Dipartimento della sicurezza
nazionale. «Le elezioni del 3 novembre – ha sentenziato – sono state le più
sicure nella storia degli Stati Uniti».
Trump non considera chiusa la partita. Più chiaro di così.
Invece, no. Perché si è scoperto che Dominion fa parte del Consiglio di
coordinamento del settore infrastrutture per le elezioni, che ha firmato
il rapporto pubblicato dalla Cisa. Un autocertificato, insomma, più che una
certificazione. Tanto più se si considera che nello stesso board c’è
anche Smartmatic presieduta da Mark Malloch Brown, lord di Sua Maestà
britannica. Ma costui è stato anche collaboratore di George Soros. Proprio il
miliardario che all’indomani della vittoria di Trump riunì politici
e Paperoni in un albergo di Washington con l’obiettivo di impedire al Tycoon di
governare. Chissà se in Italia i sedicenti mastini del giornalismo d’inchiesta
decideranno di trarne ispirazione per uno dei loro micidiali reportage.
Già in agosto l’allarme degli esperti sul sistema di scrutinio.
Non è la prima volta che i software di Dominion finiscono nell’occhio del
ciclone. Era già accaduto il 9 giugno, nel corso delle primarie in Georgia, uno
degli Stati oggetto dei ricorsi di Trump. La Georgia li acquistò nel 2019 per
106 milioni di dollari, nonostante più d’un esperto ne avesse evidenziato
criticità legate alla sicurezza dello scrutinio. Come, ad esempio,
l’informatico Harri Hursti che l’allarme lo aveva già lanciato il 24 agosto
scorso. A suo giudizio, «la configurazione del software» rischiava «di escludere
dallo scrutinio intenzionalmente alcuni voti». Era già capitato nella contea
di Fulton. Lì, spiegò Hursti, «il sistema ha operato in un modo che aumenta
i rischi sulla sicurezza a un livello estremo». E ancora: «I Dispositivi di
contrassegno delle schede (Bmd) generano risultati che non sono verificabili».
Forse, proprio pazzo Trump non è.
Stefano Graziosi per "la Verità" l'11 dicembre 2020. Joe Biden ha
un problema: suo figlio. Hunter è infatti sotto inchiesta da parte della Procura
federale del Delaware. È stato lo stesso diretto interessato a renderlo noto
mercoledì con una nota in cui ha affermato di essere indagato a causa dei suoi
«affari fiscali». Il sito della Cnn ha riportato che la Procura si sta
coordinando con l' Fbi e l' Irs criminal investigation, aggiungendo che «secondo
due persone informate sull' indagine, gli investigatori hanno esaminato
molteplici questioni finanziarie, tra cui se Hunter Biden e i suoi soci abbiano
violato le leggi fiscali e quelle sul riciclaggio di denaro negli affari
condotti in Paesi stranieri, principalmente in Cina». Sempre stando a Cnn,
Hunter sarebbe rimasto coinvolto in transazioni che, secondo l' Fbi, «hanno
suscitato le preoccupazioni del controspionaggio». Particolarmente critico
Donald Trump che, su Twitter, ha lasciato intendere come, se fosse uscita prima,
la notizia avrebbe potuto cambiare il corso delle elezioni. L' indagine - che
stando ad Abc News sarebbe stata aperta già nel 2018 - non coinvolgerebbe
direttamente Joe Biden. Un Joe Biden che rischia comunque un deciso
indebolimento politico da questa vicenda. Se il presidente entrante ha infatti
diramato un comunicato nelle scorse ore dicendosi «orgoglioso di suo figlio»,
restano tuttavia per lui dei nodi non indifferenti. In primis, la notizia dell'
indagine è arrivata in prossimità di due scadenze politiche importantissime: non
solo il 14 dicembre i grandi elettori si riuniranno per eleggere formalmente il
presidente, ma - il prossimo 5 gennaio - si terranno i due ballottaggi della
Georgia: ballottaggi che stabiliranno quale sarà il partito a detenere la
maggioranza in Senato. La posizione politica di Biden potrebbe quindi farsi
traballante, in quanto sempre più potenzialmente esposta agli attacchi dei
repubblicani e della sinistra dello stesso Partito democratico. Non solo l'
asinello rischia di uscire elettoralmente danneggiato dalla questione, ma il
medesimo Biden - una volta insediato - dovrà decidere se tollerare la spada di
Damocle di questa indagine o se - bloccando tutto attraverso il Dipartimento di
Giustizia - attirarsi le accuse di abuso di potere. Una situazione non certo
rosea, che potrebbe tuttavia non dispiacer troppo a quanti desiderano una
presidenza capitanata da Kamala Harris (e che sperano in una rapida
archiviazione del vecchio Joe). Frattanto, il senatore repubblicano Tom Cotton
ha chiesto che venga nominato un Procuratore speciale per investigare su Hunter.
In secondo luogo, è pur vero che Joe Biden non risulta al momento indagato e che
la responsabilità penale è personale. Resta tuttavia il fatto che il presidente
entrante si trascina da tempo fondati sospetti di conflitto di interessi. Nel
2013, da vicepresidente in carica, si fece accompagnare in una visita a Pechino
dallo stesso Hunter, il quale - guarda caso - poco tempo dopo ottenne la licenza
commerciale in Cina per una società che aveva contribuito a fondare. Senza poi
dimenticare come, nel 2014, proprio Hunter fosse entrato ai vertici della
società ucraina Burisma: appena un mese dopo che il padre era stato nominato da
Barack Obama come tramite tra il governo di Kiev e quello di Washington. Sempre
in questa veste, nel 2016, Biden pretese e ottenne il siluramento del
Procuratore ucraino che stava indagando per corruzione proprio su Burisma. In
terzo luogo, registriamo come un rapporto dei senatori repubblicani, Ron Johnson
e Chuck Grassley, avesse messo in evidenza la preoccupazione che le attività
economiche di Hunter in Cina avvenissero in connessione con pezzi dello stesso
governo cinese. Il fatto che adesso Cnn abbia riportato le apprensioni dell' Fbi
in materia di controspionaggio sottolinea allora che quelle preoccupazioni non
fossero del tutto infondate. Ricordiamo inoltre che il suddetto rapporto si era
in particolare soffermato sulle relazioni strette da Hunter con il controverso
businessman cinese, Ye Jianming: una figura che, oltre a essersi attirato accuse
di corruzione, risultava vicinissimo all' Esercito popolare di liberazione. Alla
luce di tutto ciò, la censura preventiva degli articoli del New York Post sulla
famiglia Biden da parte dei social network e di ampi settori della stampa appare
adesso - anche più di prima - decisamente fuori luogo. Tra l' altro, mentre con
il Russiagate sono state fatte trapelare illegalmente ai giornali quantità
cospicue di informazioni (più o meno fondate), l' indagine su Hunter è rimasta
stranamente segreta per circa due anni. Senza contare che la notizia della sua
esistenza è arrivata nelle stesse ore in cui è scoppiata una bufera sul deputato
dem, Eric Swalwell, che - secondo quanto rivelato da Axios - ha intrattenuto
(tra il 2012 e il 2015) stretti legami politici con una donna cinese, Christine
Fang, sospettata oggi di essere una spia di Pechino. Insomma, le ombre cinesi
che aleggiano sulla famiglia Biden e su alcuni settori del Partito democratico
potrebbero rivelarsi un imbarazzo non di poco conto per l' amministrazione
entrante. Un' amministrazione che rischia di partire già azzoppata.
Dagospia l'11 dicembre 2020. Da Daily Mail. Bill Barr era a
conoscenza delle indagini che coinvolgono il figlio di Joe Biden , Hunter,
almeno dalla primavera, secondo un rapporto, e ha fatto del suo meglio per
impedire che le informazioni trapelassero prima delle elezioni. Una notizia che
ha fatto arrabbiare il suo capo Donald Trump , il procuratore generale – la cui
poltrona si dice già essere in bilico - ha agito per impedire che l'indagine
fosse resa pubblica, ha riferito il Wall Street Journal. Le linee guida del
Dipartimento di Giustizia consigliano agli investigatori di non intraprendere
azioni in vista di un'elezione per non essere visti come condizionanti il
risultato. "Perché i Fake News Media, l'FBI e il Dipartimento di Giustizia non
hanno riportato la questione di Biden PRIMA delle elezioni", ha twittato Trump
giovedì sera. "Va bene, va bene, abbiamo comunque vinto le elezioni - 75.000.000
di VOTI !!!" Twitter ha contrassegnato il suo tweet come disinformazione. Le
azioni di Barr sono il ribaltamento di quelle dell'ex direttore dell'FBI James
Comey, che sentiva di dover rendere pubblica la notizia che le e-mail di Hillary
Clinton erano oggetto di indagine. Ha annunciato prima delle elezioni che le
indagini erano terminate, ma il danno è stato fatto. Comey ha detto che sapeva
che sarebbe stato dannato se avesse annunciato le indagini, e dannato se non
l'avesse fatto. Hunter ha rivelato mercoledì che è sotto inchiesta federale
sulle sue tasse. "Ho appreso ieri per la prima volta che l'ufficio del
procuratore degli Stati Uniti nel Delaware ha consigliato al mio consulente
legale, anche ieri, che stanno indagando sui miei affari fiscali", ha detto
Hunter. La dichiarazione è stata rilasciata dal presidente eletto Joe Biden e
dall'ufficio di transizione del vicepresidente eletto Kamala Harris.
L'Associated Press ha riferito che il Dipartimento di Giustizia sta esaminando
alcuni degli accordi commerciali cinesi di Hunter Biden e non il contenuto del
suo laptop, condiviso nelle settimane prima dell'elezione dall'avvocato di
Trump, Rudy Giuliani. Mentre l'indagine è iniziata nel 2018, martedì è stato
emesso un nuovo ciclo di citazioni in giudizio, anche a Hunter Biden, ha detto
l'Associated Press. Trump e i suoi colleghi repubblicani hanno esortato per mesi
Barr a perseguire Hunter, con le loro chiamate che aumentavano man mano che le
possibilità elettorali di Joe Biden aumentavano. Una fonte ha detto al WSJ che
Barr ha evitato le pressioni dei repubblicani al Congresso per ottenere
informazioni sulle indagini. I pubblici ministeri federali a Manhattan avevano
anche esaminato gli affari e gli affari finanziari di Hunter, come parte di
un'indagine penale più ampia che due persone che avevano familiarità con la
questione dissero che il WSJ era un'indagine finanziaria internazionale che era
in corso da almeno un anno. Fox News ha riferito che Hunter è un "soggetto /
bersaglio" dell'indagine del gran giurì. Un obiettivo significa che c'è "un'alta
probabilità che una persona abbia commesso un crimine" e un soggetto è qualcuno
che "non conosci per certo" ha commesso un crimine. Le fonti di Fox hanno
affermato che le transazioni da "Cina e altre nazioni straniere" hanno innescato
rapporti di attività sospette, spingendo l'indagine. Fox ha detto che l'indagine
è iniziata nel 2018, il che significa che ha preceduto Barr che ha assunto il
posto di primo piano al Dipartimento di Giustizia. Barr ha dichiarato
pubblicamente che il presidente eletto non è sotto inchiesta e due fonti hanno
detto alla CNN che l'indagine non accusa alcun illecito da parte di Joe Biden.
Né l'indagine fiscale né l'indagine finanziaria di Manhattan implicano il
presidente eletto, riporta il giornale. Il team di transizione di Biden ha
rifiutato di dire quando Joe Biden ha appreso delle indagini. Una dichiarazione
diffusa da quella squadra mercoledì ha detto che il presidente eletto Biden è
"orgoglioso di suo figlio, che ha combattuto attraverso sfide difficili, inclusi
i feroci attacchi personali degli ultimi mesi, solo per emergere più forte".
Barr era sotto forte pressione per dichiarare formalmente che stava indagando su
Hunter e suo padre. Jim Jordan, un membro del Congresso repubblicano in
rappresentanza dell'Ohio, che è membro della commissione giustizia della Camera,
ha scritto al direttore del Federal Bureau of Investigation Christopher Wray
chiedendo quali passi l'FBI avesse intrapreso per indagare sulle informazioni
contenute nel "rapporto esplosivo". Una portavoce dell'FBI ha detto che
l'ufficio di presidenza ha risposto alla lettera e ha rifiutato di commentare
ulteriormente. Il 19 ottobre, i repubblicani al Congresso hanno esortato Barr a
nominare un avvocato speciale per indagare su Hunter Biden e suo padre, e hanno
chiesto a Barr di rispondere entro cinque giorni. Il giorno dopo, alla domanda
su Fox News se era favorevole a intercettare un procuratore speciale, Trump ha
detto: "Dobbiamo convincere il procuratore generale ad agire. Deve recitare e
deve agire in fretta. Deve nominare qualcuno. Questa è una grave corruzione e
questo deve essere conosciuto prima delle elezioni". L'indagine fiscale su
Hunter Biden è stata scatenata in parte da segnalazioni di attività sospette
presentate da una banca che ha gestito transazioni estere a lui collegate, ha
detto una fonte. Hunter, avvocato, ha lavorato per numerose società
internazionali. Per circa cinque anni, fino all'aprile 2019, è stato membro del
consiglio di amministrazione di una compagnia di gas ucraina, Burisma Holdings,
dove è stato pagato circa $ 50.000 al mese per il suo lavoro. Hunter ha svolto
anche attività di consulenza per China CEFC Energy Co., poiché la società ha
concluso accordi in Europa e Medio Oriente. Più o meno nel periodo in cui il
CEFC stava cercando di entrare negli Stati Uniti, la sua attività è diventata al
centro di un caso di corruzione promosso dall'ufficio del procuratore
statunitense di Manhattan, che ha portato alla condanna del 2018 di un ex
funzionario di Hong Kong con l'accusa di aver corrotto funzionari africani per
garantire vantaggi aziendali per CEFC. Un elemento di interesse per gli
investigatori potrebbe essere un diamante da 2,8 carati donato a Hunter Biden
nel 2017 dal fondatore ed ex presidente di CEFC China Energy, Ye Jianming, dopo
un incontro di lavoro a Miami, ha detto la CNN. Il diamante faceva parte
dell'indagine originale, ma non è chiaro se sia ancora un punto focale, ha
riferito la rete. Hunter Biden ha descritto di aver ricevuto il diamante durante
la sua intervista del luglio 2019 con il New Yorker, dicendo che dopo aver
incontrato Ye e aver offerto di usare i suoi contatti per aiutare l'uomo
d'affari cinese a identificare i progetti di gas naturale liquefatto negli Stati
Uniti, il diamante è stato inviato nella sua camera d'albergo. Hunter Biden ha
detto di non aver interpretato come una tangente. "Per cosa mi avrebbero
corrotto?" chiese. "Mio padre non era in ufficio." Ma decise comunque di non
tenere la gemma. "Sapevo che non era una buona idea prenderlo", ha detto. Hunter
Biden ha detto di aver dato il diamante a uno dei suoi soci e non sapeva cosa
gli fosse successo.
“Nascose 400mila dollari al fisco”: l’email che inchioda
Hunter Biden. Roberto Vivaldelli su Inside Over il 14
dicembre 2020. Un nuovo scandalo colpisce Hunter Biden, figlio del presidente
eletto, che nei giorni scorsi ha rivelato di essere indagato dal Procuratore
generale del Delaware per questioni fiscali. Secondo alcune e-mail che
l’emittente Nbc News ha potuto visionare, il figlio dell’ex vicepresidente Joe
Biden non avrebbe dichiarato nel 2014 al fisco americano 400 mila dollari
ricevuti come compenso dalla società ucraina del gas Burisma. Lo rivela, in una
mail, un ex socio in affari di Hunter Biden, il quale inviò un messaggio al
figlio dell’ex vicepresidente nel 2017 dicendogli che non aveva incluso nella
sua dichiarazione dei redditi i 400 mila dollari che aveva guadagnato come
componente del consiglio d’amministrazione della Burisma, la società di gas
ucraina nella quale si era insediato dal 2014. Il messaggio è di Eric Schwerin,
allora presidente di Rosemont Seneca Partners, nel quale spiegava che Hunter
Biden doveva “modificare” la sua dichiarazione dei redditi. “Nel 2014 sei
entrato a far parte del consiglio di amministrazione di Burisma e abbiamo
bisogno di modificare i tuoi redditi del 2014 per riportare ciò che non hai
dichiarato”.
“Nascosti 400 mila dollari la fisco”: nuovi guai per Hunter
Biden. L’e-mail prosegue notando che Hunter Biden, che ora è oggetto di
un’indagine fiscale federale, ha guadagnato più di 1,2 milioni di dollari l’anno
come advisor della Rosemont Seneca, come membro dello studio legale e,
ovviamente, come membro del cda di Burisma. Come nota la stessa Nbc News, non
c’è alcuna indicazione sul fatto il lavoro svolto dal figlio del presidente
eletto per la compagnia nazionale del gas Burisma faccia parte delle indagini,
ma “l’e-mail ottenuta da Nbc News solleva nuove domande sugli affari fiscali di
Hunter Biden”. Il suo avvocato, George Mesires, riferisce sempre l’emittente,
non ha risposto alla richiesta di commento. Un portavoce del team di transizione
di Biden ha rifiutato di commentare quando gli è stato inviato un elenco di
domande, incluso se Hunter Biden ha modificato la sua dichiarazione dei redditi
del 2014. Il documento è stato messo a disposizione di Nbc dall’avvocato di Rudy
Giuliani, Robert Costello, il quale ha dichiarato di aver ricevuto una copia del
drive dal proprietario del negozio di riparazione di computer dove il figlio di
Biden avrebbe lasciato il suo laptop, senza più andare a ritirarlo.
Così i media e i social hanno oscurato gli scandali del figlio di
Biden. “Il 10% degli elettori avrebbe cambiato il proprio voto se avessero
saputo prima” gli affari di Hunter Biden. Questa è la convinzione di Tucker
Carlson, celebre anchorman di Fox News, e di molti altri commentatori
conservatori americani. Probabilmente è così ma sta di fatto che gran parte dei
media liberal – non solo americani – ha volutamente ignorato per tutta la
campagna elettorale gli scandali che vedono come protagonista, suo malgrado, il
figlio del presidente eletto. “I media hanno aiutato a mettere a tacere una
storia e ad alterare i risultati di un’elezione. Probabilmente stanno ridendo
nelle redazioni di tutto il Paese”, ha detto a Fox News il vice presidente del
Media Research Center Dan Gainor. Il 14 ottobre scorso il New York
Post pubblicava un’inchiesta bomba: secondo le e-mail ottenute dal giornale
conservatore, infatti, Hunter Biden presentò suo padre, all’epoca
vicepresidente, un alto dirigente di Burisma meno di un anno prima che Joe Biden
facesse pressioni sui funzionari del governo di Kiev affinché licenziassero un
procuratore che stava indagando sulla stessa società nel quale il figlio era un
membro del cda. L’incontro è menzionato in un messaggio di apprezzamento che
Vadym Pozharskyi, un membro del cda di Burisma, avrebbe inviato Hunter Biden il
17 aprile 2015, circa un anno dopo che il figlio dell’ex vicepresidente si era
unito al consiglio di Burisma con uno stipendio di 50.000 dollari al mese.
L’e-mail proviene proprio dal laptop di Hunter Biden, lasciato in un negozio del
Delaware.
Cina e Ucraina, gli affari di Hunter Biden.
Roberto Vivaldelli su Inside Over il 14 dicembre 2020. E così
anche la stampa cosiddetta mainstream e più vicina ai democratici, ha dovuto
ammettere che il presidente eletto Joe Biden ha un “problema”, e non di poco
conto: il suo nome è Hunter Biden, al centro di numerose inchiesta
giornalistiche – e ora anche giudiziarie. Nella giornata di mercoledì, infatti,
il figlio dell’ex vicepresidente ha fatto sapere che l’ufficio del procuratore
del Delaware sta indagando su di lui per questioni fiscali. “Prendo la questione
molto seriamente, ma sono fiducioso che una revisione professionale e obiettiva
di tali questioni dimostrerà che ho gestito i miei affari legalmente e in modo
appropriato, anche con l’avvallo di consulenti fiscali professionisti”, ha detto
Biden in una dichiarazione. Secondo la Cnn, che ha riferito di aver contattato
l’avvocato di Hunter Biden e la campagna presidenziale di suo padre nei giorni
scorsi per un commento, il procuratore del Delaware “sta esaminando molteplici
questioni finanziarie”, al fine di appurare se il figlio del Presidente Usa e i
suoi soci “hanno violato le leggi fiscali e sul riciclaggio di denaro nei
rapporti d’affari in paesi stranieri, principalmente con la Cina”.
I rapporti di Hunter Biden con il Partito comunista cinese. Come
ricorda il Corriere della Sera, nel 2103 Joe Biden era il vice presidente degli
Stati Uniti. Hunter lo accompagnò in una missione a Pechino, dove incontrò
alcuni partner di affari. Tra questi ci sarebbe un imprenditore petrolifero, Ye
Janming, che gli regalò un diamante. Hunter entrò in contatto anche Patrick Ho,
condannato dalla magistratura newyorkese per aver versato una tangente ai
funzionari governativi in Ciad e Uganda, usando canali finanziari americani. I
rapporti con pechino, però, non si limitano a questo. Come riportato lo scorso
ottobre da IlGiornale.it, alcuni sms pubblicati in esclusiva da Fox
News sembrano far supporre che l’ex vicepresidente incontrò, nel maggio 2017,
gli emissari di una società energetica cinese, nonostante il candidato dem
avesse smentito questa ricostruzione. Fox News ha ottenuto gli sms da Tony
Bobulinski, un tenente in pensione della Marina degli Stati Uniti, nonché ex Ceo
di SinoHawk Holdings e socio in affari di Hunter. “Fammi sapere se faremo cena
presto con tuo zio e tuo padre e dove, anche per la traduzione dei documenti?”
Bobulinski scrive ad Hunter il 2 maggio 2017. “Papà non sarà qui prima delle 11”
risponde l’interessato. Più tardi Bobulinski invia un messaggio a Jim, il
fratello di Joe Biden, lo stesso giorno, il 2 maggio 2017, dicendo: “È
fantastico conoscerti e passare un po’ di tempo insieme, grazie Joe per il suo
tempo”. L’oggetto dell’incontro? Forse un prestito alla famiglia. Un’altra
e-mail inviata a Tony Bobulinski da un alto funzionario cinese il 26 luglio 2017
mostra che la compagnia energetica cinese Cefc propone un prestito “senza
interessi” di 5 milioni di dollari alla famiglia del candidato dem “sulla base
della loro fiducia”. Meno di due settimane dopo, l’8 agosto 2017, 5 milioni di
dollari vengono trasferiti dalla Cefc all’azienda di Hunter Biden, secondo i
documenti in possesso del Senato. Il proprietario della Cefc, Ye Jianming, era
tra i più ambiziosi dei magnati cinesi prima che il suo impero degli affari
crollasse. Il nome di Bobulinski è diventato pubblico nei giorni scorsi, quando
il New York Post ha pubblicato una delle mail contenute nel laptop di Hunter
Biden recuperato da un negozio di riparazioni di computer nel Delaware.
Ecco gli affari in Cina del figlio del presidente eletto. Tony
Bobulinski, destinatario di una email pubblicata da New York Post, nella quale
sembrerebbero indicati i dettagli di una transazione d’affari tra un’azienda
cinese e membri della famiglia Biden, ha confermato la “autenticità” del
documento. Come riporta l’agenzia Adnkronos, l’email risale al 13 maggio 2017 e
nel testo si fa riferimento a “Hunter” e a tale “Big Guy”, il ‘pezzo grosso, che
sarebbe, secondo quanto raccontato da Bobulinski a Fox News, lo stesso ex
vicepresidente degli Stati Uniti. Bobulinski, ex partner d’affari di Hunter
Biden, smentisce quanto affermato da Joe Biden in più occasioni, il quale ha
affermato di non essersi mai interessato alle attività imprenditoriali del
figlio. Hunter “faceva spesso riferimento a lui per il suo via libera o per
consigli su potenziali affari – sostiene Bobulinski – ho visto il vice
presidente Biden dire che non parlava mai con Hunter dei suoi affari. Posso dire
per esperienza diretta che non è vero, perché non si trattava solo degli affari
di Hunter, dicevano che mettevano in gioco il nome della famiglia Biden”. Le
accuse si fanno ancora più dirette: “La famiglia Biden ha aggressivamente fatto
uso del proprio nome per guadagnare milioni di dollari da entità straniere,
anche se alcune erano controllate dalla Cina comunista”. Secondo il Wall Street
Journal, avrebbe dovuto chiarire i suoi rapporti con Pechino. “La maggior parte
dei media ignora le e-mail trovate nel laptop di Hunter Biden, ma questo non
significa che non siano notizie”, scrive l’autorevole quotidiano finanziario.
L’Fbi è in possesso del computer portatile che apparterrebbe ad Hunter e nel
quale sarebbero contenute le email che indicherebbero i suoi affari all’estero,
compresi i contatti con l’Ucraina e la Cina.
L’Ucraina e Burisma. C’è poi il fronte ucraino, che non sappiamo,
al momento, se sia oggetto di indagini. Come riportato da InsideOver, il
vicepresidente di Obama fece la sua prima visita a Kiev nell’aprile 2014,
proprio quando il governo post-Maidan stava lanciando la sua operazione militare
contro i separatisti russi nel Donbass. Rivolgendosi al parlamento di Kiev,
Biden dichiarò che “la corruzione non potrà più avere spazio nella nuova
Ucraina”, sottolineando che gli Stati Uniti “sono la forza trainante dietro il
Fmi” e stavano lavorando per assicurare a Kiev “un pacchetto multimiliardario
per aiutare” il governo. Nello stesso periodo, Hunter Biden venne nominato nel
consiglio di amministrazione di Burisma. La cacciata del presidente Viktor
Yanukovych (febbraio 2014) pose il fondatore e presidente di Burisma, l’oligarca
Mykola Zlochevsky, in una posizione delicata. Quest’ultimo era stato ministro
dell’ambiente di Yanukovych, e il cambio di regime lo mise in difficoltà. Anche
perché stava affrontando dei seri problemi legali: un’inchiesta sulla corruzione
nel regno Unito aveva portato al congelamento di parte del suo patrimonio, pari
a 23 milioni di dollari. L’oligarca aveva a necessità di farsi dei nuovi amici:
si trattava di Hunter Biden, figlio del vicepresidente degli Stati Uniti, e
dell’Atlantic Council. Il figlio di Joe Biden aveva già ottenuto un
incarico presso il National Democratic Institute (Ned), un’organizzazione di
“promozione della democrazia” finanziata dagli Stati Uniti che ha contribuito a
rovesciare il governo filo-russo di Yanukovich insieme all’Open Society del
finanziere George Soros. Hunter venne così arruolato in una posizione di grande
prestigio in Burisma, a 50 mila dollari al mese, nonostante la sua totale
mancanza di esperienza nel settore energetico e negli affari ucraini. Hunter
Biden lo ripagò contattando un importante studio legale di Washington, Dc,
Boies, Schiller e Flexner, dove aveva lavorato come consulente. Nel gennaio
successivo, i beni dell’oligarca vennero scongelati nel Regno Unito. Nella
primavera del 2014, l’Associated Press e persino il New York Times, sollevarono
perplessità sul ruolo di Hunter Biden nella compagnia ucraina, nonostante Joe
Biden assicurasse di non saperne nulla.
L’accusa
(clamorosa) del team legale di Trump: “Italia coinvolta nei brogli”.
Roberto Vivaldelli su Inside Over il 2 dicembre 2020. L’accusa del team legale
del Presidente Usa Donald Trump è pesantissima: anche Roma sarebbe
potenzialmente coinvolta nei presunti brogli denunciati dal partito repubblicano
che avrebbero consentito a Joe Biden di vincere le ultime elezioni presidenziali
negli Stati Uniti. Ricordiamo che l’avvocato dell’ex consigliere per la
sicurezza nazionale Michael Flynn, Sidney Powell, ha intentato nei giorni scorsi
una causa per annullare i risultati delle elezioni nel Michigan denunciando
“centinaia di migliaia di schede illegali, non ammissibili, duplicate o
puramente fittizie”, rese possibili dalla “massiccia frode elettorale”. Al
centro della battaglia legale della Powell c’è il sistema di voto Dominion
voting systems, società fondata in Canada, le cui apparecchiature e software
sono utilizzati in oltre 20 Stati americani. Secondo il team legale del
Presidente Usa, attraverso questo sistema il voto sarebbe facilmente
manipolabile.
Possibili
brogli Usa, l’accusa del team legale di Donald Trump. Come spiega La Verità,
l’ultima pista investigativa che riguarderebbe il nostro Paese sarebbe
concernente parte del presunto switch elettorale, cioè del meccanismo per
spostare voti manipolando i risultati, che sarebbe stata pensata (forse sin
dalla primavera scorsa) e poi realizzata anche dall’Italia, attraverso una
triangolazione tra un officiale statunitense operante presso l’ambasciata Usa a
Roma (ipotesi che, se confermata, non rimarrebbe ovviamente priva di
conseguenze), figure militari di altissimo livello, e la collaborazione tecnica
di una società italiana nel settore della difesa. Tutto sarebbe avvenuto
attraverso quella che viene chiamata una military encryption, quindi codici e
crittografie militari per proteggere certe operazioni e renderle difficilmente
decodificabilii. Ricordiamo inoltre che, a detta dei repubblicani, il nostro
Paese è al centro della controinchiesta sul Russiagate e di una possibile
cospirazione ai danni del Presidente Donald Trump e della sua Campagna sulla
quale sta indagando il procuratore John Durham. Quest’ultimo, a seguito della
conclusione delle indagini del procuratore speciale Robert Mueller che ha
sgonfiato l’ipotesi della “collusione” fra lo staff di Trump e la Russia, è
stato incaricato da William Barr di determinare se il Dipartimento di Giustizia,
l’Fbi e le autorità dell’intelligence hanno agito in maniera impropria e
“cospirato” contro Donald Trump nel 2016.
Donald Trump:
“Ci sono stati importanti brogli”. Nei giorni scorsi The Donald è stato ospite
della giornalista Maria Bartiromo e del suo programma Sunday Mroning Futures in
onda su Fox News dove si è scagliato contro il sistema giudiziario americano e
ha fatto il punto sulla lunga battaglia legale che lui e il suo team, guidato
dall’ex sindaco di New York Rudolph Giuliani, hanno avviato denunciando presunti
brogli in molti degli stati contesi. Il Presidente Usa ha spiegato che “hanno
buttato via molte schede di Trump. Questo è il modo più semplice per
imbrogliare. Abbiamo ottenuto 74 milioni di voti” ha rimarcato. Maria Bartiromo
ha chiesto al tycoon se riuscirà a dimostrare l’esistenza di brogli: “Userò il
125% della mia energia per farlo – ha replicato Trump -. Ho bisogno di un
giudice che sia disposto ad ascoltare. C’è bisogno di una Corte Suprema disposta
a prendere una decisione davvero importante”. Su Youtube, l’avvocato di Trump ed
ex sindaco di New York Rudy Giuliani ha illustrato – a suo dire – il
funzionamento di Dominion. Quest’ultima società, afferma Giuliani, “ha un
contratto con una compagnia chiamata Smartmatic, che ha sede a Francoforte, in
Germania e a Barcelona, Spagna. E quando i voti vengono conteggiati vengono
dunque inviati, la maggior parte di essi, a Francoforte. Questi software sono
particolarmente vulnerabili agli hacker aggi ed estremamente vulnerabili da
manipolare”. Smartmatic, afferma l’ex primo cittadino della Grande Mela, “è una
compagnia che ha le sue origini intorno al 2004 circa, 2005. È stata fondata da
due venezuelani molto vicini al dittatore Chavez. Ed è stata fondata con
l’obiettivo specifico di essere in grado di commettere brogli nelle elezioni”.
Quanto ci sia di vero o falso in queste affermazioni spetta ora al team legale
di Trump dimostrarlo.
Ladri! ANSA il 6 novembre 2020. "La
controversia legale sulle elezioni finirà alla Corte suprema", ha ribadito il
presidente americano in carica Donald Trump dopo aver denunciato (senza fornire
prove) che ci sono state "varie irregolarità allarmanti" e che osservatori
repubblicani si sono visti negare l'accesso ai seggi di Philadelphia e Detroit.
"Il nostro obiettivo è proteggere l'integrità delle elezioni, non consentiremo
che ce le rubino, che i nostri elettori siano silenziati", ha aggiunto. "Se si
contano i voti legali vinto facilmente", si è spinto ad affermare Trump. E il
network tv che comprende Abc, Cbs e Msnbc ha interrotto la trasmissione del
discorso. L'anchor Brian Williams ha fatto anche un commento imbarazzante per il
tycoon: "Ci troviamo ancora nella posizione inusuale non solo di interrompere il
presidente degli Usa, ma anche di correggerlo". "Non ci saranno Stati rossi o
Stati blu quando vinceremo. Ci saranno solo gli Stati Uniti d'America". Joe
Biden parla già da presidente, anche se la lunga maratona elettorale fatta di
spasmodica attesa e notti insonni non si è ancora conclusa. Si contano ancora i
voti in un pugno di Stati chiave, ma l'ex vicepresidente sente già le chiavi
della Casa Bianca in tasca. Anche se Donald Trump, dovesse davvero perdere, non
gliele consegnerà così facilmente. Il presidente è sul piede di guerra. Parla di
brogli e di elezioni truccate, e con una raffica di azioni legali prova in tutti
i modi a bloccare e invalidare i voti conteggiati dopo l'Election Night del 3
novembre. Tutte quelle schede elettorali che quest'anno almeno 65 milioni di
americani hanno preferito spedire per non recarsi ai seggi in tempi di pandemia.
"Tutti gli Stati assegnati di recente a Biden saranno sfidati legalmente per
frode elettorale. Ci sono un mare di prove!", è il monito del presidente su
Twitter. Lui, tenendo conto solo dei voti scrutinati nella notte dell'Election
Day, si considera il vincitore di queste elezioni. Così il team dei suoi legali
e della sua amministrazione ha contestato a colpi di carte bollate l'estensione
dello scrutinio in Pennsylvania, North Carolina, Arizona, Nevada e Georgia, i
cinque Stati chiave in cui si sta giocando la partita finale. Mentre denunce
sono partite anche per Wisconsin e Michigan, già assegnati al suo rivale. Alcune
di queste cause o denunce sono già state respinte al mittente, ma sullo sfondo
resta sempre l'ultima carta in mano a Trump: il ricorso alla Corte Suprema. Con
esiti però per nulla scontati, considerando che è stato lo stesso massimo organo
giudiziario Usa a respingere prima dell'Election Day il tentativo di fermare
l'estensione del conteggio dei voti in Pennsylvania e North Carolina.
(ANSA il 6 novembre 2020) - I democratici Usa, tra i quali
Alexandria Ocasio-Cortez, stanno esortando chi ha votato via posta in Georgia a
controllare se la loro scheda sia stata accettata o meno. Lo riporta la Bbc. In
caso di rifiuto, perche' non firmata o perche' la firma non è stata considerata
valida, l'errore si può correggere fino alle 17 di oggi (ora americana),
sottolineano i dem. L'appello arriva nel momento in cui il vantaggio di Donald
Trump su Joe Biden in Georgia si è ridotto a circa 1.800 voti.
Massimo Gaggi per il ''Corriere della Sera'' il 6 novembre 2020.
Dal cellulare e dal pc mi arrivano, come a decine di milioni di altri americani
che lo seguono sui suoi siti, le martellanti richieste di Donald Trump di
contribuire generosamente alla raccolta di fondi per sostenere le spese legali
dei ricorsi per contestazioni e riconteggi dei voti negli Stati nei quali il
presidente è stato sconfitto sul filo di lana da Joe Biden. Quella di tentare di
impedire che la guida del Paese passi a un democratico dovrebbe essere una
battaglia di tutti i repubblicani. Mentre la Casa Bianca è in piena tempesta e
la campagna di Trump manda a Filadelfia una task force - figlio e cognata del
presidente, Rudy Giuliani e il consigliere «mastino» Corey Lewandowski - per
sorvegliare uno scrutinio che potrebbe rendere certa la sconfitta di The Donald,
Mitch McConnell si preoccupa di tutt' altro. Sollevato dalla sua riconferma nel
seggio senatoriale del Kentucky e dalla tenuta dei repubblicani che non hanno
perso il controllo del Senato, il leader della Camera Alta già ragiona sul varo
di un pacchetto di sostegni economici per contrastare la crisi indotta dal
coronavirus. Eric, il figlio di Trump, si infuria: «Repubblicani, mostrate la
spina dorsale contro questa frode. Se vi comportate da pecore gli elettori vi
puniranno». E mentre alla Casa Bianca i consiglieri di Trump cominciano a
parlare di una possibile sua ricandidatura nel 2024 - già battezzata
resurrection run - qualora il presidente fosse costretto a lasciare l'incarico,
un partito risollevato comincia a chiedersi se non ci sia qualche alternativa a
un futuro con mani e piedi legati ai destini dell'attuale leader. La battaglia
legale per sbarrare la strada a Biden viene combattuta soprattutto dalla
campagna di Trump. Ma la ricerca affannosa di fondi sembra indicare che il
contributo finanziario del Rnc, l'organizzazione dei repubblicani, è limitato.
Trump rimane il leader assoluto: in questi quattro anni ha demolito il vecchio
establishment repubblicano e dato spazio a una nuova leva di politici seguaci
del suo verbo populista e sovranista. Ma alcuni esponenti della vecchia guardia
sono sopravvissuti, come McConnell: un «notabile» del Sud che si è messo sulla
scia di Trump ma probabilmente non lo ama, visto che all'inzio del suo mandato
il presidente aveva tentato senza successo di defenestrarlo. Trump rimane,
insomma, il leader di gran lunga più influente del partito, ma c'è chi si
comincia a chiedere se va seguito anche in una scelta estrema come quella di
ricandidarsi nel 2024. La Costituzione non lo vieta, ma l'unico precedente
risale a oltre un secolo fa: Grover Cleveland nel 1892. Fin qui i parlamentari
del Grand Old Party hanno seguito Trump perché non potevano rinunciare al traino
del suo elettorato entusiasta. Ma i risultati dell'Election Day indicano che il
partito è andato meglio del suo leader, conquistando agevolmente maggioranze
locali anche in Stati come Michigan, Wisconsin e Pennsylvania che Trump ha perso
o nei quali sta combattendo fino all'ultimo voto.
Donald Trump accusa Joe Biden di mischiare le schede: "Brogli,
frodi e corruzione, abbiamo le prove". Libero
Quotidiano il 06 novembre 2020. Joe Biden verso la Casa Bianca, ma per il
presidente americano uscente qualcosa non torna. "Se si contano i voti legali
vinco facilmente le elezioni! Se si contano i voti illegali e quelli in ritardo,
ci rubano le elezioni", tuona Donald Trump. Il tycoon denuncia ancora "brogli,
frodi e corruzione" da parte dei democratici e annuncia il ricorso alla Corte
Suprema. Nel mirino i voti postali contati a seggi chiusi. "Abbiamo le prove -
prosegue The Donald - la corruzione a Detroit e Philadelphia la conoscono
tutti". E così questa guerra legale finisce nelle mani dei migliori: Bill
Stepien (l'onnipotente stratega che da Arlington, Virginia, guida la sua
campagna), di Pam Bondi (ex procuratrice generale della Florida) e Jay
Sekulow (il famoso avvocato, campione della destra evangelica che lo ha difeso
con successo dall'impeachment) la coppia che guida la task force di centinaia di
avvocati scelti tra i più prestigiosi studi legali degli Stati Uniti. Segue il
pensiero di Trump anche Stepien che dichiara: "Continueremo a lottare per queste
elezioni perché questo è ciò che il popolo americano merita e per smascherare le
menzogne, i furti e gli imbrogli dei democratici che stanno dilagando in questo
paese". La campagna di Trump - scrive Repubblica - si dice "convinta al cento
per cento" che la Pennsylvania sia stata vinta dal presidente uscente, a meno
che non appaiano "magiche pile di voti" per Biden. Anche per la Georgia, il team
trumpiano ha una strategia. Qui i repubblicani chiedono il riconteggio solo
nella contea di Chatham, di cui fa parte la città di Savannah (tradizionalmente
democratica), sostenendo che le schede arrivate dopo il 3 novembre sono state
illegalmente mischiate con le altre. Insomma la partita è ancora apertissima.
Matteo Salvini e il sospetto sulle presidenziali negli Stati
Uniti: "Più schede che cittadini, ci saranno sorprese".
Libero Quotidiano il 06 novembre 2020. Matteo Salvini dalla parte di Donald
Trump. Qualcosa per il leader della Lega non torna in queste presidenziali:
"Dagli Usa - spiega - c’è una grande lezione di democrazia e partecipazione,
vedere quelle file è stata una bella immagine. Che in alcune contee ci siano più
schede che cittadini qualche dubbio lo fa venire, che stiano fermando e
ricontando mi sembra necessario. Vederci chiaro fino in fondo mi sembra
necessario, poi chi vince vince l’America rimane una grande democrazia". Le
parole dell'ex ministro a 24 Mattino su Radio24 ricalcano il pensiero del
presidente uscente che ha già deciso di fare ricorso alla Corte Suprema per i
voti postali voluti dall'avversario Joe Biden. Salvini teme quanto sta accadendo
negli Stati Uniti e per questo promette: "Ha ragione Trump a dire controlliamo
voto per voto e non escludo nulla, vedrete che potranno esserci sorprese. Anche
noi alle prossime elezioni veglieremo".
Il voto americano in Italia. Salvini è la “cheerleader” di
Trump: l' "Independent" sul leghista che evoca brogli sul voto americano.
Antonio Lamorte su Il Riformista il 6 Novembre 2020. Matteo
Salvini complottista sul voto americano: il segretario
della Lega sostiene Donald Trump e le sue teorie infondate sui voti illegali,
sui brogli, sul magheggio del voto postale che starebbe favorendo lo
sfidante Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca. Un complotto che il tycoon ha
ventilato in una conferenza stampa dalla residenza presidenziale e che i
principali network televisivi hanno tagliato in diretta. Nessuna prova: hanno
scritto a lettere cubitali i media. La Cnn ha parlato della notte più triste
della Storia degli Stati Uniti. E perfino FoxNews, la televisione più vicina a
Trump, ha stigmatizzato le sue dichiarazioni. Eppure le “menzogne”, come sono
state definite, del tycoon continuano a fare proseliti. Salvini le ha riprese e
rilanciate in un’intervista a Radio 24, tanto da essere definito
dall’Independent come la “cheerleader” del Presidente americano. “Il fatto che
in alcune Contee ci siano state più voti che votanti, più schede che persone, fa
venire qualche dubbio. Quindi, credo sia necessario stoppare e ricontare perché
è come se ci fossero due milioni di voti, dove ce ne sono un milione e 200mila”,
ha detto Salvini. E su cosa si basa il leader del Carroccio per sostenere questa
tesi? L’Independent spiega che tutto nasce – oltre che dalle dichiarazioni di
Trump – da alcune grafiche che circolano sui social che mostrerebbero questo
tipo di evidenza. E i dati riguarderebbero – che coincidenza – proprio Stati in
bilico come Pennsylvania, Nevada, Arizona e Georgia. In bilico fino a qualche
ora fa, visto che la rimonta di Biden in Pennsylvania e Georgia ha
definitivamente sbilanciato la corsa alla Casa Bianca a suo favore. La teoria
secondo cui ci sarebbero più voti che votanti in questi Stati è stata smontata
dal sito di fact-checker Snopes. Fake News, insomma, ma non per Salvini,
evidentemente. Che dopo aver copiato lo slogan al tycoon (“Prima gli italiani”
da “America First”) arriva a sostenere le sue tesi complottiste e perfino l’uso
dell’idrossiclorochina, come ha fatto lo stesso Trump, pur senza alcuna evidenza
scientifica a supporto del funzionamento e della sicurezza del farmaco contro
il coronavirus. “L’idrossiclorochina è un farmaco usato in Cina, Germania e
tanti altri Paesi e in Italia tanti medici la usano. Se mi ammalassi io la
chiederei”, ha detto durante l’intervista. Trump, secondo quanto scritto da Cnn,
non sarebbe neanche intenzionato a riconoscere la sconfitta.
CONTE, “LA
CHEERLEADER DI DONALD TRUMP”.
Da europa.today.it il 9 novembre 2020. “Giuseppe Conte cheerleader italiano di
Donald Trump”. È questo il titolo che il giornale online statunitense Politico,
nella sua pagina europea, ha riservato all'articolo sulla visita del presidente
del Consiglio italiano negli Stati Uniti. Il quotidiano ha definito la
conferenza stampa congiunta tra i due “strana” con il presidente americano “che
è sembrato contento della rara opportunità di apparire al fianco di un leader
mondiale con ancora meno esperienza diplomatica di lui”. “A differenza di altri
leader europei”, come la cancelliera tedesca Angela Merkel, il presidente
francese Emmanuel Macron e il primo ministro olandese Mark Rutte“che hanno usato
le loro conferenze stampa con Trump per evidenziare i disaccordi politici”,
Conte “ha applaudito Trump che rivendicava grandi trionfi, dal G7 in Quebec, al
Summit Nato e fino al vertice con il presidente russo Vladimir Putin a
Helsinki”, ha evidenziato David M. Herszenhorn, il corrispondete dal Bruxelles
del giornale. Inoltre il giornalista ha sottolineato il fatto che Conte ha
“elogiato” Trump per "le sue prese di posizioni espresse con chiarezza",
proclamato l'Italia come il nuovo "interlocutore privilegiato" di Washington in
Europa, e dicendo di “essere personalmente disposto a diffondere il vangelo di
Trump, in particolare sulla questione delle spese della Nato”. "Sarò,
personalmente, il portatore del messaggio, e cercherò di far capire anche agli
altri queste posizioni", ha detto il “messaggero” Conte.
Carmelo Lopapa per ''la Repubblica'' il 7 novembre 2020. La
mascherina bianca, stelle e strisce "Trump 2020", quella l'ha già tolta e
rimessa in tasca ieri. Per tornare a esibire davanti alle telecamere la classica
in versione tricolore nazional-populista. Quel «stanno emergendo brogli, ha
ragione Trump» di giovedì sera ha lasciato il posto a un più cauto «gli elettori
hanno sempre ragione: è stata una grande prova di democrazia». Metamorfosi (non
solo nel look) di Matteo Salvini. Fra i sovranisti italiani, certamente "orfano"
più di altri di The Donald. Perché come ha rimarcato l 'Independent non c'è
leader europeo che più del "nostro" si sia speso per la causa che ora dopo ora
appare ormai perdente. Dato che poi, in Italia, perfino la neo presidente dei
Conservatori europei Giorgia Meloni, pur schierata per i Repubblicani, ha
volutamente tenuto in questi giorni una linea più prudente. Per non dire di
Silvio Berlusconi, che saluta ora il probabile successo di Biden come la
conferma della necessità del "centro" rispetto agli estremismi sovranisti
destinati da soli alla sconfitta. La destra del tandem Lega-Fdi tuttavia fa
fatica a rassegnarsi al tramonto del sovranismo, appunto, convinta che perderà
forse Trump, ma non il "trumpismo" anche negli Usa. «Ma davvero qualcuno pensa
che possa essere penalizzato dal futuro presidente perché portavo la mascherina
pro Trump?», si sfogava ieri sera il leader della Lega coi suoi. «Se non sbaglio
era più amico di Conte, chiamava lui Giuseppi, mica me», è stato l'unico
commento a porte chiuse. Insolito silenzio sui social e in tv, invece,
ufficialmente in attesa del responso finale. Per l'immaginario internazionale
tuttavia Salvini resta - per dirla ancora con l'Independent - «la cheerleader
italiana di Trump che diffonde teorie cospirazioniste prive di fondamento sul
voto americano». Ma anche su questo fronte, quello dell'atlantismo, c'è Lega e
Lega. Bisogna "citofonare" al numero due e responsabile esteri Giancarlo
Giorgetti, per trovare un respiro decisamente meno ultrà. «Noi eravamo, siamo e
resteremo amici degli Usa, la nostra scelta atlantica non è mai stata messa in
discussione, è una "barra dritta" che ci sarà anche con Biden». L'ex
sottosegretario, che nel giugno 2019 è stato il gran tessitore della visita
dell'allora vicepremier a Washington (poi rivelatasi fallimentare), ammette a
Skytg24 che «c'era probabilmente un'affinità politica maggiore con Trump, ma
pensiamo si possano avere relazioni positive anche con la nuova
amministrazione». Insomma, lo andrebbe a incontrare? «Biden avrà altro a cui
pensare, se eletto, ma certo non avrei problemi ad andare». Sovranismo in crisi?
«No, ma quello che avviene negli Usa provoca sempre un'onda nel mondo e in
particolare in Europa», conclude il vicesegretario leghista. Quasi un monito.
Giorgia Meloni, tra i leader del centrodestra italiano, è l'unica ad aver
costruito davvero un rapporto coi Repubblicani, che l'ha portata a febbraio fino
al National prayer breakfast, a Washington, meeting concluso proprio dal
presidente Trump. Si è sempre augurata la riconferma, anche lei. Quella dei
Conservatori europei è una famiglia da sempre legata ai Repubblicani americani,
ma adesso la leader di Fdi non si strappa i capelli. E ripete che «i rapporti
con gli States non cambieranno ».
Che tempo che fa, Silvio Berlusconi contro Donald Trump:
“Troppo arrogante, ho già mandato auguri a Biden”.
Libero Quotidiano l'08 novembre 2020. “Non ho sentito Donald Trump. Credo che
abbia pagato per il suo atteggiamento di attacco, molto spesso troppo
arrogante”. Così Silvio Berlusconi ha commentato la sconfitta del presidente
americano in carica contro Joe Biden, lo sfidante democratico che sta per
conquistare la Casa Bianca grazie ai 306 voti elettorali ottenuti alle urne. Nel
collegamento telefonico con Fabio Fazio a Che tempo che fa - che ha ospitato la
sua prima apparizione televisiva dopo il Covid - il presidente di Forza Italia
ha svelato anche di aver già mandato gli auguri di buon governo a Biden, non
condividendo quindi la linea di Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che invece per
il momento si sono ben guardati di andare contro all’alleato Trump. “L’America
esce divisa da queste elezioni”, ha dichiarato il Cav che poi ha aggiunto: “Oggi
Biden lo ha detto nel suo primo discorso e credo che abbia chiara la necessità
di essere il presidente di tutti gli americani e questo credo possa essere un
bene anche per tutti noi”.
Carmelo Lopapa per “la Repubblica” il 9 novembre 2020.
L'imbarazzo della destra italiana. Spiazzata, per certi versi ammutolita dalla
vittoria finale di Joe Biden. Non sarà il presidente di Salvini e Meloni, lo si
sapeva, ma ormai si contano sulla mano i leader politici che nel mondo non hanno
riconosciuto almeno il risultato, se si fa eccezione per Bolsonaro in Brasile,
per gli emiri in Arabia Saudita e per i capi delle formazioni di estrema destra
europea. Non così Berlusconi, che saluta il nuovo inquilino della Casa Bianca e
dice che Trump «ha pagato per la sua arroganza». I sovranisti-populisti con lui
perdono il loro nume tutelare Oltreoceano. A far più rumore in Italia è il
silenzio di Matteo Salvini, che dai risultati in Pennsylvania e in Nevada di
sabato pomeriggio ha rilasciato sui social commenti sul commissario alla sanità
in Calabria o sulla sindaca Raggi. Ma non c' è più traccia della denuncia dei
"brogli" negli Usa, come della mascherina pro Trump. A dettare la linea della
Lega sui nuovi rapporti con Washington è il responsabile Esteri Giancarlo
Giorgetti, il vice che, come spesso accade nei momenti più complicati, indica la
rotta. O almeno ci prova. «Se la Lega vorrà davvero governare questo Paese sarà
importante dialogare con la nuova Amministrazione Usa», ha dichiarato ieri nell'
intervista a Repubblica , riconoscendo intanto il risultato. Almeno lui. Quel
che Salvini lascia trapelare, per ora, è che si è trattato di «una grande prova
di democrazia» (dunque si suppone che non ci siano stati brogli), che «gli
elettori hanno sempre ragione» e che «per la Lega l' Italia era e sarà sempre
amica degli Stati Uniti». Giorgia Meloni ha detto la sua solo ieri pomeriggio
via Facebook, ma parlando di «possibile vittoria dei democratici», ancora non
certa, dunque. «Non penso che l' Italia faccia una bella figura con tutte queste
cheerleader strepitanti - scrive - la nostra visione di politica estera si basa
sull' interesse nazionale italiano e prescinde dalle tifoserie di parte». A
differenza del leghista, non ha mai indossato mascherine pro Trump o fatto
proclami. In nome dell'«orgoglio nazionale», come ripete ai suoi, nessun "tifo"
per un capo partito o di Stato straniero. Si muove ormai da presidente dei
Conservatori europei, del resto. Una linea che il capo delegazione a Bruxelles
di Fdi e responsabile Esteri, Carlo Fidanza, declina così: «C' è un rapporto
storico di amicizia tra i due Paesi che non viene messo in discussione, se Biden
sarà presidente, dialogheremo con lui. Nella speranza che su Cina e Medioriente
dia continuità alle scelte di Trump». Silvio Berlusconi è su tutta un' altra
sponda. Lo ha chiarito quando ieri sera Fabio Fazio gli ha chiesto a "Che tempo
che fa" se fosse contento del nuovo presidente. «Guardi, io ho mandato già i
miei auguri di buon governo a Biden, l' America è divisa ma credo che lui abbia
chiara la necessità di essere presidente di tutti gli americani e penso che
questo possa essere un bene anche per tutti noi. Trump? Ha pagato il suo
atteggiamento molto spesso troppo arrogante ». Altro che mascherine e brogli.
Mario Ajello per ''Il Messaggero'' il 7 novembre 2020. Con Trump,
Berlusconi non s' è mai preso. Su Biden invece ci punta, anche per ricostruire
quel rapporto tra Stati Uniti e Europa che al Cavaliere sta a molto cuore. In
più, è la versione di Silvio, la sconfitta di The Donald e l'affermazione del
suo avversario sono la dimostrazione che si vince al centro. Lì dove si colloca,
nel campo dei moderati, Forza Italia. Berlusconi ha vissuto, via tivvù, la
partita americana come se la guardasse da vicino e il risultato lo trova
piuttosto ottimista per quello che avverrà tra le due sponde dell'Oceano. E lo
conferma nella sua convinzione: una destra alla Trump non è quella capace di
raccogliere, anche qui da noi, la maggioranza dei consensi.
Presidente, come crede che sarà l'America di Joe Biden?
«Ciò che conta è che i rapporti transatlantici si consolidino per
affrontare alcune grandi sfide: dalla tutela dei comuni interessi commerciali
con la Cina al consolidamento della Nato, dalla lotta al terrorismo islamico
alla pace nel Mediterraneo ed in Medio Oriente con la tutela dei diritti di
Israele, dalla difesa della democrazia e della libertà in paesi sudamericani
come il Venezuela allo sviluppo del continente africano libero da ingerenze di
Pechino».
Come cambieranno i suoi e i vostri rapporti con gli Stati Uniti?
«L'America per noi è un grande alleato strategico, con il quale
condividiamo valori e interessi. La vicinanza e la gratitudine verso gli Stati
Uniti, da sempre garanti della libertà nel mondo, non verranno mai meno».
La questione Covid sembra aver influito nella vicenda americana.
E anche qui è diventato il centro di ogni questione politica. Il nostro governo
poteva arrivare più preparato a questa seconda fase?
«Certamente sì. Da mesi avevo messo in guardia, in tutte le
occasioni possibili, contro il rischio di una seconda ondata dalle conseguenze
ancora più gravi della prima. Occorreva e occorre lavorare per adeguare le
strutture sanitarie, per costruire reparti Covid e terapie intensive, per
predisporre un tracciamento serio e dettagliato, per formare nuovo personale.
Continuo a non capire come si possa rifiutare di utilizzare i fondi del Mes che
servirebbero proprio a questo scopo».
Se ci fosse stato un governo di centrodestra che cosa avrebbe
fatto di diverso e di meglio rispetto al governo Conte?
«Il centro-destra avrebbe agito in maniera diversa, ma non è
questo il momento delle polemiche. E' il momento di unire gli sforzi guardando
al futuro piuttosto che al passato. Dobbiamo pensare a salvare gli italiani
prima dalla malattia e poi dalle disastrose conseguenze economiche di quello che
sta avvenendo. Questo significa per esempio indennizzo immediato a tutti coloro
che hanno dovuto chiudere la propria attività e hanno perso il lavoro».
Si è dato troppo potere alle Regioni e ora va cambiato il titolo
V della Costituzione che lo consente?
«Il problema del rapporto Stato-Regioni certamente esiste. Ma
oggi è scorretto invocare questo tema per svalutare il grande lavoro che molte
regioni hanno compiuto per fronteggiare un'emergenza senza precedenti».
Ora serve un governo di unità nazionale?
«L'unità nazionale deve esistere intorno alle istituzioni. Un
governo di unità nazionale non è possibile né auspicabile. Quello che occorre
invece è uno sforzo concorde di tutte le forze politiche, ma anche del resto
della classe dirigente del Paese, dall'imprenditoria alla cultura, per uscire da
questa situazione».
Lei condivide il ricorso alle piazze? I moderati non dovrebbero
evitarle?
«Premesso che noi non promuoviamo alcuna manifestazione di
piazza, dico però che bisogna distinguere. Capisco perfettamente i commercianti
che vanno in piazza per denunciare la drammatica situazione nella quale molti di
loro si sono venuti a trovare. Condanno fermamente invece chi usa la piazza in
modo violento, chi fa del teppismo sfruttando il malcontento, chi attacca le
forze dell'Ordine o le proprietà dei cittadini. Questo non può essere tollerato
e si deve reagire con la massima fermezza.
Lei è sempre stato a favore di più poteri e più risorse per Roma?
Non è questo il momento di battersi?
«E' un'antica battaglia di Forza Italia, fortemente propugnata da
Antonio Tajani e dai nostri parlamentari romani. In realtà una legge esiste già,
è stata fatta nel 2009 dal nostro governo, e prevede una serie di poteri
speciali per Roma Capitale. Basterebbe applicarla e questo dipende da Governo,
Regione e Comune. In questa legislatura Forza Italia ha anche proposto una legge
costituzionale, a prima firma Barelli, per assegnare a Roma uno status
particolare, analogo a quello delle grandi capitali europee, Londra, Parigi,
Berlino.
Il primo progetto che lei farebbe per il rilancio della Capitale?
«Difficile rispondere: Roma è forse la città più bella, più
conosciuta, più amata del mondo, ma è gravata da problemi immensi. Anche
questioni banali come le buche nelle strade e la raccolta dell'immondizia
sembrano irrisolvibili. C'è poi il grande tema dei quartieri: Roma non è
soltanto il centro storico, sul quale si concentra l'attenzione. Esistono vaste
aree della città abbandonate a sé stesse. Le periferie, dove vivono centinaia di
migliaia di romani, meritano un intervento di riqualificazione speciale.
Sicurezza e lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti devono diventare una
priorità. Anche per il governo. L'immagine di Roma è l'immagine dell'Italia. E
poi occorre trovare una soluzione all'enorme problema del debito. Ma questa è
ordinaria amministrazione. Roma meriterebbe molto di più: mi piacerebbe che ci
fosse qualcuno capace di volare alto, di avere una visione, un progetto, un
sogno. Che sappia capire il potenziale che questa città ha nel mondo e che
sappia e voglia raccogliere il messaggio che viene dalla sua storia e
rilanciarne il volto e l'immagine».
Si parla della possibilità di rinviare - causa Covid - le
elezioni comunali di primavera. Sia a Milano sia a Roma. Che cosa ne pensa?
«Il rinvio delle elezioni è sempre una cosa grave, in democrazia.
Spero davvero che da qui alla prossima primavera le condizioni sanitarie
consentiranno di andare a votare in condizioni di sicurezza».
Al centrodestra piacerebbe mandare Berlusconi sul Colle. I
moderati del centrosinistra potrebbero appoggiarla. Per lei il Quirinale è un
sogno possibile?
«Il Quirinale è autorevolmente occupato e lo sarà ancora per
diverso tempo: discuterne oggi è anche irrispettoso verso il Presidente
Mattarella».
Maria Giovanna Maglie su Donald Trump: "Brogli nelle elezioni
americane? Parecchi e vistosi", per il presidente non è finita?
Libero Quotidiano il 4 novembre 2020. Maria Giovanna Maglie in
collegamento con il Tg4 è stata un fiume in piena contro i sondaggisti che,
proprio come quattro anni, ci hanno capito poco o nulla delle elezioni
presidenziali americane. Al punto che alla giornalista è venuto il sospetto che
lo facciano quasi per “lavoro”, anche se concorda nel definirli i grandi
sconfitti, dato che Donald Trump era dato praticamente per spacciato e invece è
lì a battersi con ardore, anche se sfavorito rispetto a Joe Biden per come si è
messa la situazione, dato che al candidato dem basta tenere in Nevada e Arizona
(dove è in vantaggio) per vincere la corsa alla Casa Bianca. “Non solo i
sondaggisti sono stati incapaci - ha attaccato la Maglie - ma sono anche
responsabili dei problemi del dopo voto perché se tu per mesi racconti una cosa
che non corrisponde alla verità, copri la realtà elettorale e influenzi il voto,
perché chi ha voglia di votare per un candidato perdente? Se per mesi ci
raccontano che c’è la marea blu, il risultato poi rischia di essere questo”. La
giornalista non ha concluso qui, dato che ha affrontato anche la polemica dei
presunti brogli innescata da Trump: “Se ne sta aspramente discutendo in queste
ore, pare che ci siano parecchi e vistosi brogli e ambiguità”.
Andrea Morigi per “Libero quotidiano” il 6 novembre 2020. Chi
vota non decide nulla, mentre chi scrutina i voti decide tutto. L' esito delle
presidenziali statunitensi, comunque vada, è il furto del secolo, non solo ai
danni di Donald Trump, ma di ogni singolo elettore americano. Alle testimonianze
non ancora censurate dai social network, che spiegano come il voto per
corrispondenza sia stata l' arma più efficace per i Democratici, si oppone l'
Osce - l' Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa - i cui
osservatori non si sono accorti di alcun broglio. Del resto, non hanno avuto la
solerzia di andare a controllare se negli elenchi degli aventi diritto al voto
ci fossero dei morti oppure, come in Nevada, ben 10mila persone che non vivono
più lì e si sono recate alle urne benché siano registrate altrove. E nemmeno si
sono premurati di verificare le denunce degli impiegati postali verso i
capiufficio, che imponevano loro di stampigliare la data del 3 novembre sulle
schede arrivate successivamente, come riportato dal giornalista investigativo di
@Project_Veritas, James O' Keefe. «Ogni voto arrivato dopo l' election day non
sarà contato», tuona Trump dal suo account Twitter, chiedendo di «Fermare il
conteggio». Ed è convinto che «se si contano i voti legali vinco facilmente le
elezioni! Se si contano i voti illegali e quelli in ritardo, possono rubarci le
elezioni». Non basta. Occorrerà capire il motivo degli improvvisi picchi di
preferenze che hanno consentito una rimonta a Biden in Michigan e in Wisconsin.
Le squadre dei legali, capitanate da Rudolph Giuliani, ex sindaco di New York
City, e Jay Sekulow, uno dei principali avvocati che hanno difeso il presidente
dall' impeachment, sono pronte a lanciarsi nella disputa. Per ora, in Michigan
il primo assalto è stato respinto dal giudice di una corte statale, secondo il
quale era stato garantito un numero di accessi sufficienti ai rappresentati del
partito repubblicano ai seggi durante il conteggio delle schede. Anche Biden si
è presentato all' appuntamento con un agguerrito team legale, guidato da Dana
Remus, consulente legale della sua campagna. Al suo fianco vi è Bob Bauer, ex
consigliere legale della Casa Bianca e delle campagne elettorali di Barack
Obama. La Remus ha organizzato una «unità speciale per il contenzioso» con gli
ex procuratori Donald Verrilli e Walter Dellinger, che guidano centinaia di
avvocati pronti a combattere Stato per Stato. I ricorsi e i riconteggi
riguardano sei Stati in bilico: L' Alaska, con 3 Grandi elettori, l' Arizona
(11), la Georgia (16), il Nevada (6), la North Carolina (15) e la Pennsylvania
(20). Ma per ora Biden non è riuscito a ottenere i 270 voti elettorali
necessari, fermandosi a 264, cioè 50 più del rivale, che tuttavia teoricamente
potrebbe conquistarne altri 60 e restare così alla Casa Bianca. Ma, se proprio
dovesse andare male, il magnate potrebbe tentare di riconquistare la Casa Bianca
tra quattro anni. L' idea, tecnicamente possibile in base alla Costituzione Usa,
viene proposta da diversi suoi ex consiglieri ed è possibile che presto arrivi
direttamente alle orecchie del presidente. Parlando al programma Today della
Bbc, Bryan Lanza, ex consigliere di Trump, ha detto di ritenere che il
presidente si troverebbe in «buona posizione» per correre di nuovo nel 2024.
Anche Steve Bannon, ex capo stratega di Trump e uno degli architetti della
vittoria nel 2016, il mese scorso, prima del voto, aveva detto che, anche in
caso di sconfitta, «non vedrete la fine di Donald Trump». Una nuova candidatura
non è vietata dalla Costituzione, che al 22esimo emendamento recita: «Nessuno
potrà essere eletto alla carica di presidente più di due volte», ma non accenna
a un limite di tempo nel quale i due mandati si possono espletare. In tal modo,
Trump potrebbe saltare un turno ed essere rieletto per un secondo mandato
singolo. Non sarebbe il primo nella storia nordamericana. Nel 1892, il
presidente Grover Cleveland fu rieletto alla Casa Bianca, dopo essere divenuto
presidente nel 1884, ma fallendo la rielezione nello scontro col rivale
repubblicano Benjamin Harrison.
Il “postino” bussa solo per Biden e Trump non ha torto a
sospettarlo. Ecco perché. Lando Chiarini mercoledì 4
Novembre 2020 su Il Secolo d'Italia. Si scrive Rust Belt, si legge Far West.
Visti sulla cartina, gli Stati compresi tra la catena nord degli Appalachi e
i Grandi Laghi sono distantissimi dalle ricche terre del lontano ovest che oltre
un secolo e mezzo fa scatenarono la corsa all’oro. Politicamente, invece,
c’entrano molto. Perché è proprio l’esito del duello elettorale
tra Trump e Biden in quegli Stati in bilico a dirci se gli Usa sono ancora una
grande e potente nazione o il set di un film western. La situazione è appesa a
un filo. E questa volta non c’entra la drammatizzazione dei media o l’allarmismo
dei soliti esperti. L’America che noi conosciamo e che per tanti versi amiamo
quasi non esiste più. E non per colpa di Trump. Almeno non solo. Vero,
l’attuale presidente ha rinfocolato vecchie tensioni, ma è altrettanto vero che
esse scorrevano carsicamente da sempre nella società statunitense. Così com’è
vero che ha saputo radicarsi elettoralmente nelle classi meno abbienti. Si è
presentato come il vindice dei lavoratori emarginati dalla globalizzazione e
appiedati dalla delocalizzazione degli impianti. Ma anche delle vittime della
grande bolla finanziaria del 2007. Che forse neanche sarebbe scoppiata se nel
1999 Bill Clinton non avesse abrogato la legge Glass-Steagall che dal 1933
separava le banche commerciali da quelle d’affari. L’aveva voluta Roosevelt per
erigere un muro tra il risparmio dei cittadini e le speculazioni finanziarie
senza rete. Clinton lo abbattè un minuto prima di lasciare la Casa
Bianca varando il Gramm-Leach-Bliley Act. È su questo vulcano in ebollizione
che si è innestata la riacutizzazione della questione razziale. Il mainstream ne
ha presentato il conto a Trump, sdoganando a livello planetario la protesta
dei Black Lives Metter. Ma violenze contro i neri furono commesse
dalla polizia anche con Obama. Sia chiaro: Trump non è esente da colpe. Ma il
solco che ha approfondito serviva soprattutto a tenere a distanza un Deep
State che non lo ha mai accettato. E lui ha ricambiato fino al paradosso di
un capo di Stato che diffida di quel che lui stesso rappresenta. È il motivo per
il quale ha bollato sin da subito come «fonte di imbrogli» il voto per posta.
Vero o falso, si vedrà. O forse non lo capiremo mai. Di sicuro c’è che sin da
subito proprio lì Biden e democrats hanno fondato le loro speranze di vittoria.
«L’onda blu è nelle buste», ha titolato profetico il New York Times, alludendo
al voto per corrispondenza. E il postino, si sa, bussa due volte solo nei film.
Elezioni americane, “schede bianche truccate”.
Rec News il 6 Novembre 2020. Le schede senza preferenza relative
alle ultime elezioni presidenziali degli Stati Uniti sarebbero state manipolate.
E’ quanto mostrano… on ci sono solo i “voti cinesi” per posta. Le schede bianche
relative alle ultime elezioni presidenziali degli Stati Uniti sarebbero state
manipolate. E’ quanto mostrano diversi video che stanno circolando sul web.
Donald Trump aveva già denunciato l’impossibilità di accedere ad alcuni seggi da
parte degli “osservatori”, personale deputato alla sorveglianza della
correttezza delle operazioni di voto. Contestualmente, tuttavia, gli scrutini
stando a quanto è stato possibile appurare sarebbero stati ripresi da telecamere
e da dispositivi indossabili.
Beatrice Pagan per movieplayer.it il 6 novembre 2020. Bernie
Sanders aveva previsto alla perfezione cosa sarebbe accaduto durante le elezioni
presidenziali americane in occasione una partecipazione al talk show condotto da
Jimmy Fallon. Il senatore aveva persino anticipato che Donald Trump avrebbe
dichiarato, senza fondamento, di aver vinto le elezioni. In un video si può ora
rivedere Bernie Sanders che dichiara: "Ogni voto deve essere contato. Sospetto
che in stati come Pennsylvania, Michigan, Wisconsin e altri, si riceverà
un'enorme quantità di voti via posta. A differenza di stati come Florida e
Vermont, non potranno scrutinare i voti fino all'Election Day o fino alla
chiusura dei seggi. Quindi significa che ci saranno degli stati che dovranno
fare i conti con milioni di voti via posta". Il senatore aveva inoltre
dichiarato: "Potrebbe inoltre accadere che alle 10 di sera della notte delle
elezioni, Trump starà vincendo in Michigan, in Pennsylvania, in Wisconsin e
andrà in televisione per dire 'Grazie americani per avermi rieletto, è tutto
finito, buona giornata'. Ma poi il giorno successivo e quello dopo ancora, tutti
questi voti via posta inizieranno a essere contati e si scoprirà che Biden ha
vinto in quegli stati e a quel punto Trump dirà "Ecco? Vi ho detto che c'erano
delle frodi. Vi avevo detto che i voti via posta sono truccati. Quindi ora non
ce ne andremo"". Sanders aveva quindi le idee chiare già da tempo e quello che
aveva detto si è trasformato in realtà, con il risultato delle elezioni
presidenziali americane ancora in sospeso, in attesa di conteggiare tutti i voti
validi.
Elezioni Usa 2020, l'ombra del presidente Hayes sulla corsa
Trump-Biden. Stando ai conteggi del momento la sfida
per la Casa Bianca potrebbe essere la più contestata dal 1876, quando un solo
voto elettorale divise repubblicani e democratici. Anche quella volta ci furono
contestazioni, accuse di brogli e la nomina slittò fino a marzo. Ecco perché si
rischia un esito analogo. Gianfranco Turano su L'Espresso il 04 novembre 2020.
Potrebbe essere l'elezione più tirata dai tempi di Rutherford Hayes contro
Samuel Tilden nel primo anniversario dell'Indipendenza (1876). Allora finì 185 a
184 per il repubblicano Hayes dopo mesi di contestazioni, denunce di frode,
violenze di piazza e la costituzione di una commissione composta da senatori,
deputati e giudici della Corte Suprema. A metà pomeriggio in Europa la
situazione dei conteggi negli Usa presenta ancora sette stati da conteggiare:
Pennsylvania, Wisconsin, North Carolina, Georgia, Alaska, Arizona, Michigan. Se
Joe Biden vincesse tutti gli stati in cui si trova avanti nel conteggio in
questo momento, spesso per poche migliaia di preferenze, a lui andrebbero
Michigan, Wisconsin, Arizona e Nevada per un totale di 43 voti. Aggiunti ai 227
che lo sfidante democratico ha già si arriverebbe alla quota minima di 270 voti
sufficiente per vincere la corsa alla Casa Bianca. Mentre è in corso lo
scrutinio, il presidente in carica Donald Trump ha un vantaggio considerevole in
Pennsylvania, lo stato in attesa di conteggio che al momento vale il maggior
numero di grandi elettori (20). Trump è largamente in testa anche in Alaska (3
voti elettorali) dove ha quasi doppiato Biden. La situazione è più equilibrata
nei due stati sotto la Mason-Dixon line, Georgia (16 voti elettorali) e North
Carolina (15 voti elettorali). Nei conteggi al Sud in questo momento il
presidente batte il rappresentante democratico con un margine fra 100 e 150 mila
voti, all'incirca lo stesso vantaggio che Biden ha su Trump in Arizona. Ma in
Nevada, Michigan e Wisconsin, la corsa è “too close to call”. I margini
ristretti rendono impossibile dire chi vincerà ma è già possibile dire che, se
Biden non porta a casa gli stati che lo vedono in vantaggio, sarà difficile per
lui non concedere la vittoria. Chi non concederà la vittoria a nessun costo e
con nessuno scenario è proprio il presidente in carica. Trump teme, e lo si è
visto molto presto nella notte americana, l'esito dei conteggi sul voto postale
che vale ancora diversi milioni di preferenze. Il tycoon repubblicano è
consapevole che le mailbox riservate al voto e sparse nei vari stati possono
portargli una sconfitta che, prima del disastro Covid-19, sembrava impossibile
di fronte a un avversario più vecchio di lui, privo di qualunque attrattiva. Se
è vero che le cassette postali votano democratico, sarà battaglia legale come
nel 1876. Allora il primo vincente sembrava essere Tilden con un risultato di
184 a 166. Mancavano 19 voti elettorali e andarono tutti a Hayes. Certo erano
tempi diversi. Molti stati di oggi erano semplici “territori” nelle Grandi
Pianure dell'Ovest dove i nativi americani circolavano ancora e facevano
l'ultimo tentativo di alleanza contro l'invasione bianca culminato nella
battaglia vinta a Little Big Horn (25 giugno 1876). Ma a Washington la guerra
per la Casa Bianca fu spietata quanto si annuncia adesso. Hayes, abolizionista
secondo la linea fissata da Abraham Lincoln a ridosso della Guerra civile, giurò
da diciannovesimo presidente il 3 marzo 1877. A questo punto del conteggio non è
escluso che finisca in modo simile.
Gli aggiornamenti sul voto americano.
Elezioni Usa: Biden verso la vittoria, Trump denuncia
“irregolarità allarmanti” ma i media lo smentiscono. Redazione su Il Riformista
il 5 Novembre 2020. Al terzo giorno di spogli e calcoli di Grandi Elettori,
le elezioni americane sembra stiano arrivando a un risultato. Joe Biden, salvo
imprevedibili sorprese, si appresta a diventare il 46esimo presidente
degli Stati Uniti d’America. Ancora da assegnare alcuni Stati: l’Alaska,
l’Arizona, il Nevada, la Pennsylvania, la Georgia e North Carolina. Il candidato
democratico al momento è a 253 Grandi Elettori contro i 214 di Donald Trump.
Sono 270 per conquistare la Casa Bianca. Per vincere Biden ha bisogno della
Pennsylvania (da molti considerato lo Stato chiave di queste elezioni) oppure
due Stati tra Arizona, Nevada e Georgia. Si riducono sempre più le opportunità
di Donald Trump: il presidente in carica avrebbe bisogno oltre alla Nord
Carolina e all’Alaska, nelle quali è più avanti, anche necessariamente della
Pennsylvania con Georgia e Nevada o con Arizona e Georgia.
I CANDIDATI – Biden ha parlato in conferenza al fianco della
candidata vice-presidente Kamala Harris. Il candidato democratico si è detto
fiducioso e ha annunciato che sarà “presidente di tutti gli americani”. Ha anche
anticipato che gli USA rientreranno negli accordi sul clima di Parigi.
Tutt’altro ambiente in casa repubblicana: Donald Trump ha chiesto il riconteggio
dei voti in Wisconsin e ha lanciato azioni legali per bloccare lo spoglio in
Georgia, Michigan e Pennsylvania. “Stanno tentando di rubarci le elezioni”, ha
detto Trump.
TRUMP DENUNCIA IRREGOLARITA’, LE TV LO TAGLIANO – “Pensiamo che
ci saranno molte controversie perché non possiamo farci rubare un’elezione come
questa” ha detto il Presidente Donald Trump in diretta dalla Casa Bianca. La
sfida elettorale sarà decisa dalla Corte Suprema secondo il tycoon che ha
denunciato “varie irregolarità allarmanti” e che ha assicurato come “il nostro
obiettivo è proteggere l’integrità delle elezioni, non consentiremo che ce le
rubino, che i nostri elettori siano silenziati”. Parole eversive, secondo alcuni
media. Il network che comprende Abc, Cbs e Msnbc. L’anchorman Brian Williams,
per esempio, ha commentato: “Ci troviamo ancora nella posizione inusuale non
solo di interrompere il presidente degli Usa ma anche di correggerlo”.
DISORDINI – Vanno avanti in queste ore disordini e scontri in
diverse città. A Washington, Portland, nella contea di Maricopa in Arizona, a
Denver e a Minneapolis. A New York decine di persone sono state arrestate. Le
tensioni sono esplose durante una protesta pacifica. I media locali hanno
scritto che la manifestazione è degenerata a causa di un gruppo di persone che
ha lanciato uova contro la polizia. Altri manifestanti hanno dato fuoco a dei
cassonetti di rifiuti e hanno sfondato le vetrine di negozi. Centinaia di
persone nel Washington Square di Manhattan si sono riunite per chiedere il
ri-conteggio dei voti.
SOVVERSIVO – Le parole di Trump sono state stigmatizzate da tutti
i media americani, anche dalla maggior parte di quelli conservatori o più vicini
ai repubblicani. Il rischio, secondo questi, è che le denunce di brogli, del
negato accesso agli osservatori ai seggi, possa esacerbare gli animi. Parole
sovversive, da parte del presidente, secondo i commentatori.
IL PUNTO ALLE ORE 7:00 – Manca ormai poco, qualche ora e il mondo
saprà chi sarà il prossimo presidente degli Stati Uniti. Gli stati in ballo sono
sempre gli stessi: Georgia, Pennsylvania, Nevada e Arizona. I primi risultati ad
arrivare dovrebbero essere quelli di Pennsylvania e Georgia. Se dovesse essere
chiamata prima la Pennsylvania, che vanta 20 elettori, Biden risulterebbe
vincitore. Con questi raggiungerebbe i 273 Grandi Elettori in virtù dei suoi
attuali 253. Lo sfidante democratico parla da presidente ma lancia appelli alla
pazienza. Trump accusa i democratici di scippare le eversioni. I media americani
hanno definito il suo discorso dalla Casa Bianca come infarcito di menzogne e
sovversivo.
DAGONEWS l'11
novembre 2020. Melania Trump deve ancora chiamare Jill Biden dopo le elezione
del marito a 46° presidente degli Stati Uniti. Seguendo la linea adottata dal
marito che continua a farneticare su brogli e ricorsi, rifiutandosi di concedere
la vittoria all’avversario, anche Melania non ha chiamato la nuova first lady in
entrata alla Casa Bianca. Come da tradizione la vecchia first lady invita la
nuova alla White House per un tè. Melania era stata accolta da Michelle Obama e
la stessa Michelle aveva ricevuto il benvenuto da Laura Bush. Ma questa volta la
transizione, anche nell'ala est, non è così semplice. Jill Biden, intanto, sta
lavorando alla creazione del suo staff e alla definizione della sua agenda come
first lady, che avrà come priorità l’istruzione, i veterani e la lotta al
cancro.
Fra. Sem.
per “la Stampa” l'11 novembre 2020. Tra chi vuole mettere fine all' avventura
politica di Donald Trump e famiglia sembra esserci Ivana, la prima moglie del
presidente. «Non gli piace perdere, quindi si batterà», afferma in un'
intervista a People auspicando però di attendersi che i suoi figli - Ivanka,
Donald Trump Jr e Eric - tornino a New York alle loro «vite normali». «Penso si
siano divertiti ma, grazie al cielo, è finita», dice l' ex modella ceca ora
imprenditrice. Parole che aprono scenari poliedrici sul futuro dell' ex marito e
della prole. Il distacco dalla politica, per nulla scontato, si tradurrebbe in
un ritorno agli affari di famiglia, a quella Trump Organization che dalle ultime
dichiarazioni dei redditi non appare navigare in acque placide e sulla cui testa
pende la spada di Damocle delle inchieste ancora in corso, specie a New York. Il
presidente sostiene che la permanenza alla Casa Bianca è costata dai 3 ai 5
miliardi di dollari in mancati guadagni, soprattutto all' estero a causa dei
vincoli etici. Decaduti i quali Trump & family potrebbero tornare a fare affari
diversificando, sia attraverso tradizionali attività immobiliari sia per mezzo
di concessioni. Una sorta di franchising del marchio «Trump» per attività
disparate come moda, ristoranti, agenzie di viaggi, Internet. Ci sono in ballo
potenziali accordi di collaborazione con istituzioni di Paesi esteri (ad esempio
in Medio Oriente) a cui Trump ha lasciato il biglietto da visita da presidente.
L' ipotesi di rimanere in politica rimane centrale, se ne faccia una ragione
Ivana: in previsione di un «Trump 2024», con il trio Donald, Ivanka e Don Jr.
Opzione che va ben ponderata in termini di ricadute sui bilanci del gruppo. L'
ipotesi più accattivante è però quella della televisione. Con un' esperienza nel
reality «The Apprentice», l' ultima consistente fonte di reddito del gruppo,
Donald potrebbe tornare in tv in veste di commentatore politico o in altro
ruolo, e così i figli. C' è l' idea del lancio di una rete in stile Bloomberg, e
non può mancare l' opzione del libro, biografico, sui quattro anni al 1600 di
Pennsylvania Avenue. E per finire lo attendono i discorsi a pagamento: perché
Trump potrà anche non essere più presidente, ma sarà per sempre in campagna
elettorale.
Articolo del “New York Times” – dalla rassegna stampa estera
di “Epr comunicazione” il 17 novembre 2020. Solo cinque anni fa Jared e Ivanka
erano i reali dei dinner party qui a Manhattan. È quel tipo di posto. Avevano
soldi, avevano la gioventù, avevano la celebrità. Erano magri. Mi hanno detto
che le loro maniere erano impeccabili, quindi non si direbbe mai che il padre di
lui fosse un vero criminale e quello di lei uno di fatto. E poi, non si può
mettere la famiglia contro qualcuno, no? Non siamo noi a scegliere come nascere.
Ma da quel momento in poi, facciamo delle scelte, e ne siamo responsabili. Jared
e Ivanka stanno per essere ritenuti responsabili – scrive il NYT. Hanno scelto
di legare la loro fortuna a quella del padre, hanno scelto di andare avanti,
hanno scelto di vedere fino a che punto poteva portarli. E se Ivanka diventasse
la prima presidente donna, cosa che i suoi conoscenti di Manhattan mi hanno
assicurato che lei ha immaginato. Lei e Jared hanno razionalizzato i capricci
del padre, alimentato le sue illusioni, sbiancato la sua crudeltà e mantenuto
l' Instagram di Ivanka a fuoco con le immagini della loro nuova favolosa vita a
Washington. Laggiù, vicino al confine: bambini migranti in gabbia. Laggiù,
vicino al Potomac: Ivanka tra i loro tableaux dorati. Sono la coppia di
figuranti faustiani della presidenza Trump, il re e la regina del ballo della
tortura in cui tanti hanno ballato al loro fianco, anche se con un abbigliamento
meno squisitamente sartoriale. Sono Mitch McConnell dopo un restyling, Ted Cruz
andato alla scuola di charme, Mike Pompeo con un regime di fitness più rigoroso,
Lindsey Graham con meno tempo sulle piste. Sono Mike Pence e Nikki Haley e
decine di altri dentro e fuori dall'ufficio, così affascinati dal potere, così
incantati dai vantaggi, così pronti per i futuri premi, che hanno strappato
valori che si supponeva avrebbero sempre tenuto e declassato la decenza a
qualcosa di ornamentale, un rametto di prezzemolo su un filetto di pesce. Dimmi,
Jared. Sii onesta, Ivanka. Ne è valsa la pena? È una domanda per l'intera corte
di collaboratori, scioccamente popolosa, intorno al presidente Trump. Il tempo
lo dirà. Il trumpismo non sta finendo. Lo stesso Trump non se ne va. Avrà il suo
PAC, forse avrà la sua nuova impresa mediatica, c'è quella voce - la chiamerei
una minaccia - che sta guardando al 2024. Un carro agganciato al suo potrebbe
non essere ancora arrivato al fosso. Ma il carro che apparteneva a Jared e
Ivanka era diverso dagli altri. Non si adattava bene alla variegata carovana di
espedienti e ambizioni dell'amministrazione Trump: Erano truffatori piu' loschi.
Quella dissonanza li faceva deridere in modo particolare, perché era
un'illustrazione particolarmente inquietante dei compromessi che la gente è
disposta a fare, dei compromessi cui si può scendere. I compagni evangelici di
Pence e Pompeo non li hanno e non li rimprovereranno per il loro culto di Trump,
perché tutti insieme hanno trovato quella religione contorta. E nessun
osservatore serio è disilluso da McConnell, perché nessun osservatore serio si è
fatto illusioni su di lui. Fa quello che deve fare per massimizzare il suo
impatto. Ma che dire di Jared e Ivanka? Essi incarnano la classe elitaria, molto
titolata, degli americani di Davos che suo padre derideva. Ma si
accontenteranno davvero del loro nuovo habitat sociale, ora che il 1600 di
Pennsylvania Ave. non è più il suo club? Dove, geograficamente, si piazzeranno?
Questa è stata una domanda esplorata in modo prominente nei giorni scorsi su
Vanity Fair e CNN, che li ha ritratti più o meno come "vagabondi
Vuitton". Washington non funzionerà, nemmeno una suite al Trump International
Hotel, perché non c'è niente di più patetico che soffermarsi a una festa una
volta che la musica si è fermata. Mar-a-Loco non è probabile. È la casa dei
giochi di Melania, e lei e Ivanka suonano insieme con la stessa dolcezza di
Andrew Cuomo e Bill de Blasio. Il New Jersey è il luogo dove i Kushner hanno le
loro radici, ma Ivanka è abituata ad avere più sfarzo. A questo punto sono
Aspen, non Asbury Park. Ho dei suggerimenti. La Corea del Nord, per esempio.
Ivanka ha incontrato il suo sovrano ed è stata nella Zona Demilitarizzata. Non
dovrebbe chiedere indicazioni. L'Arabia Saudita. Jared e il principe Mohammed
bin Salman sono gemelli spirituali, uniti dal loro senso di superiorità. La
Russia. Sì, la Russia! Sarebbe la scelta poetica, così da portare l'avventura
presidenziale della famiglia Trump a pieno titolo. Ma è New York City, dove
Ivanka possiede ancora un appartamento, che sicuramente attira il loro sguardo.
E questo è, beh, imbarazzante. L'amministrazione Trump l'ha definita una
"giurisdizione anarchica" nel tentativo di negarle 12 miliardi di dollari di
fondi federali. Ivanka avrebbe qualcosa da spiegare. Potrebbe non trovare molte
persone disposte ad ascoltare. "Chiunque abbia rispetto di sé, una carriera, una
morale, il rispetto per la democrazia, o non voglia che i suoi amici li
svergognino sia in privato che in pubblico, se ne starà alla larga", ha detto a
Emily Jane Fox, una loro ex conoscente non identificata, per il suo articolo su
Vanity Fair. Un altro ha detto: "Ivanka non è la principessa Margaret e Jared
non è il Duca di Windsor che intrattiene gli ospiti con divertenti storielle.
Nessuno vuole sentir parlare delle torte di Sarah Huckabee o delle camicie di
Steven Bannon". Javanka non può protestare dicendo di aver moderato il
presidente, non dopo le sue smodate settimane di rabbia contro la democrazia e
di connivenza per sovvertirla. Non possono rivendicare retroattivamente una
qualche profonda ma soppressa ambivalenza sul suo regno, non dopo la sua
fantasmagoria di fangirl alla convention repubblicana. No, sono artefici essi
stessi della loro situazione.
Da "globalist.it" il 17 novembre 2020. Differenza di stile e di
classe: quattro anni fa "misi da parte la rabbia" per la vittoria di Donald
Trump e mi impegnai per una transizione "rispettosa e senza intoppi". "Non fu
facile", ma "la democrazia è più grande del nostro ego". A scriverlo oggi su
Instagram è l'ex first lady Michelle Obama, mentre Trump continua a non
accettare la sconfitta. Quattro anni fa "rimasi ferita e delusa, ma i voti erano
stati contati e Donald Trump aveva vinto. Il popolo americano aveva parlato. E
una delle grandi responsabilità di una presidenza è ascoltarlo", ha scritto la
moglie di Barack Obama. "Assieme a mio marito abbiamo detto al nostro staff di
realizzare quanto George e Laura Bush avevano fatto per noi: una transizione
rispettosa e senza intoppi". "Devo essere onesta, non è stato facile. Donald
Trump aveva diffuso bugie razziste su mio marito e messo la mia famiglia in
pericolo. Non era una cosa che ero pronta a perdonare, ma ho dovuto trovare
forza e maturità per mettere la mia rabbia da parte", ha detto , ricordando il
suo invito a Melania Trump per un tè alla Casa Bianca. "Il nostro amore per il
paese ci richiede di rispettare i risultati elettorali", sottolinea la ex first
lady, esortando "tutti gli americani, specie i leader nazionali, qualsiasi sia
il partito, a onorare il processo elettorale e fare la propria parte per
incoraggiare una transizione morbida del potere, come hanno sempre fatto i
presidenti in carica".
Ecco perché Trump ha perso i primi ricorsi.
Trump minaccia ricorsi a valanga per fermare i brogli: "Con i
voti legali ho vinto io". Ma per ora ha perso i ricorsi che aveva presentato
volti a fermare lo spoglio delle schede arrivate per posta. Orlando Sacchelli,
Venerdì 06/11/2020 su Il Giornale. Non ha dubbi Donald Trump. In piena notte
americana, al solito tramite Twitter il presidente degli Stati Uniti chiede alla
Corte Suprema di cancellare i "voti illegittimi". Punta il dito affermando che
gli osservatori del processo elettorale non hanno potuto monitorare il
conteggio, e ribadisce la sua linea battagliera: "Vinco facilmente la presidenza
degli Stati Uniti con i voti legittimamente espressi. Agli osservatori non è
stato consentito, in alcun modo o forma, di svolgere il proprio lavoro e quindi
i voti accettati durante questo periodo devono essere considerati voti illegali.
La Corte Suprema degli Stati Uniti dovrebbe decidere!". In un altro tweet
preannuncia che "ci saranno ricorsi legali in tutti gli stati rivendicati da
Biden per frode elettorale. Siamo pieni di prove, controllate i media.
Vinceremo, America first". Intanto Trump ha perso la causa con cui chiedeva,
nello stato del Michigan, di fermare gli scrutini a causa dei brogli. E lo
stesso è avvenuto in Georgia, dove il ricorso era stato presentato per impedire
il conteggio dei voti arrivati in ritardo rispetto all'Election Day. Notizie non
buone, per il presidente, anche dalla Pennsylvania, dove il procuratore generale
(ministro della Giustizia) Josh Shapiro ha detto: "La campagna elettorale è
finita, i voti sono stati espressi ed ora è il momento di contarli e rispettare
la volontà degli elettori. Non consentirò a nessuno di fermare il processo di
conteggio. Si tratta di voti legali e saranno contati". La battaglia legale va
avanti a tappeto, praticamente in tutti gli stati chiave, con risultati alterni.
Lo staff di legali che guida i ricorsi di Trump, capeggiato dall'ex procuratrice
della Florida Pam Bondi, affiancata dall'ex sindaco di New York Rudolph Giuliani
e da Eric Trump, ha ottenuto dalla Corte di appello la possibilità di entrare in
un seggio di Filadelfia (Pennsylvania), per "supervisionare lo spoglio",
restando a distanza di un metro e mezzo anziché i 15-30 metri inizialmente
previsti (eccessivi per controllare davvero la regolarità). In Georgia la
richiesta di annullare alcuni voti giunti per posta è stata respinta. Il
presidente ha chiesto il riconteggio dei voti (recount) in Michigan e Wisconsin,
entrambi assegnati a Biden. Le regole sono diverse per i due stati. Nel
Wisconsin si può richiedere se la distanza tra i due sfidanti è inferiore all'1%
dei voti. Se il distacco è superiore allo 0,25% è a carico di chi lo chiede. Nel
Michigan, invece, il riconteggio scatta automatico nel caso in cui lo scarto di
voti sia inferiore o uguale a duemila. In tutti gli altri casi a sostenere i
costi è chi chiede il riconteggio. Ricalcolo automatico anche in Arizona nel
caso in cui il divario sia inferiore o pari allo 0,1% dei voti. In Pennsylvania
lo stesso ma lo scarto deve essere entro lo 0,5%.
AGI il 9
novembre 2020. Nella sua battaglia per rimanere alla Casa Bianca, il presidente
Usa, Donald Trump, non ha la facoltà di ricorrere direttamente alla Corte
Suprema federale, dove al momento siedono 6 giudici conservatori e tre
progressisti; e tantomeno la Corte Suprema federale ha interesse a politicizzare
e avocare a sè la decisione finale nel duello finale per l'elezione del 46esimo
presidente Usa. Nell'analisi di Francesco Clementi, docente di diritto pubblico
comparato all'Università di Perugia, è questa la 'fotografia' delle carte che
Trump può ancora giocarsi per rimanere alla Casa Bianca. "L'argomento delle
frodi e dei brogli può trovare fondamento solo se ci sono prove, che un giudice
ritiene tali. E tali prove, eventualmente, vanno presentate innanzitutto di
fronte ai tribunali degli Stati, i soli che possono consentire a Trump e ai suoi
legali di ricorrere fino alle rispettive Corti supreme: così, se quelle Corti
supreme gli sbarrano la strada non ci sono alternative, a meno che Trump e i
suoi legali non si appellino - a quel punto, e solo a quel punto, cioè dopo aver
esperito tutti i passi dell'iter legale all'interno dei sistemi giudiziari degli
Stati - alla Corte Suprema federale. Quest'ultima, tuttavia, può decidere di non
accettare il conflitto, rigettando la richiesta, ritenendola non fondata.
Oppure, al contrario, avocare la questione a sè, accettando il conflitto. Al
momento, tuttavia, stante il quadro che si va formando, ritengo questa ipotesi
poco probabile". Clementi spiega così i prossimi passi della campagna Trump:
"Gli avvocati del presidente dovranno quindi esperire innanzitutto tutti gli
insidiosi passaggi giuridici all'interno di uno Stato se vogliono poi arrivare -
come sostiene il Presidente Trump - fino alla Corte Suprema". In questo senso,
"appare improbabile - continua il docente - riscontrare uno scenario simile a
quello che si ebbe nel 2000 in Florida, quando fu la Corte Suprema ad assegnare
la vittoria finale al repubblicano George W. Bush contro Al Gore" proprio perché
- sottolinea Clementi - "non credo che la Corte Suprema federale abbia interesse
ad avocare a sè la scelta, gettandosi nell'agone politico fino a questo punto.
Un esito simile, infatti, getterebbe anche la Corte, e l'intero potere
giudiziario, nel pieno del fortissimo conflitto politico che attualmente vediamo
negli Stati Uniti". Se non trascinati per i capelli, dunque, i giudici della
Corte Suprema si terranno fuori dall'attuale contesa. "E a maggior ragione -
osserva Clementi - perché ci sono sei giudici conservatori e tre democratici. Il
dilemma del prigioniero è già scritto: se assegnano la vittoria a Trump
sarebbero accusati di essere di parte; se non lo fanno, si attirerebbero il
disdoro dei repubblicani, che da ultimo hanno rafforzato la loro presenza con la
legittima nomina - ma fortemente contestata politicamente - della giudice Amy
Corey Barrett. Per cui oserei dire che i giudici cercheranno di allontanare da
sè questo tema caldo. Se giocassimo a baseball direi che è una palla troppo
calda: così calda che è meglio schivarla, facendola passare". Il sistema di
gestione del sistema elettorale in Usa è tutto decentrato - spiega ancora
Clementi - così come è decentrato il suo controllo, e la campagna di Trump ha
già cominciato a far partire le cause negli Stati in bilico e contestati. "In 43
Stati su 50 ci sono leggi che consentono il riconteggio dei voti; inoltre in 20
su 50 sono in vigore leggi che consentono il riconteggio automatico, quando la
forchetta di voti tra i due candidati è molto bassa. Il puzzle della definizione
del numero dei grandi elettori dipende dunque da 50 sistemi giuridici
diversificati in ciascuno Stato". Gli Stati che normalmente procedono al
riconteggio, sono gli 'Swing State', osserva ancora, "ossia quelli in cui il
risultato è tradizionalmente molto ravvicinato, ma sono anche quelli che hanno
un'amministrazione di controllo più efficiente, numericamente più attrezzata,
proprio perché storicamente sono i più abituati a procedere al riconteggio. La
particolarità di queste elezioni, invece, è che oggi tra gli Stati in bilico non
ci sono solo gli Stati classicamente "swinging", ma anche Stati nuovi come
Arizona e Georgia: Stati cioè con una consolidata tradizione politica e dunque
nei quali l'amministrazione burocratica statale, ossia quella che è chiamata a
governare e a controllare il processo elettorale, è meno attrezzata, con meno
mezzi, uomini e strutture proprio perché di solito il riconteggio, in quelle
realtà, non serve. Ed è anche per questo quindi che, in queste ore, il conteggio
va a rilento".
Donald Trump, il silenzio della first lady Melania: "Non
riconoscerà Biden, ma non sosterrà il marito nella battaglia legale".
Libero Quotidiano il 07 novembre 2020. Joe Biden sarà il
46esimo presidente degli Stati Uniti, ma per l’ufficialità bisognerà attendere
l’8 dicembre: entro questa data dovranno essere risolte tutte le controversie
che Donald Trump è pronto a scatenare dopo aver annunciato battaglia legale per
quella che ha definito una “elezione rubata”. L’attuale presidente ha fatto
sapere che lascerà la Casa Bianca senza però accettare la sconfitta, dato che
per lui la questione non è finita, anzi è appena iniziata: dalle urne si
sposterà alle aule dei tribunali. “The Donald” è determinato ad andare fino in
fondo con questa sua convinzione di “frode elettorale”, spalleggiato dai
fedelissimi: tra questi non sembrerebbe però rientrare la moglie Melania Trump.
Un funzionario della Casa Bianca ha svelato alla Cnn che la first lady non
dovrebbe rilasciare alcun tipo di dichiarazione, né a sostegno della battaglia
del marito nel contestare il risultato elettorale né per riconoscere la vittoria
di Joe Biden. A differenza dei figli che invece si stanno battendo fieramente
per il padre, Melania non ha mai scritto o parlato a difesa di Trump. Il quale
invece confida molto soprattutto nella figlia Ivanka, che potrebbe diventare la
sua erede nel partito repubblicano dopo il percorso di crescita politica
iniziato sotto la sua ala protettiva.
Da huffingtonpost.it l'8 novembre 2020. All’indomani della
vittoria di Joe Biden, Melania Trump si prepara a lasciare la Casa Bianca e a
tornare nella lussuosissima dimora della Trump Tower. Dopo la fine della
presidenza c’è già chi scommette sul suo divorzio da Donald, a cui è legata da
16 anni. Secondo la ex assistente del presidente Usa, Omarosa Maigault Newman,
dopo 15 anni di matrimonio “Melania sta contando i minuti dall’uscita del marito
dalla Casa Bianca così da poter divorziare”. “Se Melania lo facesse mentre è
ancora in carica, lui troverebbe un modo di punirla”, ha aggiunto la Newman
autrice del libro ‘Unhinged’ che svela retroscena sul matrimonio della coppia.
Nonostante i momenti di gelo in pubblico, la signora Trump ha sempre sostenuto
di avere una “stupenda relazione” col marito, dalla quale la dividono ben 26
anni e con il quale non dorme. Ma c’è chi smentisce. “Non stanno divorziando.
Onestamente, sono fatti l’uno per l’altra”, ritiene invece Stephanie Winston
Wolkoff, che era amica intima di Melania e suo braccio destro nella East Wing
prima di una burrascosa separazione. Nel suo libro uscito in estate, "Io e
Melania", aveva scritto che la moglie del presidente, prima di trasferirsi alla
Casa Bianca da New York, aveva negoziato un accordo post-matrimoniale per
garantire al figlio Barron la giusta fetta dell’impero Trump. All’epoca, Melania
aveva raccontato di essere rimasta a Manhattan per prendersi cura del figlio
adolescente, Barron.
DAGONEWS il 16 novembre 2020. Quanto riuscirebbe a spillare
Melania se dovesse divorziare da Trump? Ivana Trump ha ricevuto 14 milioni di
dollari e alcune proprietà immobiliari costose quando ha divorziato da Donald
Trump, ma gli esperti dicono che Melania potrebbe ottenere molto di più. Ivana,
la prima moglie del presidente e madre di tre dei suoi figli, ha ottenuto 14
milioni di dollari più una villa a Greenwich, nel Connecticut, un appartamento
al Trump Plaza e l'uso della villa a Mar-a-Lago in Florida quando la coppia ha
firmato il divorzio nel 1992. Secondo l'archivio de “The New York Times”, Trump
ha anche dovuto pagare circa 650.000 all'anno per il mantenimento dei figli Don
Jr, Eric e Ivanka. L’accordo del divorzio era sostanzialmente simile a quando
stabilito nell’accordo prematrimoniale. Sia lei sia Marla Maples, seconda
moglie di Trump e madre di Tiffany, provarono a contestare gli accordi, ma alla
fine ottennero quanto stabilito prima del matrimonio. Secondo gli esperti se
Melania decidesse di divorziare, potrebbe ottenere almeno 50 milioni di dollari
più qualche proprietà immobiliare. Una cifra che non è così gigantesca se si
pensa lo stile di vita alla quale è abituata la signora Trump. Senza contare il
mantenimento di Bannon di cui Melania otterrebbe la custodia primaria.
ANNA GUAITA per il Messaggero l'8 novembre 2020. Un impero
editoriale, una seconda candidatura nel 2024, o l'esilio? Ora che la permanenza
di Donald Trump alla Casa Bianca è finita, il suo futuro appare alquanto
nebbioso. Molti dei suoi collaboratori pensano che il presidente uscente abbia
un seguito così forte che non lo abbandonerà neanche finita la presidenza. Il
punto interrogativo è come mantenere alta la passione della massa popolare e
come indirizzarla. Il genero di Donald, Jared Kushner, marito di Ivanka, già da
vari mesi sta esplorando la possibilità di dare vita a un polo televisivo, una
tv 24/7, una Donald Trump News sul modello Fox. Negli ultimi tempi infatti il
presidente si è detto scontento del canale che lo ha sempre sostenuto, e anzi si
era spostato a concedere interviste a un altro canale, ancora più di destra,
l'Oann, One America News Network. Kushner ha fatto però capire che Trump
preferirebbe fondare un suo canale. Da parte di Rupert Murdoch, padrone e
fondatore della Fox è venuto un gelido: «La concorrenza fa bene
all'informazione». Il progetto televisivo tuttavia appare difficile. Trump sarà
anche riuscito a farsi la fama di essere un grande uomo d'affari, ma nella
realtà ha messo insieme una gran quantità di fallimenti, e trovare finanziatori
per un simile progetto erculeo si è finora dimostrato quasi impossibile. I suoi
famosi successi televisivi sono venuti per la sua abilità di uomo di spettacolo,
con il programma The Apprentice, che però era ospite di un forte e ricco canale,
l'Nbc, amministrato da gente esperta nel settore. E comunque è molto probabile
che Trump non abbandoni le aspirazioni politiche: «Non gli piace perdere. Sono
certo che si ricandiderà» ha affermato il suo ex capo di staff, Mick Mulvaney.
C'è la probabilità, spesso discussa, che combatta nel 2024 non in prima persona
ma attraverso il figlio Don Junior, che è stato in primo piano nella campagna e
a cui ha spesso affidato compiti importanti. Non è un mistero che Don abbia
ambiziose mire politiche, nonostante a 42 anni non abbia nessuna esperienza
diretta se non come aiutante e portavoce del padre. Nell'universo Maga (acronimo
che sta per Make America Great Again, lo slogan di Trump), Don junior è
estremamente popolare, ed è seguitissimo nel suo account Twitter, non meno
infuocato di quello del padre. Ma i possibili progetti politici della famiglia
Trump dovranno comunque scontrarsi con il desiderio di affermazione dei
discepoli del trumpismo, che intendono candidarsi fra 4 anni. Almeno due
senatori che hanno fatto da teste di ponte per Trump al Senato, Tom Cotton
dell'Arkansas e Josh Hawley del Missouri, sono diventati più trumpisti di Trump,
e sono pronti a sfidare il loro guru. E poi si faranno di nuovo avanti i
candidati che Trump aveva sconfitto nel 2016, come Marco Rubio e Ted Cruz. Per
non parlare del vicepresidente Mike Pence, che quasi sicuramente sta preparando
la sua corsa.
LA MINACCIA. Tutte queste elucubrazioni devono comunque fare i
conti con il fatto che appena lasciata la Casa Bianca Donald Trump perderà
l'immunità e potrebbe vedersi immediatamente incriminato dalla procura dello
Stato di New York per frodi fiscali, minaccia per cui qualcuno ipotizza che il
tycoon possa emigrare in qualche Paese che non abbia accordi di estradizione con
gli Usa. Quel che è certo è che l'alta società newyorchese spera che Trump e i
suoi restino a Washington o si trasferiscano tutti in Florida. Come ha detto
acidamente una commentatrice delle cronache cittadine: «È' molto improbabile che
i Trump continuino a ricevere inviti alle feste di gala».
Massimo Gaggi per il ''Corriere della Sera'' il 7 novembre 2020.
E se Trump, che non riconosce la sconfitta, pretendesse di restare presidente?
«Verrà scortato fuori dalla Casa Bianca» risponde Biden. Non è così facile e non
solo perchè i militari si sono già smarcati. Il sistema elettorale Usa è basato
sulla concessione da parte del perdente. In sua assenza si entra in quella che i
costituzionalisti definiscono una terra incognita. Per motivi difficili da
sintetizzare in un articolo né la Costituzione americana (che risale ai 1787) né
l’Electoral Count Act del 1887, l’unica legge che regola le procedure
elettorali, criticata fin dal suo varo dai giuristi perché «confusa e con
passaggi incomprensibili», indicano con chiarezza cosa accadrebbe in caso di
contestazioni che riuscissero, in alcuni Stati, a bloccare la proclamazione
ufficiale dei risultati del voto. Le denunce e i ricorsi sulla correttezza degli
scrutini che la campagna di Trump sta già distribuendo a raffica negli Stati
conquistati da Biden sul filo di lana potrebbero anche essere respinti in blocco
(alcuni sono già stati cestinati). Ma se in alcune realtà locali i giudici
prenderanno sul serio le contestazioni, qualche Stato potrebbe anche non
ratificare il risultato del voto popolare bloccando il suo trasferimento nella
scelta dei Grandi elettori (come noto, negli Usa i cittadini non votano
direttamente per il presidente ma per 538 delegati complessivi scelti dagli
Stati che a loro volta eleggono il presidente: è il cosiddetto Electoral
College). A quel punto si aprirebbero scenari inquietanti coi parlamenti locali
(ricordiamoci che in Stati al momento vinti da Biden come Pennsylvania, Georgia,
Michigan, Arizona e Wisconsin, queste rappresentanze sono in mano ai
repubblicani) che potrebbero mandare a Washington grandi elettori scelti da loro
anziché dal popolo, essendo giunti alla conclusione che non c’è modo di avere
una rappresentazione corretta dell’esito del voto entro i termini
costituzionali: in base alla legge, infatti, i grandi elettori devono essere
nominati dagli Stati entro l’8 dicembre. Sei giorni dopo, il 14, questi 538
delegati votano per il presidente. Il 3 gennaio del 2021 si insedierà il nuovo
Congresso e il 6 Camera e Senato, riuniti in seduta comune, conteranno i voti
dell’Electoral College. Quelli che normalmente sono solo passaggi formali,
stavolta potrebbero diventare qualcosa di ben più drammatico perché, come
spiegano i costituzionalisti, il sistema elettorale presuppone un comportamento
fair, costruttivo, da parte dei contendenti: battaglia elettorale dura, ma alla
fine lo sconfitto «concede» la vittoria all’avversario. È un rito: chi perde
parla per primo, poi tocca al vincitore che lo ringrazia. Ma è un rito che è
anche sostanza politica. Vent’anni fa, nella disputa tra George Bush e Al Gore,
tante volte evocata in questi giorni, la partita finì non quando la Corte
Suprema diede ragione al candidato repubblicano, ma quando, il 13 dicembre del
2000, l’ex vice di Bill Clinton, concesse la vittoria a Bush. I suoi consiglieri
lo spingevano a continuare la battaglia al Congresso (dove lui, in quanto
vicepresidente, era il leader del Senato), ma Gore decise di non farlo per non
gettare il Paese nell’instabilità. Trump ha già chiarito che non si pone di
questi problemi: non accetterà in nessun caso di dichiararsi sconfitto. Rischi
autoritari? Trump interpreta le leggi in modo molto personale, ma non è un
dittatore. Quando dice, come ha fatto più volte in passato, «sono pronto a
rispettare l’esito del voto...se vinco io», bisogna capire se sta semplicemente
immaginando una via d’uscita dialettica e prepara, magari, una nuova battaglia
politica da leader che si definisce illegalmente defenestrato e cerca di
raccogliere voti per tornare al potere, o se vuole andare davvero fino in fondo
nella contestazione del voto, qualunque siano le conseguenze per la stabilità
degli Stati Uniti. Dobbiamo, poi, chiederci fino a che punto verrà seguito dal
suo partito. Per ora Trump appare saldamente in sella e deciso a sfruttare con
spregiudicatezza le ambiguità della legislazione americana. Leggi vecchie di
centinaia di anni che, in situazioni estreme, consentono qualcosa — sostituire
la volontà espressa dal popolo con la decisione di un parlamento locale — che la
nostra sensibilità di oggi ci fa apparire come profondamente antidemocratico. È
per questo che la Fox, la rete conservatrice, bombarda il suo pubblico coi
resoconti dei mille ricorsi che vengono presentati in queste ore, mentre alcuni
conduttori e i politici repubblicani di rango che vengono intervistati ripetono
di continuo che la vittoria di Biden è il frutto di scrutini fraudolenti. Trump
può evitare di consegnare la Casa Bianca ai democratici senza atti che
somigliano a un golpe? L’esercito dei suoi avvocati ci lavora da mesi e ha
individuato un percorso possibile nel labirinto giuridico americano: non una via
legale ma nemmeno palesemente illegale perché, come hanno detto a The Atlantic
gli esperti del Transition Integrity Project che studiano i possibili sbocchi di
un infarto del sistema elettorale, siamo in una situazione senza precedenti.
Nella quale conteranno molto le decisioni del Congresso e, soprattutto, quelle
del capo del Senato, il vicepresidente degli Stati Uniti. Che, fino
all’insediamento del successore di Trump, il 20 gennaio, sarà Mike Pence.
Donald
Trump, ricatto al presidente? "Dossier già aperti": se accetta la sconfitta,
sarà assedio giudiziario.
Libero
Quotidiano il 09 novembre 2020. La convinzione di “elezioni rubate” lascia il
tempo che trova, ma nasconde un disegno più ampio di Donald Trump. Secondo un
articolo di Liberation tratto dalla rassegna stampa estera di Epr
comunicazione e rilanciato da Dagospia, il presidente non vuole ammettere la
sconfitta e riconoscere la vittoria di Joe Biden perché ci sono una dozzina di
dossier già aperti contro di lui che potrebbero trasformarsi in valanghe non
appena metterà piedi fuori dalla Casa Bianca. Secondo il New York
Times i pubblici ministeri sono già all’opera, così come legioni i avvocati sono
pronte ad occuparsene: Trump sa bene che dal giorno in cui cesserà di essere
presidente (ha praticamente due mesi per prepararsi) non solo perderà
l’immunità, ma lo aspetteranno fascicoli e inchieste che era riuscito abilmente
a schivare negli ultimi 4 anni. Tra traffico d’influenza, accordi fiscali,
conflitto d’interessi, rapporto Mueller e quant’altro Trump rischia davvero
grosso una volta che sarà tornato ad essere un normale cittadino americano: il
tycoon newyorkese ne è pienamente consapevole, per questo intanto si è barricato
alla Casa Bianca e sta minacciando battaglie legali su presunti brogli che però
finora non è riuscito a dimostrare, non essendoci lo straccio di una prova ed
essendo praticamente impossibile manomettere decine e decine di migliaia di voti
senza che un sistema elettorale come quello americano se ne accorga. Sul The New
Yorker un ex consigliere di Bill Clinton ha rivelato quale potrebbe essere in
realtà la strategia di Trump: potrebbe cercare un accordo con Biden per
l’ammissione della sconfitta e un passaggio di consegne senza troppe turbolenze
in cambio di un “ammorbidimento” dei procuratori sulle cause che rischiano di
metterlo in guai seri. Sono infatti due le principali potenziali minacce per
“The Donald”: la prima è il rapporto Mueller, che contiene migliaia di pagine di
indagini sui sospetti di interferenze russe nelle elezioni presidenziali del
2016. Tale dossier era stata la causa principale della procedura di impeachment
che era stata sventata dai repubblicani non senza perdite pesanti, dato che
erano stati condannati anche due parenti di Trump, oltre al suo avvocato Michael
Cohen e al responsabile della campagna Paul Manafort. A questo va aggiunto il
fatto che il presidente nell’ultimo decennio ha pagato solo poche centinaia di
dollari di tasse: l’accusa è di aver falsificato sistematicamente i suoi conti,
per questo fa molta paura l’indagine per frode fiscale e assicurativa che
riguarda la Trump Organization. Senza dimenticare che ci sono almeno altri dieci
fascicoli pronti per provare a far crollare “The Donald”, che a questo punto
potrebbe agevolare una “transizione morbida” alla Casa Bianca in cambio di un
occhio di riguardo per le inchieste che lo riguardano.
Articolo
di “Liberation” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione” il 9
novembre 2020. Traffico d'influenza, accordi fiscali, conflitto d'interessi...
Una dozzina di dossier, scrive Liberation, sono già aperti contro il presidente.
«The people vs Donald J. Trump». Negli Stati Uniti, ci sono quelli che sognano
il processo, inondando i social network di ritratti di un presidente deposto in
tuta arancione. Secondo il New York Times, ci sono quelli che non dormono la
notte, tipo il principale interessato e i suoi cari. E poi quelli che si
preparano, un pugno di pubblici ministeri già all'opera e una legioni di
avvocati pronti ad occuparsene. Sia in campo civile che penale sono stati aperti
una dozzina di fascicoli. Trump è un sopravvissuto. Nel corso della sua carriera
e fino al suo unico mandato di capo dello Stato, è stato oggetto di
un'impeachment, sei fallimenti, circa 30 accuse di "cattiva condotta sessuale" e
circa 4.000 denunce relative ai suoi casi. Anche se il miliardario è sempre
riuscito a farla franca, la possibilità di una fine berlusconiana gli è passata
più di una volta per la testa. Già nel 2017, in un tweet, ha cercato di
rassicurarsi: "Ho il diritto assoluto di GRAZIARE me stesso, ma perché dovrei
farlo visto che non ho fatto nulla di male?” Labirintico, la potenziale causa
che minaccia Trump può essere suddivisa in tre grandi pezzi. In primo luogo, la
bomba a orologeria del famoso "rapporto Mueller", quelle migliaia di pagine di
indagini sui sospetti di interferenze russe alle elezioni presidenziali del
2016. Se questo memorandum fiume, cuore della procedura di impeachment sventata
dai repubblicani, non ha potuto causare la caduta di Trump durante il suo
mandato, potrebbe servire da mina giuridica una volta revocata l'immunità
presidenziale. In particolare i fatti di intralcio alla giustizia e di
finanziamento illegale della campagna elettorale sostenuta da Robert Mueller,
che hanno già portato a cinque condanne nella prima cerchia di Trump, portando
alla detenzione di due suoi parenti, il suo avvocato, Michael Cohen, e il suo
responsabile della campagna elettorale, Paul Manafort. Per non parlare dei
sospetti di spergiuro da parte dei membri della famiglia Trump e del tentativo
di costringere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ad avviare un'indagine
contro il figlio di Joe Biden in cambio di aiuti militari. Nella sua roccaforte
newyorkese si sta formando un altro iceberg per il contribuente Donald Trump,
che nell'ultimo decennio ha pagato solo poche centinaia di dollari di tasse.
Accusata di aver sistematicamente falsificato i suoi conti, la Trump
Organization è oggetto di un'indagine per frode fiscale e frode assicurativa,
tra le altre malversazioni. In parallelo, a Manhattan, il procuratore Cyrus
Vance Jr, un tempo incaricato del caso Strauss-Kahn, scava la pista dei
versamenti occulti a diverse donne che hanno avuto relazioni con Trump, la più
nota delle quali è l'ex attrice porno Stormy Daniels, che ha pagato 130.000
dollari (circa 110.000 euro) attraverso il suo avvocato un mese prima delle
elezioni del 2016. Non illegale negli Stati Uniti di per sé, ma lo schema
finanziario utilizzato dal team Trump era simile al finanziamento illegale della
campagna elettorale, che ha portato Cohen in prigione. E, come dimostra il
Rapporto Mueller, l'ordine è stato ricondotto a un certo "Individuo 1, candidato
alla presidenza". Ironia della sorte, questo tentativo incompetente di comprare
il suo silenzio ha portato al libro best-seller di Stormy Daniels, passato alla
storia per la sua suggestiva descrizione del suo "fastidio di essere scopata da
un tizio con uno yeti pubico e un cazzo a forma di fungo in Mario Kart". Infine,
giornalisti e avvocati sottolineano la miriade di conflitti di interesse tra
l'Organizzazione Trump e la Casa Bianca. Secondo quanto riferito, lobbisti e
diplomatici stranieri sono stati incoraggiati a soggiornare negli hotel e nei
campi da golf Trump nella speranza di ottenere l'accesso al Presidente, il che
potrebbe equivalere a un piano di corruzione. Inoltre, secondo il Washington
Post, la Trump Organization ha fatto pagare al governo federale più di 2,5
milioni di dollari di tasse - dalle stanze occupate dalle guardie del corpo dei
servizi segreti nella sua residenza in Florida a Mar a Lago, ai bicchieri
d'acqua (3 dollari ciascuno) durante un incontro uno contro uno con il
giapponese Shinzo Abe. Se si fosse scoperto che l'uomo d'affari Trump aveva
gonfiato il disegno di legge del presidente Trump, secondo diversi esperti ci
sarebbero stati i presupposti per un'azione penale. Ancora più ambizioso, Glenn
Kirschner, un ex procuratore federale, ritiene che la sua gestione disastrosa
della pandemia di Covid-19 potrebbe essere riclassificata come "omicidio
colposo". Se un eventuale «auto-perdono» del Presidente potrebbe essere respinto
dalla Corte suprema, accusare un ex presidente resta un esercizio altrettanto
pericoloso. Che potrebbe infiammare le tensioni e creare un precedente
altrettanto rischioso avvertono alcuni esponenti del diritto. Questo potrebbe
innescare tensioni e creare un precedente vendicativo, avvertire alcuni esperti
legali. Secondo questo principio, Richard Nixon, costretto alle dimissioni dal
Watergate nel 1974, era stato graziato dal suo successore repubblicano, Gerald
Ford. Sul The New Yorker, un ex consigliere di Bill Clinton immagina che Trump
si accordi con Joe Biden per l'ammissione di una sconfitta e un passaggio di
potere senza intoppi con Joe Biden in cambio di un calo della causa. In
alternativa, i Democratici potrebbero lanciare una seconda procedura di
impeachment, a posteriori, per evitare una candidatura di Trump nel 2024. In
ogni caso, di fronte all'inevitabile tsunami legale, Trump rischia qualcosa di
più imbarazzante per lui che la prigione: la rovina, annegato nelle spese
legali.
Peter Maass
per theintercept.com il 6 novembre 2020. Non solo in casa Trump o all’interno
del partito repubblicano, si battaglia anche all'interno della famiglia Murdoch,
proprietari di Fox News. Venerdì mattina, un giorno prima che Joe Biden fosse
dichiarato presidente eletto, una delle nuore di Rupert Murdoch, Kathryn
Murdoch, ha twittato una critica senza precedenti a Fox News e alla gestione
della rete da parte della famiglia mentre il presidente Donald Trump si stava
dirigendo verso la sconfitta. Rispondendo al presentatore della CNN Jake Tapper
che diceva che era tempo per Fox e i Murdoch di chiarire che non c'erano prove
credibili di frode elettorale, Kathryn Murdoch ha twittato: "Sono d'accordo con
questo". Il pensiero di Kathryn Murdoch sembrava avere il sostegno all'interno
della famiglia, perché i loro media - non solo Fox News - hanno iniziato a
inviare chiari segnali al presidente Trump che avrebbe dovuto accettare la
sconfitta. Venerdì sera, la pagina editoriale del Wall Street Journal ha
osservato con scetticismo che la campagna di Trump "dovrà dimostrare" le sue
affermazioni infondate di frode elettorale e ha consigliato al presidente di
essere pronto a "concedere con garbo". Il titolo dell'articolo era "The
Presidential Endgame". La scorsa notte su Fox News, la conduttrice della prima
serata Laura Ingraham, ospite alla Casa Bianca solo pochi giorni fa, ha detto
che il presidente dovrebbe esibire "garbo e compostezza”, quando sarebbe
arrivato il momento di ammettere la sconfitta, che sembrava sentire presto. Un
grafico visualizzato durante il suo programma indicava che uno dei tre compiti
da svolgere è "accettare i risultati delle elezioni". Infine, il titolo in prima
pagina del New York Post di sabato mattina sembrava segnare una svolta netta
dall'era Trump: "Pronto, Set ... Joe?" L'inclinazione politica di Fox News e di
altri media riflette l'orientamento di destra di Rupert e del figlio maggiore
Lachlan, che ora sovrintende alla rete come amministratore delegato della sua
società madre, Fox Corporation. La proprietà dell’impero mediatico è una
divisione del 50-50 tra Rupert da una parte e i suoi sei figli dall'altra. Ma
quando si tratta di governare l'impero, sono stati quasi sempre il conservatore
Lachlan e suo fratello minore James, che è un centrista. Kathryn Murdoch è la
moglie di James. Negli ultimi anni, lei e James non hanno nascosto le loro
preferenze politiche: hanno fatto donazioni significative alle campagne di Pete
Buttigieg e più tardi, Joe Biden, una volta che è diventato il candidato del
Partito Democratico. All'inizio di quest'anno, dopo che James ha perso una
battaglia per la successione contro Lachlan e si è dimesso dall'ultima carica
rimasta nel consiglio di amministrazione, ha diffuso una critica obliqua della
direzione politica delle aziende della famiglia, ma non ha detto nulla di
specifico su Fox News e il suo ruolo centrale nel "riciclaggio" dell'estremismo
nazionalista bianco e delle relative teorie del complotto. Con la sconfitta di
Trump, la rete e la famiglia si trovano a un bivio, affrontando controlli e
pressioni molto più critici di quanto non abbiano mai fatto negli Stati Uniti.
Fox è nella posizione, in questo momento, di quelle emittenti televisive di
stati sudamericani dove un leader impopolare è stato bocciato dal voto ma
rifiuta di accettare il risultato. L'emittente sarà fedele al leader sconfitto e
affermerà che le elezioni sono state truccate, un percorso che probabilmente non
avrà successo ma che garantirebbe quasi un livello più elevato di instabilità
post-elettorale? O l'emittente prende la strada giornalisticamente e moralmente
corretta di riferire il fatto che il presidente ha davvero perso un'elezione che
non è stata truccata contro di lui? È utile fare un passo indietro e rendersi
conto della deformità di questo momento. A causa del potere unico di Fox News -
insieme a Facebook, è la piattaforma più importante negli Stati Uniti per la
diffusione della disinformazione di destra - una singola famiglia con un
patrimonio netto di circa $ 17 miliardi è in grado di decidere se le teorie del
complotto elettorale avranno l’ossigeno mediatico di cui hanno bisogno per
diffondersi ampiamente e profondamente in tutto il paese. È un concentrato di
potere che è stato accumulato e abusato per decenni dalla famiglia Murdoch, e ha
causato danni immensi anche negli Stati Uniti e in altri paesi (i Murdoch sono
responsabili di danni simili nel Regno Unito e in Australia, dove hanno anche
partecipazioni mediatiche). Il 13 marzo 2019, dozzine di manifestanti si sono
riuniti al quartier generale di Fox News, mentre la società ha tenuto una
riunione di "emergenza" per corteggiare i marchi nervosi per continuare a fare
pubblicità sulla rete. La protesta, intitolata "Drop Fox" è stata organizzata
in seguito a una sfilza di storie negative su Fox News, inclusi vecchi nastri
audio del conduttore Fox, Tucker Carlson, che fa, dichiarazioni razziste,
misogine e bigotte. Quando i risultati delle elezioni sono arrivati e hanno
mostrato Trump sulla traiettoria della sconfitta, la copertura di Fox si è
notevolmente divisa all'inizio di questa settimana . Il cosiddetto lato
giornalistico della Fox, che è ancorato nella sua programmazione diurna con
giornalisti conservatori ma non deliranti come Chris Wallace e Bret Baier, ha
svolto un lavoro generalmente diretto nel riportare i risultati. Fox è l'unica
rete via cavo ad aver dato Biden in vantaggio in Arizona, una mossa che ha fatto
infuriare la Casa Bianca e apparentemente è stato un fattore che ha portato una
folla di manifestanti pro-Trump fuori da un ufficio di conteggio delle schede
elettorali a Phoenix a urlare "Fox News fa schifo". Altro cambio di rotta quando
il New York Post, una delle prime acquisizioni mediatiche di Rupert negli Stati
Uniti, ha pubblicato due articoli, entrambi con toni decisamente diversi dal
passato. Nel primo, si accusava Trump di lanciare "accuse infondate che i suoi
nemici politici stavano tentando di rubargli le elezioni". Nel secondo, Donald
Trump Jr, figlio del presidente, veniva definito "in preda al panico" e autore
di "tweet senza senso". Abbastanza, per segnare un netto cambio di linea
editoriale e lanciare il segnale che Rupert Murdoch ha chiaramente preso le
distanze da una Presidenza che quattro anni fa, con i suoi media, contribuì a
far nascere. Ma i presentatori in prima serata di Fox News, in particolare Sean
Hannity, che funge anche da consigliere non ufficiale di Trump, non si sono
mossi così rapidamente per cambiare il loro coretto pro-Trump. L'episodio di
giovedì sera del talk di Hannity è stato particolarmente eclatante, con ospiti
come il senatore del Texas Ted Cruz e l'ex presidente della Camera Newt Gingrich
che hanno ripetuto con rabbia le affermazioni di frode elettorale. Sono stati 60
minuti di diffusione di cospirazione a livello nazionale, una brutale
dimostrazione del potere di Fox di diffondere un virus politico in America.
Mentre Ingraham ha modificato la sua posizione venerdì sera, Hannity non ha
cambiato musica: Biden sta rubando le elezioni. Brian Stelter della CNN ha
puntato il dito sui Murdoch dopo che è stata diffusa la notizia che un
promemoria circolato a Fox News venerdì scorso ha ordinato ai conduttori in onda
di non riferirsi a Biden come ‘’presidente eletto’’. "Rupert e Lachlan Murdoch -
ha detto Stelter - sono responsabili di ciò che andrà in onda nelle prossime
ore". Sabato mattina, Stelter ha indicato il cambiamento di Ingraham e
l'intransigenza di Hannity, dicendo che c'è un "tiro alla fune gigante" alla Fox
in questo momento. Kathryn Murdoch è l'unico membro della famiglia ad aver
parlato dopo le elezioni ma il suo tweet era un invito alla famiglia a mettere
la nazione prima del profitto, toccando quella che potrebbe essere la
preoccupazione principale della famiglia: il denaro. Sebbene Rupert e Lachlan
abbiano forti convinzioni politiche conservatrici, la proposta di Fox è sempre
stata di tipo commerciale: la famiglia ha raccolto miliardi dalla rete. Nel
Regno Unito nel 1997, le aziende dei media di Murdoch hanno spostato il loro
sostegno all'allora leader del partito laburista Tony Blair, non per ragioni
ideologiche ma per motivi economici. Ora, Kathryn Murdoch, nel chiedere alla
rete di riferire onestamente sulle teorie del complotto per frode elettorale,
sembra riconoscere che non sarebbe una posizione in grado di aumentare le
entrate. Molti dei telespettatori pro-Trump di Fox News sarebbero infuriati e
una perdita di spettatori potrebbe in ultima analisi influenzare il flusso di
entrate cruciale della rete: le tariffe via cavo. Dopo decenni di gestione di
Fox News come un'irresponsabile macchina di propaganda di destra, perché
cambiare ora? La risposta potrebbe essere che la notevole impunità goduta dalla
famiglia Murdoch potrebbe davvero essere finita poiché ora c'è un maggiore
controllo sull’informazione di cui sono responsabili. E dopo che Biden è stato
dichiarato presidente eletto sabato, Kathryn Murdoch ha fatto un altro passo
nella resistenza anti-Trump, twittando: "Ce l'abbiamo fatta!!!" Qualunque
direzione prendano i Murdoch con Fox News nelle prossime ore e giorni, il loro
sforzo per evitare il giudizio della storia, se non anche il giudizio dei
tribunali, è forse segnato anche se la loro rete riporta ora la verità che la
sconfitta di Trump è ufficiale. Lo ha notato Angel Carusone, amministratore
delegato di Media Matters for America. “Quando tutto sarà finito”, ha twittato ,
“tutti dovrebbero prendersi una tregua. E poi, dobbiamo finalmente fare qualcosa
contro la forza ingannevole e distruttiva che è Fox News”.
Henry
Kissinger: "Europa e Usa uniti davanti alla Cina".
Mathias
Döpfner su La Repubblica il 9 novembre 2020. L'ex segretario di Stato Henry
Kissinger con l'allora vicepresidente Joe Biden in una foto del 9 novembre
2016, New York City. Intervista al segretario di Stato di Nixon e Ford: "Conosco
Biden, siamo stati in disaccordo su alcune questioni, ma non è tipo da
perseguire i suoi obiettivi come uno schiacciasassi". Henry Kissinger, premio
Nobel per la pace e consigliere di politica estera di tutti i presidenti degli
Stati Uniti dai tempi di John F. Kennedy, parla come è sua abitudine con calma,
concentrazione e con un potere analitico quasi ipnotizzante.
Che cosa
rappresentano per il popolo americano le elezioni negli Stati Uniti e che cosa
implicano per l'Europa e le relazioni transatlantiche?
"Il risultato
più importante sarà il grado con il quale il prossimo presidente riuscirà a
ripristinare una certa unione nel popolo".
È ottimista?
"Conosco Biden
da decenni e, pur essendo stato in disaccordo con lui su alcune questioni
politiche, non è una persona che persegue i suoi obiettivi come uno
schiacciasassi. Il problema per l'America sarà ricomporre le sue lacerazioni
interne e comprendere che i problemi con i quali dovremo fare i conti dureranno
ben oltre un'unica Amministrazione".
Che cosa si
aspetta sul versante della politica estera?
"Una questione
di cruciale importanza sarà quella delle relazioni con la Cina. Il problema ha
due sfaccettature: la prima è la crescita della Cina, che provoca un cambiamento
negli equilibri di potere del mondo. La seconda è la differenza ideologica. Per
il futuro, il problema sarà capire in che misura il conflitto ideologico
prevarrà sulle relazioni tra i due Paesi. La crescita delle capacità economiche
e militari cinesi è una cosa, ma è in atto anche un consistente cambiamento
nella natura di queste capacità".
Che cosa
intende di preciso?
"Prendiamo in
considerazione, per esempio, la questione dei rapporti commerciali. È possibile
ottenere un risultato negoziato quando grandi società del settore hi-tech si
scontrano operando da piattaforme che hanno una portata globale? Oppure sarà
possibile raggiungere accordi economici negoziati che equilibrino la relazione
in modo tale che vari Paesi possano possedere quelle piattaforme? E di sicuro ci
sarà un'evoluzione della tecnologia: questo implica che il conflitto militare
sarà difficile da contenere".
Come lo si
potrebbe scongiurare?
"Il mondo non
dovrebbe scivolare in una situazione simile a quella della Prima guerra
mondiale. È fondamentale valutare la possibilità di un controllo degli
armamenti. Io rientro nel novero di quanti, oggi una minoranza, credono sia
imprescindibile cercare di risolvere i problemi più gravi con i negoziati. Sono
nato in Europa e ho trascorso gran parte della mia carriera occupandomi di
problemi tra europei e americani. Riprendere in mano tutto ciò è
indispensabile".
Come considera
il ruolo della Nato in tutto questo?
"Il mio punto
di vista si è andato formando quando è stata creata la Nato e quando c'era una
paura comune per un nemico ideologico. Quell'atteggiamento mi sembra difficile
da applicare alle circostanze odierne, tenuto conto che perlopiù le sfide non si
presentano alle frontiere dell'Europa. È indispensabile che Europa e Stati Uniti
trattino le relazioni sino-americane in parallelo".
In che misura
le relazioni tra America ed Europa cambieranno? Penso ai rapporti con
l'islamismo, la politica in Medio Oriente, in Cina, i rapporti con la Russia, il
Nord Stream II. Pensa siano ingenue le aspettative di una nuova epoca di
armonia?
"Sarebbe un
grave errore per l'Europa adesso festeggiare, come se un cambiamento alla
presidenza degli Stati Uniti potesse ribaltare tutto quello che ha reso
insoddisfatti gli europei. L'armonia richiede seri sforzi e impegno a dialogare
sia in Europa sia negli Stati Uniti sulle nostre idee riguardanti il futuro".
Come valuta
gli ultimi quattro anni di Trump?
"Molte
questioni sollevate erano serie. I rapporti economici tra Cina e Stati Uniti
stavano pendendo da una parte sola. Pertanto, è stata giusta la decisione di
dichiarare che il trasferimento delle acquisizioni tecnologiche e in generale il
metodo di condurre gli accordi commerciali e i negoziati non potevano essere
accettati a tempo indefinito. Il problema, adesso, è capire se si possa trovare
un terreno comune a partire dal quale comprendere l'imperativo di non scivolare
di scontro in scontro in tutto il mondo".
Lei è stato
l'artefice di uno dei cambiamenti più radicali nell'apertura alla Cina. Con il
senno di poi, avrebbe fatto una scelta diversa?
"Se si guarda
all'evolversi delle relazioni, ci si rende conto che ci sono state molte fasi
diverse. Quando i rapporti hanno iniziato ad aprirsi, né Nixon né io abbiamo mai
creduto che l'ideologia cinese sarebbe cambiata in conseguenza di quei nuovi
rapporti. A quell'epoca, l'obiettivo strategico principale era tener conto della
Cina nella Guerra Fredda con l'Unione Sovietica e al tempo stesso aprire gli
orizzonti del nostro popolo e dei nostri alleati".
Che opinione
che si è fatto di Biden?
"Lo conosco da
più di quarant'anni. Quando è stato eletto senatore non aveva ancora trent'anni.
Partecipò a una riunione della Commissione del Senato per le relazioni estere
quando ero Segretario di Stato. Quando entrò non lo conoscevo e gli dissi che
'non mi ero reso conto che i membri dello staff potessero partecipare'. Lui fu
molto cordiale. Mi piace come persona. Spesso sono stato in disaccordo con lui,
ma mi aspetto che conduca una politica estera moderata e consapevole. Il periodo
post-elettorale è ancora poco chiaro, ma userò tutta l'influenza che ho per
promuovere l'unione". (Traduzione di Anna Bissanti)
Usa 2020, i nuovi eletti al Congresso sono il simbolo di un
Paese mai così diviso. Entrano i primi neri
dichiaratamente gay, transgender, attivisti di Black Lives Matter e vengono
confermate le deputate della "Squad". Ma sull’altro fronte arrivano giovani
complottisti di QAnon e fanatici delle armi. Manuela Cavalieri e Donatella
Mulvoni su L'Espresso il 06 novembre 2020. È una nazione lacerata quella che
riaffiora da questa inquieta stagione elettorale. Le due anime del Paese, per
motivi opposti, si sono mobilitate in quelle che tutti hanno definito le
elezioni più importanti della storia. Due poli che da anni si allontanano. E si
barricano in posizioni che oggi sembrano semplicemente inconciliabili: sul
terreno della fede come della scienza, dei diritti civili, della sanità,
dell’economia, delle relazioni sociali come pure delle libertà individuali.
«Donald Trump non è quello che siamo noi», diceva Joe Biden in campagna,
rivendicando la sua battaglia per “l’anima” della nazione. «Non consegneremo mai
l’America in mano agli estremisti socialisti», tuonava Trump, infuocando la sua
base. Appelli che hanno sortito un effetto travolgente. Gli americani sono corsi
in massa alle urne. Per esercitare il proprio diritto al voto, certo, ma
soprattutto per rivendicare una visione del mondo, una filosofia di vita, un
sistema di valori completamente diversi da quelli degli avversari politici
divenuti oramai “nemici”.
Ecco perché Trump può risorgere.
Francesco Boezi su Inside Over l'8 novembre 2020. Donald Trump ha perso le
elezioni presidenziali del 2020. Su questo ormai esistono pochi dubbi. Certo, i
legali del tycoon presenteranno numerosi ricorsi, ma i distacchi nei vari Stati
iniziano ad essere considerevoli. Così come gli Stati in cui questi distacchi
sono stati rilevati. E una battaglia legale deve avere solide basi su cui
poggiare. Questa della via legale rimane una variabile, ma per ora conviene
soffermarsi su un altro tema: cioè sul perché l’ormai ex presidente degli Stati
Uniti non possa già essere considerato alla stregua di un attore esterno del
palcoscenico politico americano. Procediamo con ordine. Intanto negli Stati
Uniti esiste un elettorato “trumpiano”. Bisognerà comprendere se gli elettori
repubblicani hanno votato Trump per il Gop o Trump proprio perché Trump. La
sensazione è che, in percentuale, sia soprattutto vera la seconda affermazione,
in specie per la ultima turnata elettorale. E questo perché The Donald ha
sostanzialmente monopolizzato il partito nel corso degli ultimi cinque anni. Un
percorso lungo, che è iniziato con le primarie con cui ha sconfitto, tra gli
altri, il ben più quotato Jeb Bush. Nel caso il Gop, con i neo-conservatori in
testa, provassero a “de-trumpizzare” il partito degli elefantini, cosa ne
sarebbe dell’elettorato “trumpiano”? Davvero possiamo ipotizzare che un
elettorato così convinto e battagliero si dimentichi del suo polo, orientandosi
su un leader ed una classe politica più sistemica? Davvero Paul Ryan e simili
possono ambire allo stesso bacino elettorale dell’ex Commander in Chief? La
risposta a tutte queste domande, almeno finché Trump sarà nell’agone politico,
sembra essere no. E questo per la frangia elitaria del Gop rappresenta un
problema non da poco. Facciamo un’altra ipotesi: nel caso in cui Donald Trump
decidesse di creare un partito personale, quanti elettori repubblicani lo
seguirebbero al momento? Una domanda difficile cui rispondere. Ma possiamo
immaginare che quel numero sarebbe sufficiente per rendere il Partito
Repubblicano meno pesante, dal punto di vista elettorale, rispetto a com’è ora.
Poi esistono altri fattori: Trump, con le presidenziali del 2020, ha allargato
la sfera d’influenza del Gop: gli elettori hispanici, nello specifico, hanno
certificato di essersi avvicinati al Gop, mediante l’espressione dei consensi.
Il Gop aveva proprio questo problema: come attrarre le minoranze, durante un
periodo storico in cui la demografia, cambiando, sembra suggerire maggiori
facilità di successo per i Democratici. E Trump ha almeno tamponato anche questa
problematica, che è strettamente numerica. Ivanka Trump e suo marito Jared
Kushner sembrano avere velleità presidenziali. Lo stesso discorso può essere
avanzato nei confronti di un altro figlio di Trump, ossia Eric. Trump, dalla
sua, ha anche il potere mediatico maturato in quattro anni in cui, in casa Gop,
si è parlato quasi o solo di lui. E The Donald, che alcune cronache americane
raccontano come distanziato da Fox News, avrebbe intenzione di fondare una sua
televisione personale, attraverso cui il “trumpismo” potrebbe sopravvivere
meglio delle visioni del mondo portate avanti dagli altri presidenti sconfitti
della storia degli States. Proprio la storia viene in nostro aiuto: è vero che
George H.W. Bush perse la rielezione dopo il primo mandato come Trump, ma è
anche vero che i Repubblicani riuscirono a riconquistare la Casa Bianca proprio
con la vittoria del figlio di George H.W. Bush. Un esempio di come le dinastie
negli Usa non possano essere messe a sedere con facilità. Se Trump dovesse
invece seguire la narrativa Qanon o le altrettante assurde tesi della destra
estrema americana, allora si relegherebbe ad un ruolo minoritario. Trump ha più
opportunità continuando a ruotare attorno alle istanze del Gop: questo è
abbastanza chiaro ai più. Nel frattempo, nel corso di questi mesi, continueremo
a sentir parlare di The Donald, che per via dei presunti brogli che ha
ventilato, potrebbe anche optare per non riconoscere la vittoria a Biden,
creando una situazione più unica che rara nella storia della democrazia
americana. Comunque vadano le cose nelle prossime settimane, il politico Donald
Trump non è giunto alla fine della sua corsa. E i repubblicani di Washington
avranno – nel caso lo volessero – grosse difficoltà a liberarsi di una figura
così ingombrante e così polarizzante.
Elezioni
Usa 2020, la campagna elettorale più costosa di sempre.
Un enorme
flusso di denaro, praticamente raddoppiato rispetto al 2016 nonostante la
pandemia. La mobilitazione dei donatori per i dem ha raccolto quasi il doppio
dei Repubblicani. Ma restano le ombre sui fondi oscuri protetti dall'anonimato.
Manuela Cavalieri su L'Espresso il 03 novembre 2020. Washington DC - Passa dal
portafogli la riscossa delle donne americane in politica. La campagna elettorale
dei record - la più costosa della storia - ha infatti registrato un consistente
aumento dei finanziamenti corrisposti da donne per le donne. A fare la
differenza, il partito di appartenenza. «Abbiamo rilevato enormi flussi di
denaro a favore delle democratiche che si candidano al Senato e spesso
sorpassano le loro controparti maschili», spiega all’Espresso Grace Haley,
responsabile delle ricerche su genere e razza per il Center for Responsive
Politics. Secondo il watchdog, che traccia il flusso di denaro nelle casse dei
partiti, sono quasi 14 in totale i miliardi di dollari in circolo per sostenere
i candidati alla Casa Bianca, al Senato e alla Camera, e altre voci come ad
esempio i vari referendum statali, durante questa incredibile tornata
elettorale. Se le progressiste si avvicinano a colmare il divario di genere
(almeno nelle donazioni), lo stesso non si può dire per le conservatrici. «Le
donne repubblicane hanno grosse difficoltà a raccogliere fondi simili a quelli
degli uomini» , continua Haley. In casa dem a giovare è stato senza dubbio
l’ingresso in squadra della senatrice Kamala Harris, candidata alla vice
presidenza, con conseguenti donazioni femminili raddoppiate dopo l’annuncio. Che
le elezioni 2020 avrebbero registrato un nuovo picco di spesa era quasi
scontato: è un trend che difficilmente si potrà invertire se non cambieranno le
regolamentazioni. Quello che però ha stupito è che la cifra complessiva «sia
praticamente raddoppiata rispetto al 2016; si tratta di un enorme balzo in
avanti», ci dice Brendan Quinn, responsabile delle attività esterne del Center
for Responsive Politics. Dietro queste cifre astronomiche ci sono ovviamente i
Super Pac (i potentissimi e influenti i gruppi di appoggio esterni), i grandi
donatori vicini a entrambi i partiti, ma anche i piccoli donatori, quelli che
per intenderci hanno donato meno di 200 dollari. Proprio questi ultimi si sono
mobilitati come mai prima, nonostante la pandemia e le conseguenti difficoltà
economiche. Nel dettaglio, i democratici hanno raccolto 1,7 miliardi, i
repubblicani si sono fermati a uno. «I piccoli donatori rappresentano una
percentuale sempre più ampia della raccolta fondi complessiva - spiega Quinn -
Ciò è dovuto in parte alla facilità delle donazioni online». Basta un clic per
donare anche solo un dollaro. Questa rivoluzione digitale negli anni ha portato
alle casse dem più che a quelle repubblicane decine di milioni di dollari.
Pensiamo al successo della piattaforma dem Actblue. L’organizzazione, balzata
agli onori della cronaca durante la campagna elettorale di Bernie Sanders nel
2016, ora è diventata uno strumento di cui si avvale ogni candidato e permette
di disegnare in poche mosse una pagina di fundraising con il link alle
donazioni. È stata considerata, se vogliamo, la risposta blu allo strapotere dei
grandi donatori che insieme ai Super Pacs rappresentano il 50% della spesa
totale. Entrambi i candidati, intanto, possono contare sui mega assegni di
generosi miliardari. È stato Joe Biden, secondo il rapporto del watchdog, il
primo a sfiorare un miliardo di dollari in donazioni, a metà ottobre, con 938
milioni contro i 596 di Donald Trump. Nel team repubblicano giocano i titani dei
casinò Sheldon e Miriam Adelson che hanno “investito” nella vittoria rossa ben
183 milioni, attraverso il super Pac “Preserve America”, la cifra più alta che
una coppia abbia mai donato durante un unico ciclo elettorale. Per Biden,
invece, è sceso in campo l’ex sindaco di New York e candidato alla presidenza
Michael Bloomberg. Il magnate ha regalato 107 milioni di dollari al partito per
poi continuare supportando gli sforzi di Biden in Florida, Ohio e Texas. In
generale, se per gli assegni più robusti i repubblicani hanno potuto contare su
energia e risorse naturali, ma anche agroalimentare, i democratici, invece,
hanno fatto affidamento sul settore delle comunicazioni e dell’elettronica. Ed
ovviamente sullo star system Hollywoodiano, il cui sostegno però è arrivato più
tardi rispetto a quanto accaduto con Barack Obama o Hillary Clinton. Ad
entusiasmare le celebrity nello sprint finale, ancora una volta la californiana
Kamala Harris. In prima fila per lei Reese Witherspoon e Kate Hudson. Con circa
93 milioni di elettori che hanno già espresso la propria preferenza, con voto
anticipato o per corrispondenza, queste elezioni hanno davvero tutte le
caratteristiche per passare alla storia. A non cambiare, rispetto al passato,
sono le ombre che accompagnano le attività e le motivazioni dei gruppi di potere
dei Super Pac. «Sulla carta sono trasparenti. Sono tenuti a rivelare chi dà loro
i soldi, ma abbiamo scoperto due scappatoie. La prima - ci spiega Brendan Quinn
- è che possono accettare soldi da gruppi non-profit, che non sono tenuti a
rivelare i loro donatori. E poi ci sono anche quelli che noi chiamiamo “Super
Pac pop-up”, ovvero quelli che si formano a ridosso delle elezioni. Spendono
grandi somme di denaro in poco tempo, riuscendo a non rivelare chi sono i loro
donatori fino a dopo le elezioni». Fondi oscuri protetti dall’anonimato, che
facilita l’influenza che questi possono avere sui processi decisionali della
politica. Grazie ai Pac, liberi di sponsorizzare le loro cause e raccogliere
fondi, a patto che questi non concordino i loro messaggi con i candidati, i
grandi donatori riescono a dribblare la legge, pensata per limitare la cifra che
un privato può donare direttamente a una campagna. Ma come viene usato questo
mare di denaro? «Gran parte va alla pubblicità, televisiva in primis, ma anche
allo staff della campagna elettorale, ad esempio, o al mantenimento degli
uffici», dice Quinn. «Se moltiplichiamo queste voci per tutti i 50 stati
dell’Unione, è facile capire perché le casse dei candidati siano sempre al
limite. È così costoso candidarsi perché tutti raccolgono sempre più fondi e
spendono sempre di più. È un circolo vizioso. Bisogna raccogliere sempre più
denaro ad ogni ciclo elettorale per tenere il passo con il proprio avversario».
Quello che è certo è che queste ingenti disponibilità hanno cambiato il modo in
cui i candidati gestiscono le elezioni. «Molti di loro, una volta eletti, devono
spendere molte ore ogni settimana per raccogliere fondi già in previsione del
prossimo turno». Un’intero ingranaggio a ciclo continuo. «Penso che sia
possibile una versione differente delle elezioni americane senza tutto questo
flusso di denaro, ma avrebbe un aspetto molto diverso, i candidati sarebbero
meno visibili agli elettori, senza i miliardi di dollari spesi in pubblicità».
Dalla rassegna stampa di ''Epr Comunicazione'' il 5 novembre
2020. Se il presidente Trump dovesse perdere la sua la rielezione, come sembra
sempre più probabile , sarebbe la prima sconfitta di un presidente in carica in
28 anni. Ma una cosa sembra certa: che vinca o perda, non se ne andrà in
silenzio – scrive il NYT. Come minimo, gli restano 76 giorni di carica per usare
il suo potere come meglio crede e per cercare di vendicarsi di alcuni dei suoi
percepiti avversari. Arrabbiato per una sconfitta, può licenziare o mettere in
disparte una serie di alti funzionari che non sono riusciti a realizzare i suoi
desideri, tra cui Christopher A. Wray, il direttore dell'FBI, e il dottor
Anthony S. Fauci, il miglior specialista governativo in malattie infettive nel
bel mezzo di una pandemia. E se sarà costretto a lasciare la Casa Bianca il 20
gennaio, Trump si dimostrerà probabilmente più resistente del previsto e quasi
sicuramente rimarrà una forza potente e dirompente nella vita americana. Ha
ricevuto almeno 68 milioni di voti, o cinque milioni in più rispetto al 2016, e
ha ottenuto circa il 48 per cento del voto popolare, il che significa che ha
mantenuto il sostegno di quasi la metà del pubblico nonostante quattro anni di
scandali, battute d'arresto, impeachment e la brutale epidemia di coronavirus
che ha ucciso più di 233.000 americani. Questo gli dà una base di potere per
svolgere un ruolo che altri presidenti sconfitti per un mandato come Jimmy
Carter e George Bush non hanno svolto. Trump ha a lungo giocato con l'avvio di
un proprio network televisivo per competere con Fox News, e in privato
ultimamente ha proposto l'idea di tornare a correre nel 2024, anche se a
quell'epoca avrebbe già compiuto 78 anni. Anche se i suoi giorni da candidato
sono finiti, i suoi 88 milioni di follower su Twitter gli danno un megafono per
essere una voce influente sulla destra, facendolo potenzialmente diventare un
kingmaker tra i repubblicani in ascesa. "Se c'è qualcosa di chiaro dai risultati
elettorali, è che il presidente ha un enorme seguito, e non ha intenzione di
uscire di scena a breve", ha detto l'ex senatore Jeff Flake dell'Arizona, uno
dei pochi funzionari repubblicani a rompere con Trump negli ultimi quattro anni.
Questo potrebbe ancora permettere a Trump di ottenere un secondo mandato e
quattro anni per cercare di ricostruire l'economia e rimodellare il Partito
Repubblicano a sua immagine. Ma anche da fuori del suo mandato, potrebbe tentare
di fare pressione sui senatori repubblicani che hanno mantenuto la loro
maggioranza per resistere a Biden in ogni occasione, costringendoli a scegliere
tra la conciliazione o l'attraversamento della sua base politica. Fino a quando
una nuova generazione di repubblicani non si farà avanti, Trump potrebbe
posizionarsi come leader de facto del partito, brandendo una straordinaria banca
dati di informazioni sui suoi sostenitori che i futuri candidati vorrebbero
affittare o a cui accedere in altro modo. Gli alleati immaginavano che altri
repubblicani facessero un pellegrinaggio nella sua tenuta di Mar-a-Lago in
Florida per chiedere la sua benedizione. "Non è che il suo account Twitter o la
sua capacità di controllare un ciclo di notizie si fermi", ha detto Brad
Parscale, il primo responsabile della campagna del presidente in questo ciclo
elettorale. "Il Presidente Trump ha anche la più grande quantità di dati mai
raccolta da un politico. Questo avrà un impatto sulle competizioni e sulle
politiche per gli anni a venire". Gli exit poll hanno mostrato che, a
prescindere da importanti "disertori" repubblicani come il senatore Mitt Romney
dello Utah e i Never Trumpers del Lincoln Project, Trump ha goduto di un forte
sostegno all'interno del suo stesso partito, vincendo il 93 per cento degli
elettori repubblicani. Ha fatto anche un po' meglio con gli elettori neri (12%)
e gli elettori ispanici (32%) rispetto a quattro anni fa, nonostante la sua
retorica spesso razzista. E dopo il suo blitz ad alta energia attraverso gli
stati in bilico, gli elettori che hanno deciso tardivamente gli hanno aperto la
strada. Alcune delle argomentazioni di Trump hanno avuto un peso considerevole
con i membri del suo partito. Nonostante la pandemia di coronavirus e il
relativo pedaggio economico, il 41 per cento degli elettori ha detto che stava
andando meglio di quando è entrato in carica, rispetto a solo il 20 per cento
che si è descritto in condizioni peggiori. Adottando le sue priorità, il 35 per
cento degli elettori ha indicato l'economia come la questione più importante, il
doppio di quelli che hanno citato la pandemia. Il 49 per cento ha detto che
l'economia era buona o eccellente, e il 48 per cento ha approvato la gestione
del virus da parte del suo governo. "Se sarà sconfitto, il presidente manterrà
l'eterna fedeltà degli elettori del partito e dei nuovi elettori che ha portato
nel partito", ha detto Sam Nunberg, che è stato uno stratega della campagna di
Trump per il 2016. "Il presidente Trump rimarrà un eroe all'interno
dell'elettorato repubblicano". “Il vincitore delle primarie presidenziali
repubblicane del 2024 sarà il presidente Trump o il candidato che gli assomiglia
di più". Non tutti i repubblicani condividono questa opinione. Mentre Trump
continuerà senza dubbio a parlare e ad affermarsi sul palcoscenico pubblico,
hanno detto che il partito sarebbe felice di cercare di andare oltre a lui se
perdesse e sarebbe ricordato come un'aberrazione. "Non ci sarà mai un altro
Trump", ha detto l'ex rappresentante Carlos Curbelo della Florida. "Gli
imitatori falliranno". Gradualmente svanirà, ma le cicatrici di questo periodo
tumultuoso della storia americana non scompariranno mai. In effetti, Trump non è
riuscito a riprodurre il suo fortunato successo del 2016 quando si è assicurato
la vittoria del Collegio Elettorale anche se ha perso il voto popolare contro
Hillary Clinton. Per tutti gli strumenti di cui disponeva, non è riuscito a
raccogliere un solo stato che non aveva vinto l'ultima volta, e da mercoledì ne
ha persi due o tre, con un paio di altri ancora sul filo del rasoio. Altri
presidenti sfrattati dopo un solo mandato o meno - come Gerald R. Ford nel 1976,
Carter nel 1980 e Bush nel 1992 - sono svaniti nell'ombra politica. Ford
contemplò brevemente un ritorno, Carter occasionalmente criticò i suoi
successori e Bush fece una campagna per i suoi figli, ma nessuno di loro rimase
a lungo una delle principali forze politiche all'interno del loro partito.
Politicamente, almeno, ognuno di loro era visto, a vari livelli, come una forza
persa. L'ultimo presidente sconfitto che, dopo aver lasciato la carica, cercò di
svolgere un ruolo di mediatore di potere fu Herbert Hoover, che si posizionò per
candidarsi di nuovo dopo la sua sconfitta nel 1932 a Franklin D. Roosevelt e
divenne un leader schietto dell'ala conservatrice del Partito Repubblicano. Pur
avendo esercitato un'influenza significativa per anni, non ha riconquistato la
nomina né ha cambiato il verdetto della storia. Per Trump, che più di ogni altra
cosa si preoccupa di "vincere, vincere, vincere", essere conosciuto come un
perdente sarebbe intollerabile. Il giorno delle elezioni, durante una visita al
quartier generale della sua campagna elettorale, ha meditato ad alta voce su
questo. "Vincere è facile", ha detto ai giornalisti e ai membri dello staff.
“Perdere non è mai facile. Non per me, no non lo è". Per evitare un tale
destino, mercoledì il presidente ha cercato di convincere i sostenitori che le
elezioni erano state rubate semplicemente perché le autorità statali e locali
stavano contando le schede elettorali legalmente giunte. Il fatto che non fosse
vero evidentemente non gli importava molto. Stava mettendo in piedi un racconto
per giustificare le contestazioni legali che persino gli avvocati repubblicani
ritengono infondate e, se questi non ci riuscissero, si presenterebbe come un
martire che non era stato ripudiato dagli elettori ma in qualche modo derubato
da forze nefaste invisibili. Lo stesso Trump ha una lunga storia di accuse di
frode. Sua sorella ha affermato di aver convinto qualcun altro a sostenere
l'esame di ammissione al college. Le figlie di un ortopedico del Queens
sostenevano che il loro defunto padre aveva fatto a Trump una diagnosi di
speroni ossei per proteggerlo dalla leva per la guerra del Vietnam come favore a
Fred Trump, suo padre. E i suoi affari lo hanno spesso intrappolato in accuse e
cause legali. Trump ha pagato 25 milioni di dollari agli studenti della sua
Trump University per risolvere le accuse di frode. La sua fondazione di
beneficenza è stata chiusa dopo che le autorità hanno trovato uno "scioccante
schema di illegalità". Secondo un'indagine del New York Times, negli anni '90 ha
partecipato a regimi fiscali dubbi, compresi i casi di frode vera e propria. E
Michael D. Cohen, il suo ex avvocato , ha scritto in un recente libro che ha
truccato due sondaggi online per conto del signor Trump. Il presidente è
sopravvissuto a tutto questo e a una serie di fallimenti e altri fallimenti
attraverso una vita di celebrità e di appelli populisti che gli hanno dato
l'aura di un vincitore che ha coltivato. Dal suo periodo nel settore immobiliare
e della televisione reality, ha fatto parte del firmamento della cultura pop del
Paese per 30 anni, figura ricorrente nei film, negli spettacoli televisivi e nei
suoi stessi libri. È stato, per milioni di persone, un simbolo di aspirazione e
di ricchezza dorata. È stato il protagonista di una serie televisiva popolare
per 14 stagioni, che lo ha introdotto nel Paese molto prima che si candidasse. E
una volta fatto, le sue esuberanti manifestazioni gli hanno legato i suoi
sostenitori in un modo che ha sottolineato quanto sia un fenomeno culturale. Per
mesi, mentre le sue possibilità di essere rieletto si riducevano, Trump diceva
ai consiglieri - a volte scherzando, a volte no - che se avesse perso avrebbe
prontamente annunciato che si sarebbe candidato di nuovo nel 2024. Due
consiglieri hanno detto che terrebbe fede a quella dichiarazione se le sue
contestazioni legali falliscono, una mossa che, se non altro, gli permetterebbe
di raccogliere fondi per finanziare le manifestazioni che lo sostengono. Quando
sembrava che perdesse la sua campagna nel 2016, lui e alcuni membri della sua
famiglia hanno parlato di avviare una impresa mediatica, vagamente concepita
come "Trump TV". Alcune di queste discussioni sono proseguite anche quest'anno,
secondo le persone che le conoscono. "Non c'è dubbio che sia una delle più
grandi figure politiche polarizzanti della storia moderna", ha detto Tony
Fabrizio, uno dei sondaggisti di Trump. "I suoi sostenitori lo adorano e i suoi
avversari lo insultano. Non c'è una via di mezzo per Donald Trump".
Cosa ha
deciso il voto negli Stati Uniti.
Andrea
Muratore su Inside Over il 4 novembre 2020. L’esito delle elezioni statunitensi
è ancora tutto da scrivere, ma le tendenze dell’Election Day confermano quanto
si percepiva da tempo: il Paese è polarizzato, spaccato in due e diviso da linee
di faglia sempre più profonde. L’onda blu e la marea democratica di cui molti
sondaggi avevano parlato non si è realizzata, dato che tra Joe Biden e Donald
Trump si è svolto un braccio di ferro politico, riflesso di una campagna
elettorale nervosa, sporca e scarsamente concentrata sui temi concreti e i
trendi strategici che, in prospettiva, hanno però acquisito rilevanza al momento
delle urne. Le elezioni statunitense non sono mai un monolite, sono cinquanta
voti in uno. E in una fase in cui, come detto, le faglie tendono a rafforzarsi
questa è risultata essere una realtà di fatto. Ci sono state dinamiche sommerse
dal duro scontro frontale e dal ruvido scambio d’accuse tra i candidati, che
possiamo riassumere in alcuni macroargomenti che hanno condizionato la scelta
alle urne degli elettori. In primo luogo, si conferma la concezione che vede
le minoranze etniche nel Paese come qualcosa di fortemente eterogeneo al loro
interno. Le speranze democratiche di una marea elettorale e di una vittoria
annunciata già dai primi scrutini puntavano fortemente su un vero e proprio
“accerchiamento” del Grand Old Party attraverso la creazione di un blocco unente
alla popolazione bianca urbana e agli studenti un sostanziale dominio
trasversale nel voto della minoranza nera e latina. Considerazione che si è
scontrata con la diversa condotta di due Stati come la Florida e l’Arizona. Nel
Sunshine State Trump si è riconfermato rispetto al 2016, forte di un incremento
di consensi tra gli elettori latini che hanno toccato il record di 2,5 milioni
di iscrizioni in Florida (17% del corpo elettorale) e di una strenua tenuta
nella roccaforte democratica di Miami. In Arizona, invece, il voto delle contee
al confine col Messico ha trainato la rimonta di Biden rispetto al risultato di
Hillary Clinton del 2016. Risulta importante sottolineare che in Florida buona
parte della popolazione latina sia di ascendenza cubana o venezuelana, dunque
politicamente più interessata al Grand Old Party, mentre in Arizona contano per
la maggior parte i cittadini originari del Messico e del resto del Centro
America, che rappresentano un’immigrazione più recente. Inoltre, la vocazione
plebiscitaria dei democratici tra i latini non è paragonabile a quella detenuta
nella comunità afroamericana. Come riporta Vox, i sondaggi davano Biden in linea
con la Clinton, al 63% dei consensi tra i latini, contro il 71% di Barack
Obama nel 2012. Trump ha ottenuto un lieve, ma tutt’altro che
insignificante, miglioramento, passando dal 28% a oltre il 30% su base
nazionale. Un passaggio che può essere confermato dalla tenuta di uno Stato
chiave come la Florida anche in un contesto di alta affluenza. A mantenere
aperta la pista per la Casa Bianca per Biden, in prospettiva, possiamo dire sia
stata la sua ritrovata focalizzazione sui temi del lavoro e
dell’occupazione insipientemente negletti dalla Clinton nel 2016 e che sono
stati pagati con disastrose sconfitte negli Stati operai della Rust Belt:
Michigan, Wisconsin, Pennsylvania. L’elevata affluenza, l’alta percentuale di
voti espressi per posta e i rischi di ricorsi legali non consentono di dare un
giudizio definitivo su chi sarà il trionfatore nell’ex cuore industriale
d’America. I ritardi nel conteggio fanno il resto. Ma la partita resta
apertissima: e in un certo senso Biden è competitivo per la capacità di
riscoprire i temi portati avanti da Bernie Sanders sulla materia della
reindustrializzazione, della creazione di posti di lavoro e del rilancio
dell’economia nazionale. Promesse che rappresentano il work in progress più
importante dell’agenda economica di Trump. Pragmatismo contro sentimento: Biden
ha, pragmaticamente, portato avanti un’agenda economica diversa dalla sua
tradizionale impostazione centrista, ma nonostante i ritardi nel rilancio della
produzione nella Rust Belt Trump è rimasto pienamente in partita e, anzi, in
attesa dei dati definitivi del voto per posta ha iniziato la notte in testa
negli scrutini del voto espresso nell’Election Day. Questo si può indubbiamente
spiegare con la presa emotiva che il tycoon newyorkese ha avuto modo di
conquistare su una fascia di elettorato operaio, impegnato nell’industria e
straniato dal confronto con le metropoli della costa a cui in passato i
democratici non sono riusciti a dare rappresentanza. Exit poll diffusi alla
chiusura delle urne in Ohio, Stato consolidatosi come repubblicano, segnalano
che il 56% dei lavoratori iscritti al sindacato hanno scelto Trump, un dato
estremamente indicativo su cui anche Biden, in caso di elezione, dovrà
ragionare. Due anni fa anche un duro critico del Presidente come Bruce
Springsteen, In un’intervista alla Cnn, h asottolineato come i democratici
dovessero trovare la capacità di parlare con la stessa voce” di Trump a
un’America timorosa delle conseguenze della globalizzazione, socialmente
conservatrice. E di risolvere il vero problema costato la sconfitta nel 2016
alla Clinton: la massiccia defezione di una fascia consistente di elettorato,
soprattutto bianco, passato all’astensione, come ha ricordato con puntualità lo
storico e politologo Mario Del Pero. La partita elettorale conferma un’America
sempre più divisa, polarizzata e in cui l’incomunicabilità delle istanze
politiche appare confermato da risultati diametralmente
contrastanti. California, Illinois e New York votano a valanga Biden, mentre i
flyover States dell’America profonda si confermano colorati di rosso intenso
repubblicano. Da un lato l’economia dei servizi e la globalizzazione, dall’altro
l’America rurale, conservatrice e identitaria: una faglia profonda acuitasi in
quattro anni di forte contrapposizione e resa ancora più palese dalla pandemia.
Il coronavirus è stato indicato da molti come il game changer che poteva
trainare una vittoria travolgente dei democratici. Ma alla prova dei fatti la
mappa elettorale del 2020 e quella del 2016 sono fortemente sovrapponibili. La
categoria in cui essa ha funto da fattore trainante per drenare consensi è stata
quella degli elettori oltre i 65 anni tra i quali, secondo un sondaggio Cnn
commentato da Il Riformista, “Biden gode del 60% dei consensi tra gli
elettori “silver”, mentre Trump resta al palo (39%). Lo stesso sondaggio spiega
anche perché: il 78% degli intervistati di età pari o superiore a 65 anni cita
proprio l’epidemia di coronavirus come un “fattore estremamente
importante” nella scelta del prossimo presidente”. Bisognerà valutare, a conti
fatti, quanto questo avrà pesato negli Stati in bilico, dall’Arizona alla Rust
Belt. Ma anche l’opinione sulla pandemia è conseguenza, e non causa, delle aspre
polarizzazioni che al voto 2020 abbiamo visto tornare nuovamente in superficie.
Gli
avversari (sconfitti) del trumpismo.
Francesco
Boezi su Inside Over il 4 novembre 2020. Mentre scriviamo lo spoglio di queste
elezioni presidenziali è ancora in corso, ma qualche conclusione può già essere
tratta: l’onda blu pro Joe Biden – quella che avrebbe dovuto destrutturare del
tutto il ruolo ed il significato politico del presidente Donald Trump, non si è
verificata. E i primi sconfitti sono gli opinion maker di questa turnata. Tra
questi, vale la pena citare gli ecclesiastici progressisti, i capi-popolo dei
movimenti che hanno interessato le cronache americane in questi mesi e larga
parte della stampa main-stream, che ha di certo sbagliato le previsioni,
pronosticando una facile vittoria per il candidato dei Democratici. Joe Biden,
alla fine di questa storia, che si preannuncia come piuttosto lunga, potrebbe
anche vincere, ma la propaganda politica, e in qualche caso la pastorale, non ha
suscitato gli effetti sperati. Il gesuita James Martin e l’arcivescovo di
Washington, che Jorge Mario Bergoglio creerà a breve come cardinale, non
potranno dire di aver intercettato l’opinione maggioritaria dei cattolici. I
flussi elettorali non sono ancora noti, ma i dati su alcuni Stati sì. Sono
numeri sufficienti per dire che la base dei fedeli americani non si è riversata
nelle urne per contrastare l’azione di Trump, impedendogli di raggiungere un
secondo mandato. Questo, in fin dei conti, era l’obiettivo dichiarato dei
progressisti ecclesiastici degli States. Nella tarda serata di ieri, i gesuiti
della rivista America hanno persino organizzato una preghiera. Certo, anche il
fronte conservatore ha pregato, in questo caso per Trump, ma i cardinali
tradizionalisti non possono certo affermare di essere parte integrante di questo
pontificato. La Chiesa americana, insomma, ne esce se possibile ancor più
polarizzata, contribuendo alla narrazione di uno Stato federale spaccato a metà
al suo interno un po’ su tutti i piani. Un discorso simile può essere fatto per
i movimenti. Il Black Lives Matter, anche qui in via esemplificativa, non sembra
aver convinto troppi elettori. Anzi, alcune zone in cui i movimentisti hanno
manifestato durante gli scorsi mesi, magari creando qualche disordine, si sono
espresse in favore del presidente uscente. E questo è un elemento che non può
non essere considerato. Così come appare rilevante che Donald Trump abbia
dimostrato di avere con le minoranze un rapporto più solido di come molti
benpensanti supponevano: la vittoria in Florida parla da sola di questa
tematica. E non bisognerebbe stupirsi troppo se sempre i flussi elettorali
dimostrassero che la comunità ispanica abbia preferito Trump in misura superiore
rispetto alle elezioni presidenziali di quattro anni fa. Si tratta di ipotesi,
ma il combinato disposto tra i risultati parziali e le tendenze elettorali
fotografano questa che è qualcosa di più di una semplice supposizione. Un
discorso a parte andrebbe riservato agli operatori della stampa progressista che
per messi hanno ventilato certezze sul distacco che Biden sarebbe stato in grado
di costruire nella Rust Belt, che sino a questo momento sembra aver scelto di
nuovo il tycoon, in barba a molte considerazioni pre-elettorali. Non sappiamo
ancora con che tipo di America avremo a che fare nel corso dei prossimi quattro
anni. Così come non conosciamo dunque i rapporti che potrebbero intercorrere tra
la Santa Sede, le gerarchie ecclesiastiche in loco ed il presidente degli Stati
Uniti d’America. Quello che è chiaro riguarda ancora una volta la fallacia di
chi riteneva che la storia non potesse che andare in una direzione. Joe Biden
non ha trionfato alla maniera di chi deve bere un bicchier d’acqua. Poi il
candidato degli asinelli potrà anche vincere questo incredibile appuntamento
elettorale, ma gli Stati Uniti continueranno ad essere divisi tra due visioni
del mondo opposte. La parte progressista della Chiesa cattolica, i movimenti di
protesta e la maggioranza degli organi di stampa non hanno costruito una
maggioranza inattaccabile all’interno dei confini americani. E questa,
considerando i presupposti da cui si era partiti, è già una notizia che può
essere sottolineata.
La lezione Trump: Sovranismo contro ”Internazionale
narcisista”. Andrea Cionci su Libero Quotidiano il 07
novembre 2020. Andrea Cionci. Storico dell'arte, giornalista e scrittore, si
occupa di storia, archeologia e religione. Cultore di opera lirica, ideatore del
metodo “Mimerito” sperimentato dal Miur e promotore del progetto di risonanza
internazionale “Plinio”, è stato reporter dall'Afghanistan e dall'Himalaya. Ha
appena pubblicato il romanzo "Eugénie" (Bibliotheka). Ricercatore del bello, del
sano e del vero – per quanto scomodi - vive una relazione complicata con
l'Italia che ama alla follia sebbene, non di rado, gli spezzi il cuore. A meno
di non assistere a qualche colpo di scena finale, la sconfitta quasi certa di
Trump segna la nuova sfida per i leader sovranisti: il terreno di scontro del
futuro non sarà sui CONTENUTI, (ormai ovvi), ma sulla FORMA. Questa dicotomia
potrebbe aggiungersi a quella già individuata in questo articolo sui due grandi
sistemi di pensiero che oggi si scontrano. Il grande nemico da abbattere,
quindi, sarà il Narcisismo: un pifferaio che ipnotizza milioni di persone
indirizzandole a sinistra persino contro i loro stessi interessi. Perché,
infatti, l’elettorato democratico non ha apprezzato gli “zero tituli” di Trump
alla voce “esportazione di democrazia”? E i buoni risultati sull’occupazione e
sugli altri temi cari al socialismo? Probabilmente non si è ancora compreso a
fondo il potere seduttivo dell’appartenere a una élite estetico-intellettuale.
Un esempio? I pro-immigrazione: costoro non provano autentica solidarietà umana
- e la prova è che tale empatia non vale allo stesso modo per i concittadini
stuprati, mangiati, o presi a picconate – ma gli accoglientisti esprimono
fondamentalmente un messaggio egoico subliminale: “Io ce l’ho fatta: vivo in una
bella zona e l’insicurezza portata dai clandestini non mi tange. Appartengo alle
classi dominanti e, ovviamente, sposo il loro pensiero”. Un’altra forma
larvatamente narcisistica è l’adesione al dirittismo Lgbt: “Sono così evoluto
che accetto ogni stravolgimento in materia familiare e bioetica. Il mondo dei
vecchi, coi suoi valori stantii, non mi appartiene perché sono ancora giovane e
bello”. L’europeismo/globalismo fornisce, poi, ritorni autoreferenzialistici
ancora più raffinati: “Ma basta dai, ancora con l’Italietta e queste visioni di
voi provinciali. Io ho una visione internazionale, sono un cittadino del mondo,
ho viaggiato, conosco le lingue…”. Ci si potrebbe divertire ancora a lungo
individuando il vanesio sottotesto in ogni posizione “dem”. Quell’intimo senso
di superiorità che alberga spesso nei laureati in Lettere e Filosofia è stato
democratizzato, standardizzato e diffuso come un prodotto di consumo: “Spocchia
radical prêt-à-porter”. Così, il contatto coi bisogni della gente, in politica,
da moltissimi elettori non viene più visto come un valore, ma diventa
un “tevvibilmente volgave” sintomo di vicinanza con gli zoticoni. I giovani poi,
da millenni in cerca di una identità mai trovata, si strafanno di
ideali chic presi a basso costo dal discount progressista: la pace, l’ecologia,
l’accoglienza, l’”ammore” perché i valori tradizionali sono “da vecchi”. (In
effetti, bisogna ammettere che chi è di sinistra, con la maturità, può finire
talvolta a destra, ma non si verifica mai il contrario. Curioso). Comunque,
solleticando questa vanità medio-borghese, la sinistra occidentale raccoglie
milioni di voti e colpisce l’avversario nel suo punto debole: la forma. Trump è
stato infatti massacrato per le battutacce, le scivolate, le ineleganze, le
donnine, perfino per come tiene il bicchiere (con due mani pensate!). A
proposito, la mano stretta a Kim Jong Un si è svuotata completamente di
significato quando Donald non ha raccolto quella di Melania, scendendo
dall’aereo. Bagattelle, certo, che producono, però, effetti di un certo peso:
Biden adesso autorizzerà ovunque l’aborto al 9° mese, come da programma, e
migliaia di bambini saranno fatti a pezzi. Tutto per qualche gaffe trumpiana di
troppo. Pensiamo al nostrano Salvini: è stato messo in croce per come mangia le
ciliegie, per le foto coi biscotti, per le parolaccette, il mohito, il Papeete,
la felpa, la panza, le divise della Polizia etc. E ora siamo senza decreti
sicurezza e la gente viene decapitata. Non è un caso che la Meloni voli nei
sondaggi: nonostante qualche ruggito “Garbatella-style”, la giovane signora si
presenta sempre carina, decisa, ma a modo, e lascia che Matteo faccia da
parafulmine per gli attacchi degli arbiter elegantiarum avversari. I leader di
destra sappiano, dunque, che saranno inchiodati dall’”Internazionale
narcisista” non sui fatti, ma sulle sciocchezze, sullo stile, sul linguaggio,
sul bon ton a tavola, sul garbo con la moglie, in un grande, bigotto e pettegolo
salotto di Versailles mediatico. Il sovranismo italiano ha, quindi, urgente
bisogno di nuovi panni, eleganti e fascinosi: occorre un nuovo, assertivo
rigore, un orgoglio della serietà, una NUOVA ESTETICA che trascenda i consueti,
rassicuranti modelli nazional-popolari “pizza-Nutella-Tricolore” per competere
con le seduzioni del radicalchicchismo. Si può essere vicini al popolo anche con
signorilità: si ricordi don Enrico Berlinguer, nobile sardo e cavaliere
ereditario. Si può dire la verità senza sbraitare, in giacca e cravatta, si può
agire pro-vita senza fare i gagà con le ragazze. Conservare la Patria,
l’Identità e la Famiglia dovrà figurare come l’obiettivo di una élite
coraggiosa, integerrima e colta, depositaria di una missione alta come quella
del restauratore, del filologo, o del chirurgo che opera e che salva. E il
popolo percepirà questo prestigio.
Donald Trump, calci pugni e schiaffi. Video shock dalla
"democratica" America. Gentiloni l'ha visto?. Libero
Quotidiano l'08 novembre 2020. L'America "civile e progressista" festeggia la
vittoria del democratico Joe Biden prendendo a schiaffi, pugni e calci un
fantoccio di gomma con l'immagine del presidente uscente Donald Trump. Un
festival dell'odio di cui la stampa internazionale e i tanti politici di
sinistra che in queste ore si stanno complimentando con Biden ovviamente non
fanno menzione. E se Paolo Gentiloni, ex premier del Pd oggi commissario Ue
all'Economia, ha esultato con una immagine grottesca per la sconfitta di Donald
("Mi abbraccerei da solo"), qualcuno a Bruxelles potrebbe mostrargli il video
virale postato anche da Radio Savana su Twitter. Commento ironico e amaro: "Gli
effetti collaterali della metanfetamina spiegati in 60 secondi". Magari fosse
tutto dovuto alla droga.
Scene d’isteria collettiva a New York: fantoccio di Trump
preso a calci e sputi tra gli applausi. Prisca
Righetti domenica 8 Novembre 2020 su Il Secolo d'Italia. Si scatena, tutto
insieme l’odio contro Trump. Un fantoccio del presidente uscente. O meglio, la
sua immagine stampata su un mega cuscino triangolare, diventa il fantoccio che
un elettore di Biden prende a calci e sputi in mezzo alla strada a New York. La
folla, radunatasi per streets ed avenue in tutta la Grande Mela fa da corollario
rumoroso, incitando e applaudendo fragorosamente il cittadino irriverente di
turno…Scene da brividi, quelle che arrivano da oltreoceano, che hanno solo il
compito di scatenare la sociopatia degli elettori anti-Trump. Le immagini che
arrivano da New York non esprimono solo l’astio covato nel profondo per il
presidente uscente. Ma rappresentano un odio sociale senza limiti che confonde
il dissenso con la ferocia simbolica. E infatti, nelle sequenze immortalate da
un cittadino americano e diffuse via social, non si limitano a manifestare la
soddisfazione per la controversa e tormentata elezione del 46 inquilino della
Casa Bianca: un’attestazione di vittoria maturata nel caos e nel dubbio. No, gli
americani pro-Biden stanno mostrando il peggio di loro. E approfittando di
queste ore di euforia, trasformano la soddisfazione in ingiuria. E i
festeggiamenti per l’elezione di Biden diventano l’occasione per inscenare
rancore e malcontento di parte da manifestare senza freni. Nel video, postato su
Twitter dal sito Radiosavana, vediamo infatti più elettori che si alternano
vicendevolmente in una sorta di staffetta della vergogna. E che, armati di
cuscinone con l’immagine di Trump, prima cominciano a strapazzare il feticcio.
Poi, in una escalation di furia e goliardia selvaggia, lo prendono a calci,
sputi e cazzotti. Per il pubblico ludibrio dei manifestanti come loro che gli
lasciano tutta la scena, limitandosi ad approvare rumorosamente. Poi, in una
sorta di staffetta vergognosa, uno ad uno, si fanno sotto gli altri,
incoraggiati dalla reazione “entusiastica” del pubblico. Ognuno si passa lo
scomodo testimone e infierisce con cazzotti, calci che fanno volare il simulacro
offeso e svillaneggiato. c’è chi lo lancia in aria e chi infierisce con calci e
sputi. E si va ancora avanti, così, scaraventando ovunque, a più riprese, il
cuscinone con il volto di Trump. E lo “show” di protesta supera ogni limite di
decenza e buon gusto. Tutto intorno, la folla applaude, ride, sghignazza e
fischia in segno di approvazione. Poi, non contenti, i protagonisti che si
alternano nella vergognosa performance, prendono anche una bicicletta e la
scagliano violentemente sul fantoccio improvvisato. Più volte. Immagini di una
efferatezza, non solo simbolica, che si commentano da sole...
Giorgia Meloni su Donald Trump e le "cheerleader italiane":
Salvini? "No, la vergogna della sinistra italiana su Biden presidente".
Libero Quotidiano l'08 novembre 2020. “Non penso che l’Italia
faccia una bella figura con tutte queste cheerleader strepitanti”. Giorgia
Meloni decide di interrompere il silenzio sulle elezioni presidenziali americane
e curiosamente per scagliarsi contro gli avversari sceglie un termine che
l’Independent aveva usato per provocare Matteo Salvini in quanto sostenitore
di Donald Trump. Ormai Joe Biden è sicuro di diventare il 46esimo presidente
degli Stati Uniti e ha già iniziato a pensare e lavorare da tale, con buona pace
di Trump che insiste sui brogli elettorali che però non riesce a dimostrare. Di
certo c’è che, nonostante la sconfitta, l’era politica di Donald non finisce
qui: nulla gli impedisce di riprovarci tra quattro anni per vendicare quanto
accaduto in queste elezioni conquistando il suo secondo mandato da presidente.
Intanto la Meloni è intervenuta così sulla questione: “Leggo imbarazzanti
dichiarazioni della sinistra e dei media mainstream sulle elezioni americane e
sulla (possibile) vittoria dei democratici a termine di una competizione molto
serrata con i repubblicani. La nostra visione di politica estera si basa
sull’interesse nazionale italiano e prescinde dalle tifoserie di parte”.
Insomma, la leader di Fdi non ha abbandonato Trump ma al tempo stesso neanche è
disposta a perdere credibilità seguendolo nella sua battaglia su presunti frodi
elettorali: “La nostra visione vale per i rapporti con i partner europei, come
per quelli con Cina e Russia e anche per quelli con gli Stati Uniti. Guardiamo
sempre a quello che succede negli altri Stati con la lente del tricolore
italiano. Purtroppo - ha chiosato la Meloni - è un concetto che la sinistra
italiana, che confonde la sua pozzanghera ideologica con i confini
dell’universo, non potrà mai capire”.
Massimo Rebotti per il “Corriere della Sera” il 9 novembre 2020.
Giorgia Meloni guida il gruppo dei Conservatori europei che con i Repubblicani
Usa ha un legame storico. La presidente di FdI, poi, ha stretto relazioni
personali con l' amministrazione Trump che l' hanno portata, unica esponente del
centrodestra italiano, a tenere un discorso nel 2019 alla Conservative political
action conference , kermesse annuale dei Repubblicani. In virtù di questa
sintonia le deve risultare indigesta la vittoria di Biden. Oppure è tra chi
ancora pensa che ci siano stati dei brogli? «Penso che Trump, se ha le prove,
abbia il diritto di perseguire tutte le strade che la legge e la Costituzione
gli consentono. Spetterà agli organi competenti, e non a qualche network
televisivo anti-Trump, confermare o meno la vittoria di Biden».
L'America di Trump ora pare quasi sparita, visibile solo nelle
milizie armate.
«Dopo il voto ci sono state decine di arresti e tutti tra i
manifestanti anti-Trump, estremisti dei movimenti Antifa e dei Black Lives
Matter. Esattamente come negli ultimi mesi di violenze. Chi ha votato Trump, in
numeri persino maggiori rispetto al 2016, ha dimostrato che esiste una larga
parte della popolazione Usa che non si riconosce nel pensiero caro al
mainstream. Gente che condivide il modello fatto di meno tasse, difesa della
produzione nazionale, più sicurezza e rivendicazione dell' orgoglio nazionale di
fronte a chi vuole abbatterne i simboli, come le statue del nostro Cristoforo
Colombo. Con questi principi e con questi elettori tutti dovranno fare i conti
per molto tempo ancora».
Quattro anni fa la vittoria di Trump aprì un ciclo «populista»
che ora potrebbe chiudersi pure in Europa.
«Veramente sento gridare al pericolo populista e sovranista da
molto prima dell' elezioni di Trump. E da ancora prima si pronostica la nostra
scomparsa. Ma gli analisti di sinistra confondono spesso la realtà con i loro
desiderata. L'ideologia globalista, quella delle frontiere aperte, della finanza
che vince sull' economia reale, del politicamente corretto è lontana dalla gente
e questo pone in capo a noi il dovere di rappresentare al meglio una visione del
mondo antitetica».
Lei appare la più trumpiana nel centrodestra.
«Non mi piacciono le etichette, l' unica definizione corretta per
me e per Fratelli d' Italia è quella di patrioti italiani. Condivido con Trump
idee e valori e in questi anni ho lavorato per rafforzare i legami. Ma non
faccio la cheerleader di nessuno. Ho sperato che vincesse perché lo ritengo
migliore per l' interesse nazionale italiano. È questa l' unica lente che uso
quando guardo all' estero. Mentre la nostra sinistra è sempre alla ricerca di
qualche mito di importazione».
L'impatto del voto Usa si sentirà tra i conservatori Ue?
Diventerete più europeisti?
«Continueremo a criticare questa Ue distante dalle vere esigenze
dei cittadini. Oggi ricordiamo l' anniversario della caduta del muro di Berlino.
Ieri come oggi la nostra Europa è quella che difende la libertà e l' identità
dei popoli. Piuttosto sono rimasta stupita nel vedere il mio omologo presidente
del Ppe, l' ex premier polacco Tusk, tifare smodatamente per Biden. Anche a
Bruxelles su molti temi i popolari vanno spesso al traino delle sinistre. Mi
auguro che chi tra loro, e sono tanti, non condivide questa deriva, si faccia
sentire».
Cosa teme di Biden?
«Sono preoccupata su due dossier: Cina e Medio Oriente. Sul primo
perché Biden ha una storia di vicinanza alla Cina, mentre io ritengo che Trump
abbia fatto bene a porre i temi di un mercato globale equo e della sicurezza dei
nostri dati e delle nostre infrastrutture. E sul secondo perché Biden era il
vice di Obama ai tempi del sostegno acritico alle primavere arabe, che ci hanno
regalato fondamentalismo islamico e immigrazione incontrollata».
Nella sinistra italiana c'è euforia per il voto Usa.
«L'euforia della sinistra è spesso commovente, molto bambinesca.
Ho provato un certo imbarazzo nel leggere il tweet del commissario Ue Gentiloni
che diceva di essere così felice per la vittoria di Biden che si stava
abbracciando da solo. Il messaggio che provano a far passare è che è stato
sconfitto un mostro pericoloso e non un avversario politico legittimato dal
consenso popolare. È una distorsione delle normali dinamiche democratiche che la
sinistra sta mettendo in atto negli Usa come in Europa: qualsiasi mezzo è lecito
per sconfiggere la pericolosa destra. Magari anche la censura sui media oppure
il ricorso alla violenza. Mi piacerebbe avere di fronte una sinistra capace di
confrontarsi sulle proposte, invece di quella attuale che ha come unica
strategia quella di demonizzare l' avversario, e con lui i cittadini che
condividono quelle stesse idee».
Da repubblica.it il 9 novembre 2020. Il regista Spike Lee, indiscusso punto di
riferimento del cinema afroamericano, ha festeggiato la vittoria di Joe Biden
insieme a decine di sostenitori per le strade di Fort Greene, quartiere di New
York. Davanti all'abitazione del cineasta afroamericano si è tenuto un vero e
proprio raduno e il regista ne ha approfittato per stappare una bottiglia di
champagne per celebrare l'evento. In tarda serata, Spike Lee, microfono in mano,
ha dichiarato davanti alla folla in festa: "Negli ultimi quattro anni siamo
stati lo zimbello del mondo. Ci ridevano dietro, ma oggi non ridono più.
L'America è tornata. Gli Stati Uniti hanno fatto la dannata cosa giusta!"
Elisabetta
Moro per elle.com il 9 novembre 2020. Se non fosse tutto vero, sarebbe forse da
rotolarsi dalle risate. Direi che si possono riassumere più o meno così le
ultime reazioni dei repubblicani all'aumentare dei voti blu che portano Biden un
po' più vicino alla vittoria. Trump, ormai, sembra aver perso un tantino il
controllo, è arrabbiato e alterna tweet in cui intima a caratteri cubitali "STOP
THE COUNT" "STOP THE FRAUD" and so on, a discorsi ufficiali dove fa
dichiarazioni pesantissime, eversive e palesemente false accusando i democratici
di aver "truccato" le elezioni (no, non c'è nessuna prova che lo stiano facendo,
se ci fossero dubbi). Ma le proteste del Presidente non sono nulla in confronto
al folle video che sta girando sui social della preghiera pronunciata dalla
consigliera spirituale di Trump, Paula White. Ora, ammettiamolo, forse anche noi
martedì sera prima di andare a letto una preghierina (almeno con la mente)
l'abbiamo fatta e con preghierina intendo un qualsiasi appello a qualsiasi
Entità Superiore, un qualsiasi rituale o gesto scaramantico o anche solo un
semplice "Che Dio (o chi per lui) ce la mandi buona". Ecco, ovviamente ognuno ha
la sua spiritualità e niente da dire per carità. Però: date un'occhiata alla
preghiera di White e poi ne riparliamo. "Colpisci, colpisci, colpisci, colpisci,
colpisci, colpisci, colpisci, colpisci, colpisci, colpisci, colpisci, (sì, lo
ripete undici volte) fino alla vittoria! Per ogni nemico schierato contro di te
colpiamo la terra perché ci darai la vittoria, Dio. Sento il suono della pioggia
abbondante, sento il suono della vittoria! Sento il suono della vittoria.
Vittoria, vittoria, vittoria, vittoria!". Inizia più o meno così la preghiera
recitata da White e trasmessa mercoledì sera sui suoi canali social durante una
sessione di preghiera in diretta. Niente da dire: la predicatrice evangelica ci
mette indubbiamente tutta se stessa tanto da sembrare quasi in trance mentre
colpisce l'aria con la mano e scandisce i versi in modo ritmato chiedendo a Dio
di allontanare "i demoni che stanno infestando queste elezioni", mentre invoca
l'invio di angeli dall'Africa e dal Sudamerica e mentre parla in lingue
incomprensibili ("A manda aka ata raka debaka"). Il risultato è tendenzialmente
grottesco. Come potete facilmente intuire, il mondo del web è letteralmente
impazzito davanti a questo spettacolo che con la democrazia ha ben poco a che
vedere e i meme (che di questi tempi non risparmiano nessuno) stanno circolando
ovunque anche se qualcuno sottolinea che la preghiera sia talmente assurda da
superare qualsiasi tipo di satira. C'è comunque chi ci prova (e ci riesce): "Gli
angeli sono stati inviati dall'Africa e dal Sudamerica", scrive un utente su
Twitter, "Ma non hanno ottenuto il visto". Insomma, l'intrattenimento social
continua.
Vittorio Feltri su Donald Trump: "Detestato in Italia da
giornalisti mediocri, cosa scrivono di lui i simpatizzanti di sinistra".
Vittorio Feltri su Libero Quotidiano l'8 novembre 2020.
Comincio col dire che le elezioni tenutesi negli Stati Uniti mi hanno emozionato
come una partita di calcio di serie C. Non mi hanno minimamente appassionato.
Mentre ho seguito con molto interesse i commenti riguardanti Trump e Biden
prodotti dai soliti sapientoni da talk-show o prima pagina. Ho udito e letto
cose turche. Il vecchio Donald è stato trattato da chi manco lo conosce come
fosse il diavolo, un ammazzapopoli, un farabutto meritevole della sedia
elettrica. Viceversa il suo avversario democratico, il quale è stato
santificato, dipinto quale salvatore dell'America. I toni usati dai nostri bulli
da tastiera sono stati e continuano ad essere apocalittici, ricordano le
battaglie all'ultimo sangue condotte dai comunisti negli anni Cinquanta, quando
tra rossi e scudocrociati non c'era alcun dialogo bensì un fitto scambio di
brucianti insulti. Capisco lo stato d'animo degli statunitensi impegnati a
sostenere uno dei due candidati a costo di affermare fregnacce, tuttavia mi
domando che senso avesse il livore dei nostri pennaioli alla moda contro il
leader ormai uscente. Di lui ne sono state vergate di ogni colore, improperi
disgustosi di norma riservati ai peggiori delinquenti, non certo a uomini
politici che possono piacere oppure no ma che vanno comunque rispettati. Non
voglio fare i nomi di coloro che nel nostro Paese hanno lapidato Trump con
violenza, segnalo soltanto che si tratta di giornalisti mediocri, privi di
autocontrollo, ovviamente simpatizzanti per la sinistra. La quale si conferma
una consorteria di malviventi che si sentono autorizzati a infangare chiunque
non la pensi come loro.
Estratto
dell'articolo di Marco Travaglio per il “Fatto quotidiano” l'11 novembre 2020.
[...] è bastata la sola esistenza in vita di Donald Trump per trasformare Joe
Biden nel nuovo Abramo Lincoln [...] [...] Tre anni fa La Stampa ancora diretta
dallo yankee Molinari era impegnatissima a dimostrare che Putin truccava le
elezioni in tutto il mondo, convincendo a colpi di hacker, troll e fake news
centinaia di milioni di abitanti del pianeta a votare i cattivi sovranisti al
posto dei soliti buoni. [...] L'articolo di Biden sulla rivista Foreign Affairs,
anticipato da La Stampa, svelava il fallito tentativo di pilotare le elezioni
francesi del 2017 [...] [...] Del resto all'epoca il vecchio Joe era considerato
in patria un buontempone specializzato in gaffe: appena apriva bocca perdeva una
preziosa occasione per tacere. Tipo quando aveva definito Obama "un nero pulito
in grado di parlare in modo articolato" e sostenuto che in America "il 47% dei
poveri sono scansafatiche". Infatti lo presero sul serio giusto l'Innominabile e
La Stampa [...] Ora si attendono lumi da Biden e dalle sue cheerleader italiote
sulle ultime presidenziali: com' è che ha vinto lui ed è il presidente più
votato di sempre? S'è alleato coi russi o, niente niente, Putin s'è distratto un
attimo?
Donald Trump, "festa di liberazione d'America": Massimo
Giannini ai piedi di Joe Biden. Libero Quotidiano l'08
novembre 2020. “Questo 3 novembre è il 25 aprile d’America. È una festa di
Liberazione”. Così Massimo Giannini nell’editoriale in prima pagina ha esultato
per l’elezione di Joe Biden in qualità di 46esimo presidente degli Stati Uniti.
Ma soprattutto il direttore de La Stampa ha festeggiato la sconfitta di Donald
Trump, dipinto come un dittatore che però ha preso 71 milioni di voti e ha perso
con scarti minimi in tutti gli Stati chiave: qualcosa vorrà pur dire… Tra
l'altro Giannini ha probabilmente fatto il funerale al Tycoon un po’ troppo
presto: “I quattro anni del primo e per fortuna unico mandato sono stati una
cavalcata nell’Apocalisse. Hanno prodotto danni universali e strutturali. Per
quanto sofferta e contrastata, la vittoria di Biden cambia il corso della
storia”. In particolare per il direttore de La Stampa si tratta di una svolta
“per tutte le democrazie occidentali”, arrivando a definire queste elezioni
presidenziali americane “le più importanti del dopoguerra non solo per il futuro
degli Stati Uniti ma per i destini del pianeta”. E ancora Giannini ha insistito
su questa linea: “Stavolta la posta in palio non era solo la Casa Bianca, ma
c’erano in gioco il senso ultimo di cosa sia l’America, il concetto di libertà,
l’idea stessa di democrazia”.
Joe Biden, la stampa italiana in ginocchio. Giannini ridicolo:
è il 25 aprile del mondo. Adele Sirocchi domenica 8
Novembre 2020 su Il Secolo d'Italia. E’ tutto un lecca lecca, dice
caustico Nicola Porro nella sua rassegna stampa mattutina. Commenta i giornali
italiani che salutano la vittoria di Joe Biden. Un evento narrato come uno
spartiacque nella storia dell’umanità: prima le tenebre avvolgevano il mondo,
ora spunta la luce. La melassa trasuda dalle prime pagine dei quotidiani,
avvolti da un conformismo soporifero per quanto riguarda l’analisi sul voto Usa.
Un coretto di voci uniformi che ben spiega il calo di vendite nelle edicole.
Kamala che entra nella storia, il populismo battuto nelle urne, il Biden Day, le
milizie dell’estrema destra pronte a rovinare la festa, il virus che finalmente
sarà sconfitto, il sogno americano, il clima che tornerà odoroso di rose. E c’è
poi chi raggiunge vette di retorica imbarazzante. Uno è Massimo Giannini, che
sulla Stampa firma un editoriale vergognoso per sostenere che l’elezione di
Biden rappresenta il 25 aprile del mondo. Ma perché, gli replica via
Twitter Guido Crosetto, c’era una dittatura in America? Trump non era venuto
fuori da democratiche elezioni? Certo ma – come annota Maria Giovanna Maglie –
la sinistra ama il popolo solo se gli consegna la vittoria. Altrimenti torna ad
essere sporco, brutto e cattivo. Sul Messaggero appare anche un’intervista
a Francesco Rutelli il quale assicura che Biden è innamoratissimo della città di
Roma. Insomma se non possiamo sperare nella Raggi c’è sempre lo zio d’America
che ha un pensiero buono per i romani… . E la nuova first lady? Anche per lei
solo biografie confettate. Pensate che ripristinerà l’orto di Michelle Obama
alla Casa Bianca. Non è una notizia che può cambiare la vita a milioni di uomini
e donne? Il limite lo supera Il Fatto con un video in cui Biden in versione
Padre Pio incontra un ragazzino balbuziente. Un faccia a faccia provvidenziale
visto che poi il ragazzino farà a sua volta un video per dire agli americani
quanto lo abbiano aiutato le parole di Biden facendo addirittura regredire la
balbuzie. E’ solo uno dei primi miracoli di Joe Biden. Ne seguiranno sicuramente
altri e la stampa italiana starà lì pronta a sottolinearli col solito spirito
critico che la contraddistingue. Del resto a dare il fiato alle trombe erano
stati per primi gli esponenti del Pd, anche loro senza timore del ridicolo, a
cominciare dal comico tweet di Paolo Gentiloni, commissario europeo per
l’Economia “Una giornata indimenticabile per l’Europa e la democrazia. Mi sto
abbracciando da solo”. La linea è stata quella da subito, quindi. E le testate
si sono volentieri uniformate.
Media e
sinistra contro Trump: un assedio durato quattro anni.
Roberto
Vivaldelli su Inside Over il 4 novembre 2020. Mai come questa volta, nella
storia americana, si è avuta la sensazione che la nazione fosse sul pericoloso
ciglio di una guerra civile, scatenata da una politica sempre più polarizzata e
dalla pericolosa deriva della identity politics, che ha animato il dibattito a
stelle strisce negli ultimi mesi dopo il barbaro assassinio di George Floyd e le
successive manifestazioni di Black Lives Matter. Come avevamo peraltro osservato
su InsideOver in tempi non sospetti, la sinistra radicale si era organizzata da
tempo per scendere in piazza e manifestare contro un eventuale vittoria del
presidente uscente, Donald Trump, al fine di mettere ferro a fuoco l’America:
due delle principali organizzazioni che hanno pianificato la mobilitazione di
massa sono l’Indivisible Project e Stand Up America. Queste ultime hanno riunito
dozzine di associazioni e progressiste e altrettanti movimenti – da Public
Citizen, MoveOn e End Citizens United Action Fund a sinistra a Republicans for
the Rule of Law e Stand Up Republic, tutte unite contro Donald Trump. Un clima
da guerra civile che si è respirato anche nelle scorse ore, con le città
americane che si sono letteralmente “blindate” in attesa dell’esito del
vincitore. A cominciare da Washington, che nel fine settimana si è letteralmente
corazzata e svuotata. Negozi, ristoranti, uffici, banche, tutto chiuso, come
riportato dall’agenzia Agi. E tutto blindato con il legno, che qui chiamano
“wood”. Sullo sfondo, la Casa Bianca, con il suo colonnato.
I media e i
social contro Trump. I grandi media cosiddetti “mainstream”, hanno – sin dal
primo giorno – osteggiato l’azione politica del presidente Donald Trump. Sin dal
primo momento, lo hanno giudicato come un rozzo populista non all’altezza di
ricoprire il ruolo per il quale era stato democraticamente eletto. Dopo aver
alimentato il falso scandalo del Russiagate e soffiato sul fuoco del processo di
impeachment, nelle ultime settimane di campagna elettorale, i grandi media
tradizionali hanno accuratamente evitato di menzionare lo scandalo che coinvolge
il figlio di Joe Biden, Hunter. Nella guerra a tutto campo contro The Donald, i
social network hanno addirittura fatto un passio ulteriore: Facebook e Twitter,
infatti, hanno deciso di limitare la diffusione di un articolo-inchiesta del New
York Post, entrato in possesso di email di Hunter Biden. Quei messaggi di posta
elettronica rivelerebbero che Hunter Biden, figlio del candidato democratico
Joe, presentò a suo padre un alto dirigente di Burisma, la società energetica
ucraina in cui lavorava, prima che l’allora vice presidente Usa facesse
pressioni sui funzionari del governo di Kiev affinché licenziassero un
procuratore che stava indagando sull’azienda. Uno scandalo enorme, che la stampa
ha perlopiù ignorato, tentando di favorire Joe Biden. Gli stessi media che hanno
ripetuto per mesi che Joe Biden lo avrebbe travolto, quando la serata elettorale
di ieri ci ha detto una cosa molto diversa.
Un presidente
sotto assedio, dall’inizio alla fine. In questi quattro anni, Donald Trump ha
avuto più nemici che amici all’interno della Casa Bianca. The Donald è apparso,
dall’inizio del suo mandato, un uomo solo, desideroso di cambiare Washington
dall’interno, assediato da quello “stato profondo” contro il quale si era messo
in competizione in qualità di uomo “anti-establishment”. Quasi un corpo
estraneo. E, in effetti, contro il tycoon della Casa Bianca si è mobilitato il
mondo intero: star di Hollywood, vip di ogni genere, intellettuali, artisti,
giornalisti fino al virologo Anthony Fauci. Senza contare quelli a cui aveva
dato fiducia e che hanno deciso di scrivere un libro per screditarlo, come l’ex
consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton o il generale James Mattis.
Alla fine è stata Washington a cambiare pelle a Donald Trump? Di sicuro Trump ha
cambiato l’America.
Così le tv censurano la diretta di Trump.
Le principali tv americane, tranne Fox e Cnn, hanno interrotto la
diretta con il presidente Trump che parlava di brogli e prometteva dura
battaglia. Lo scontro negli Stati Uniti si fa sempre più duro. Orlando
Sacchelli, venerdì 06/11/2020 su Il Giornale. Si inasprisce lo scontro tra il
presidente Trump e i principali network televisivi americani. Durante un
discorso dalla Casa Bianca (nella notte italiana) Trump è tornato a denunciare
che vi sono stati brogli ed ha promesso battaglia: "Se si contano i voti legali,
vinco facilmente. Se si contano i voti illegali, possono provare a rubarci
l’elezione". In particolare Trump ha fatto riferimento ai risultati di alcuni
stati chiave: Wisconsin, Michigan, Pennsylvania e Georgia. Discorso molto teso
quello di Trump, trasmesso in diretta tv e sui social network. Per tutta
risposta Abc, Cbs e Nbc hanno interrotto il collegamento. Episodio gravissimo
perché in quel momento, comunque la si pensi, stava parlando il presidente degli
Stati Uniti. Le altre tv come si sono comportate? Cnn e Fox News hanno trasmesso
integralmente il discorso. Ma la Cnn lo ha bollato come "il più disonesto della
sua presidenza", aggiungendo in sovraimpressione che "senza prove Trump sostiene
di essere vittima di una frode". In questo caso, sia pure da posizioni molto
critiche e, per certi versi agli antipodi, l'emittente tv si è limitata a
commentare e criticare duramente ma non ha censurato le parole di Trump. Le
altre tv, invece, hanno scelto il bavaglio. Shepard Smith (Nbc) l'ha annunciato
così ai propri telespettatori: "Interrompiamo il discorso del presidente perché
ciò che sta dicendo, in larga parte, è assolutamente falso. E non possiamo
consentire che vada avanti". Su Msnbc Brian Williams ha spiegato: "Ci troviamo
ancora una volta nell’insolita posizione di dover non solo interrompere il
presidente degli Stati Uniti, ma anche di doverlo correggere. Non abbiamo
nessuna evidenza di voti illegali - ha aggiunto - e non siamo a conoscenza di
alcuna vittoria da parte di Trump". Alla fine del discorso di Trump la Cnn ha
replicato in questo modo: "Che notte triste per gli Stati Uniti vedere il
presidente accusare falsamente qualcuno di aver tentato di truccare le elezioni.
E attaccare la democrazia ripetendo bugie su bugie su bugie. Tutto questo,
francamente, è patetico". Si può criticare finché si vuole un discorso politico
e lo si può persino "smascherare", facendo un accurato fact checking, ma
interrompere la trasmissione ha qualcosa di sinistro che non va nella direzione
della libertà. La battaglia ovviamente è in corso anche sui social network.
Facebook ha oscurato il gruppo "Stop the deal" (Ferma il furto), che alcuni
sostenitori di Trump stavano utilizzando per organizzare le proteste contro lo
spoglio elettorale. Alcuni membri avevano invocato azioni violente, altri si
erano limitati ad accusare i democratici di "rubare" le elezioni.
Antonio Monda per ''la Repubblica'' il 7 novembre 2020. «Quello a
cui stiamo assistendo - spiega Gay Talese - è una straordinaria prova di
democrazia, ma anche una tragedia». Lo scrittore è chiuso nel suo bunker, il
piano interrato della sua townhouse a Park Avenue dove scrive ogni giorno fino
alle sei del pomeriggio, senza televisione né telefono.
Perché parla di tragedia?
«Iniziamo dal dato positivo: è un grande momento di civiltà.
L'elettorato ha risposto in massa come mai nella storia degli Stati Uniti e ha
scelto liberamente e democraticamente. Mi viene in mente la battuta di Jfk:
"Quanto c'è di brutto nel nostro Paese può essere sempre risolto da quanto c'è
di bello". Ovviamente ora c'è da augurarsi che, una volta terminato il
riconteggio dei voti, Trump accetti il verdetto.
La tragedia è innanzitutto la sua: non sembra in grado di capire
questa semplice verità democratica, non è nel suo Dna. La conferenza stampa di
giovedì è gravissima dal punto di vista eversivo, ma anche il segno tragico di
un uomo che vive nelle sue illusioni e non accetta di essere arrivato al termine
del viaggio. È poi una tragedia per i suoi elettori che continuano ad
appoggiarlo attribuendogli poteri quasi messianici, specie dopo la guarigione
dal Covid: quel mondo, in gran parte non istruito e pieno di rancore, non vuole
dialogare con il nuovo presidente e purtroppo dubito che egli riuscirà ad
entrare in sintonia con loro. Infine è una tragedia per i media».
Che cosa intende?
«Innanzitutto c'è l'ennesima riprova della loro minima influenza
sul risultato: se dovessimo tener conto dell'appoggio della stampa, Biden
avrebbe dovuto vincere a valanga. Secondo: per molte testate Trump ha
rappresentato una manna. Solo al New York Times c'erano almeno sei giornalisti
che si occupavano di lui: ora di che cosa scriveranno? Certo non del decoroso
Sleepy Joe. Mi viene in mente la battuta di Nixon quando si ritirò dopo la
sconfitta alle elezioni in California: "Non avrete più me da prendere a calci"».
Il suo sembra un atteggiamento molto benigno: Trump si è distinto
per atteggiamenti indifendibili.
«Non lo difendo affatto, l'unico talento che gli attribuisco è
un'impressionante energia e il saper interpretare un mondo abbandonato dal resto
della politica. Dico però, che con l'eccezione di Fox News, non ricordo un
atteggiamento così negativo nei confronti di qualcuno dai tempi di Eichmann.
Trump ha rappresentato un'esasperazione volgare, violenta e degenerata della
lotta al politicamente corretto che ha asfissiato questo Paese negli ultimi
trent' anni: è riuscito a trasformare l'ignoranza in forza e a impadronirsi del
partito spingendolo su posizioni estreme e svilendone le più interessanti
istanze della destra. Un'ennesima tragedia di cui sono vittima i conservatori.
Trump rifiuta di ammettere la sconfitta. Circola ovunque il bel
discorso che fece McCain quando venne eletto Obama.
«Quello è un mondo superato e da rifondare che non ha più neanche
un leader: non dimentichi che il vecchio establishment di partito ha appoggiato
Biden a cominciare da Bush, Powell e Romney».
Perché è scettico riguardo a Biden?
«Perché si ritroverà un Paese lacerato e impoverito. Dubito che
riesca a fare molto anche per questione di età: in otto anni Obama non è
riuscito neanche a chiudere Guantanamo».
Maurizio
Tortorella per “la Verità” l'11 novembre 2020. Paolo Mieli s' è ricreduto. La
decisione di chiudere brutalmente il collegamento audio di un Donald Trump che
sta denunciando l' esistenza di presunti brogli elettorali, decretata in diretta
da alcuni dei principali anchorman americani, non è più la scelta «impeccabile,
perfetta, inappuntabile» di alcuni «eroi televisivi», come aveva scritto lunedì
in un editoriale sul Corriere della Sera. Sommessamente criticato dalla Verità,
che ieri gli ha fatto notare come si tratti di una pratica del tutto sbagliata,
che incarna piuttosto un' inaccettabile censura preventiva, illiberale e
contraria a ogni regola del buon giornalismo, Mieli - con grande onestà
intellettuale - ha cambiato idea: «Mi viene il dubbio che abbia ragione a
criticarmi». È quanto l' ex direttore del Corriere ha dichiarato ieri a Radio
24, nella trasmissione del mattino condotta da Simone Spetia, che gli chiedeva
conto delle obiezioni della Verità e intanto gli faceva ascoltare la nuova,
brusca (e assurda) interruzione imposta nella notte da un conduttore di Fox News
all'addetta stampa di Trump, Kayleigh McEnany, che in modo del tutto neutro
parlava della necessità di «ricontare voti legali e illegali». Mieli, dopo aver
ascoltato il giornalista di Fox News che a quelle parole sussulta e grida «Non
ci sono le prove!», e di colpo lascia cadere la mannaia sull' audio, imponendo
così un' evidente (e inaccettabile) censura, ha ammesso: «Forse sbagliavo». Poi,
rivolgendosi a Spetia, ha aggiunto: «Quel che mi hai fatto ascoltare è
assolutamente incredibile. Non è che adesso, ogni volta che parla un
rappresentante di Trump, o Trump stesso, si spegne il microfono!». Eppure questo
è esattamente il rischio segnalato ieri dalla Verità: quando il giornalista
abbandona il suo tradizionale diritto di critica e s' impanca a «giudice
preliminare», arrogandosi il diritto di stabilire che cosa sia «vero» e «non
vero», e comincia a cancellare dalla pagina, dal video o da un audio tutto
quello che decide d' infilare a forza nella seconda categoria, opera solo e
soltanto una censura preventiva. Che è pericolosa e inammissibile non soltanto
nei confronti di Trump, ma anche nei confronti di Joe Biden come di chiunque
altro. Ieri La Verità faceva l' esempio, volutamente paradossale, di Osama Bin
Laden, il fondatore di al Qaeda cui nessun giornalista vent' anni fa si sarebbe
mai sognato di togliere la parola, malgrado si trattasse del più pericoloso fra
i terroristi e dell' ideologo della Jihad, la guerra santa islamica. La parola
gli veniva liberamente data, e altrettanto liberamente veniva qui criticata, là
derisa, e a volte perfino giustificata. Ma visto che ora, purtroppo, il taglio
della voce e del video sembra essere la nuova tendenza dei mass media americani,
si crea il rischio di una deriva pericolosa, forse capace di avvelenare l'
informazione dell' intero Occidente. Su questo, per fortuna, anche Mieli si dice
d' accordo. E dato che si tratta di un grande giornalista, e si sa che i
giornalisti non amano smentirsi, il cambio di rotta gli fa doppiamente onore:
«Quel che è accaduto stanotte sulla Fox è una vergogna», ha ammesso ieri, «e
probabilmente avrei fatto meglio a usare toni più cauti». Speriamo condividano
la «svolta» anche al Corriere, che a Mieli aveva affidato come spesso accade la
posizione più nobile che «impegna» anche il giornale. Dal canto suo, l' ex
direttore ha spiegato che della prima censura imposta dai conduttori
statunitensi a Trump, in realtà, aveva colto soprattutto - e apprezzato - il
tentativo di evitare che le dichiarazioni bellicose del presidente sulla truffa
elettorale si trasformassero in benzina da gettare sul fuoco delle proteste,
innescando nuove violenze e incidenti: «Ma un conto era stato l'una tantum di
quella notte», nella quale, ha precisato, temeva «una guerra civile» e «in quel
momento pensavo fosse giusto». Ora, invece, Mieli si dice convinto che la
situazione negli Stati Uniti sia molto più serena: «Non vedo armati nelle
strade». La guerra civile, insomma, sembra scongiurata. Per questo, ha precisato
nella sua intervista di ieri a Radio 24, «non vorrei prendesse questa piega: che
chiunque parla a nome di Trump, o Trump stesso, non meriti». S' immagina volesse
concludere: di essere ascoltato. Mieli infine ha voluto ironizzare sul
comportamento della Fox, l' emittente americana tradizionalmente più vicina alla
destra repubblicana, che è stata l' ultima a unirsi al coro dei taglia-voce
inaugurato da Nbc, Cbs, Abc e Cnn. L' ex direttore del Corriere l' ha criticata
(«Rischia di cadere nel ridicolo») e ha paragonato la sua svolta a 180 gradi a
quella dei «partigiani del 26 aprile», cioè i tanti «complici del regime» che
dopo la sua caduta, nel 1945, s' erano velocemente riciclati e «indossavano
camicie rosse, si facevano vedere con il mitra a tracolla, mostrando benemerenze
che chiaramente non avevano». Ma se la censura è sempre e comunque
intollerabile, sui cambi di casacca si può essere più tolleranti. Perché le
umane debolezze, proprio in quanto inevitabilmente umane, sono spesso da
giustificare. Dopotutto, poi, la testa degli uomini è rotonda proprio per
permettere alle idee di girare. E di cambiare. A volte anche nel giro di 24 ore.
INFORMAZIONE NEGLI USA. BIDEN, GIU’ LA MASCHERA.
Andrea Cinquegrani su La Voce delle Voci il 3 Novembre 2020.Il
fondatore di uno dei più prestigiosi siti sul fronte della controinformazione
negli Stati Uniti, Glenn Edward Greenwald, lascia la sua creatura, “Intercept”,
in clamorosa rottura con la proprietà, reo di lesa maestà nei confronti di Joe
Biden. Quando il potere fiuta il vento che tira e chi cerca ancora giustizia,
verità e informazione viene fatto fuori. Segato come un ramo secco. Siamo alla
democratica (sic) dittatura a stelle e strisce, come già si annuncia. Ma vediamo
di cosa si tratta.
Intercept viene creato sei anni fa, nel 2014, dall’avvocato
costituzionalista e blogger Glenn Greenwald, insieme a Laura Poitras e Jeremy
Scahill. Si tratta della prima pubblicazione di “First Look Media”, la
piattaforma di informazioni finanziata da Pierre Omidyar, il fondatore di
“eBay”. Inizialmente la piattaforma si basa su una serie di contenuti che
viaggiano su un binario doppio: inchieste di giornalisti e collaboratori, ed una
serie di segnalazioni che arrivano in via del tutto anonima, con le fonti
perfettamente tutelate nella loro privacy, come era successo per
i Wikileaks di Julien Assange, ancora sotto processo a Londra e con il rischio
di essere estradato e spedito nelle galere americane. Il propellente principale
nella fase di start, comunque, viene assicurato dall’immenso archivio di Edward
Snowden, che proprio in questi giorni ha chiesto la cittadinanza russa. Uno dei
temi più trattati e analizzati riguarda la security negli States, i suoi
meccanismi, i suoi sistemi. Un terreno bollente, un campo assolutamente minato.
Al centro delle investigazioni di Intercept ci sono i Programmi di
Sorveglianza di massa imposti dalla National Security Agency, con i suoi cento
tentacoli. Ma il raggio d’azione presto si allarga ad un giornalismo di
denuncia, capace di alzare il velo sulla malapolitica, la malagiustizia e la
corruzione. Una spina nel fianco del potere e soprattutto di quel Deep State che
condiziona e avvelena sempre più la scena politica statunitense. E’ schierato
sul fronte dei diritti civili, Intercept, ma i suoi nemici sul campo si fanno
sempre più agguerriti, cercando di delegittimarne il ruolo e la dirompente
carica. La sua piattaforma open source, denominata SecureDrop, è stata
sviluppata da Aaron Swartz e viene gestita da un’organizzazione non a scopo di
lucro, “Freedom of the Press Foundation”. E sul ponte di comando, per sei anni,
resta lui, l’avvocato costituzionalista Greenwald, il quale si è anche
aggiudicato un premio Pulitzer. Fino ad oggi. Quando succede il ribaltone. Per
aver “osato” scrivere qualcosa di politically non correct su quel Biden che si
appresta a sbarcare alla Casa Bianca. Più che ogni altro dettaglio o commento,
preferiamo offrirvi la lettura dell’ultimo articolo scritto per il
suo Intercept. Il suo – per ora – addio. Ho creato l’Intercept nel 2013 perché
mi rendevo conto che c’erano molte restrizioni imposte ai giornalisti e alle
nostre possibilità di riportare liberamente al pubblico fatti che contrastavano
la narrazione del governo o dei centri di potere. L’Intercept è stato fondato
proprio per garantire a chi ci lavora la completa indipendenza giornalistica,
senza la necessità, per i suoi giornalisti di dover fare favori a questo o quel
politico per via della vicinanza politica tra un l’editore ed un partito. Per
questo è così straordinario che la redazione di un giornale da me co-fondato,
che è stato costruito sulla mia reputazione e credibilità e sui miei successi
giornalistici, sia intervenuta, sei giorni prima di un’elezione, per non farmi
pubblicare notizie ed analisi su fatti, oramai provati, che fanno sorgere
legittimi dubbi sulla condotta politica del candidato che loro supportano
veementemente ed entusiasticamente. L’Intercept è stato per qualche tempo una
pubblicazione unica perché il nostro scetticismo (legittimo anzi obbligatorio)
nei confronti degli apparati dello stato, le cui azioni abbiamo sempre
sottoposto a verifica, ha attirato gli attacchi della CIA e dell’NSA. Hanno
attaccato tutti noi ma soprattutto me, i miei report e le mie fonti, ma nel
tempo abbiamo avuto ragione: sapevamo ed abbiamo dimostrato che hanno mentito in
modo sfacciato ed indecente ai cittadini. E se c’è una cosa che mi fa rabbia è
che il giornale che ho fondato (con altri due), l’unico articolo che ha
pubblicato su tutti questi documenti emersi su Joe Biden, oltre al mio che
criticava la censura di Facebook e Twitter, si è limitato a liquidare tutta
questa storia come qualcosa a cui non prestare attenzione dato che si trattava
di disinformazione di matrice russa, citando come fonte una lettera di John
Brennan, James Clapper e altri feroci personaggi dell’NSA e della comunità
dell’intelligence, il tutto nonostante la lettera stessa informasse che non
avevano minimamente le prove di quanto asserivano. Ma nell’articolo il fatto che
non ci fosse nessuna prova veniva escluso. Cioè quelli dell’Intercept hanno
citato una lettera di membri dell’intelligence cercando di convincere i lettori
che lo scoop del New York Post fosse disinformazione russa, nonostante le loro
fonti ammettessero che di prove non c’era nemmeno l’ombra. Nel frattempo
peraltro è diventato chiaro che le mail sono autentiche (insieme alle migliaia
di foto intime) e che nessuno, nemmeno Joe Biden, si è sognato di dire che le
mail scoperte nel computer del figlio fossero false. Ma questa è la vera storia
degli ultimi quattro anni durante l’amministrazione Trump. Nella sinistra c’è
sempre stato un sano scetticismo sulle attività della CIA e altre agenzie, c’era
un attivismo pacifista ancora nell’epoca di Cheney e Bush. Ebbene tutto questo è
scomparso. Ed è scomparso perché l’intelligence dal primo giorno della
presidenza Trump, prima anche che ci fosse stata l’investitura ufficiale, si è
impegnata a sabotare la nuova amministrazione. Così la CIA e gli operativi del
deep state sono diventati gli eroi dei liberal di sinistra. E questi presunti
liberal, che sostengono il PD, sono entrati in completa sintonia con i neo-con
impiantati nel potere da Bush, la CIA, i giganti della Silicon Valley e Wall
Street: questa è l’unione di potere che, con i media mainstream, sostiene a
spada tratta il PD. E li considero pericolosi dato che sono autoritari e vivono
grazie alla censura che riescono a imporre alla popolazione. In questi anni
occupandoci dei report riguardanti il Russiagate ci siamo resi conto che gli
strumenti che i servizi di intelligence dovrebbero usare solo all’estero
venivano rivolti verso i cittadini USA. Lo stesso avviene con la CIA che
addestra persone per utilizzarle per campagne di disinformazione, questo è il
loro lavoro: mentono per vivere. Ma queste attività si devono rivolgere, per
legge, verso altri paesi, non all’interno degli USA. Prendi qualsiasi canale
televisivo o grande giornale e tutto ciò che vedrai sono ex membri della CIA,
del DOJ (Departmente Of Justice), dell’FBI, dell’NSA che dicono agli americani a
cosa devono credere. Hanno infiltrato i mezzi di comunicazione nazionali e lì
svolgono la loro solita attività: fare propaganda e mentire agli americani, ma
questa cosa finirà tremendamente male. Indipendentemente da quale sia la tua
ideologia.
Lo scandalo dei media che oscurano Trump.
Max Del Papa, 6 novembre 2020 su Nicolaporro.it. Non è un granché
la democrazia tecnologica del ventunesimo secolo se con tutti i suoi strumenti
sofisticati, perfetti serve a soffocare, a censurare e arriva perfino al
presidente degli Stati Uniti, un tempo l’uomo più potente del mondo.
Censura social. Donald Trump esce nel suo stile, che è quello del
bisonte in cristalleria, ma possono i principali network televisivi occultarlo,
possono i social media chiuderlo perché a loro giudizio dice palle? Dirà palle,
non porterà pezze d’appoggio ma è difficile contestare la farsa dei voti che in
certi stati risultano più degli iscritti nelle liste elettorali, votanti morti,
resuscitati, perfino vecchi di 200 anni. Questo va bene, questo non va
sorvegliato dagli scrupolosi gendarmi dell’agenda globale? I quattro anni di
bufale continue, di scandali russi, di mignotte svergognate, di inchieste
boomerang, di accuse di ogni genere dagli stupri al cannibalismo, questo può
passare in cavalleria? E passa, e nessuno invoca “le prove, le prove”,
altrimenti non siete seri, non siete credibili e noi vi censuriamo. No, non un
grande affare la democrazia virtuale se i critici di Biden vengono bloccati per
giorni e settimane, se più accumulano follower e più, misteriosamente, il numero
dei follower cala e intanto i tweet di Trump vengono strangolati. Questo
pluralismo sorvegliato, limitato non si ferma all’elezione della più grande, e
se vogliamo controversa, democrazia al mondo, si riverbera sulle dittature:
Youtube si censura per non spiacere ai cinesi, Microsoft del filantropo Bill
Gates, filantropo filocinese, si adegua, in Iran la rivoluzione verde è abortita
a nascere perché i manifestanti, dandosi appuntamenti via Twitter, potevano
essere intercettati per tempo dal regime che poi li stroncava. Ma nessuno ha
protestato, il livello di tolleranza per la barbarie totalitaria è direttamente
proporzionale all’inflessibilità contro Trump, il miliardario che si è permesso
di diventare presidente e ha dimostrato che, piaccia o non piaccia, lo sapeva
fare, risultati alla mano e meno brutalmente di quanto appariva, meglio dei
politici di mestiere, di carriera.
Popstar anti Trump. Non si può dire che Greta è un manichino
mosso dal globalismo, che i suoi endorsement a Biden sono patetici e odiosi, ma
se la popstar cretina dice che in caso di vittoria di Trump è meglio fuggire in
Australia, se l’intellettuale imbecille sostiene che gli elettori di Trump sono
tutti assassini seriali, solo fremiti di piacere e condivisioni. Queste popstar
alla Bruce Springsteen, detto il Boss, talmente Boss che sta sempre sul palco
col candidato democratico di turno, a prescindere, e pontificano dall’infimo di
un livello culturale e di competenza geopolitica da scuola elementare. O la Lady
Gaga, una che solo a vederla ne cogli le devastazioni mentali. Ma è la
democrazia, non è vero? Una strana democrazia che guarda al dito e mai alla
luna, non si pone il problema di un cambio di rotta in America, non si preoccupa
degli scenari garantiti da un Biden che è un prestanome a scadenza dei soliti
clan, gli Obama anzitutto. Che succederà con un presidente debole, incapace di
arginare la Cina, disponibile alle peggiori degenerazioni del politicamente
corretto? Ma ci sarà, come sempre, modo di riscrivere il presente, di dirottare
gli effetti. Gli idioti sono utili anche per questo. In Italia gli idioti sono
parecchi e non si capisce bene la loro foia, non si arriva a comprendere se
tanto zelo sia strategico o genetico, l’unica cosa chiara è che c’è una voglia
provinciale a superare nel peggio gli altri paesi, una esaltazione nella merda
che sconcerta, tutta una corsa a chi è più bugiardo, più violento, più
scorretto, più ultrà nell’odio verso Trump e nella santificazione di un
personaggio cadente e decadente, puro raccatto dem, come Biden. Ma già all’epoca
di Obama si vedevano agghiaccianti assessori di paese col selfie mentre
telefonavano sotto la foto di Barack, come un tempo con Stalin, il “piccolo
padre” che portava prosperità e democrazia in Russia.
Fanatismo (anti)democratico. Per un Federico Rampini che si
svincola dal fanatismo, che, con snobismo sublime, denuncia le escandescenze
dei Black Lives Matter come speculari a quelle dei fondamentalisti della destra
fuciliera, che sbugiarda i corifei e mette i puntini sulle i della sanità
americana, ci sono dieci, cento, mille che rispondono a sorrisini di
compatimento, che si gonfiano della loro faziosità e scorrettezza. Per chi
lavorano questi? Per se stessi, per il Pd che potrà dire, nel solito modo
grottesco, “con Biden abbiamo vinto noi”. Italia di merda, provincia franata
dell’impero in decadenza. Sulla Rai 3 militante chiamano la Botteri, in fama di
vittima per i capelli scompigliati, e quella arriva a dire “la Cina, i diritti
umani, la democrazia, vabbè”. Vabbè? Poi passano l’analisi a Giobbe Covatta, uno
che fa ridere solo quando spiega il suo lumpenambientalismo mattocchio. Dite che
non è il caso di metterla giù dura, che in fondo si è sempre fatto così? Sì e
no, ogni elezione è stata distorta da propagande, da colpi bassi, da manovre e
compromessi irriferibili, la politica sangue e merda d’accordo, ma mai con
questo livello di bassezza, di immoralità intellettuale, di censura dal sapore
di fascismo, democratico ma fascismo. Le stesse dinamiche si riverberano su ogni
issue, sul clima, sul Covid, sui migranti, su tutto. Non è vero quel che c’è ma
quello che non c’è ma conviene ci sia. Ed è vero solo quel che si lascia dire.
I social network hanno una loro politica garantista che nessuno capisce,
cancellano contenuti ad esclusivo arbitrio, bloccano autori senza spiegazioni,
Facebook può sospendere iscritti sulla semplice constatazione che “ti abbiamo
già bloccato in passato”, quindi ti fermiamo ancora. Siamo al processo kafkiano,
ma sempre ad una dimensione, ad un senso di marcia. In compenso, pagine pedofile
o allegramente blasfeme restano dove sono, o, nel frasario da Silicon Valley,
“rientrano nella nostra policy”. C’è chi sull’intolleranza travestita da
solidarietà, sull’odio spacciato per amore si costruisce carriere, chi ci fa i
soldi, chi si inventa un mestiere. C’è chi, come il sito di Enrico Mentana, può
mettere serenamente che il Covid cresce nei soli stati a maggioranza di elettori
trumpiani”, e sì che hanno fior di cacciatori di balle. Per molti ma non per
tutti, come il famoso aperitivo. Ma compiacersi perché l’agenda globale è
faziosa oltre l’ossessione è da stupidi, stappare perché Trump avrebbe perso
anche per queste nefandezze che mortificano chiunque abbia il compito di
riportare, di informare, è da allucinati. Se non altro perché dall’abisso è
quasi impossibile risalire. Max Del Papa, 6 novembre 2020
Annalisa Chirico, cos'è successo con Edward Luttwak: "Se lo
fanno Floris o Formigli va bene, giornalismo maschilista".
Libero Quotidiano il 06 novembre 2020. Annalisa Chirico ha deciso
di sfogarsi in un video per quanto accaduto sui social dopo l’intervista
a Edward Luttwak. “In Italia funziona così - ha esordito - se Giovanni
Floris o Corrado Formigli invitano quel politologo americano per esprimere le
sue opinioni su Italia e Stati Uniti, e in questo caso sulle elezioni
presidenziali, va bene. Se lo intervisto io per lachirico.it - ha accusato la
giornalista - non va bene. Luttwak ha espresso le sue opinioni, che a volte sono
forti e che talvolta condivido. In questo caso ha detto che gli afroamericani
della classe media che hanno lavoro, famiglia e vivono nella legalità avrebbero
votato per Trump, mentre quelli più criminali per i democratici. Questa è stata
la sua analisi - ha sottolineato la Chirico - eppure sui social tanti
giornalisti di più o meno vana gloria si permettono di darmi lezioni di
giornalismo. Evviva la libertà, la democrazia e il pluralismo delle idee”, ha
chiosato la giornalista de Il Foglio.
Giovanni Sallusti per Dagospia, autore del libro ''Politicamente
Corretto - la dittatura democratica'' - Giubilei Regnani editore, il 7 novembre
2020. Caro Dago, fioccano lenzuolate in serie sulle elezioni americane, ma per
capire il loro racconto politically correct spacciato per giornalismo basta e
avanza il vecchio Orwell. Precisamente, basta rovesciare un suo famoso teorema:
ci sono latinos meno latinos degli altri, ci sono neri meno neri degli altri, ci
sono donne meno donne delle altre. Ovviamente, sono coloro che, contro le
consegne paternalistiche degli editorialisti (tendenzialmente bianchi della East
Coast), hanno votato Donald Trump. Repubblica ha seriamente titolato un pezzo di
Gabriele Romagnoli “Il tradimento dei latinos - tradimento rispetto ai
desiderata delle riunioni di redazione in Largo Fochetti, immagino- Ora ballano
con Trump”. Profonda spiegazione sociologica dello smottamento del voto
ispanico: “Il presidente incarna il loro líder ideale: è un macho”. Che,
peraltro, “ha fatto i soldi”. Vale a dire: secondo gli antirazzisti di
professione, i latini che si sono schierati con Trump sono dei minus habens
raggirati dal portafoglio gonfio e dai modi da duro. Fa meglio nella gara della
prevedibilità buonista La Stampa di oggi, che schiera l’analisi di Gianni Riotta
e l’intervista alla scrittrice Erica Jong. Il primo sviluppa il canovaccio del
giornale gemello (nel gruppo Gedi ormai gli articoli e le idee sono
interscambiabili), già dal titolo: “Lusso e machismo, il marchio di Trump che
affascina i neri” (sì, proprio così, “marchio”, come se si trattasse di schiavi
nelle piantagioni di cotone, e non di liberi cittadini pensanti e votanti). In
particolare, annota meditabondo Riotta, “Trump brilla tra i giovani neri”,
grazie a “l’immagine da ricco magnate, le limousine, le Miss dei festival, gli
abiti sgargianti” che “risuonano popolari con il culto della ricchezza, del
lusso che molti cantanti rap promuovono, icone classiche dei loro video”. Gli
afroamericani che scelgono Donald, insomma, sono tutti sfaccendati in fregola da
rapper col mito dei soldi facili. Mentre gli afroamericani che votano il Partito
Democratico, ovviamente, sono tutti fini conoscitori dell’opera di Thomas
Jefferson ed esperti nella dottrina della separazione dei poteri. Ma in vetta si
colloca decisamente Erica Jong, che a Paolo Mastrolilli confida tutto il proprio
sbigottimento per l’assenza di una valanga del “voto femminile” contro il
presidente. E perché non è accaduto? “Ignoranza. Non capisco perché una donna
possa votarlo, visto che il suo odio contro di noi è così ovvio”. È ovvio, gli
assiomi dell’intellighenzia correttista non si dimostrano, si enunciano, e chi
non li introietta è un paria in odor di suprematismo. Eppure il consenso di
Trump presso le donne bianche è addiritura cresciuto, butta là l’intervistatore
con la finta ritrosia di chi accende una miccia. “Mio Dio! Io voto come le donne
nere, perché loro sono più attente e interessate”, è la fine lettura della
scrittrice, il razzismo capovolto sulle inferiori donne repubblicane dal viso
pallido. Eh, ma “anche il vantaggio dei democratici tra le donne nere è sceso”,
incalza un Mastrolilli ormai palesemente divertito. “Perché viviamo ancora in
una società sessista, e alcune donne sono sessiste contro i loro stessi
interessi. È tragico”. No, è comico, è un perenne sofisma ubriaco, è il
Politicamente Corretto, bellezza.
"Vincerà sicuramente Biden..." Radical chic "fregati" da
Trump. Per settimane il "bombardamento" mediatico
radical chic è stato incessante per tirare la volata al democratico. Ma la
realtà è ben diversa...Ignazio Stagno, Mercoledì 04/11/2020 su Il Giornale.
Comunque vada, anche con una vittoria di Biden, il fronte radical chic ha già
perso. La rimonta di Trump è arrivata con il vento dell'imbarazzo. Non del
Tycoon (lui ha già annunciato la vittoria al primo incontro coi giornalisti
questa mattina), ma di tutti quei "profeti" della politica e di una certa stampa
di casa nostra che per giorni, settimane e mesi hanno voluto convincere loro
stessi e l'opinione pubblica della sconfitta sonora del presidente sommerso da
una ondata blu. Ebbene, come è noto, l'ondata si è trasformata in un bicchiere
d'acqua e il miraggio rosso dei Repubblicani è diventato realtà. Non vogliamo
sottolineare il flop dei sondaggisti, sarebbe fin troppo facile. Vogliamo invece
ricordare qui il flop autentico di chi si è fidato (scordando la lezione del
2016) ciecamente delle rilevazioni che puntualmente sono state sconfessate dai
fatti. Le profezie sul disastro di Trump sono state alimentate da prese di
posizioni aspre e durissime. Solo qualche giorno fa sull'Espresso è apparsa
un'intervista a Brian Klaas, editorialista del Washington Post e professore di
Politica globale presso l’University College di Londra, con un tiolo che visto
oggi, francamente, fa sorridere: "Trump è il più inadeguato di sempre. E, a
differenza del 2016, oggi tutti sanno chi è". Poi la previsione (totalmente
sballata): "Nel 2016, gli indecisi hanno ceduto per Trump all'ultimo minuto,
consegnandogli la vittoria. Quest'anno la corsa è più stabile e ci sono state a
stento variazioni nell'ultimo anno. Biden non è la Clinton. È più benvoluto (il
che in parte è dovuto alla misoginia della politica americana), ma i principali
attacchi di Trump ai democratici - genere, razza, e l'etichettamento come
"socialisti" - semplicemente non funzionano quando si corre contro un centrista
maschio, anziano e bianco". Parole che sono state letteralmente sconfessate dal
voto in America. Gli statunitensi a quanto pare "sanno bene chi è Trump" al
punto da rivotarlo dopo quattro anni di permanenza alla Casa Bianca e sanno pure
bene chi è Biden che a quanto pare non è poi così "benvoluto". Ma in questi
giorni che hanno preceduto il voto negli Stati Uniti c'è anche da registrare il
solito diluvio di anti-trumpismo imperante che si è fatto spazio nell'area
democrat di casa nostra. Leggete bene cosa scriveva Gianni Riotta solo qualche
giorno fa sull'HuffPost: "A Manhattan, come in tante città, le vetrine dei
negozi, dalle boutique del lusso di Madison Avenue alle bodegas familiari del
Bronx, vengono sbarrate da assi di legno, si temono disordini, violenze, dopo
quelli dei mesi passati. Miliziani di destra in armi sarebbero pronti a scendere
in piazza, a sinistra sulle chat si evocano opposti servizi d’ordine". Ebbene,
sulla notte elettorale negli Usa si hanno notizie di rivolte e di proteste solo
sul fronte del Blacks Live Matters, vicini ai democratici. Non c'è traccia di
sommosse di "miliziani di destra" come riportato da Riotta. Ma non finisce qui.
In questo esercito di "gufi" sulla sconfitta di Trump non poteva mancare la
penna di Beppe Severgnini che sul Corriere, lo scorso primo novembre (a due
giorni dal voto) scriveva: "Donald Trump — secondo i sondaggi, unanimi — non
dovrebbe essere rieletto. È vero: anche nel 2016 era sfavorito, eppure ha vinto.
Ma i sondaggisti si sono fatti più attenti e gli americani più scaltri. In
quattro anni il 45° presidente ha dimostrato la sua inadeguatezza — politica,
economica, culturale, morale, psicologica — a ricoprire un ruolo tanto
importante. Tutti possono sbagliare. Sbagliare è umano. Ma perseverare
nell’errore non sarebbe americano. Joe Biden non è un super-eroe. Ma è un uomo
affidabile, che accompagnerà la nazione verso l’altare di una nuova convivenza".
A quanto pare i sondaggisti non sono diventati più "attenti" e una grande fetta
di americani (che forse scaltri lo sono sempre stati, qualcuno glielo spieghi)
hanno semplicemente scelto, come si fa in una grande democrazia come quella
Americana, di dare fiducia al proprio presidente. Inutile aggiungere che la
maggioranza degli americani non ha ritenuto Biden così "affidabile" da meritare
a fuor di popolo la poltrona della Casa Bianca. E Gad Lerner? Beh, questa volta
ha evitato di avventurarsi in un pronostico come fece nel 2016. Ma sul Fatto ha
messo nel mirino più volte il Tycoon parlando di "performace fallimentari" ed
etichettandolo come "uomo solo al comando capace di far strame della cultura
liberale". Anche lui, Lerner, un incompreso. In America non gli hanno dato
retta. Infine, nella fiera del pressing mainstream pro-Biden, ci sono i
capitomboli di alcuni testate italiane che mercoledì mattina hanno dovuto far
sparire il megafono che raccontava la vittoria di Biden con goffe retromarce
parlando di un'ondata rossa trumpiana "teorizzata" e di un risultato "non
inatteso". Ogni altro commento è superfluo visto l'esito fornito dalle urne che
ha (per il momento) il sapore di un remake del 2016. Va, infine, sottolineata
ancora la previsione di Severgnini: "Se Donald Trump viene rieletto, dobbiamo
accettare che la società americana ha rinunciato al decoro e alla decenza cui ci
aveva abituato. Se Donald Trump viene rieletto, vuol dire che gli Usa hanno
scelto di voltare le spalle al pianeta". Ebbene ci dovremo tenere sul fronte
atlantico questi americani diventati a quanto pare "indecorosi e indecenti". Ma
ma mai quanto gli insulti rivolti a un popolo che non si allinea ai pronostici
radical chic.
DAGONEWS il 5 novembre 2020. Cardi B che fuma tre sigarette,
Emily Ratajkowski attaccata alla tv per seguire ogni singolo istante del
conteggio dei voti e Sharon Stone che piange quando vede il vantaggio di Trump.
La notte elettorale per i vip democratici è stata un’agonia e c’è chi, come al
solito, aveva già promesso di lasciare gli Usa se Trump fosse rieletto. Tra di
loro John Legend e Chrissy Teigen, Bruce Springsteen, Ricky Martin e Tommy Lee.
Niente di nuovo. Le stesse promesse erano state fatte nel 2016, quando uno
stuolo di celebrità tra cui Miley Cyrus, Chelsea Handler, Samuel L Jackson e Amy
Schumer avevano promesso di abbandonare gli Stati Uniti se alla Casa Bianca
fosse approdato il puzzone. Promessa che, ovviamente, non è stata mantenuta. Tra
i vip più ansiosi ci sono stati la Teigen che ha condiviso le sue paure su
Twitter. Olivia Culpo si è buttata sul cibo. Emmy Rossum ha fatto sapere a tutti
di avere i conati di vomito mentre Jenna Dewan continuava a riempirsi il
bicchiere di vino. Hilary Duff ha pubblicato una foto carina di sua figlia
Banks che mangiava una fetta di pizza mentre Jessica Alba cercava di rassicurare
gli elettori dell’Arizona. Anche Jesse Tyler Ferguson e Ashley Tisdale si sono
buttate nel cibo. Khloe Kardashian ha confessato di aver difficoltà a dormire,
Charlize Theron, invece, ha condiviso su Twitter la sua ansia mentre Mark
Ruffalo, Josh Gad, Cyndi Lauper, Patricia Arquette, James Corden e Shonda
Rhimes, Amy Schumer e Penelope Cruz hanno chiesto che fosse contato ogni singolo
voto.
Ernesto Galli Della Loggi per il “Corriere della Sera” il 5
novembre 2020. Mentre scrivo tutto è ancora incerto tranne due cose: a) che il
voto di cui finora siamo a conoscenza non ha rappresentato quella clamorosa
sconfessione popolare del presidente in carica, come molti si aspettavano, ma
anzi ha visto in parecchi Stati delle inaspettate buone se non ottime
affermazioni di Trump; a dispetto di tutti gli errori, le volgarità e le bugie
di cui egli ha costellato la sua presidenza; b) che in ogni caso, come si
temeva, Trump stesso farà ricorso ai tribunali. Il presidente potrebbe anche
rivolgersi alla Corte Suprema per cercare di invalidare il risultato del voto
postale se questo dovesse rivelarsi a lui sfavorevole. Si tratta di due cose
diverse come si vede, ma che ci parlano entrambe di due gravi problemi che oggi
si pongono per tutti i regimi democratici. La mancata sconfessione elettorale di
Trump (a questo punto si può parlare solo di questo, non di una sua vittoria)
getta piena luce sul peso che ancora oggi ha quell' America di cui si parla di
rado. L'America profonda dei grandi spazi e delle piccole città, radicata nei
suoi antichi pregiudizi, impermeabile a qualunque cosa si muova e si pensi fuori
di lei (a cominciare da parte dei vituperati media di orientamento liberal).
Convinta soprattutto che la libertà significhi in sostanza una cosa sola: poter
fare ciò che si vuole con pochissimi ed essenzialissimi limiti, e che quindi la
legge deve immischiarsi nel minor numero possibile di cose. È questa America,
con questa sua ideologia somigliante a una sorta di individualismo anarcoide,
quella che si riconosce in Trump e che lo vota a dispetto di tutto e anche a
costo di mettersi sotto i piedi alcune elementari regole della democrazia. È l'
eredità - sembrerebbe incancellabile - della storia di un Paese che si è fatto
grazie all' iniziativa spregiudicata dei singoli in una misura altrove
sconosciuta e che spesso ha visto il destino della comunità affidato unicamente
alla potenza di fuoco delle sue armi. Dal che si ricava una lezione valida anche
per noi tutti, direi. E cioè che la democrazia può funzionare al suo meglio solo
laddove esistono cittadini che in larghissima maggioranza condividono una
cultura e dei valori con essa compatibili. Sfortunatamente, però, si tratta di
una cultura e di valori che di per sé un regime democratico non è in grado, in
quanto tale, di generare autonomamente: come dimostra per l' appunto il caso
degli Stati Uniti che da oltre due secoli e mezzo sono retti da un sistema di
questo tipo e pure si sono ritrovati (e forse domani ancora si ritroveranno) un
Trump presidente. Quanto alla seconda questione - all' eventualità del più che
probabile ricorso di Trump alla Corte Suprema allo scopo di far invalidare il
voto postale a lui sfavorevole - per valutarne bene il significato non si può
guardare solo all' oggi. È necessario considerare il recente passato. Dal quale
impariamo che, a cominciare dalla legalizzazione dell' aborto nella celebre
sentenza Roe contro Wade del 1973, una parte assai cospicua della
regolamentazione in materia di accesso delle donne agli impieghi, di
«affirmative action» specie nelle Università, di eguaglianza di trattamento sui
luoghi di lavoro , di trasporto degli scolari, di divieto di discriminazione in
base agli orientamenti sessuali, e in altre materie analoghe, una parte assai
cospicua di tale regolamentazione, dicevo, è derivata non già da una qualche
legge votata dal Congresso bensì da sentenze della Corte Suprema o da
«ingiunzioni» dei tribunali federali. In altre parole nel recente passato, su
alcuni temi chiave per definire l' identità della società americana - temi
spesso drammaticamente divisivi -, il punto di vista progressista ha avuto modo
di affermarsi non già nelle aule parlamentari grazie al sostegno di una
maggioranza di rappresentanti del popolo eletti da una effettiva maggioranza di
cittadini, bensì nelle aule dei tribunali grazie a decisioni largamente
interpretative da parte delle corti. È questo un dato di fatto che induce a
qualche riflessione. Innanzi tutto questa: coloro che in passato, condividendo
un punto di vista progressista, si sono rallegrati delle pronunce di cui sopra
da parte della Corte Suprema o delle altre istanze giudiziarie, mi pare che
dovrebbero avvertire qualche difficoltà a scandalizzarsi oggi per l' eventuale
ricorso all' una e alle altre da parte di Trump. Se si crede infatti che la
pronuncia di un tribunale possa costituire l' istanza suprema del processo di
validazione democratica dei diritti, allora è giocoforza accettare che questo
meccanismo valga anche per la validazione del risultato elettorale, cioè del
diritto politico rappresentato dal voto. Sabino Cassese ha ben illustrato ieri
quali siano le forti perplessità che suscitano alcuni aspetti della Costituzione
degli Stati Uniti anche per ciò che riguarda proprio le regole della
composizione della Corte Suprema. Ma quelle regole valevano anche ieri quando
essa emanava sentenze di un certo tipo: non dovrebbe essere consentito obiettare
oggi solo perché c' è il rischio di sentenze di tipo diverso. Proprio il ruolo
sempre maggiore avuto dal sistema giudiziario americano nell' allargare la sfera
dei diritti anche in materie estremamente controverse, bypassando l'istanza
elettiva del Congresso, vale infine a spiegare almeno in certa misura il
radicalismo di larga parte dell' elettorato trumpiano: in particolare la sua
rabbiosa avversione contro le élite, nonché, temo, la sua disponibilità a
delegittimare l'odierno risultato elettorale. «Se almeno una parte delle
decisioni che per noi più contano - deve aver pensato e pensa quell' elettorato
- non passano più per le Camere, allora a che servono le elezioni e tutte le
loro regole? E se le élite da cui vengono espressi i magistrati sostengono
sempre un punto di vista a noi avverso, allora vadano al diavolo anche quelle
élite, la loro presunta neutralità e soprattutto il fair play che quando tocca a
noi di scegliere ci obbligherebbe a scegliere persone non troppo schierate».
Alla fine, insomma, vada al diavolo la democrazia: questo è il pericolo che può
produrre nella mentalità comune un'eccessiva incidenza delle decisioni
giudiziarie nella vita collettiva. Tanto più, mi verrebbe da dire, quando i
giudici non sono sottoposti ad alcun vaglio di qualsiasi tipo ma si limitano ad
aver vinto un concorso all' alba della loro carriera appena usciti dall'
Università: proprio come accade in un Paese di mia e di vostra conoscenza.
Alan Friedman contro Donald Trump: "Si comporta da dittatore.
Presto istigherà alla rivolta: pregate per la democrazia".
Libero Quotidiano il 04 novembre 2020. Il terrore sul volto
di Alan Friedman e parole pesantissime su Donald Trump. Si parla ovviamente del
voto negli Stati Uniti, del testa a testa serratissimo tra i presidente uscente
e Joe Biden. Sarà decisivo il voto per posta, contestato da Trump. Insomma,
tutto è ancora possibile. E per Friedman, ovviamente, un'eventuale rielezione di
Trump sarebbe la più assoluta delle disgrazie. E così, senza giri di parole, lo
spiega ospite in collegamento a Omnibus su La7: "Non si comporta da presidente
di una grande democrazia, ma da dittatore bielorusso o dell'africa
subsahariana", premette Friedman partendo in quarta. Dunque, il commento sulle
dichiarazioni del presidente dalla Casa Bianca, dove si è di fatto
auto-proclamato vincitore e ha detto che, in caso di sconfitta, farà ricorso
alla Corte Suprema. E ancora, The Donald ha invocato lo stop al conteggio dei
voti postali affermando che "ci sono brogli in corso". Friedman riprende: "Trump
ha detto di aver vinto, ma è falso: sono testa a testa. La conta è in corso in
stati-chiave. Ma Trump ha anche detto che andrà alla Corte Suprema e ha chiesto
di fermare il conteggio dei voti. Peggio ancora, ha detto di stoppare la conta
negli stati dove Biden potrebbe vincere ma non dove lui sta vincendo. Un
comportamento da dittatore, da persona non democratica", ribadisce. Infine, il
politologo tratteggia scenari catastrofici: "C'è un rischio di crisi
costituzionale e di una situazione senza precedenti in america. Siamo in uno
scenario da incubo: i due, sono testa a testa. E cosa fa Trump? Dichiara di aver
vinto e forse cercherà di istigare disordine sociale. Quindi siamo in una
situazione pericolosa. Auguro a tutti quelli che amano la democrazia e l'America
di incrociare le dita se siete laici, se siete credenti pregate per la
democrazia americana", conclude. Non ha forse esagerato?
Flavio Pompetti per “il Messaggero” il 5 novembre 2020. «Biden è
il vincitore più che probabile delle elezioni; non ci sono strade aperte che
puntino alla riconferma di Trump». È lapidario il commento di Edward Luttwak,
mentre le urne sono ancora aperte, e Donlad Trump denuncia il furto dei voti del
quale pensa di essere vittima. Così come articolato è il giudizio che il
politologo dà del risultato delle urne.
Trump forse perderà, ma dà l'impressione di non aver perso un
solo voto rispetto al 2016, né un singolo componente del suo elettorato?
«Trump poteva soltanto perdere questa elezione, e ci è riuscito
benissimo. Era a capo di un' economia esuberante, e aveva liberato il paese dai
balzelli di regolamenti punitivi per l' industria, alcuni dei quali erano un
retaggio degli anni '70. Avrebbe dovuto schiacciare l' avversario sulla strada
della rielezione, e farsi carico della riconquista della maggioranza
repubblicana alla camera. È riuscito invece a buttare via tutto questo
patrimonio, e regalarlo a Biden».
Di cosa è colpevole?
«Di aver affrontato da assoluto incompetente la crisi sanitaria
del coronavirus. L'ha presa sottogamba. Quando le ha dedicato un' attenzione
particolare, lo ha fatto pensando che l' emergenza gli offriva l' opportunità di
esibirsi in una conferenza stampa-comizio quotidiana, da usare per promuovere se
stesso agli occhi degli spettatori. La figlia Ivanka l'ha implorato di cambiare
tono, ma lui ha finito addirittura per annoiarsi per via del formato ripetitivo,
e si è addirittura sottratto dal confronto con il pubblico. Lo scarto tra le
poche migliaia di voti che lo condanneranno alla sconfitta e il grande distacco
che avrebbe dovuto dare all'avversario, è tutto in questo fallimento di gestione
della crisi».
Anche Biden uscirà da questa elezione molto ridimensionato
rispetto alle aspettative della vigilia?
«Non solo lui, ma l'intera lettura che il partito democratico ha
fatto del paese durante questa campagna. Gli Usa non sono un paese di estremisti
di sinistra a maggioranza afro americana. I progressisti dovranno prendere
distanze nette dall' influenza dei socialisti che si sono fatti strada tra le
sue file. Da questa elezione escono ridimensionati alla Camera, e battuti
nell'ambizione di conquistare il Senato. Trump è uno sconfitto solitario e
autolesionista, loro sono un' intera classe dirigente in diniego della realtà».
L'alternativa processuale per contestare l'esito del voto è
percorribile per Trump?
«Non credo, e sinceramente mi auguro che non sia una strada che
lui vorrà percorrere. Non è la prima volta nella storia del nostro paese che l'
elezione si conclude con uno scarto minimo. Biden pagherà in termini politici il
costo di un successo monco. L'agenda di sperpero della finanza pubblica che
aveva in mente di realizzare con sovvenzioni a pioggia dovrà essere
ridimensionata in luce dell' opposizione del Senato, che sbarrerà la strada ad
iniziative troppo sbilanciate. Ma le regole sono chiare e vanno rispettate».
La transizione tra le due amministrazioni sarà lineare? Come
risponderà la piazza?
«Non c' è nessun motivo di temere per il compimento di un
processo istituzionale ben strutturato e ben difeso dalla legge. E le grida
della piazza si esauriranno in tempi ragionevoli. L' estrema sinistra non ha
nulla da celebrare dopo questa elezione, e le milizie armate potranno sparare
qualche colpo in aria, ma poi riporranno le armi e torneranno a casa. È più
urgente tornare a domandarsi cosa sono gli Stati Uniti dopo questa fase
politica, e ridefinire le priorità nazionali in base al voto che è appena emerso
dalle urne».
Federico
Novella per “la Verità” il 9 novembre 2020. Edward Luttwak, economista e
politologo: sono state le elezioni più folli della storia americana.
Mentre
parliamo, Joe Biden ha un piede alla Casa Bianca. Ma non è detto che sia finita,
anzi: Donald Trump ha parlato apertamente di possibili brogli. Ha ragione?
«Veri e propri
brogli non ne vedo, al massimo qualche irregolarità qua e là. D' altronde la
paura del Covid ha moltiplicato per dieci la massa dei voti via posta, mentre il
numero degli addetti allo scrutinio è rimasto lo stesso. Ma sono solo problemi
organizzativi».
Trump dice di
non volersi arrendere. Prevede un cambio della guardia drammatico?
«No, Donald
Trump è abituato a rumoreggiare. Gli avvocati faranno i loro ricorsi, magari
verrà ammesso qualche riconteggio qua e là, ma nulla che ribalti il risultato. E
state tranquilli: la democrazia americana reggerà benissimo questo passaggio
difficile».
Perché Trump è
uscito sconfitto?
«Aveva tutti
contro, soprattutto quelli con i soldi: e alla fine, nel pieno d' una emergenza
sanitaria, stava quasi per vincere. Insomma, ha fatto miracoli».
Miracoli?
«Tutti i media
mainstream, dalla Cnn al New York Times al Washington Post, prevedevano una
disfatta clamorosa di Trump. Addirittura c' era chi prevedeva la scomparsa dei
repubblicani dal Senato. Pronostici sballati. Ne deduco che forse i media
americani conoscono i libanesi: sicuramente non conoscono gli americani».
E dunque?
«Dunque i
proprietari dei giornali e delle tv dovrebbero guardare in faccia i loro
giornalisti e fargli notare che hanno messo in piedi una gigantesca opera di
disinformazione».
Comunque sia.
I voti sono voti.
«È vero, Trump
ha perduto la presidenza, ma se andiamo a guardare il voto al Congresso, le cose
cambiano».
Cioè?
«Alla Camera
dei rappresentanti i repubblicani sono cresciuti. Addirittura sfiorano il
controllo del Senato. Se questo accadesse, la vita per il presidente Biden si
farebbe molto difficile, a cominciare dalle prime nomine. E poi non
dimentichiamo i dollari».
I dollari?
«In questa
campagna elettorale i democratici hanno speso il triplo dei repubblicani.
Miliardari democratici hanno investito centinaia di milioni di dollari per
cacciare dal Senato il capo della maggioranza repubblicana Mitch McConnell, e il
consigliere di Trump Lindsey Graham. Non ci sono riusciti».
Ci sta dicendo
che la sconfitta di Trump in realtà è una mezza vittoria?
«Diciamo che
Trump ha perso, ma il trumpismo ha vinto».
Il trumpismo?
«Oltre gli
scandali e le intemerate, l'eredità che lascia Trump non si tocca: ha tagliato
le tasse e ha disboscato le regole inutili e obsolete che imbrigliavano l'
economia americana. È per questo che negli ultimi quattro mesi la ricchezza del
Paese è cresciuta del 30%. Tutto ciò è stato apprezzato anche dalle minoranze
afroamericane».
Addirittura?
«Con Trump la
disoccupazione tra afroamericani e ispanici è ai minimi storici. I democratici
offrono solo belle parole e sussidi. Trump non offre sussidi e non ispira
simpatia: però crea posti di lavoro».
Sta di fatto
che Joe Biden è il presidente più votato di sempre. Un motivo ci sarà.
«È vero, ha
preso moltissimi voti popolari. Ma lo ha fatto sconfessando totalmente i
programmi del suo partito. Parlo dei vari Bernie Sanders e Elizabeth Warren,
gente che sogna un'America socialista. Molti di questi estremisti non sono stati
rieletti in parlamento, perché gli americani non vogliono saperne di quelle
teorie economiche».
Questo
smentirebbe la narrazione democratica?
«Mettiamola
così: queste elezioni dimostrano che l' americano medio non è caratterizzato
dall' etnia o dagli orientamenti sessuali. Non è un omosessuale, e neanche
bianco o nero. L' americano medio è semplicemente una persona che lavora, e che
sogna il benessere. Ecco perché sostengo che il trumpismo abbia vinto, a
prescindere dall' inquilino della Casa Bianca».
Dunque quale
sarà la linea di Biden sull' economia?
«Quella di non
toccare ciò che ha fatto Trump. D'altronde è un moderato cattolico. I suoi
nemici sono per l' appunto i democrats radicali».
Avrà vita
facile?
«Se davvero il
Senato resterà in mano repubblicana, il partito democratico entrerà in crisi di
identità».
Trump è solo
una parentesi turbolenta della storia americana?
«No, Trump
tornerà, perché le sue ricette economiche sono vincenti. Rappresenta l'America
meglio di chiunque altro. Anzi, se gli italiani potessero, dovrebbero collocarlo
al posto del Papa».
Buona questa.
«No, dico sul
serio. Dovreste prendere Trump, metterlo su un aereo e installarlo in Vaticano.
Le sue idee vi tornerebbero molto utili, perché l' economia italiana è
terribilmente soffocata dalle pastoie burocratiche».
Lei dice?
«Mi è appena
arrivato un contratto dalla vostra tv pubblica per un'apparizione televisiva.
Sono 23 pagine di testo. Dovrei stamparle su carta, firmare su ogni singolo
foglio, e poi rispedire tutto indietro. Mi pare una roba assurda. Ma da voi
funziona tutto così, a quanto sembra».
Cosa ne pensa
del nostro secondo lockdown e della suddivisione dell'Italia in regioni rosse,
gialle e arancioni?
«Il governo
italiano ha fatto una scelta legittima. Quella di proteggere gli anziani e
sacrificare i giovani».
Sacrificare i
giovani?
«In Italia è
in atto una congiura contro bambini e ragazzi. I giovani non possono più
lavorare. I ragazzi non possono andare a scuola. E forse i bambini dovranno
ancora rinunciare all' asilo. Tutto per proteggere i vecchi».
Proteggere gli
anziani non è forse una scelta obbligata?
«È una
questione di priorità. In Svezia le scuole sono rimaste aperte, ma non mi sembra
che il dato sulla mortalità del virus sia molto diverso. I contraccolpi sui
ragazzi sfuggono alle statistiche, ma sono gravi e un giorno bisognerà
occuparsene».
Quali
contraccolpi?
«Tanti bambini
e ragazzi temo usciranno traumatizzati da questo lockdown. Penseranno che, se
non possono più andare a trovare la nonna, la colpa sia loro. Per non parlare
della perdita di socialità dovuta alla chiusura delle scuole. Stanno perdendo
tempo prezioso per progredire. E questo in un Paese dove, da sempre, la
fertilità è bassissima».
E il lavoro
cosa c'entra?
«La congiura
italiana contro le giovani generazioni non nasce con il virus. Viaggia in
parallelo con la scelta di restare nell' euro al fine di proteggere le pensioni,
anziché uscirne per puntare sulla crescita, sui posti di lavoro, sulla valuta
competitiva».
Luttwak,
guardi che l'Italia non è l'America. Guerre di indipendenza non se ne possono
fare.
«Intanto
potreste cominciare abolendo il divieto di licenziamento, che per me è una pura
atrocità».
Come sarebbe?
Non serve a garantire i lavoratori nell' emergenza?
«Il punto è
che se non permetti i licenziamenti, non permetti neanche le assunzioni. Un
datore di lavoro che deve ridurre l' organico a Genova per avere risorse a Bari,
non può farlo. Questo paralizza il sistema».
Lei cosa
propone?
«La crescita
dell' economia prevede che alcune attività si esauriscano, per far sì che ne
emergano di nuove. Invece, mentre gli Stati Uniti eliminano i divieti, l' Italia
ne aggiunge di nuovi. Siete il popolo più produttivo d' Europa, ma vi
autosoffocate con regole medievali».
Per ora,
procediamo con i sussidi.
«Appunto.
Viviamo in un momento di grandi trasformazioni tecnologiche, aziende che
ripensano il loro modo di produrre, nuove sperimentazioni di lavoro da casa:
davvero pensate di andare avanti col sussidio, con metodi di trent' anni fa?».
Insomma, cosa
insegnano all'Italia queste elezioni americane?
«Intanto
insegnano al vostro presidente della Repubblica che evitare le elezioni ad ogni
costo non è la scelta più saggia. Soprattutto se l' alternativa è tenersi un
governo di intrallazzatori».
Prego?
«Se non
sbaglio il governo Conte è nato grazie a Matteo Renzi. Perché avrebbe fondato un
nuovo partito, staccandosi dal Pd?».
Per gettare le
basi di un centro moderato?
«No. Per
portare a casa le nomine che gli interessavano. Tutto qua. Ecco, Renzi
personifica alla perfezione la sudamericanizzazione dell' Italia».
Sono le regole
del gioco di una repubblica parlamentare. Torno a dirle che non siamo l'America.
«Infatti gli
americani non avrebbero mai tollerato un governo come il vostro. Anzi, nessun
Paese in Europa avrebbe mai tollerato un primo ministro nato sulla base di un
accordo di palazzo tra due partiti che la pensano all' opposto. Insomma, spero
che passata l' emergenza l' Italia torni alla normalità».
E qual è la
normalità?
«Si vota, e
chi vince governa. In America, da più di duecento anni, tra alti e bassi,
funziona così».
Biden, la Chiesa progressista esulta: Bergoglio ha un alleato
in più. Francesco Boezi su Inside Over l'8 novembre
2020. La vittoria di Joe Biden alle presidenziali del 2020 rappresenta pure una
sconfitta per il “fronte conservatore” della Chiesa cattolica. “Open” e
“progressive” sono due delle parole che il nuovo presidente degli States ha
utilizzato con soddisfazione in queste ore. Il messaggio, rispetto a Trump, è
già cambiato. E i prossimi mesi potrebbero essere quelli della riforma bioetica,
con il ritorno alla visione aperturista di Obama in materia di aborto, istanze
Lgbt e così via. I tradizionalisti americani, così come la base pro life, hanno
confidato in un secondo mandato di The Donald ma, al netto dei ricorsi a cui
assisteremo nelle prossime settimane, è abbastanza facile prevedere come la
gestione Biden-Harris sia destinata a distanziarsi dalla impostazione che era
stata data dal leader del Gop, con la battaglia condotta contro Planned
Parenthood che tanto era piaciuta a buona parte dei cattolici americani. Qualche
cardinale ha persino espresso simpatia verso il tycoon. Il che, nel corso del
regno “bergogliano”, non è proprio consueto. Joe Biden è cattolico. E questa è
una novità abbastanza marcata per gli equilibri della politica americana. La
Conferenza episcopale americana, durante la giornata di ieri, ha inoltrato il
suo messaggio di congratulazioni, ponendo più di qualche accento sulla parola
“unità”. Sappiamo quanto siano stati difficili i rapporti tra l’episcopato a
stelle e strisce e la gestione targata Trump-Pence. La questione dei fenomeni
migratori, giusto per fare un esempio, ha costituito un tema divisivo. Per non
parlare del dossier Cina: la Santa Sede ha stipulato un accordo biennale per la
nomina dei vescovi che non è mai piaciuto né agli esponenti del trumpismo né a
quelli del “fronte tradizionale” cattolico. Adesso, con Biden al comando, le
relazioni muteranno. E la previsione non può che narrare di un clima destinato
alla distensione. Papa Francesco e la dottrina del multilateralismo diplomatico
del segretario di Stato Pietro Parolin, in buona sostanza, hanno un alleato in
più. Ma Biden è un cattolico abortista, e i tradizionalisti non hanno fatto
fatica a sottolinearlo nel corso della campagna elettorale. Monsignor Carlo
Maria Viganò, il cardinale Raymond Leo Burke e pochi altri: le critiche a Biden
sono arrivate da alti ecclesiastici che si contano sulle dita di una mano. Il
popolo cattolico – quello sì – si è esposto verso Trump. E in queste ore sta
continuando a pregare affinché i ricorsi vadano in un certo modo. La Chiesa
cosiddetta “istituzionale”, invece, festeggia, con James Martin, consultore
della segreteria per la Comunicazione del Vaticano e sostenitore della necessità
di un “ponte” tra cattolicesimo ed istanze Lgbt, in testa. Il dado è tratto: i
progressisti cattolici avranno di sicuro la possibilità di costruire una
sintonia maggiore con il presidente che si insedierà – se tutto dovesse andare
come previsto – durante il mese di gennaio. I conservatori rimangono senza
rappresentanza o quasi. In questa storia può risiedere anche un aspetto
escatologico, con la “minoranza creativa” di stampo ratzingeriano che potrebbe
divenire appunto sempre più minoritaria nel palcoscenico culturale globale.
Quella Chiesa che Joseph Ratzinger pensava dovesse ripartire da un esiguo numero
di fedeli è, nella interpretazione di alcuni commentatori, una realtà già
narrabile. In questi mesi, qualcuno ha provato a dire che Joe Biden, in quanto
abortista, non dovesse accedere all’Eucaristica. Anche Benedetto XVI, quando era
pontefice, era stato chiaro sul punto, ma i tempi sono cambiati. E la linea
dell’accoglienza di Bergoglio non prevede ostacoli insormontabili per chi
ricerca la verità, cattolicamente intesa. Trump si era spinto fino al
condividere su Twitter la missiva in cui monsignor Carlo Maria Viganò parlava di
destini del mondo in gioco. Jorge Mario Bergoglio, d’altro canto, aveva
preferito non incontrare il segretario di Stato Mike Pompeo nella sua recente
visita a Roma.
Massimo Franco per il “Corriere della Sera” il 12 novembre 2020.
Un cauto benvenuto a Joe Biden. Una guardinga presa d'atto sulla sua vice Kamala
Harris. E l'ombra pesante di Donald Trump e dei cattolici conservatori sullo
sfondo. Almeno fino a ieri, il Vaticano non si era ancora congratulato col
presidente eletto degli Stati Uniti: un silenzio condiviso, tra i pochi altri,
con la Russia di Vladimir Putin e la Cina di Xi Jinping. Ma quello dei due
presidenti, soprattutto di Putin, è spiegato con l'attesa per l'esito definitivo
del conteggio dei voti e tradisce preoccupazione. Il silenzio della Santa Sede,
invece, riflette una cautela che protegge una certa soddisfazione: almeno nella
cerchia papale. «Nell'immaginario, Trump era diventato una sorta di
anti-Francesco», spiega un esponente vaticano. «Biden è una speranza di
distensione. Ma temiamo l'ipoteca dell'ala radicale dei democratici: esponenti
come la deputata di New York, Alexandria Ocasio-Cortez, più ancora della
vicepresidente Harris. Una prospettiva del genere potrebbe lacerare un
episcopato cattolico già polarizzato tra conservatori e progressisti». Per
questo, l'unico commento ufficiale è stato affidato al presidente dei vescovi
Usa, Josè Gomez, di Los Angeles. «Congratulazioni a Mr. Biden. Riconosciamo che
si unisce al defunto John F. Kennedy come secondo presidente degli Stati uniti a
professare la fede cattolica», ha dichiarato Gomez il 7 novembre. Parole sobrie
accompagnate da un significativo appello a «difendere la vita», che sembrano
registrare il superamento della «questione cattolica»: il contrario di quanto
accadde sessant' anni fa proprio con Kennedy, additato allora dall'élite
protestante come burattino nelle mani del papato romano «straniero». Oggi Biden
deve guardarsi dal cattolicesimo conservatore, più che da altre religioni
cristiane. A ottobre un prete, Robert Morey, ha rifiutato la Comunione al futuro
presidente in una chiesa di Florence, in South Carolina, per il suo appoggio
all'aborto: tesi rilanciata dal cardinale conservatore Raymond Leo Burke. E l'ex
nunzio a Washington, Carlo Maria Viganò, critico ossessivo di Francesco, ha
scritto l'ennesima lettera di solidarietà a Trump per la «colossale frode
elettorale»; e stigmatizzato una supposta scellerata alleanza tra «Stato
profondo americano» e «Chiesa profonda». Si evoca un complotto globalista e
anticristiano di cui l'elezione di Jorge Mario Bergoglio sarebbe stato il
prodotto nel 2013. E, sebbene le posizioni dell'ex nunzio Viganò siano
screditate in Italia, nella destra cattolica americana continuano ad avere un
qualche peso. Il cardinale Timothy Dolan, arcivescovo di New York e moderato, ha
spiegato che avrebbe dato la Comunione a Biden; ma si è mostrato comprensivo
verso il rifiuto opposto dal sacerdote di Florence. La cautela della Santa Sede
va letta dunque come un tentativo di non esasperare i contrasti in un episcopato
che approva l'ostilità di Trump all'aborto e alle unioni omosessuali; diffida
dei democratici; e che da alcuni anni, ormai, rappresenta la frontiera avanzata
della resistenza alle aperture di Francesco. Il settimanale dei gesuiti Usa,
America , ha ricordato che Biden rivendica l'educazione ai valori cattolici come
«un dono»; e ha cercato di spiegare in che consista la sua fede. È un modo per
accreditarlo presso l'«altra America» pro-Trump. Lo scontro attraversa il mondo
cattolico. Oltre a vescovi ci sono state suore che si sono schierate contro
Biden, e suore che lo hanno appoggiato. Lo stesso arcivescovo Gomez qualche mese
fa ha smentito un'indiscrezione che lo dava come elettore del neopresidente.
Dunque, i giudizi vengono espressi sottovoce. Si apprezza la spinta all'unità
nazionale che il presidente democratico vuole imprimere dopo quattro anni di
trumpismo. Viene sottolineato che le congratulazioni di Gomez probabilmente sono
state concordate con il nunzio a Washington, monsignor Christophe Pierre, uomo
vicino a Francesco. E si fa presente che sono circolati documenti riservati
della Chiesa Usa per dire ai cattolici di non sentirsi obbligati a votare Trump
in nome dei cosiddetti «valori non negoziabili». E, sul piano internazionale, si
intravede un ritorno al multipolarismo che permetterà al Vaticano di esercitare
meglio le sue mediazioni. Ma Biden costringerà il papato a rivedere alcuni suoi
atteggiamenti. Il presidente rappresenta un establishment che è l'antitesi del
populismo di cui Trump e Bergoglio, seppure su posizioni agli antipodi, sono
stati additati come figure speculari. In più, il rapporto con la Cina rimarrà un
elemento di tensione con il Vaticano di Francesco. Pochi pensano che una Casa
Bianca in mano ai democratici cambierà atteggiamento nei confronti di Pechino,
considerata la capitale nemica della nuova Guerra Fredda. L'accordo provvisorio
e segreto appena rinnovato per due anni tra Santa Sede e Cina è visto come un
cedimento rischioso al regime comunista: le parole pesanti contro il Vaticano
pronunciate qualche settimana fa dal segretario di Stato uscente, Mike Pompeo,
potranno essere dette in modo più educato dal successore, uomo o donna che sia;
ma la sostanza rimarrà. Se è vero che Biden sta pensando a un'alleanza delle
democrazie occidentali e asiatiche per contenere l'espansionismo cinese, sarà
interessante vedere come il Vaticano riuscirà a rispondere a quella che
assomiglierà molto alla richiesta di una scelta di campo tra libertà e
autoritarismo.
L’impatto
della vittoria di Biden sulle relazioni Usa-Vaticano.
Andrea
Muratore su Inside Over il 9 novembre 2020. Con la vittoria di Joe Biden alle
elezioni presidenziali statunitensi sono da monitorare le future relazioni tra
gli Stati Uniti e il Vaticano, che con l’uscente amministrazione Trump aveva
avuto ben più di un’incomprensione e uno screzio. Tensioni legate
principalmente alla grande attenzione data da Papa Francesco alla transizione
del mondo verso il contesto multipolare e, in questo contesto,
all’approfondimento dei legami tra l’Oltretevere e la Cina rivale numero uno di
Washington. Washington ha negli ultimi anni contestato l’avvicinamento
sino-vaticano utilizzando sia le armi politiche della tutela dei valori
occidentali e dell’ideologia dei diritti umani che quelle legate alla precaria
condizione religiosa storicamente vissuta dai cattolici cinesi. Il Papa e la sua
cerchia hanno però tirato dritto, e il grande gelo che ha diviso il segretario
di Stato Usa Mike Pompeo e l’omologo vaticano Pietro Parolin nel contesto della
recente visita romana dell’ex capo della Cia testimonia l’ampiezza della faglia
che divide i due “imperi paralleli”. Il tramonto dell’era Trump e l’ascesa
dell’era Biden porterà alla Casa Bianca il secondo cattolico della storia
statunitense. Un elemento di sinergia con la Chiesa di Bergoglio, senz’altro, ma
che non basta in sè e per sè a dare per scontato il fatto che Vaticano e
Washington ricostruiranno una relazione di piena fiducia. Non dimentichiamo che
anche durante l’era di Barack Obama, in cui l’amministrazione statunitense ebbe
il fondamentale sostegno papale per aprire alla storica mediazione con Cuba, ci
furono punti di forti disaccordo tra Stati Uniti e Santa Sede, ad esempio in
occasione del possibile attacco della Nato a Bashar al-Assad nel 2013, frenato
dalla ferma opposizione morale del Papa e da quella politica di Vladimir Putin.
Se Biden appoggerà nuovamente un’agenda multilateralista e aprirà un dialogo
politico a tutto campo col Vaticano certamente l’Oltretevere non potrà non
apprezzare; ma d’altro canto il futuro presidente non potrà fare a meno di
continuare a gestire il dossier cinese nell’ottica di un contenimento delle
ambizioni politiche e strategiche dell’Impero di Mezzo. E dunque di vedere come
fumo negli occhi una normalizzazione dei rapporti con un attore di rilevanza
mondiale quale la Santa Sede. Secondo Pasquale Annicchino, Senior Research
Associatedel Cambridge Institute on Religion & International Studies
dell’Università di Cambridge intervistato da Formiche, il punto chiave è “vedere
come verrà declinata la politica estera dell’amministrazione Biden. Sarà
disposta ad applicare sanzioni per violazione dei diritti umani o a imporre
divieto all’export ad aziende anche statunitensi che operano nello Xinjiang
perché quei prodotti possono essere utilizzati per la sorveglianza della
minoranza uigura?”. Un ritorno in auge dei liberal interventisti dell’era Obama
come Susan Rice, ex consigliera alla sicurezza nazionale, non scelta da Biden
per la vicepresidenza perché tenuta pronta per la successione a Pompeo,
porterebbe con sè la strategia della pressione sulla retorica dei diritti umani,
che dal canto suo il trumpismo non aveva certamente riposto nel cassetto. Il
Vaticano è disposto ad accettare che sul dossier cinese alle critiche americane
provenienti dal campo conservatore sulla perdita della sua “autorità morale”
(che in un Paese che vede il mondo cattolico diviso hanno un certo seguito) si
sommino le accuse degli “illuministi” progressisti sempre pronti a usare contro
i rivali di Washington come arma geopolitica la carta dei diritti individuali e
della loro tutela? Non dimentichiamo che più volte gli interventisti
statunitensi hanno trovato un’accoglienza fredda nei confini vaticani: nel
2007 Condoleeza Rice, segretario di Stato di George W. Bush, trovò sbarrate le
porte dell’ufficio di Benedetto XVI per l’opposizione vaticana alla guerra in
Iraq. Il Vaticano ha un’agenda politica ben consolidata e Francesco intende
tenersi margini di autonomia notevoli. Per quanto una sintonia dialettica
maggiore con l’amministrazione Biden non è affatto da escludere, bisogna
valutare se a questo seguirà la buona volontà di creare un modus
vivendi politico. Nella consapevolezza che al dossier cinese e all’ampliamento
delle relazioni con la Cina il Vaticano non è affatto disposto a rinunciare. E
bisognerà capire la volontà di Biden, la cui amministrazione si prefigura come
altrettanto anticinese della precedente, di accettare questo dato di fatto.
Da "tgcom24.mediaset.it" il 12 novembre 2020. Ci si è messo anche
il tempo a guastare la prima uscita pubblica di Donald e Melania Trump dalla
sconfitta alle elezioni presidenziali. In occasione del Veterans Day, il
presidente uscente ha reso omaggio ai veterani militari americani. Trump ha
visitato la Tomba del Milite Ignoto al Cimitero Nazionale di Arlington, in
Virginia. Sotto la pioggia battente Donald Trump si è soffermato qualche minuto
davanti a una maestosa corona di fiori per il suo tributo alle forze armate
degli Stati Uniti. Al suo fianco la moglie Melania Trump. “Al suo fianco” si fa
per dire. La First Lady infatti è arrivata a braccetto con un militare. Il
giovane in divisa ha accompagnato Melania in giro per il cimitero. Donald, a
debita distanza, guardava con aria cupa. Certo, il Veterans Day non è certo una
celebrazione leggera. Se ci aggiungiamo anche la sconfitta elettorale a favore
di Joe Biden, che Trump non ha ancora riconosciuto, possiamo concludere che
questi non debbano essere giorni felici per il tycoon. Come se non bastasse, si
fanno insistenti le voci che vogliono Melania Trump a un passo dal divorzio dal
marito. Secondo i ben informati infatti la First Lady starebbe contando i giorni
che la separano dalla fine del mandato presidenziale per dare il ben servito a
Donald. Avrebbe già fatto le valigie, pronta per tornare a New York e dire addio
a Trump, dopo 16 anni al suo fianco. Che si sia presentata al braccio del
prestante militare invece che di suo marito non è che una conferma del gossip.
Per quanto riguarda il look, Melania Trump era splendida in un cappotto di
Dolce&Gabbana (1.750,00). L’elegante modello in grisaglia con profili in
passamaneria a contrasto e ampio collo con revers, è perfettamente adatto
all’evento austero. Ancora una volta, come già accaduto in Florida quando si è
recata (in Gucci) al seggio a votare, la First Lady non indossava la mascherina
di protezione. Infine, non ci sono scatti che mostrano con chiarezza cosa avesse
ai piedi, probabilmente le sue irrinunciabili pump tacco 12 di Christian
Louboutin o Manolo Blahnik. Per scappare il più in fretta possibile dalla Casa
Bianca però a Melania converrebbe indossare un paio di comode sneakers
Davide Frattini per il “Corriere della Sera” il 12 novembre 2020.
Agli esordi in politica, da poco eletto senatore, Joe Biden visita Israele. È l'
estate del 1973, quaranta giorni dopo scoppia la guerra di Yom Kippur, il
conflitto che più ha messo in pericolo lo Stato ebraico. Viene ricevuto da Golda
Meir, ricorderà le sigarette che la prima ministra fumava una dietro e l' altra
e «uno degli incontri più significativi della mia vita». È improbabile che il
presidente eletto atterri in Medio Oriente poco dopo l' insediamento (Donald
Trump scelse l' Arabia Saudita come prima tappa), le priorità (sanitarie) sono
altre. È improbabile che i rapporti tra Biden e i governi della regione restino
immutati. I più prudenti come Mohammed Bin Zayed hanno preferito scollarsi da
Trump negli ultimi mesi e lo sceicco degli Emirati Arabi ha spedito a Washington
il suo ministro degli Esteri per firmare gli accordi di Abramo. I più avventati
come Benjamin Netanyahu dovranno ricalibrare le aspettative, anche se la
sintonia - prevedono gli analisti - non potrà essere tanto mancante quanto con
Barack Obama. Adesso il premier si affretta a dire «repubblicani o democratici
per Israele non fa differenza», sa però che Biden non potrà garantirgli gli
stessi doni dell' amico Donald. Allo stesso tempo il leader americano non sembra
avere intenzione di richiedere al mittente alcuni pacchi già scartati, in pochi
pensano che decida di riportare l' ambasciata americana da Gerusalemme a Tel
Aviv. «Con la vice Kamala Harris - spiega Haaretz , il quotidiano della sinistra
- condivide un impegno verso la sicurezza di Israele che è in parte
sentimentale, a differenza di Obama». Biden ha elogiato le intese per la
normalizzazione tra lo Stato ebraico, gli Emirati e il Bahrein; è consapevole
che le trattative con i palestinesi sono difficili da far ripartire (almeno non
snobberà le richieste del presidente Abu Mazen e frenerà i piani israeliani di
annessione della Cisgiordania); sarà meno indulgente verso il principe Mohammad
Bin Salman e gli abusi dei diritti umani perpetrati dalle monarchie del Golfo
(ma spingerà perché anche l' Arabia Saudita arrivi a un' intesa con gli
israeliani); di certo non arriverà a chiamare Al Sisi, il presidente egiziano,
«il mio dittatore preferito» (così era per il predecessore alla Casa Bianca).
Roberto D’Agostino per VanityFair.it il 12 novembre 2020. Come
facevano gli americani ad avere alla Casa Bianca uno che crede che plutonio sia
il cane di Topolino, non lo sa nemmeno Walt Disney. Se Donald nasceva in Italia
anziché il potere degli Stati Uniti gli davano il Telegatto. Fin da giovane era
talmente gasato che quando si tuffava in mare l'acqua diventa Schweppes e le
cozze si ossigenavano, uscivano e se ne andavano allo Studio 54. Così frenetico
che farebbe apparire un battaglione di marines come un gruppo di perdigiorno.
Tale clown per quattro anni ha spinto la sinistra liberal e bella americana a
ingollare ogni sera boccette di Xanax per addormentarsi. Come recitano le
agiografie, Donald Trump si fatto da sé. Tutto, anche i capelli. Ma è anche il
tipo di persona che un serpente rifiuterebbe di morsicare per solidarietà di
categoria. Un uomo egotistico e rude. Non di strada, ma che viene dalla strada.
Dai cantieri edili di suo padre, dove gli operai sudano, imprecano e sbavano sul
culo a mandolino delle donne. ‘’Io sono il brand più sexy del mondo’’. Così il
“mucho macho” si presentò alla prima sfida presidenziale: “Se Hilary Clinton non
può soddisfare suo marito cosa le fa credere di poter soddisfare gli Stati
Uniti?”. Ancora: ‘’Francamente, se Hilary Clinton fosse un uomo, non avrebbe
neanche il 5% dei voti’’. Altra smanacciata al “pacco”, lingua fuori e via:
‘’Sono automaticamente attratto dalla bellezza, inizio subito a baciarle, è
così. È come una calamita. Bacio subito. Nemmeno aspetto. Quando sei famoso te
lo lasciano fare. Puoi fare tutto. Afferrarle dalla figa. Puoi fare tutto…”.
Questo cazzone cedrone da “nun sai che te farebbbe…” non è uscito da un vecchio
film di Carlo Verdone; no, è uno che ha sfidato la complessità della politica
con la sua straordinaria ascesa da star dei reality e uomo d'affari alla
presidenza degli Stati Uniti e dopo quattro anni è ricaduto sulla terra. Game
over. Dopo averne combinate di tutti i colori alla Casa Bianca, Trumpone è stato
soprattutto battuto dal tampone del Covid che ha ucciso più di 236.000 persone
negli Stati Uniti e buttato sulla strada milioni di gente senza lavoro. Eppure
il marchio aspro ed irritante, sovente trucido-tweet, dell’era del trumpismo
lascerà il segno, anche se sconfitto. E la sua performance elettorale migliore
del previsto (71 milioni di voti) contro il democratico Joe Biden suggerisce che
il suo impatto probabilmente risuonerà per generazioni e non solo in politica.
Oltre al disprezzo per l’establishment infighettato ad Harvard e Stanford, è
evidente che Trump ha interpretato meglio di ogni altro l’elemento spettacolo,
innato nella cultura americana: uno show popolare, clownesco e pericoloso, ma
sempre uno spettacolo. I giornalisti cresciuti nei salotti di New York e Los
Angeles e nel sacro culto della correttezza politica non hanno mai avuto la
minima idea di come sia il mondo reale. Quindi non potevano vedere
nell'esasperazione volgare, violenta e degenerata di Donald l’essenza incarnata
degli Stati Uniti e l’hanno gettato nell’olio bollente come un sofficino Findus.
I radical-chic erano affezionati al professore di decoro Barack Obama, che aveva
trasformato la Casa Banca in una classe di Harvard. Presidente ideale, padre
ideale, che aveva scelto di essere nero, perché era nato da una donna bianca ma
aveva deciso di sposare una nera. Intelligente, anche lei laureata a Princeton.
Dopo tanto bon ton, è arrivato come un ciclone il bon-trop. Quattro anni fa la
stampa si è ritrovata un presidente bugiardo e traditore (come tutti i politici)
ma sfacciato e “impresentabile”, i cui valori si identificano con la ricchezza.
Mentre i liberal di Hollywood fanno un sacco di soldi ma non lo dicono,
preferendo tra una villa a Malibu e un’isola caraibica, scassare le palle con il
cambiamento climatico e il Me-Too, Trump fa bling-bling, la ricchezza la ostenta
come un qualsiasi Berlusconi - e forse non è neppure vera, visto che ha sempre
nascosto la dichiarazione dei redditi. E poi i media amano dipingerlo come un
porcone in preda a zoccole e pornostar. Tanti altri lo sono stati, dai fratelli
Kennedy a Martin Luther King fino a Bill Clinton. Ma da Trump però non si
accettano simili comportamenti. In America, per un uomo così, possono avere
simpatia solo gli operai e i poveracci e i burini dell’Oklahoma, ‘’dove i
cavalli si puliscono con la chioma’’ (Pippo Franco). Per comprendere
l’”incidente Trump”, bisogna leggere Gay Talese, il leggendario
giornalista-scrittore americano: “La città più razzista in America è New York.
Non siamo a Birmingham nel 1965, ma abbiamo le scuole segregate: i ricchi vanno
in quelle private, i poveri in quelle pubbliche. Poi c'è la segregazione
edilizia, perché non ci piace stare con chi non è come noi. Gli americani
predicano l'eguaglianza e la giustizia, ma non la praticano. Se avessimo onestà
e integrità, aboliremmo le scuole private per garantire che tutti vengano
istruiti nello stesso modo. L'America oggi è così: un circo di ipocrisia”.
Presidenziali Usa, Alexander Stille spiega perché spera che vinca Joe Biden.
Umberto De Giovannangeli su Il Riformista il 3 Novembre 2020.
“Unite for a better future“ (uniti per un futuro migliore). È l’America di Joe
Biden. Nel giorno del giudizio elettorale, Il Riformista ne parla con Alexander
Stille, giornalista e scrittore statunitense, professore alla prestigiosa Scuola
di Giornalismo della Columbia University.
Professor
Stille, qual è l’America di cui Joe Biden si è fatto garante e che vorrebbe
portare, se sarà eletto, alla Casa Bianca?
«La
visione di Joe Biden dell’America è quella di un Paese aperto, rispettoso del
parere degli altri. È l’America di un presidente che vorrebbe mettere fine alle
divisioni e agli odi sociali che hanno caratterizzato l’epoca trumpiana. Quello
di cui Biden si è fatto portatore in questa campagna elettorale è stato un
appello all’unità, e a un periodo più civile e rispettoso della nostra storia».
In una
nostra precedente conversazione, lei ha sostenuto che il low profile che ha
caratterizzato la campagna del candidato democratico sia stata, tutto sommato,
una scelta azzeccata. Ciò vuol dire che quello di oggi sarà un referendum pro o
contro Trump?
«Direi
proprio di sì. Queste elezioni sono soprattutto un referendum pro o contro
Trump. Gli elettori di Biden hanno un giudizio decisamente negativo del mandato
di Trump, lo vedono come un presidente che ha fortemente indebolito le
istituzioni democratiche del Paese usando il Governo per fini personali e di
parte, strumentalizzando e piegando ai suoi interessi i vari rami del Governo.
Un atteggiamento che si è rafforzato e radicalizzato in campagna elettorale. Gli
esempi che si possono fare in questo senso sono tanti: Trump che chiede al suo
ministro della Giustizia di incriminare e spedire in prigione Barack Obama, ex
presidente, e Joe Biden suo avversario politico. Abbiamo visto Trump abusare del
suo potere presidenziale chiedendo, quasi imponendo, al presidente dell’Ucraina
di iniziare una indagine contro Biden per mettere in difficoltà il suo rivale,
un chiaro abuso di potere che ha portato i Democratici a chiederne
l’impeachment. Ma se queste elezioni si sono trasformate in un referendum sul
Presidente è soprattutto per come lui ha gestito la drammatica crisi pandemica.
Se è possibile fare una battuta, direi che se Trump sarà sconfitto, più che da
Biden lo sarà dal Covid-19 e della gestione scellerata, ondivaga, che lui ha
avuto nel contrasto al virus. Una maggioranza del Paese ha giudicato
negativamente la risposta del presidente Trump alla sfida del coronavirus. Trump
ha rifiutato di dare un indirizzo chiaro alla nazione, lasciando ai singoli
Stati di inventare risposte diverse al contagio. Al tempo stesso, ha minimizzato
il più possibile il pericolo del virus dicendo che era una semplice influenza,
che sarebbe scomparso da un giorno all’altro, poi quando si è stufato delle
misure di prevenzione ha chiesto che fossero riempite le chiese durante le feste
di Pasqua, ha contestato i governatori democratici che cercavano di contenere il
contagio dicendo: liberate il Michigan, liberate il Wisconsin, liberate la
Virginia. Ha attaccato le stesse misure di distanziamento sociale nel Paese, per
cui era diventato una specie di simbolo di appartenenza politica portare o no la
mascherina, col risultato che mentre in Europa durante l’estate il virus era
molto contenuto, negli Stati Uniti ha dilagato in tanti Stati che non erano
stati colpiti durante la prima ondata. Gli Stati Uniti sono il primo paese al
mondo per morti per il coronavirus, con 225mila vittime. Un record tragico».
Quattro
anni fa, Trump sfondò nell’America più profonda, quella che più aveva subito gli
effetti negativi, in termini di posti di lavoro persi e di un abbattimento delle
tutele sociali, di una globalizzazione senza regole. In quella parte di
elettorato, quello dei colletti bianchi e delle tute blu, Biden è riuscito a
entrare?
«Non
c’è dubbio che una delle chiavi della vittoria di Trump nel 2016 è stata aver
spostato una parte importante del voto democratico tradizionale, quello degli
operai, dei bianchi senza laurea che lavoravano nelle fabbriche, nell’industria,
verso il partito Repubblicano, per la prima volta. Sia il Partito democratico
che quello tradizionale Repubblicano hanno sottovalutato l’impatto negativo
della globalizzazione su questa parte dell’elettorato, e questa parte ha scelto
di punire il Partito democratico anche perché Trump si è presentato come
paladino della classe operaia. Su quel fronte, Trump ha risposto in due modi:
per quanto riguarda la politica economica, non ha fatto granché per eliminare o
per lo meno accorciare le disuguaglianze che aveva denunciato nella sua prima
campagna presidenziale. Il pilastro del suo programma economico è stato un
grande taglio delle tasse, che ha favorito però prevalentemente i ceti più alti:
l’1% più ricco risparmiava qualcosa come 60mila dollari all’anno in tasse mentre
uno della classe operaia magari ne risparmiava 600. La sua politica economica si
è rivelata alla fine la tradizionale politica dei repubblicani che favorisce la
classe dei donatori. Quello che lui ha invece dato a quella parte di elettorato,
è un marcato senso di appartenenza tribale, a cui ha fatto appello per essere
rieletto. Un appello che ha alimentato l’odio razziale. Pochi giorni fa, in
Minnesota, Trump davanti ad una folla quasi esclusivamente bianca ha parlato di
“buoni geni” di quella folla, dicendo che erano dei cavalli di razza e che se
Biden avesse vinto il Minnesota sarebbe stato ridotto ad un campo profughi. È
interessante rimarcare che nel passato il Partito repubblicano prendeva la
maggioranza dei voti dei bianchi con la laurea, mentre adesso perde molto sia
tra bianchi con un titolo di studio superiore sia tra le donne, perché questi
discorsi non piacciono a una parte dell’elettorato, come quella a cui accennavo,
mentre eccitano quella più radicalizzata, border line con il suprematismo bianco
o quella che sostiene che, in fondo, Trump dice quello che noi diciamo in
privato ma che non osiamo esternare in pubblico. Invece a un’altra parte di
elettori, si spera la maggioranza, non piace una retorica come quella di Trump
che divide, lacera il Paese. In questa chiave, una delle armi più efficaci di
Biden è stata quella di presentarsi come il candidato che vuole unire l’America
e reintrodurre un approccio più dignitoso e rispettoso nel discorso politico».
A proposito
di donne. Quanto ha pesato in questa campagna elettorale e quanto potrebbe
pesare in caso di vittori di Biden, la sua vice Kamala Harris?
«Alla
fine, la presenza della Harris non sembra essere stata decisiva. Lei ha avuto un
profilo abbastanza basso durante la campagna elettorale, però va detto che in
genere la regola più importante nell’indicare un vice presidente è che il
prescelto non finisca per nuocere. Kamala Harris ha aiutato senza nuocere, la
scelta di una donna di colore ha mandato un segnale rassicurante all’elettorato
nero, che è uno dei pilastri dell’elettorato democratico, e un segnale positivo
alle donne, che forse rappresentano pilastro più grande. Inoltre, Kamala Harris
è di sinistra senza però esserlo troppo. Si presenta bene, certamente ha più
carisma di Biden. Negli ultimi giorni di campagna, Trump ha cercato di fare di
lei il suo avversario, dicendo che Biden sarebbe stato esautorato dopo qualche
settimana al potere e il presidente sarebbe stata la Harris, ma non credo che
questo discorso abbia delle gambe lunghe».
Si è detto
e scritto che il king maker di Biden sia stato Barack Obama. L’eventuale
vittoria di quello che è stato il suo vice, può configurarsi come la rivincita
di Obama?
«Non
direi che Obama sia stato il king maker di Biden. Chi lo è stato veramente è un
deputato nero del South Carolina, Jim Clyburn, che ha dato il suo appoggio a
Biden quando lui era nel momento più basso nelle primarie democratiche, aveva
perso le prime primarie e si andava in South Carolina, dove l’elettorato
democratico è formato in grande maggioranza da cittadini neri Naturalmente il
fatto che Biden sia stato il vice presidente di Obama, è stata una specie di
garanzia immediata per molti elettori neri che hanno visto in lui una persona
affidabile».
La prima
vittoria di Obama è stata caratterizzata dalle parole “Yes we can”, quella di
Trump da “America first”. E Biden?
«Lo
slogan più efficace di Biden è fatto di tre “b”: build back better, ricostruire
meglio. Recuperare ciò che era stato prodotto negli anni di Obama, ma facendo
meglio. Ad esempio estendere la sua riforma sanitaria a quei cittadini che non
ne avevano beneficiato; fare di più per rendere più progressivo il nostro
sistema fiscale, per affrontare la crisi climatica del riscaldamento globale, e
quindi prendere l’indirizzo e il tono della presidenza Obama ma al tempo stesso
rispondere alle nuove esigenze di questi ultimi otto anni, compreso alcune delle
problematiche che la vittoria di Trump aveva posto, come il dramma di una classe
operaia che si è sentita mortificata. Da Obama, oltre Obama. È l’orizzonte
dell’America di Joe Biden, se sarà lui il quarantacinquesimo presidente degli
Stati Uniti».
Stefano Zurlo per “il Giornale” il 5 novembre 2020.
Biden? Massimo Cacciari sta seguendo in tv l' interminabile
giornata americana.
«È in vantaggio nel Wisconsin. Possiamo dire, forse, scampato
pericolo».
E poi?
«E poi basta. Non c' è da stappare bottiglie o da festeggiare.
Biden è una figura sbiadita del passato. Passato anche in senso
buono, per carità, ma passato».
La sinistra italiana fa il tifo.
Risata: «Anch' io nel mio piccolo parteggio per lui. Basta avere
le idee chiare. Meglio un passato decente anche se piatto rispetto a un futuro
avventuroso, nelle mani di Trump».
Davvero non si aspetta niente da Biden?
«Sul piano culturale e politico nulla di nulla».
Professore, è così categorico?
«La sinistra italiana ed europea era già caduta a suo tempo nel
trappolone dei Clinton, di Blair e Obama. C' era stata l' illusione che il verbo
arrivasse da questi signori».
Risultato?
«La sinistra ha tradito, ha inseguito le politiche neoliberiste
dei leader anglosassoni, ha perso per strada i ceti che rappresentava. I
militanti, gli operai, gli strati più in difficoltà».
È cominciata così la diaspora dell' elettorato rosso?
«A Marghera dove io prendevo il 70% dei voti c' è stato un
mutamento clamoroso. Gli operai del Vicentino o del Trevigiano hanno fatto ciao
ciao ai partiti che prima li tutelavano. Bene, molto hanno giocato questi
innamoramenti frettolosi: l' Ulivo mondiale, il papa straniero, tutta la
sbandierata retorica obamiana».
Dobbiamo leggere in questa chiave anche l' avvento dei Cinque
stelle?
«Certo. I 5 Stelle, come Podemos o Syriza di Tsipras in Grecia
sono figli di questa metamorfosi, di questo smottamento e della conseguente
incomprensione dell' elettorato. Il disorientamento si coagula nei movimenti di
protesta».
Biden è insomma una pallida imitazione di chi l' ha preceduto?
«Quelle almeno erano figure di rottura, portavano suggestioni di
cambiamento, con tutti gli squilli di tromba del caso, oggi Biden è solo il male
minore. Strano destino il suo».
Perché?
«Ai tempi di Obama simboleggiava il polo moderato, necessario
contrappeso all' Obama che poteva spaventare i benpensanti. Oggi è lui a
rassicurare al confronto di Trump, ma ha bisogno di qualcosa di più frizzante,
vivace e passionale alla sua sinistra».
La sua vice, Kamala Harris?
«Mi pare che sia lei la vera novità di queste elezioni. Qualcosa
più di sinistra».
Per ora non si sa nemmeno con certezza se Biden ha vinto.
«È evidente che questa storia, la guerra del voto postale con
tutti gli strascichi connessi, si trascinerà per giorni. Un brutto segnale di
destabilizzazione che arriva dagli Stati Uniti. Speriamo non si scoprano
intromissioni cinesi o russe».
È la crisi della democrazia americana?
«Mi pare proprio di sì. Assistiamo alle convulsioni di un Paese
incapace di arrivare rapidamente a una sintesi».
Qualcuno ipotizza il rischio di una guerra civile.
«No, francamente mi pare troppo. Forse in altri tempi. Oggi direi
di no o almeno lo spero.
Però questa spaccatura profonda testimonia la fragilità di una
società che per noi era un modello».
Trump ha tenuto. Come mai i sondaggi fanno cilecca?
«Questo discorso è parte di quello spaesamento che descrivevamo
prima. L' elettorato è fluido, non ha più punti di riferimento, salta da una
parte all' altra».
Negli Usa come in Italia?
«Siamo in una società sempre più liquida. Gli elettori seguono
ora questo ora quel leader: Renzi, Grillo, Salvini, la Meloni».
Siamo in una giostra. Ma la sinistra?
«Non ho la vista così acuta da scorgere leader all' orizzonte».
D' accordo, ma i progressisti da dove possono ripartire?
«Certo, non rincorrendo Biden. Non si vedono ideali, strategie,
suggerimenti interessanti. Però può anche essere che all' improvviso emergano
figure nuove capaci di catalizzare l' opinione pubblica e di segnare una svolta.
Io seguo con interesse Kamala Harris che indubbiamente è qualcosa di inedito nel
panorama politico degli Usa, dominato dalle grandi dinastie, dalle stesse
famiglie, sia in casa democratica che fra i repubblicani. Magari, al prossimo
giro lei sarà il primo presidente donna. E quella sarà una lezione per tutti
noi».
Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera” il 5 novembre 2020. La
moderazione, la ragionevolezza, i programmi, perfino la mancanza di carisma di
un «leader per caso» difficile da amare ma anche da detestare, sembravano poter
diventare un elemento di forza nella sfida lanciata da Joe Biden a un presidente
che puntava tutto sulla sua fisicità: un leader che si considera l' incarnazione
dell' agenda politica dei conservatori, un condottiero invulnerabile che può
permettersi anche di sfidare le istituzioni della democrazia americana, fino al
punto di contestare l' esito delle elezioni. Non è stato così. Biden ha condotto
una battaglia politica pulita, ha conquistato più voti di qualunque altro
candidato alla presidenza della storia americana in un' elezione che ha visto
una partecipazione al voto senza precedenti, ma non si può dire che la sua corsa
al risparmio - per evitare il rischio di diffondere, insieme al virus, anche le
sue celebri gaffe - lo abbia premiato. È probabile, che riesca a farcela. Pur
dicendosi in attesa dei risultati ufficiali, ieri ha promesso di governare come
«presidente di tutti gli americani». Ma la «valanga blu» che avrebbe potuto
trasformare la politica americana, non c' è stata. Anche se riuscirà ad entrare
alla Casa Bianca, il leader democratico sarà un presidente indebolito non solo
dalla mancanza di controllo sul Parlamento (i democratici sembrano lontani dalla
riconquista del Senato), ma anche da una vittoria sul filo di lana, aspramente
contestata da un Trump che potrebbe diventare ancor più pericoloso come leader
di un' opposizione movimentista: non più invulnerabile, ma sempre condottiero di
mezzo Paese convinto che il suo leader è stato messo fuori gioco in modo
fraudolento. Le colpe di questa eventuale vittoria dimezzata non sono di Biden,
scelto come candidato per mancanza di altri più giovani e carismatici e per
uscire dallo stallo che stava logorando un partito democratico frantumato tra le
sue varie anime: quella che oggi ci appare come l' eccessiva prudenza della sua
campagna era giustificata da sondaggi che in modo quasi unanime gli attribuivano
una vittoria con ampio margine. Rilevazioni che, nonostante tutte le cautele e
le correzioni metodologiche introdotte dopo la catastrofe demoscopica del 2016,
si sono rivelate ancor più sballate di quelle delle presidenziali di quattro
anni fa. Cosa che, intanto, porta a rivedere il giudizio dato allora sulla
campagna di Hillary Clinton: la sconfitta democratica fu messa tutta in conto a
una ex first lady bollata come arrogante e «divisiva». Evidentemente c' era
anche altro: in alcune contee delle città industriali in crisi e tra gli
ispanici della Florida Hillary aveva addirittura ottenuto molti più suffragi di
quelli raccolti ieri da Biden. Nemmeno la popolarità di Barack Obama è servita a
risollevare più di tanto un partito democratico in debito d' ossigeno. Segno che
anche l' immagine del leader delle grandi speranze del 2008 è ormai logorata.
Basti pensare alla battaglia all' ultimo voto che Biden è stato costretto a
combattere in Michigan, lo Stato maggiormente beneficiato dalle politiche di
Obama che 11 anni fa scommise gran parte del suo capitale politico sul
salvataggio dell' industria automobilistica di Detroit, con un progetto coronato
da pieno successo. Evidentemente, al di là dei limiti politici e personali di un
leader democratico chiaramente invecchiato, la sinistra americana, come del
resto quella europea, continua a pagare il prezzo della sua incapacità di
contrastare l' aumento delle diseguaglianze economiche. Le speranze suscitate da
Obama sono rimaste tali: certo, il primo presidente nero della storia americana
(con Biden come vice) si è trovato ad operare in circostanze storiche
straordinarie, a partire da una crisi bancaria gravissima che ha richiesto
soprattutto interventi sul fronte finanziario per evitare una catastrofica
depressione. Tutto ciò, insieme al boom dell' industria tecnologica, ha portato
a un ulteriore, forte aumento delle diseguaglianze economiche aprendo la strada
alla conquista di molti operai travolti dalla crisi da parte della destra
populista. Per questo, come ha dichiarato ieri al Corriere il politologo Michael
Walzer, Biden, se arriverà alla Casa Bianca, dovrebbe cercare di essere non il
continuatore dell' opera di Obama ma, piuttosto, un nuovo Franklin Delano
Roosevelt, capace di varare imponenti programmi di riforme e di rilancio dell'
economia. Sarebbe stata comunque un' impresa assai ardua per il vecchio Joe, ma
con un Paese e uno scenario politico così devastati la sua sembra addirittura
una mission impossible.
Bianche,
razziste e armate: sono le donne dell'ultradestra che votano Trump.
Il
movimento delle ”sisters in hate” ora indagato in un libro, si dice "per la
libertà di parola": per celebrare il negazionismo, coltivare la paura e
diffondere l'odio. Manuela Cavalieri e Donatella Mulvoni su L'Espresso il 29
ottobre 2020. Si definiscono orgogliosamente anti-femministe. Sventolano
bandiere a stelle e strisce come antidoto contro l’America multirazziale.
Celebrano il culto di una nazione che non esiste più. Accolgono e rilanciano
teorie complottiste, coltivano la paura. Difendono la Costituzione e negano
l’esistenza del razzismo sistemico nei confronti delle minoranze, anzi bollano
Black Lives Matter come un collettivo violento di marxisti. Tutto si riduce a
una irrinunciabile istanza: la libertà di espressione messa in pericolo dalla
“combriccola dei liberal”. Sono le donne - bianche - dell’ultra destra
americana. Spesso nelle retrovie, attive sui social più che in tv, poco plateali
come i colleghi. Ma non me.
I fascisti e i complottisti italiani che tifano per Trump:
«Liberaci dalla dittatura». Estrema destra,
ultra-cattolici e negazionisti uniti sui social per The Donald, definito «il più
grande Uomo e Presidente del Mondo della storia contemporanea». Patrizia
Ruviglioni su L'Espresso il 05 novembre 2020. Lo chiamano il «salvatore», colui
che «libererà» il nostro Paese dalla dittatura sanitaria, dai poteri forti,
dall'Unione Europea. Per spingerlo alla vittoria pregano, invocano Dio. E poi,
se non dovesse farcela, passano direttamente alle accuse di complotto. I tifosi
italiani di Donald Trump, organizzati in pagine Facebook in stile culto della
persona, fan-club e associazioni vere e proprie, sono simili ai cugini
d'oltreoceano: negazionisti del covid, ultra-cattolici, fascisti, esperti in
presunte dietrologie. E non hanno dubbi: l'America first, il sovranismo a stelle
e strisce, può essere una grande opportunità anche per noi. Perché va bene il
Make America Great Again, il rendere l'America "grande" di nuovo; ma il nostro
Paese, dicono, merita e avrà la propria parte dalla Casa Bianca. Il "come", a
giudicare dai loro dibattiti sui social, non è chiaro. Ma ora che il Tycoon
invoca brogli e ricorsi resistono, si allineano. Ed è un copione già scritto, in
cui tutto torna: da mesi, in mezzo ai suoi interventi, condividono teorie
cospirazioniste, idee no-mask e accuse alle dittature «globaliste». A dettare le
coordinate, forte di una pagina Facebook da 50mila iscritti, è l'associazione
Noi con Trump. Che lo definisce «il più grande Uomo e Presidente del Mondo della
storia contemporanea». Che sul proprio blog promette: «Gandhi ha insegnato come
raggiungere la libertà, il Presidente Trump la realizzerà». E che, dopo aver
inviato una diffida a La7 per non aver risparmiato «commenti offensivi
addirittura della persona del Presidente», durante il programma Atlantide,
adesso si fa avanti. Votare repubblicano, assicurano, significa votare contro:
la «dittatura sanitaria», rimarcata da video di attriti fra Forze dell'ordine e
cittadini che non indosserebbero mascherine, perché l'Italia «non deve essere
come il Cile degli anni 70»; il «mainstream», che corrisponde all'egemonia di
Bill Gates e soci; e il «deep state», ovvero la teoria del complotto per cui
sarebbe lo "Stato nello Stato", i "potenti del mondo", a compiere le scelte
decisive per le nostre sorti, al posto dei leader democraticamente eletti. Ma
non di Trump, evidentemente. Nei commenti, emoticon di mani giunte in preghiera:
«Glorioso San Michele Arcangelo difendici nella lotta vieni in nostro aiuto
contro i figli delle tenebre che ostacolano la Vittoria del Presidente Trump con
inganni di ogni tipo». Del resto, Joe Biden rappresenta un mondo «satanico», per
quelli dell'associazione, il «Male» che si contrappone al «Bene». Ma se «i DEM
stanno rubando le elezioni», sulla presunta questione dei brogli non c'è da
temere: «Per fortuna la Corte Suprema è ad ampia maggioranza Repubblicana.
Altrimenti avrebbero alterato il risultato elettorale», dice Mariarosa. Per lei
come per gli altri, "repubblicano" fa evidentemente rima con "imparzialità";
"democratico", no. Mentre persino Matteo Salvini e Giorgia Meloni (che pure non
perdono occasione per schierarsi dallo stesso lato della barricata) sono
ritenuti troppo poco antisistema, il Tycoon è l'icona «dell'andare
controcorrente», come specifica la descrizione di un fan-club italiano a lui
intitolato, il cui admin sostiene di essere stato bloccato da Facebook per una
settimana per aver scritto "maledetti cinesi". Ma «senza avere nessuna reale
intenzione di suscitare odio», precisa. Poi guarda al futuro: «Su La7 un
giornalista di cui non so il nome dice che Trump sta organizzando milizie armate
“suprematiste” per riprendersi il potere. Magari lo facesse!». Strano, perché le
loro fonti non allineate hanno pronosticato a lungo i repubblicani come
vincitori schiaccianti. E sul gruppo Amici di TRUMP (4mila iscritti) continuano
ad arrivare informazione di servizio: «I fake media stanno trattenendo i
risultati reali. Trump avrebbe già raggiunto abbondantemente i 270 seggi utili
per la sua rielezione MA i media (deepstate) stanno facendo di tutto per tirarla
lunga con brogli elettorali». Ecco un altro punto fondamentale: diffidare sempre
e comunque dei giornalisti. Quella di Noi con Trump, per esempio, è una lotta
sia contro la «pedofilia» (con tanto di illustrazione di lui che trae in salvo
dei bambini da una vampira, in perfetto stile QAnon), e sia contro le «fake
news» del regime mediatico pro-Biden (da loro storpiato in «bidet»), che
alimenta terrore nei confronti del virus. Il binomio è facile: i politici «sono
attaccati al COVID con le stesse forze con cui rimangono attaccati alle
poltrone, consapevoli che se sparisce il primo spariscono anche le seconde». Ma,
come promette il Tycoon, «dal 4 novembre non ne sentirete più parlare». E,
aggiungono loro, anche per noi italiani «inizierà un grande percorso di
rinascita che ci vedrà protagonisti». Ma, più in là, gli iscritti affrontano i
complessi di inferiorità con l’originale: «L'Italia sta attendendo l'intervento
del Presidente Trump.. Siamo disperati». Poi giù a preghiere, di nuovo. Come il
"Padre Nostro" «x Trump» che campeggia nel gruppo Donne con Trump. O come quelle
che – sempre in Noi con Trump – catalizzano gli interventi di Carlo Maria
Viganò, ex nunzio apostolico a Washington, ultra-cattolico, negazionista e in
rotta col Vaticano. «Un piano globale chiamato il Grande Reset è in corso. Il
suo architetto è una elitè globale che vuole sottomettere l’umanità intera,
imponendo misure coercitive con le quali limitare drasticamente le libertà
individuali e quelle dell’intera popolazione», scrive in un messaggio alla Casa
Bianca. E il lockdown? Un’arma di distruzione. «Questa lettera la giri anche al
suo capo», gli rispondono nei commenti. A proposito: «Che ne pensate di questo
Bergoglio?», chiede Annabella agli iscritti di Amici di Trump. «Che se morisse
ORA sarebbe meglio». L'ultimo protettore della cristianità, qui, è il Tycoon.
Della cristianità, e degli «uomini liberi». Parola di Forza Nuova, che alla
vigilia delle elezioni sul proprio blog aveva previsto come «l’inumanità
livellatrice del progetto mondialista si infrangerà miseramente dinanzi
all’opposizione ferma e coraggiosa dei figli della Luca». Cospirazioni, ancora,
che ora il partito di Roberto Fiore rimarca esultando per l'ingresso al Senato
della candidata repubblicana Marjorie Taylor Greene, riconoscendole il merito di
essere «convinta della teoria di QAnon», l'ultima frontiera del complottismo
americano. Appunto: dopo complottisti, negazionisti e ultra-cattolici, con
l’estrema destra il cast dei tifosi italiani di Trump non ha nulla in meno di
quello statunitense. E aspetta, chissà ancora per quanto, la venuta del proprio
leader.
Piazzapulita, Federico Rampini zittisce Corrado Formigli: "In
tanti contro il razzismo scesi in piazza senza mascherina, ma nessuno ha detto
niente". Libero Quotidiano il 06 novembre 2020.
Federico Rampini riesce a zittire Corrado Formigli. Questo il pensiero che
prevale su Twitter dove in tantissimi hanno condiviso l'uscita del
corrispondente estero di Repubblica a Piazzapulita nella puntata di giovedì 5
ottobre. "Quando qui a giugno le piazze erano piene di giovani che
manifestavano contro il razzismo, erano tutti incollati senza mascherina e
nessuno ha detto niente", ha tuonato su La7 il giornalista. Tantissimi i
commenti a sostegno: "Federico Rampini - scrive un utente - dice voi criticate i
comizi di Trump che sono tutti senza mascherina e quando c'erano le
manifestazioni per l'afroamericano Floyd ucciso dalla polizia che erano tutti
senza mascherina invece vi andava bene? Formigli zitto non riesce a rispondere".
E ancora: "Mi sono perso uno dei migliori interventi del 2020. Il giornalista
Rampini ( di sinistra ) smaschera la grande ipocrisia della sinistra nelle tv
italiane e americane. Consegnato alla storia". Democratici colpiti e affondati.
DAGONEWS il 5 novembre 2020. Una manifestante anti-Trump è stata
arrestata a New Yorkd opo aver sputato in faccia a un poliziotto durante una
manifestazione in attesa dell’esito del voto. Devina Singh, 24 anni, è tra le 57
persone arrestate a New York mercoledì notte dopo essere stata filmata nel
quartiere del West Village di Manhattan mentre urlava a un agente “Fuck you
fascist” prima di sputargli in faccia. Il filmato, diventato virale su Twitter,
è stato immediatamente condannato dal NYPD e dai sindacati di polizia, che hanno
fatto sapere che azioni come questa non saranno tollerate: «Coloro che
commettono questi atti verranno arrestati» ha twittato il NYPD. Il sindacato
degli investigatori del NYPD, la Detectives Endowment Association, ha aggiunto:
«Questo comportamento spregevole non sarà tollerato! Questo dopo aver appiccato
incendi e aver distrutto proprietà. Sappiamo che i newyorkesi rispettosi della
legge non vogliono che i loro poliziotti vengano trattati in questo modo». Dopo
aver sputato al poliziotto, Singh è stata messa a terra e arrestata. Singh, che
secondo la polizia è di Schwenksville, in Pennsylvania, è stata accusata di
oltraggio a pubblico ufficiale e molestie.
"Fottuto fascista". Insulti choc e sputi in faccia al
poliziotto. Devina Singh è stata filmata nel quartiere
del West Village di Manhattan mentre aggrediva un agente. Arrestata con l'accusa
di oltraggio a pubblico ufficiale e molestie. Ignazio Riccio, Venerdì 06/11/2020
su Il Giornale. L’esito sul filo di lana delle elezioni presidenziali negli
Stati Uniti, con il prevedibile colpo di coda polemico dei protagonisti della
campagna elettorale, ha reso incandescente il clima politico negli Usa. Donald
Trump si dice pronto a ricorrere alla Corte Suprema per fare chiarezza sul voto
degli americani, sentendosi derubato del risultato finale, e per le strade
cominciano a manifestare i sostenitori sia del presidente uscente sia di Joe
Biden. Nella notte di mercoledì si è tenuta a New York un’iniziativa contro
Trump, durante la quale sono state arrestate ben 57 persone. In manette è finita
anche una manifestante di 24 anni, che ha sputato in faccia a un poliziotto.
Devina Singh è stata filmata nel quartiere del West Village di Manhattan mentre
urlava a un agente “Fuck you fascist”, prima di sputargli in faccia. Il video è
diventato ben presto virale su Twitter ed è stato immediatamente condannato dai
sindacati di polizia. La ragazza è stata arrestata con l'accusa di oltraggio a
pubblico ufficiale e molestie, e poi rilasciata dal tribunale. La donna si è
giustificata dicendo di essere stata provocata dai poliziotti, che avrebbero
attaccato senza motivo i manifestanti. Il video a disposizione degli inquirenti,
però, sembrerebbe smentire la 24enne. Dalle immagini si vede il poliziotto che
rimane fermo fino a quando la giovane non lo assale con forza. Il New York City
Police Department ha pubblicato sulla propria
pagina Twitter il video dell’aggressione scrivendo: “Azioni come questa non
saranno tollerate. Gli agitatori che commettono questi atti verranno arrestati”.
La Detectives Endowment Association, il sindacato degli investigatori, ha
aggiunto: “Questo comportamento spregevole non sarà tollerato. Questo dopo aver
appiccato incendi e aver distrutto proprietà. Sappiamo che i newyorkesi
rispettosi della legge non vogliono che i loro poliziotti vengano trattati in
questo modo”.
Da repubblica.it il 5 novembre 2020. "Gli Stati Uniti non sono
New York, San Francisco o le infinite praterie". Ma "un mondo di immensa e
sterminata ignoranza", "dove il marito di Kim Kardashan Kanye West che appoggia
Trump crea un vero dibattito nella nazione, mentre gli intellettuali non contano
più niente". Così Roberto Saviano durante la diretta di RepTv condotta da Laura
Pertici 'La scelta dell'America' davanti ai primi risultati delle elezioni Usa
che non registrano la prevista valanga blu per Biden, ma una grande tenuta dei
trumpiani. "C'è una frase che gira - ricorda Saviano -: “Gli Stati Uniti sono il
Paese del terzo mondo più ricco e potete del pianeta”. Pensavo fosse un gioco
radical, ma è così".
Paolo Mastrolilli per “la Stampa” il 5 novembre 2020.
«Odio fare paragoni storici, ma Hitler aveva lo stesso tipo di
potere sui tedeschi. Le masse lo seguivano comunque, credevano in lui, e la
gente in America crede a Trump come un culto religioso».
Paul Auster non fa questo ragionamento per stupire, ma per
mettere in guardia: «Anche se alla fine Biden vincesse, cosa che mi renderebbe
estremamente felice, è straordinario il fatto che la metà degli americani
rifiuti di vedere la realtà su Trump. Dopo questa elezione gli Usa resteranno
divisi come prima, e governare un Paese dove la metà dei cittadini vuole essere
cieca è molto difficile. Anzi, molto pericoloso».
Ma Biden sembra avanti.
«C' è troppa incertezza, però. Se il Senato resta repubblicano,
sarà molto difficile approvare qualunque legge. Io speravo che ci sarebbe stata
una valanga per Biden, rigettando Trump. Non è successo e il Paese resta diviso
come sempre. A metà degli americani piace Trump, nonostante le sue politiche
orribili e i profondi fallimenti, a partire dal Covid. In qualche modo ha vinto
la sfida retorica con mezza popolazione, convincendola che ha fatto cose buone.
Ciò è straordinario. Le prove sono chiare, ma metà degli Usa si rifiuta di
vederle. Governare un Paese dove la popolazione è cieca è pericoloso».
Perché metà degli elettori è rimasta con Trump?
«Ci vorrebbero quattro giorni per spiegarlo, ma è una questione
psicologica profonda che trascende la politica e riguarda la considerazione per
sé stessi. I seguaci di Trump sono arrabbiati e risentiti, e lui è arrabbiato e
risentito. Perciò rispondono al tono emotivo che usa, perché li fa sentire bene
con sé stessi, e quindi lo sostengono qualunque cosa faccia. Hitler era così.
Trump è come un culto religioso, un santo infallibile, e qualunque cosa faccia
va bene ai suoi seguaci. Sono credenti, ma il credo non ha nulla a che vedere
con la ragione: è una reazione emotiva».
Questo è un pericolo per il futuro dell' America?
«Sì. Ci troviamo davanti a così tanti problemi che richiedono
attenzione immediata, e se non li gestiremo il Paese continuerà a disintegrarsi.
Si sta già disintegrando fisicamente. Le infrastrutture, i ponti, le strade, le
cose non funzionano più. Abbiamo un' enorme disuguaglianza economica tra ricchi
e poveri, che si allarga. L' economia e il sistema fiscale vanno riformati, la
giustizia razziale riaffermata, e sul clima bisogna agire in maniera aggressiva
per cambiare come viviamo. Questi problemi vanno affrontati, ma volontà degli
americani non sembra andare in questa direzione».
Biden ha promesso di unire il Paese: se vincesse non potrebbe
avviare un processo per rimarginare queste ferite?
«Sì, solo con lui alla Casa Bianca sarà possibile. Però senza la
maggioranza al Senato e alla Camera sarà molto difficile far passare le leggi
necessarie. Poi bisogna vedere cosa succede nei parlamenti dei singoli Stati,
perché avranno il potere di ridisegnare i distretti elettorali e determinare il
risultato delle elezioni per i prossimi dieci anni».
Biden ha vinto il voto popolare nazionale, in Stati come Arizona
e Georgia sono in corso cambiamenti demografici, in Wisconsin e Michigan ha
recuperato tra i bianchi.
«Sono segnali incoraggianti, ma il voto popolare non conta nulla.
Il collegio elettorale che decide il Presidente è antiquato, inefficiente e non
democratico, ma è ciò che abbiamo e non cambierà, perché servirebbe un
emendamento costituzionale. Biden è avanti in Wisconsin di 20 mila voti, e ciò è
incoraggiante, ma è lo stesso margine del 2016 a favore di Trump, e potrebbe
ricambiare fra quattro anni. Le grandi tendenze indicano che forse nel lungo
termine il Paese diventerà più progressista, ma questo processo sta prendendo
molto tempo, più di quanto avrei sperato, e intanto l' orologio dei gravi
problemi che abbiamo ticchetta».
Cosa farà adesso?
«Oggi partecipo ad un evento del gruppo Writers Against Trump con
Salman Rushdie. La mobilitazione deve continuare».
Maurizio Caverzan per ''La Verità'' il 7 novembre 2020.
Buongiorno Federico Rampini, innanzitutto come sta, visto che ha
contratto il coronavirus?
«Sono ufficialmente guarito nell' Election Day, martedì 3
novembre ho avuto il primo tampone negativo dopo tre settimane. Avevo avuto
sintomi lievi, e mi sentivo già guarito».
Una volta scoperto il contagio, avrebbe preferito farsi curare in
Italia o la sanità americana si è comportata bene?
«Non posso fare paragoni perché non uso la sanità italiana da
vent' anni. Su quella americana ho collezionato impressioni negative, è costosa
e talvolta anche inefficiente. Da qui a descriverla come un inferno - uno
stereotipo tra gli italiani - ce ne corre. Non si spiegherebbe perché tanti
nostri connazionali vengono a curarsi qui in ospedali di eccellenza dove
lavorano anche bravissimi dottori italiani, cervelli in fuga. In particolare la
lezione del coronavirus è stata appresa, la reazione sia federale sia dello
Stato di New York ha dato miglioramenti evidenti. I tamponi sono facili da fare,
con poche attese, risultati veloci, gratuiti per tutti».
Federico Rampini vive negli Stati Uniti da vent' anni. Ha da poco
pubblicato Oriente e Occidente. Massa e individuo (Einaudi). I suoi interventi a
Stasera Italia su Rete 4 e soprattutto le sue corrispondenze per Repubblica sono
state un osservatorio privilegiato per seguire le elezioni americane.
La probabile vittoria di Joe Biden possiamo definirla vittoria
zoppa o vittoria di Pirro?
«Vittoria zoppa. Non c' è stata l' Onda blu che molti democratici
si aspettavano. La presidente della Camera, la leader democratica Nancy Pelosi,
era convinta di guadagnare seggi, invece pur conservando la maggioranza ha perso
dei parlamentari. Molti parlavano addirittura di una conquista democratica del
Texas: una favola. Ma soprattutto i democratici hanno fallito il sorpasso al
Senato. Biden dovrà negoziare tutto con i senatori repubblicani, dalle manovre
economiche alle nomine. Forse gli fa piacere perché gli consente di
"sterilizzare" l' ala sinistra di Bernie Sanders ed Elizabeth Warren. Però l'
equilibrio politico che esce da questo voto, se tradotto nei criteri europei,
assomiglia quasi a un governo di coalizione rossoblu».
La battaglia di Trump arriverà fino alla Corte Suprema a
maggioranza repubblicana?
«È la sua speranza, soprattutto in Pennsylvania. Qui però c' è un
paradosso. Grazie alle nomine da lui effettuate la Corte ha una soverchiante
maggioranza repubblicana: sei contro tre. Però la cultura giuridica della destra
in America è molto legata al federalismo, rispetta fino all' estremo l'
autonomia e le prerogative dei singoli Stati. Le leggi elettorali sono di
competenza locale, non esiste una regola federale su come si contano le schede o
sul voto per posta. I giudici di destra dovrebbero fare violenza ai propri
principi, andando a immischiarsi nel conteggio dei voti».
Come le proteste delle «due Americhe» di questi giorni potranno
trovare una conciliazione?
«Non sono ottimista. Da un lato abbiamo avuto un meraviglioso
spettacolo di partecipazione di massa: hanno votato 160 milioni, il 67% degli
aventi diritto, un massimo storico da oltre cent' anni. D' altro lato questa
grande mobilitazione non è all' insegna della rappacificazione. L' affluenza è
salita sia tra i democratici sia tra i repubblicani perché ciascuna delle due
Americhe è convinta di doversi difendere dalle prevaricazioni dell' altra.
Questo rifiuto di dialogare, lo vedo crescere dal giorno in cui mi trasferii a
vivere in questo Paese, ormai più di vent' anni fa. Abitavo in California quando
ci fu l'elezione contestata in Florida nel 2000, Bush-Gore. L' ostilità tra le
due Americhe era aspra già allora, non è legata al personaggio Trump. Lui ne è
un risultato».
Come giudica la decisione delle reti televisive di tagliare in
diretta la denuncia di Trump di brogli e la censura cui l' ha sottoposto
Twitter?
«Sono decisioni senza precedenti, nel paese del Primo emendamento
dove perfino l' apologia del nazismo è consentita. Però è senza precedenti anche
un presidente che dichiara corrotto e illegittimo il sistema elettorale del suo
Paese. Se Trump si ostina a descrivere gli Stati Uniti come il Venezuela,
scatena reazioni di autodifesa che sono estreme ma comprensibili».
Che lezione si può trarre dal fatto che anche stavolta
sondaggisti e media hanno clamorosamente sbagliato le previsioni?
«Non hanno imparato nulla dalla débâcle del 2016. Fino alla
vigilia del voto assegnavano la Florida a Biden, per esempio. Tutti i numeri
erano sbilanciati in favore di Biden, mai nell' altra direzione. Una vergogna.
Il disastro del 2016 poteva essere spiegato dall' anomalia del fenomeno Trump.
Perseverare quattro anni dopo nella sottovalutazione del suo consenso è
imperdonabile».
Scambiano i loro desideri per fatti?
«Questa tornata elettorale ha smentito una rappresentazione dell'
America che da quattro anni prevale sui media progressisti: Cnn, New York Times,
Washington Post. Hanno raccontato una vasta reazione di rigetto verso Trump, che
non c' è stata. Hanno annunciato svolte epocali a ripetizione, ciascuna delle
quali doveva affondare questo presidente: lo scandalo del Russiagate, l'
impeachment, il coronavirus, la recessione, le proteste contro il razzismo dopo
l' uccisione di George Floyd. La geografia elettorale invece è stabile. Grosso
modo i rapporti di forze dei due schieramenti sono rimasti al 2016, come se
nulla fosse accaduto. Trump è sempre rimasto un presidente di minoranza, i suoi
consensi oscillano attorno al 45% a livello nazionale, ma quel consenso è
intatto. Gli spostamenti, dove ci sono stati, sono modesti. Il più significativo
per assegnare la Casa Bianca a Biden, è la parziale riconquista di voti operai
nell'Upper Midwest: Wisconsin e Michigan. È la "missione compiuta" del vecchio
Joe, il salvatore dopo la sconfitta di Hillary Clinton. Però la maggioranza
degli operai ha continuato a votare Trump».
Perdono di vista l' America profonda?
«La maggior parte degli intellettuali progressisti e dei
giornalisti di sinistra non prova neppure a capire l' America profonda.
Preferisce giudicarla, usando categorie morali: razzista, ignorante, fascista,
bigotta. Ha perso ogni curiosità. Sia chiaro, anche dall' altra parte dominano
stereotipi e pregiudizi. Fox News ha dei commentatori che descrivono New York e
la California come Sodoma e Gomorra. Purtroppo questo fa bene al conto economico
di tv e giornali, per cui nessuno ha interesse a cambiare atteggiamento».
Perché l' onda del Black Lives Matter non ha fatto crescere l'
Onda blu di Biden?
«Trump è andato un po' meglio del previsto anche tra gli
afroamericani, a dispetto di tutta la retorica sulla "rivoluzione antirazzista"
di Black Lives Matter. Certi afroamericani considerano positivo il bilancio
economico dei primi tre anni di Trump, e non gli addebitano il disastro della
recessione post-pandemia, anzi pensano che le sue ricette siano più adatte a
tirare fuori l' economia da questa crisi. Le proteste antirazzismo in certe zone
hanno danneggiato la sinistra. Se sei afroamericano e commerciante, o piccolo
imprenditore, o proprietario di ristorante, e hai visto gli spacciatori e i capi
gang del tuo quartiere mettersi le magliette di Black Lives Matter, impugnare le
mazze da baseball, spaccare le vetrine per svuotare i negozi, giustamente voti
per chi sta dalla parte della polizia. Lo slogan "togliamo fondi alla polizia",
pur sconfessato da Biden, è stato gridato nelle piazze per mesi, ha l' appoggio
della sinistra radicale, ed è realtà nelle due maggiori metropoli americane
grazie ai loro sindaci democratici: Bill de Blasio a New York, Eric Garcetti a
Los Angeles».
Quanto ha pagato Trump la gestione superficiale e altalenante
della pandemia?
«Di sicuro chi ha votato per Biden mette in testa alle priorità
una risposta più efficace alla pandemia».
C' è la possibilità che dopo pochi mesi Biden si dimetta per far
subentrare la sua vice Kamala Harris?
«Non ci credo. Questo rientra nei sogni di quella sinistra ultra
politically correct che non accetta un presidente bianco, maschio, anglosassone
e pure anziano. Fin dalla sua scelta di Kamala l' hanno voluta descrivere come
la vera presidente. Biden non si farà da parte, finché la salute lo assiste.
Quel che è molto probabile, è che non intenda ricandidarsi per un secondo
mandato. Kamala aspetti il 2024».
L' identità progressista non sfonda perché è una «coalizione
delle minoranze»?
«Trump ha avuto successo tra gli ispanici in Florida. L' idea che
gli ex immigrati siano naturalmente di sinistra è un' illusione del partito
democratico. Gli ex immigrati venuti da Cuba ma anche dal Messico o da
Portorico, se hanno avuto qualche successo economico diffidano di una sinistra
che istintivamente cura ogni problema a colpi di tasse e spesa pubblica. Se
hanno ottenuto la cittadinanza americana nel rispetto delle leggi, diffidano di
una sinistra radicale che vuole aprire le frontiere anche a chi entra violando
le leggi».
Paul Auster che ha detto che per i suoi elettori «Trump è un
culto religioso, lo seguono come i tedeschi seguivano Hitler».
«Ci sono dei filonazisti tra i seguaci di Trump. L' atteggiamento
da culto religioso esiste, ma c' è il fenomeno speculare a sinistra. Certi ultrà
di Black Lives Matter, o i pasdaran del politically correct che fanno le purghe
dei moderati nelle redazioni dei giornali, sono eredi dei grandi risvegli
protestanti puritani dell' Ottocento».
Secondo lei, Biden, sensibile ai diritti civili, che politica
adotterà nei confronti della Cina?
«Nessuno sconto alla Cina, ormai anche i democratici la giudicano
un rivale minaccioso, da fermare. Però Biden investirà in una politica delle
alleanze con Europa, Giappone, Corea del Sud».
Come spiega il fatto che in Cina oggi l' epidemia sembra
sconfitta?
«Una scrittrice dissidente cinese ha appena pubblicato in inglese
il suo Diario da Wuhan, la città dove abita. Descrive i metodi autoritari usati
nel lockdown, però dà atto anche di una forte adesione volontaria della
popolazione».
Quanta responsabilità ha il governo cinese nella mancanza di
trasparenza con cui è stata gestita la pandemia?
«Enormi, gravissime, imperdonabili. Però siamo ormai nella
seconda fase, dove il bilancio che conta è un altro: l' economia cinese è già
ripartita, l' Occidente no».
“Trump furioso, USA sull’orlo della guerra civile? No, non ci
sarà”, parla Furio Colombo. Umberto De
Giovannangeli su Il Riformista il 7 Novembre 2020. Se c’è un giornalista e
scrittore che conosce ogni sfaccettatura del “pianeta Usa”, questi è Furio
Colombo. Negli Stati Uniti è stato corrispondente de La Stampa e La Repubblica.
Ha scritto per il New York Times e la New York Review of Books. È stato
presidente della Fiat Usa, professore di giornalismo alla Columbia University,
direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di New York. «Se si contano i voti
legali sto vincendo io facilmente». E ancora: «Non permetteremo ai corrotti di
rubare le elezioni, il nostro obiettivo è di difendere l’integrità delle
elezioni». E poi il minaccioso messaggio, quasi un diktat, rivolto ai nove
giudici della Corte Suprema: «La Corte Suprema cancelli i voti illegittimi».
Così Donald Trump mentre, dopo il sorpasso in Georgia e
Pennsylvania, Joe Biden è ormai vicinissimo al traguardo. Tu che conosci così
bene l’America, che comportamento è quello che sta tenendo Trump?
«Chi conosce l’America non riconosce
l’America in ciò che sta succedendo. Perché quello di Trump è un comportamento
eversivo, immensamente pericoloso negli Stati Uniti e fuori. Per fortuna quel
Paese è dotato di un giornalismo coraggioso, perché le televisioni hanno
interrotto il collegamento a metà di quelle dichiarazioni, chiarendo subito al
pubblico che colui che parlava stava dicendo cose non vere e loro non
trasmettono menzogne. E questo è accaduto per tutte le televisioni che erano
collegate con la sala della stampa della Casa Bianca. Quei mezzi di
comunicazione che avrebbero dovuto trasmettere ciò che lui voleva dire
solennemente e gravemente nel mezzo della notte, buttando all’aria l’intero
processo che ormai è giunto alla fine, hanno risposto: Trump non può dire bugie
con i nostri strumenti. Una grande e importante assunzione di responsabilità di
chi ha il compito di fare da collegamento tra ciò che accade e ciò che i
cittadini sanno. Detto questo, stiamo attraversando un momento estremamente
pericoloso e difficile. Fortunatamente Joe Biden, che non è un eroe ma è un uomo
normale, impedisce qualunque manifestazione, anche se è vicinissimo ad ottenere
la nomina, e fa in modo che non vi sia alcuna reazione, neppure se proporzionata
e neppure se giustificata, da parte dei suoi elettori».
Resta un’America divisa, lacerata, incattivita. Nonostante
bugie, corruzione, improvvisazione, incapacità di governo, pessima gestione
della crisi pandemica, per finire con le minacciose frasi di cui abbiamo
parlato, il 47% dell’elettorato americano ha continuato a votare Donald Trump.
«È una situazione allarmante perché
ci dice che praticamente un americano su due è in favore di un presidente che ha
squassato, quasi distrutto non solo il sistema democratico ma anche il sistema
informativo americano. Siamo di fronte – noi, loro, la parte democratica del
mondo – a un momento veramente difficile: basti pensare che Trump, fondatore e
indirettamente proprietario della Fox television, attraverso Murdoch, si è visto
negare anche dalla Fox, che è dichiaratamente una televisione di destra, la
disponibilità a sostenere la sua denuncia di illegalità. Non tanto il
personaggio Donald Trump quanto il presidente degli Stati Uniti che pronuncia
frasi eversive, non può che essere una infezione, una parola che purtroppo ci è
diventata abituale, per altri Paesi democratici».
Cercando di proiettarci in un futuro che non sia così
lacerante. Per Obama lo slogan vincente, che lo portò per la prima volta alla
Casa Bianca, fu “Yes, we can”. Per Trump “America first”. Joe Biden e gli
strateghi della sua campagna elettorale hanno coniato lo slogan delle tre “B”:
Build Back Better”. Come dovrebbe tradursi con Biden alla Casa Bianca?
«Credo, come succede sempre con gli
slogan elettorali, si adatterà e si evolverà, un po’ come accade con le cose in
natura, alla nuova situazione, la quale avrà un bisogno enorme di concordia, di
visione coerente, di verità e di comunicazione ben diverse da quelle cui il
Paese è stato sottoposto finora. Sospenderei, in questo istante, la traduzione
politica di questo slogan, perché nel momento cui Biden diventerà presidente
avremo una prospettiva e una rappresentazione radicalmente diverse dal passato.
E la prima cosa che farà effetto sarà la grande diversità della riscoperta
dell’America, di un’America normale, onesta, seria, coerente e in grado di stare
all’altezza del suo potere».
Molto dipenderà anche dall’atteggiamento dei repubblicani che.
secondo i dati, manterranno la maggioranza al Senato. A tuo avviso, seguiranno
Trump su questa via dello scontro frontale ora che Biden ha traguardato la
fatidica soglia dei 270 grandi elettori?
«Rispondere in questo momento è
azzardato, perché ci sono alcune incognite che non siamo in grado di valutare
mentre parliamo. Per esempio, bisogna domandarsi prima se Trump insisterà e
manterrà questa posizione di rivoltoso. Perché questo tipo di rivolta non può
mantenersi a lungo come una rivolta di parole e di avvocati. E quindi è di un
pericolo grandissimo. Per natura è il tipo di pericolo che gli americani – non i
repubblicani o i democratici – dai tempi della guerra civile non amano. Quindi è
difficile dire se, quali e quanti repubblicani potrebbero decidere di seguire
Trump sulla strada della follia. Non resta che osservare il quadro, nutrendoci
della speranza che l’America è sempre stata un Paese profondamente democratico e
lo resterò anche adesso. Una speranza che trae conforto anche dal fatto che
tutte le istituzioni giuridiche sono al momento contrarie, e rigettano Stato per
Stato i ricorsi locali e a Trump rimane solo la Corte Suprema, che però ha già
fatto sapere che non intende diventare il giudice politico. E lì non si tratta
più di destra e sinistra, si tratta della percezione della credibilità del più
alto organo giudiziario americano».
Hai parlato del ruolo dei media, del potere giudiziario. Ma
quando si evoca uno scenario da guerra civile, è inevitabile non chiedere anche
dei militari.
«Dai grandi giornali e dalle
maggiori rete televisive americane sappiamo soprattutto degli orientamenti dei
comandanti supremi. Sappiamo che sono assolutamente contrari ad ogni intervento
anche solo per mettere ordine nelle strade. Dopo alcuni cedimenti iniziali,
proprio in avvio della campagna elettorale, tipo usare soldati a cavalli per
respingere la folla attorno alla Casa Bianca, hanno fatto sapere che non
sarebbero intervenuti nelle città dove si era manifestato nelle strade il
movimento Black lives matter. Quindi si sa che hanno detto in modo quasi brutale
che non intendono partecipare a questa parte politica della vita americana. C’è
stata una dichiarazione, una volta sola, dei tre generali numero uno ed anche
del Chairman of the Joint Chiefs of Staff, il capo dello stato maggiore
congiunto delle forze armate statunitensi, che è per legge l’ufficiale di rango
più elevato dell’Esercito USA. Trump non ha risposto e loro hanno lasciato in
sospeso la questione, ma dicendo che non intendevano usare soldati americani in
eventuali disordini o problemi di immigrazioni o cose del genere. Per esempio,
hanno ritirato i soldati dalla frontiera con il Guatemala. Sappiamo che non è un
putsch militare, in nessun modo».
Siamo tutti
dio, Donald e famiglia: ecco gli evangelici che votano (quasi tutti) Trump.
Quattro anni fa lo hanno scelto in massa. Ma oggi, dopo la
pandemia, c’è chi si è pentito. Davide Mamone su L'Espresso il 29 ottobre 2020.
Nel villaggio di New Freedom, 5mila anime a sud della cittadina di Lancaster in
Pennsylvania, il reverendo protestante Mitchell Hescox capì fin da subito che la
crisi del coronavirus si sarebbe ritagliata un ruolo drammatico. Quando ha visto
un numero crescente di fedeli continuare a fingere che il problema non ci fosse,
ha deciso di intervenire. «Tra i protestanti c’è stato a lungo il sentore che
fosse un’invenzione dei media, invece la pandemia è reale eccome», dice
all’Espresso Hescox, che a New Freedom ci vive e ricopre il ruolo di presidente
dell’Evangelical Environmental Network negli Stati Uniti.
Presidenziali Usa, perché spero che vinca Donald Trump.
Paolo
Guzzanti su Il Riformista il 3 Novembre 2020. Prima scoperta: la vittoria
di Biden su Trump, come dire del bene sul male, non è affatto scontata e il
primo ad ammetterlo è Joe Biden, il più vecchio candidato alla Casa Bianca della
storia, che non ha un suo vero sex appeal perché il suo valore aggiunto è semmai
la sua vice: Kamala Harris che si spaccia, senza esserlo, afroamericana. Biden
dalla sua ha un unico merito davanti agli elettori che odiano Trump: di non
essere Trump e di essere l’unica alternativa alla sua occupazione della Casa
Bianca per altri quattro anni. Dalla banda degli amici dei miei figli
adolescenti in Florida so che la Harris è detestata dai giovani perché, come
giudice, ha massacrato proprio i ragazzi afroamericani spediti in galera per una
canna. Ma è adorata da tutti i liberal del mondo i quali, essendo
inconsapevolmente razzisti (misurano le loro simpatie regolandosi sul colore
della pelle) si entusiasmano proprio e soltanto sul colore che ha la sua origine
genetica, da un padre ex funzionario indiano nell’impero britannico e da una
madre giamaicana: parenti discendenti degli schiavi, zero. Vale la pena
ricordare che nemmeno Barack Obama discende dagli schiavi americani, ma da un
padre ex funzionario dell’impero britannico in Kenya dove risiede un fratello di
Barack, Tony, che gli dà più o meno dell’impostore. Dunque, Kamala, non avrebbe
i titoli per presentarsi con il tema identitario razziale. Invece, Kamala nei
dibattiti dichiara per prima cosa di essere non una pericolosa donna di sinistra
ma la madre di colore di un bambino nero. Di lei dà anche molto fastidio la
serie di espressioni sprezzanti, sarcastiche e taglienti che di solito non
piacciono agli americani e che infatti costituiscono uno dei punti deboli della
personalità di Trump. La strategia è evidente: se Biden va alla Casa Bianca è
probabile che muoia e che lei diventi automaticamente presidente, la prima donna
per di più di colore, magari per un secondo quadriennio e oltre, blindata dal
potente clan degli Obama e dei Clinton che la sostengono. Ma purtroppo, non
sembra avere neppure metà dello charme di Michelle, sua fervida sostenitrice.
Proprio in queste settimane è uscito su Netflix un bel documentario – Becoming –
sull’ex First Lady la quale ricorda con tristezza che nel 2016, al momento del
voto “our people didn’t show up”, la nostra gente non si fece vedere ai seggi
determinando allora l’inimmaginabile vittoria dei Donald Trump il quale oggi,
secondo i sondaggi avrebbe conquistato il dieci per cento del voto femminile
nero, che è considerato un risultato che quattro anni fa sarebbe stato
impensabile. Se l’elettorato afroamericano legato ai democratici dovesse
astenersi di nuovo nelle prossime ore, questo potrebbe essere un grande problema
per i democratici, dal momento che nel frattempo è cresciuto un secondo
elettorato nero che vota per Trump e che non ha gradito le insurrezioni e gli
incendi perpetrati in nome del “Black lives matter”. Quali sono dunque i motivi
che oggi consigliano di non vendere la pelle dell’orso Trump prima di averlo
ucciso? Proviamo ad elencarli: prima del Covid l’economia americana andava a
gonfie vele e non si arricchivano soltanto i ricchi ma la classe media, gli
agricoltori e il ceto medio-basso fatto di neri, latinos e immigrati di seconda
generazione. Ciò è avvenuto certamente a causa di un drastico taglio delle tasse
che ha spinto gli imprenditori a reinvestire nelle loro aziende, assumendo.
Questa è la ragione per cui, fino al Covid, Trump poteva anche essere
considerato l’uomo più odioso e odiato del mondo, ma portava ricchezza non solo
ai ricchi, ma anche ai poveri. Se guardiamo, o ascoltiamo il programma del suo
avversario Joe Biden, su questo punto, l’economia, non troviamo granché: Biden,
che cerca disperatamente di non apparire troppo di sinistra, propone banalmente
di far crescere le tasse soltanto per i super miliardari e di far crescere la
sanità pubblica seguendo l’accidentato percorso inaugurato da Obama e mai
arrivato in porto perché, piaccia o no a noi europei, gli americani hanno
mostrato di non gradire una sanità pubblica uguale per tutti in cui lo Stato o
il comune ti assegna il medico, perché neanche i poveri ne vogliono sapere:
contrariamente a quel che si dice in Europa, gli americani più poveri, come i
più ricchi, sono coperti dalle assicurazioni mentre chi soffre è il ceto medio
che perde l’assicurazione insieme al posto di lavoro, in caso di crisi. E poi si
arriva al Covid. Chi ha voglia può divertirsi a leggere l’ultimo libro di Bob
Woodward (uno dei giornalisti più famosi del mondo che con il suo collega Carl
Bernstein fece cadere il presidente Nixon per lo scandalo Watergate) intitolato
Rage, rabbia, in cui è documentata la schizofrenia con cui Trump ha affrontato
il Covid. Woodward ha registrato – con il consenso di Trump – tutte le
telefonate che il presidente gli faceva all’inizio dell’epidemia in questo 2020,
e in cui Trump gli confidava di considerare il Covid un mostro, una malattia
letale che non ha niente a che fare con un’influenza e che avrebbe fatto milioni
di vittime nel mondo. Poi però il presidente si presentava in pubblico e diceva
il contrario di ciò che aveva detto confidenzialmente a Bob. E cioè che il Covid
è poco più d’un raffreddore. Bob Woodrow allora lo richiamava e gli chiedeva
ragione di queste evidenti bugie Trump gli rispondeva: «Vedi Bob, non voglio
mandare in panico gli americani altrimenti il panico manderà a picco il Paese».
Ma quando è uscito Rage con la trascrizione di tutte le conversazioni udibili
anche su Internet, Trump ha risposto che sono tutte bugie e che Bob si era
inventato tutto, con una sfacciataggine che oltre ad essere il suo limite, fa
anche parte integrante del suo sex appeal politico. Ieri ha detto ai suoi
elettori che non devono accettare alcun lockdown e non perdere soldi con
chiusure assurde perché grazie al suo dinamismo sta per uscire il vaccino che
salverà il mondo intero, frutto della sua magica determinazione. La gente vede
le bugie e i trucchi di scena, ma lo ama anche per questo. Gli elettori di Trump
sono pazzi di lui proprio perché ha una personalità debordante, perché si
contraddice, perché ripete senza sosta che tutto è magnifico, “terrific”. Uno
dei più stimati studiosi di comportamento elettorale Jim Rickards, che
nella Casa Bianca ha lavorato per più di trent’anni, è sicuro della sua
vittoria: «Io dico che Trump non solo vince, ma stravince perché si sta
verificando un fenomeno ben noto. Nessuno dice di votare per lui e anche fra gli
iscritti per i democratici ci sono decine di migliaia di voti per Trump. Sono un
numero enorme». Rickards dice che tutto il ceto medio americano ha imparato a
non dichiarare mai apertamente di votare repubblicano per non incorrere nelle
rappresaglie e nel bullismo a scuola, sui posti di lavoro e nella vita sociale
davanti al barbecue. Ed è proprio Rickards a sostenere che il presidente ha
conquistato il dieci per cento del voto femminile nero. Quando qualcuno mi
chiede se voterei io stesso per Trump, onestamente rispondo che come europeo e
italiano mi sentirei più protetto da un’America interventista e schierata
in Europa, nel Medio Oriente e sui Balcani, in grado di farci da mamma a spese
del mitico tax payer, il contribuente americano. Dunque, forse avrei preferito
Obama ieri e Biden oggi perché paradossalmente i democratici sono fautori della
guerra fredda e del pugno di ferro in Europa, specialmente nei confronti dei
russi. Ma da americano, non avrei dubbi come non ne hanno tutte le persone sane
di mente, educate e colte che vivono in America e che fanno parte della mia
famiglia e cerchia di amicizie. Votano Trump perché ha riportato a casa gli
interessi americani impoveriti dalla delocalizzazione, specialmente in Cina. E,
a proposito della Cina, in Italia e in genere in Europa pochi si rendono conto
che in questo momento le flotte giapponese, vietnamita, australiana e americana
stanno fronteggiando una flotta cinese di proporzioni mai conosciute con
cui Pechino intende impossessarsi del braccio di mare in cui transita il
commercio mondiale, in attesa di mangiarsi l’isola di Taiwan in un solo boccone,
cosa che oggi potrebbe portare alla guerra totale. Trump ha ripristinato in
quattro anni la forza militare e tecnologica americana che era stata largamente
abbandonata dall’amministrazione democratica, e lo ha fatto con investimenti che
hanno prodotto un fall-out industriale enorme. Un altro impulso industriale e
scientifico voluto da Trump è quello della corsa nello spazio, in cui la Cina è
per ora in testa con una serie di satelliti militari nascosti dalla parte
coperta della Luna, per arrivare su Marte entro venti anni, con un
coinvolgimento già attivo delle industrie tecnologiche di tutto il mondo,
americani in testa. I blue collar, le tute blu delle aziende metalmeccaniche e
dell’automobile sono schierate con Trump che ha sbarrato la strada alla
preponderanza e alla prepotenza tedesca che si fonda sull’enorme risparmio sulla
spesa militare. In questo momento una brigata corazzata della Nato è schierata
in Polonia per le annuali esercitazioni che servono per contenere le esuberanze
russe in Ucraina e la Germania non è in grado di provvedere allo schieramento di
poco meno di tremila uomini perché non ci sono. E perché i loro carri armati
mancano di carburante e i militari tedeschi sembrano spesso degli hippy
pacifisti. Così la Germania produce e consuma ricchezza, ma lo fa grazie al
fatto che l’Europa è ancora protetta da un sistema di difesa pagato dagli Stati
Uniti e non ne vuole sapere di spendere neppure il due per cento del
suo Pil come scritto sulle carte dell’alleanza atlantica. L’America di Trump
sente il peso dell’Europa e punta a recuperare come un suo Stato esterno
il Regno Unito insieme agli altri componenti dei “Five Eyes” ovvero la comunità
dei popoli di lingua inglese che includono Canada, Australia e Nuova Zelanda,
oltre il governo indiano che ancora tentenna fra cinesi e russi.
L’Europa insomma, vista da Washington costa troppo, è egoista, ha più abitanti e
ricchezze degli Stati Uniti ma non vuole pagare l’affitto, vuole invece solo
spendere nei servizi sociali, cosa che ingolosisce la Cina, che ha già
provveduto a occupare quasi tutta l’Africa con le sue aziende coloniali. Lo
scenario è molto complicato e visto dall’Italia quasi sconosciuto e certamente
remoto. Ma è su questo scenario che si combatterà fino all’ultimo voto fra poche
ore nella più antica democrazia repubblicana del mondo.
Come funzionano le elezioni americane? Quei 270 "voti" che
servono per la Casa Bianca. Alessio Sgherza su La
Repubblica il 30 ottobre 2020. L'Electoral College, ovvero: come si possono
prendere 3 milioni di voti in più ma perdere la presidenza. Un sistema
elettorale molto maggioritario, in cui i singoli Stati e i loro rapporti di
forza contano tanto quanto, e forse più secondo un certo punto di vista, del
voto degli elettori. Un sistema che è stato creato alla fine del '700, ma che
ancora oggi decide chi sarà l'uomo più potente del mondo: il Presidente degli
Stati Uniti d'America. Il sistema elettorale per scegliere il presidente Usa è
peculiare e per i cultori della materia molto affascinante. Ma anche
controintuitivo per molti aspetti. Proviamo, andando per ordine, a spiegare come
funziona.
Come funzionano le elezioni americane? Con l'Electoral college. I
cittadini dei 50 Stati (a cui si aggiunge il Distretto di Columbia, ovvero la
città di Washington) il primo martedì dopo il primo lunedì di novembre -
quest'anno cade il 3 - votano per il nuovo presidente, oltre che per la Camera
dei Rappresentanti e per un terzo del Senato (i senatori sono eletti per 6 anni,
e ogni biennio si rinnova un terzo dell'assemblea). Il sistema elettorale
assegna a ogni Stato un peso, i "voti elettorali". In tutto i voti elettorali
che i candidati si devono spartire sono 538. Per ottenere la presidenza, un
candidato deve ottenere quindi 270 voti elettorali.
Elezioni americane: come si annuncia il vincitore? Il sistema AP
di Raffaella Menichini. Ogni Stato ha un numero di voti elettorali pari al
numero di deputati dello Stato (che sono in proporzione alla popolazione) più il
numero di senatori (2 per ogni Stato, senza differenze di popolazione). In più,
il District of Columbia elegge tre grandi elettori, tanti quanto lo Stato più
piccolo. L'elezione presidenziale funziona come tante grandi elezioni
uninominali: il candidato presidente più votato in ogni Stato, anche se di un
solo voto, ottiene tutti i voti elettorali di quello Stato. Biden vince
in California? Ottiene tutti i 55 rappresentati della California nell'Electoral
College. Trump vince in Texas? Ottiene tutti i 38 voti elettorali del Texas. E
così via. I voti elettorali si sommano via via che lo spoglio dei singoli Stati
è definito nel corso della lunga notte elettorale: a causa dei fusi, le urne nei
vari Stati chiudono in orari diversi, partendo dall'1 di notte ora italiana e
fino alle nostre 7.
Uno Stato, un vincitore. Con due eccezioni. Sono due le eccezioni
alla regola maggioritaria: Maine e Nebraska. Ogni Stato è infatti libero di
scegliere la propria legge elettorale. Il Nebraska elegge 5 grandi elettori, il
Maine 4. Due grandi elettori vengono assegnati al candidato più votato a livello
statale, mentre gli altri 2 (nel Maine) o 3 (in Nebraska) vengono assegnati al
più votato al livello delle circoscrizioni elettorali che formano lo Stato.
Storicamente, il risultato è quasi sempre che un candidato conquista tutti i
voti elettorali di quello Stato. Eccezioni ci sono state solo nel 2008 (4 voti
del Nebraska a McCain e 1 a Obama) e nel 2016 (3 voti del Maine a Clinton, 1 a
Trump).
Cosa sono i grandi elettori e che ruolo hanno. C'è anche
da aggiungere che da un punto di vista puramente formale il presidente e il
vicepresidente degli Stati Uniti sono in realtà eletti con un sistema indiretto,
ovvero non sono eletti direttamente dal popolo. In realtà con il voto del 3
novembre i 538 voti elettorali non sono altro che 538 rappresentanti (i grandi
elettori) che hanno 'promesso' di sostenere il candidato al quale sono
collegati. I 270 voti elettorali rappresentano quindi 270 grandi elettori o
rappresentanti nell'Electoral college. Saranno questi grandi elettori a metà
dicembre, a formalizzare l'elezione del presidente degli Stati Uniti. Si tratta
di fatto quasi sempre di una formalità: i grandi elettori votano sempre per il
candidato che hanno promesso di sostenere. Ci sono stati dei casi in cui questo
non è successo (ma non in numeri tali da non far eleggere un presidente) ma sono
molto rari.
Francesco Berrò per youtrend.it il 5 novembre 2020. In passato
negli USA diversi grandi elettori non hanno votato il presidente e il
vicepresidente che avrebbero dovuto sostenere. Per vincere la elezioni
presidenziali americane occorre ottenere la maggioranza dei 538 grandi elettori:
l’elezione del presidente e del vicepresidente degli Stati Uniti non è infatti
diretta, ma è mediata dai grandi elettori. Il ruolo di questi ultimi, in linea
teorica, è solo formale, dal momento che la notte delle elezioni di norma è già
possibile capire quale ticket è stato in grado di superare la soglia dei 270
grandi elettori necessaria per l’elezione. I voti dei grandi elettori, però, non
sempre hanno eguagliato i dati emersi nella notte elettorale: è infatti capitato
più volte in passato che alcuni grandi elettori, al momento di eleggere
effettivamente il presidente e il vicepresidente, decidessero di votare non in
conformità con quanto previsto dal loro partito. Questi elettori vengono
definiti faithless electors, cioè “elettori infedeli”, e nelle 58 elezioni
presidenziali della storia americana essi sono stati in tutto 205.
Chi sono i grandi elettori? Il sistema elettorale delle
presidenziali statunitensi è un maggioritario in base al quale il ticket che
prevale nel voto popolare in uno Stato ottiene in blocco tutti i grandi elettori
che esso mette in palio, che equivalgono numericamente alla somma dei
parlamentari eletti in quello stesso Stato (2 senatori più un numero di
rappresentanti proporzionale alla popolazione, da 1 a 53). Le uniche eccezioni a
questo sistema winner-take-all sono Maine e Nebraska, che utilizzano un sistema
elettorale leggermente diverso. Poiché deputati e senatori sono in tutto 535,
verrebbe da pensare che anche i grandi elettori siano lo stesso numero. In
realtà i grandi elettori sono 538: vanno infatti aggiunti 3 grandi elettori per
il Distretto di Columbia, che non ha rappresentanza congressuale ma, per
l’appunto, partecipa all’elezione presidenziale. I grandi elettori insieme
formano l’electoral college: il lunedì dopo il secondo mercoledì di dicembre –
quest’anno cadrà il 14 dicembre – essi votano per eleggere presidente e
vicepresidente degli Stati Uniti, e per essere eletti occorre almeno la metà più
uno dei grandi elettori (270). Nella pratica saranno quindi queste 538 persone a
scegliere i prossimi inquilini di Casa Bianca e Number One Observatory Circle
(residenze ufficiali rispettivamente di presidente e vicepresidente): essendo
comunque i grandi elettori selezionati dai partiti, questo dovrebbe garantire la
loro fedeltà nel voto. Ma così, come vedremo, non è sempre stato.
La storia dei faithless electors. La decisione di adottare il
sistema dei grandi elettori fu presa dai padri fondatori, convinti che
l’elettorato non avesse le necessarie informazioni sui candidati per prendere
delle decisioni informate. Nel Federalist Paper Number 68, Alexander Hamilton
scrisse che il compito dei grandi elettori, dotati di maggior giudizio rispetto
agli elettori comuni, doveva essere quello di evitare che un candidato con
“talents for low intrigue, and the little arts of popularity” potesse diventare
presidente. Per questo motivo nel 2016 due grandi elettori repubblicani che
aspiravano a convincere i loro omologhi a votare un candidato moderato al posto
di Trump presero il nome di Hamilton electors. Come detto all’inizio, nelle 58
elezioni presidenziali svolte finora, 205 grandi elettori non hanno votato il
ticket a cui avrebbero dovuto dare la propria preferenza. Di questi:
49 hanno votato per un candidato presidente diverso da quello che
avrebbero dovuto votare;
117 hanno votato il candidato presidente giusto, ma sono
stati faithless nel voto vicepresidenziale;
39 sono stati faithless sia nel voto presidenziale che in quello
vicepresidenziale.
I faithless electors, in realtà, a volte hanno dovuto cambiare il
proprio voto per cause di forza maggiore. In particolare, in due occasioni i
grandi elettori sono stati costretti a modificare il proprio voto a causa della
morte del candidato che si erano impegnati a sostenere:
Nel 1872, dopo aver votato ma prima che i grandi elettori si
riunissero, il candidato presidente Horace Greeley morì, e i voti di 63 suoi
grandi elettori andarono ad altri candidati. Di essi, 19 votarono anche per un
candidato vicepresidente diverso da quello atteso.
Lo stesso accadde nel 1912, con la morte del candidato
vicepresidente James Sherman (8 grandi elettori).
E gli altri grandi elettori? A parte uno, che si è astenuto alle
presidenziali del 2000, i restanti 133 hanno dato il proprio voto a candidati
presidenti e/o vicepresidenti diversi da quelli che si erano impegnati a
sostenere. Questo non significa comunque che abbiano necessariamente votato per
il ticket del partito opposto: semplicemente, non hanno votato i candidati alla
presidenza e alla vicepresidenza che avrebbero dovuto sostenere, ma altre
personalità.
Il caso del 2016. Quella del 1912 fu l’ultima elezione in cui ci
fu più di un faithless elector, almeno fino al 2016: quattro anni fa, infatti,
il numero tornò a superare l’unità. In particolare, 5 franchi tiratori eletti
nelle file dei democratici votarono per candidati diversi da Clinton e Kaine,
mentre 2 grandi elettori del GOP fecero lo stesso, danneggiando Trump e Pence:
questi ultimi riuscirono comunque ad essere eletti con 304 voti per il primo e
305 per il secondo. Pence, nello specifico, ricevette un voto in più di Trump
perché il grande elettore Bill Greene fu un faithless elector solo per metà:
votò infatti Ron Paul come presidente, ma seguì le direttive di partito nel
votare Mike Pence come vicepresidente. L’altro faithless elector repubblicano,
invece, votò l’allora governatore dell’Ohio John Kasich come presidente e
l’imprenditrice Carly Fiorina come vice. Sul fronte democratico, un grande
elettore delle Hawaii votò per il ticket Sanders-Warren, mentre 3 grandi
elettori dello Stato di Washington votarono l’ex Segretario di Stato Colin
Powell come presidente e tre senatrici come vice (le democratiche Maria Cantwell
ed Elizabeth Warren e la repubblicana Susan Collins). Nello Stato di Washington
ci fu anche un quarto faithless elector, che votò come presidente l’attivista
Faith Spotted Eagle (prima nativa americana a ricevere un voto nella storia) e
come vicepresidente l’ambientalista Winona LaDuke. Ai 7 faithless electors del
2016 andrebbero in realtà aggiunti 3 grandi elettori che provarono a “tradire”
il ticket per cui si erano impegnati a votare, ma le leggi statali li hanno poi
rimpiazzati o costretti a votare per il ticket giusto. In particolare, Bernie
Sanders ha ricevuto i voti di altri due grandi elettori eletti nelle file
democratiche: si tratta di David Bright del Maine e Muhammad Abdurrahman del
Minnesota, che hanno visto invalidare il proprio voto sotto le rispettive leggi
statali contro i faithless electors. Bright fu obbligato a votare per Hillary
Clinton, mentre Abdurrahman fu rimpiazzato da un altro grande elettore perché
aveva anche votato la rappresentante Tulsi Gabbard al posto di Tim Kaine come
vicepresidente. In Colorado, infine, il grande elettore democratico Michael Baca
votò per il repubblicano John Kasich, ma anche il suo voto fu dichiarato non
valido e il Segretario di Stato del Colorado Wayne W. Williams (peraltro
repubblicano) rimpiazzò Baca con un grande elettore che votò per Hillary
Clinton.
E nel 2020? Per porre fine a questo fenomeno, il 6 luglio scorso
la Corte Suprema ha stabilito all’unanimità la possibilità per gli Stati di
imporre ai grandi elettori il voto per il ticket che hanno promesso di sostenere
prima delle elezioni. Già 33 Stati più il Distretto di Columbia, peraltro, hanno
già adottato leggi in tal senso.
In ogni caso, anche se qualcuno dei grandi elettori dovesse
decidere di votare per un ticket diverso da quello previsto, incorrendo così
nelle sanzioni previste come l’annullamento o la multa, difficilmente ciò
potrebbe stravolgere l’esito delle prossime presidenziali. A meno che, forse,
non ci sia un margine di vittoria parecchio ristretto nei grandi elettori.
La “malademocrazia” Usa e quel sistema elettorale che spesso
elegge chi prende meno voti. Ugo Intini su Il Dubbio
il 13 settembre 2020. La democrazia americana rischia di schiantarsi contro due
montagne: un sistema elettorale inadeguato e la lotta razziale. La democrazia
americana rischia di schiantarsi contro due montagne. La prima è la disastrosa
inadeguatezza del sistema elettorale, che compromette la credibilità delle
istituzioni. La seconda montagna è il ritorno della lotta razziale, accompagnata
da quella “di classe” tra ricchi e poveri. Che il sistema elettorale sia
pessimo, ce ne siamo accorti soltanto recentemente perché da decenni, ancor
prima del referendum Segni del 1993, in Italia era di moda demonizzare il
proporzionale portando a esempio le “meraviglie” del maggioritario americano. Un
ciclo che sembra chiudersi con la nuova legge elettorale adesso proposta e
pertanto con il ritorno, dopo trent’anni, al punto di partenza (o quasi).
Vogliamo riassumere le “meraviglie” del sistema americano? Può essere eletto
presidente chi ha ottenuto non più, ma meno voti. Trump ha vinto le ultime
elezioni prendendo oltre due milioni di voti meno della Clinton. E potrebbe
vincere le prossime anche prendendo oltre cinque milioni meno di Biden. I grandi
elettori che scelgono il presidente sono infatti previsti Stato per Stato. E li
si conquista tutti con un solo voto di maggioranza (se il candidato vince in uno
Stato con 2 milioni di scarto, 1.999.999 voti sono superflui e contano
esattamente come quel solo voto). Ma c’è di molto peggio. Come è noto, ciascun
Stato federale esprime due senatori, indipendentemente dalla sua popolazione.
Con risultati demenziali. Un esempio. I 40 milioni di cittadini della California
sono rappresentati da due senatori democratici. Anzi da due famose senatrici: la
veterana Dianne Feinstein ( in carica dal 1992 e precedentemente, dal 1978,
sindaco di San Francisco) e la candidata vice presidente Kamala Harris. I
560.000 cittadini del Wyoming sono rappresentati da due sconosciuti senatori
repubblicani: John Barrasso e Mike Enzi. I 40 milioni della California ( la
quinta potenza economica del mondo) e i 560.000 americani periferici del Wyoming
hanno dunque lo stesso peso nel Senato. Un senatore californiano, con alle
spalle 20 milioni di cittadini, conta “uno”, esattamente come quello del
Wyoming, che ne ha alle spalle 71 volte meno. Molti americani dubitano ormai che
questa sia democrazia. Ma non soltanto la sostanza, anche le modalità del
sistema elettorale risultano disastrose. Le file per raggiungere le urne sono
spesso sterminate, così da rendere difficile il voto ( guarda caso) soprattutto
nei quartieri poveri, dove ci sono meno scuole e pertanto meno seggi ( ma più
voti democratici). Il voto per posta è di conseguenza altissimo, soprattutto tra
i democratici. Questa volta ( causa anche il coronavirus e la relativa paura)
potrà riguardare quasi la metà degli elettori. Ma il servizio postale è
inadeguato e Trump viene accusato di sabotarlo ulteriormente. C’è infine il
“gerrymandering”: la pratica cioè adottata per la prima volta nel 1812 dal
governatore del Massachussets ( e grande imbroglione) Eldbridge Gerry, che le ha
dato il nome. I collegi elettorali uninominali per Camera e Senato sono talvolta
definiti non in modo netto e incontestabile, ma con gli arzigogoli più strani:
non senza soluzione di continuità, ma a macchia di leopardo, prendendo pezzi di
qua e pezzi di là ( sulla base della composizione razziale e del reddito) allo
scopo di aiutare o ostacolare questo o quel partito. Gerry li ha disegnati a
“salamandra” (salamander ) e il suo – appunto – gerrymandering ha fatto scuola.
Non stupisce in questo contesto che, secondo i sondaggi, un terzo degli elettori
( sia democratici che repubblicani) sia indisponibile a riconoscere l’eventuale
vittoria del cosiddetto “nemico”, perché è deciso a considerarla a priori
truffaldina. Si aggiunge l’insofferenza anche psicologica tra gli schieramenti
opposti. Come si sa, il colore dei democratici è l’azzurro, quello dei
repubblicani il rosso. Se si guarda la carta degli Stati Uniti colorata secondo
le appartenenze politiche, si vedono azzurre quasi tutte le coste, rosse le aree
interne. I democratici pensano che i repubblicani rappresentino i “cow boys” e i
rozzi dell’America profonda e rurale. I repubblicani che i democratici
rappresentino gli snob e i cosmopoliti ( non i veri americani) delle metropoli
multirazziali. Si può aggiungere che il mondo ama l’America per la sua cultura,
tecnologia e innovazione, concentrata a New York o Boston, a Los Angeles o San
Francisco ( e proiettata al di là degli oceani). Ma non accetta certo la guida
di un’America chiusa e provinciale. Diciamo la verità. La democrazia americana
funzionava non “per”, ma “nonostante” il suo sistema elettorale. Contava, come
sempre, innanzitutto la politica. Un tempo, essa era dominata dalle élite. I
contrasti erano attutiti dal fair play tra gentiluomini o dalla convergenza
verso il centro sia della destra che della sinistra ( il che escludeva gli
estremismi e assicurava la continuità chiunque vincesse). Il democratico Al
Gore, vent’anni fa, avrebbe potuto non accettare la vittoria di George W. Bush.
Aveva preso complessivamente il 48,4 per cento contro il 47,9. Lo Stato della
Florida, che con i suoi 25 grandi elettori su 537 faceva la differenza, aveva
dato la maggioranza a Bush per soli 1.784 voti. Si iniziò il riconteggio (come è
normale quando il margine è inferiore allo 0,5 per cento). E come appariva
doveroso in presenza di conclamati disguidi e pasticci (dolosi o non). Il
vantaggio di Bush cominciò a scendere. Si era già ridotto a soli 325 voti (in
uno Stato allora di 15 milioni di abitanti) quando il riconteggio fu interrotto
con un artificio giuridico imposto dall’establishment repubblicano locale. Gore
avrebbe potuto fare le barricate, ma si ritirò per evitare un trauma
istituzionale. Oggi, molti osservatori temono un risultato altrettanto (o forse
più) incerto. Seguito però non da generose rinunce, bensì da scenari di guerra
civile. Si tratta di scenari resi purtroppo possibili dalla seconda “montagna”
citata all’inizio, ovvero dall’acuirsi dello scontro sociale. Gli Stati Uniti
sono il Paese più ricco e importante del mondo ma, a differenza dell’Europa (e
di noi), non hanno un sistema sanitario “universale” che garantisca tutti i
cittadini. Esattamente per questo, il virus ha prodotto un disastro così
sproporzionato. D’altronde, le statistiche dicono che la mortalità da Covid in
Europa si è differenziata per classi di età. In America soprattutto per classi
sociali: i poveri sono colpi- ti ( e muoiono) enormemente più dei ricchi. Non
solo manca un welfare State europeo. Trump è accusato di aver definito i caduti
americani in guerra dei “perdenti” e dei “fessi”. Forse non è vero. Ma certo ha
spesso sottolineato pubblicamente ( sia pure in modo meno crudo) questo concetto
a proposito dei poveri. D’altronde, non dalla sua presidenza, ma da molto prima,
la distanza tra ricchi e diseredati si è allargata a dismisura. Non un
estremista di sinistra, ma l’ex vicepresidente della Banca Federale ( e attuale
professore a Princeton) Alan Blinder scriveva. “Quando gli storici guarderanno
indietro all’ultimo quarto del 20° secolo, diranno che la caratteristica
principale è stata lo spostamento senza precedenti di denaro e di potere dal
lavoro verso il capitale, dal basso verso l’alto della piramide sociale”. Lo
scriveva non adesso, ma nel 2000. E da allora il processo ha avuto una ulteriore
accelerazione. Come si sa, i poveri degli Stati Uniti sono soprattutto i neri e
i latinos, così che la lotta di classi sociali automaticamente si trasforma in
conflitto razziale. Stupisce la violenza della polizia? È così ovvia che molti
neri ricchi, quando vanno ad abitare in un quartiere “alto”, si presentano alla
stazione di polizia, portano le foto dell’intera famiglia da esporre ed evitano
in tal modo di essere fermati o vessati dai controlli abitualmente concentrati
contro i cittadini di colore. Trump sembrava perdente, è normale vedere sulle
automobili nelle metropoli un adesivo con la scritta “ABC” (“Anybody But Trump”:
chiunque meno Trump). Ma le manifestazioni contro la polizia divenute violente
possono adesso aiutarlo, spaventando i bianchi moderati. Soprattutto perché
nella protesta acquistano crescente visibilità i sedicenti comunisti e
anarchici. Trump punta sempre più su “legge e ordine”, ma nulla è certo: le
manifestazioni potrebbero anche al contrario aiutare Biden, spingendo a votare i
neri e i poveri che normalmente se ne stanno a casa ( anche perché votare non è
automatico: comporta una procedura di iscrizione nelle liste elettorali
complessa soprattutto per gli emarginati). Colpisce vedere come la questione
razziale, che sembrava attutita con Obama, abbia una radice così profonda negli
Stati Uniti. E come Trump cerchi di cavalcarla senza prendere le distanze dai
“suprematisti” bianchi. Naturalmente, la questione razziale si confonde con il
tema della povertà, perché gli appartenenti alle minoranze svantaggiate tendono
più spesso degli altri ad avere comportamenti che diventano un facile bersaglio
per i luoghi comuni della propaganda razzista. Non ci piace ricordarlo, ma un
tempo tra queste minoranze c’erano anche gli italiani, in particolare gli
immigrati dal Sud. Sin dall’ingresso a Ellis Island, sotto la statua della
libertà a New York, i nostri meridionali erano spesso formalmente catalogati
come “neri”. E infatti molti di loro sono stati vessati o addirittura linciati e
uccisi insieme ai neri. Esistono casi clamorosi. Ad esempio nel 1891, il capo
della polizia a New Orleans fu assassinato nel contesto di una lotta di potere
politica. Si diede la colpa agli italiani per definizione “mafiosi”. Molti
furono arrestati, massacrati di botte per farli confessare e processati. Ma
assolti da un tribunale onesto. In 11 sarebbero stati scarcerati il giorno dopo,
ma la folla dei bianchi anglosassoni, guidata dai maggiorenti della città, dette
l’assalto al carcere ( con la totale connivenza delle autorità), li scovò mentre
si nascondevano disperatamente e li uccise tutti: uno per uno. Ormai su queste
violenze contro gli italiani si produce una vasta letteratura. Ad esempio la
Stony Brook University di New York ha un importante dipartimento di
italianistica, il cui direttore Mario Mignone, recentemente scomparso, ha
mostrato vignette oggi inimmaginabili sui giornali popolari dell’epoca, con gli
italiani immigrati raffigurati come scuri topi di fogna che sbarcano a frotte
immonde per contaminare l’America. I suprematisti bianchi allora
criminalizzavano i nostri meridionali come i neri. Le sa queste cose Salvini, da
sempre entusiasta di Trump, che oggi ama parlare con enfasi di “italiani”?
Probabilmente no. Ma non dovrebbe sorprendersi, perché negli anni 80 la Lega
contestava a Milano gli immigrati meridionali esattamente come li contestavano
un secolo fa a New York i suprematisti bianchi. Quelli che hanno in non pochi
“trumpiani” di oggi gli eredi naturali. In questo clima ( e lo si può capire) si
parla sempre più in America di “socialismo”. Lo fa una parte ( crescente) dei
democratici, ma anche Trump, allo scopo di dipingere tutti i democratici-
appunto- come pericolosi “socialisti”. Nell’approfondire l’argomento, si
riscopre e rivaluta l’Europa ( anche l’Italia). Il dipartimento di italianistica
prima citato della Stony Brook University ( ovvero di una università tra le più
importanti dello Stato di New York) ad esempio ha appena pubblicato nella nostra
lingua ( perché la si studia non poco) un libro sulla “letteratura italiana di
ispirazione socialista”. Dal quale gli studenti americani apprendono sul
socialismo italiano quanto neppure io sapevo con precisione. Anche questa è
l’America e anche questo non mancano gli elementi che possono condurre
all’ottimismo. Tuttavia, una analisi cruda va fatta. Perché la democrazia
americana è in crisi. E, se lo è la più importante democrazia del mondo, il
segnale, soprattutto per noi, risulta allarmante.
Federico Rampini per “Affari & Finanza - la Repubblica” l'1
novembre 2020.Il mio 11 settembre lo passai a San Francisco, quasi vent' anni
fa. Fra i tanti shock, dopo la paura e il dolore immediato, ci fu anche uno
spaesamento culturale. La città più radicale d' America, decisamente all'
opposizione nei confronti di George W.Bush, d' incanto fu tappezzata di bandiere
a stelle e strisce. Il patriottismo non era né di destra, né di centro, né di
sinistra. I valori comuni esistevano e non ci si vergognava a difenderli.
Famiglie i cui padri avevano fatto obiezione di coscienza e avevano rischiato (o
scontato) il carcere per non andare a combattere in Vietnam, custodivano in casa
delle grandi bandiere nazionali che affacciarono sui davanzali delle finestre.
Ero commosso. Rimasi altrettanto sconcertato quando Bush lanciò uno dei primi
messaggi dopo l' attacco alle Torri Gemelle e al Pentagono: uscite e comprate,
tornate negli shopping mall, fate vedere al mondo intero che gli americani non
hanno paura. Il consumismo come variante del patriottismo. A dire il vero, anche
una parte degli americani furono in disaccordo. Nella seconda guerra mondiale -
dissero ricordando Roosevelt - ci tassavamo di più per sostenere le nostre
truppe e combattere il nemico, adesso il sacrificio è diventato andare al
ristorante? Vent' anni dopo, rieccoci in una situazione quasi simile. Dico
quasi, perché l' unità nazionale è svanita. L' appello a far ripartire l'
economia, costi quel che costi, è venuto soprattutto da una parte dello spettro
politico: Donald Trump e la destra. Però ci sono tante situazioni locali o
settoriali in cui la sinistra fa proprio lo stesso appello. Per esempio:
«Andiamo tutti a comprare un libro nella piccola libreria indipendente di
quartiere». «Andiamo ad ascoltare un concerto all' aperto, tassandoci per
mantenere gli artisti disoccupati». E così via. In America spendere è un atto
positivo, costruttivo, ottimista. Gli economisti - soprattutto keynesiani -
condividono il messaggio. Proprio come Franklin Roosevelt, anche John Maynard
Keynes sosteneva che la cosa di cui dobbiamo avere più paura è la paura stessa.
Una paralisi dei consumi genera recessione, questa aumenta la disoccupazione,
quindi riduce i redditi delle famiglie, il che si ripercuote in ulteriori tagli
ai consumi. Il popolo americano sembra "keynesiano" fino al midollo. La ripresa
dei consumi è in atto, anche se vi hanno contribuito quattro manovre di spesa
pubblica che hanno sostenuto i redditi. Storicamente gli americani hanno una
propensione al consumo più alta di altre nazioni; di converso risparmiano una
quota inferiore del proprio reddito. In un' annata normale - fuori pandemia - la
tipica propensione al risparmio degli americani si situa fra un terzo e un
quinto rispetto a quella di popoli di livello analogo come tedeschi e francesi
(preferisco non fare paragoni in tempi di pandemia perché la quota di reddito
familiare che viene risparmiata è stata innalzata artificialmente dai lockdown).
E la Cina? La precoce e vigorosa ripresa della domanda cinese è stata in parte
trainata dai consumi. Questo può ispirare un' analogia tra le due più grosse
economie del pianeta. In realtà prevalgono le differenze. Tra i limiti della
locomotiva cinese: la domanda interna, benché in aumento, non svolge lo stesso
ruolo che ha nelle economie più avanzate. I consumi delle famiglie sono il 40%
del Pil cinese contro i due terzi nelle economie occidentali. Sulle famiglie
cinesi pesa anche l' alto livello d' indebitamento, che ha raggiunto il 60% del
Pil e quindi si avvicina gradualmente a livelli americani (76%). Solo in quest'
aspetto si può dire che i cinesi si stanno americanizzando: per la facilità con
cui s' indebitano. Perché il capitalismo americano ha (quasi) sempre fatto
affidamento su una superiore predisposizione al consumo, anche finanziato dai
debiti? Quali fattori influenzino le scelte fondamentali degli individui -
quanto risparmiare, quanto spendere per consumi - è un tema affascinante con il
quale gli economisti si cimentano da generazioni. Per spiegare l' iperconsumismo
degli americani, o la relativa parsimonia di altri popoli (europei o asiatici)
sono stati invocati fattori strutturali o culturali. Degli italiani, per
esempio, si disse a lungo che si portavano dietro una "cultura contadina",
avversione al rischio e quindi ai debiti; nonché un' etica familistica per cui
ogni genitore vuole lasciare qualcosa ai figli. La Cina da questo punto di vista
si può considerare come una grande Italia: ex-contadini da una generazione,
forte senso della famiglia. L' America è all' estremo opposto perché è il Paese
del capitalismo più sviluppato, e anche dell' atomizzazione individualistica. Ha
fiducia nello sviluppo, quindi trova normale indebitarsi oggi per anticipare un
reddito futuro. Ma altri fattori dovrebbero spingere gli americani nella
direzione diametralmente opposta. Hanno un sistema pensionistico meno generoso
di tanti Paesi; una sanità a prevalenza privatistica e più cara; un sistema
universitario dalle rette stratosferiche. Per tutte queste differenze di accesso
ai servizi sociali che altrove sono pubblici e semi- gratuiti, gli americani
dovrebbero spendere meno per consumi e risparmiare di più per la vecchiaia, la
malattia, gli studi dei figli. Se non lo fanno, probabilmente un ruolo lo
svolgono il sistema bancario, il credito al consumo, i servizi finanziari.
L'America ha un'industria finanziaria piuttosto efficiente nel mettere il
credito a disposizione dei consumatori. Quando la Fed ha spinto i suoi tassi a
quota zero e ha lanciato forme sempre più espansive di Quantitative easing, il
sistema bancario e le istituzioni erogatrici di mutui- casa hanno trasferito
abbastanza velocemente i benefici sulla clientela e infatti il mercato
immobiliare è ripartito. Lo stesso vale per il credito al consumo, finanziato
attraverso carte di credito oppure pagamenti rateali di acquisti di automobili,
elettrodomestici. Perfino gli studi universitari vengono finanziati con "student
loans" molto diffusi. In generale, se una famiglia ha "troppi" risparmi su un
deposito e pensa di usarli per estinguere anticipatamente un debito (per esempio
il mutuo- casa), la banca stessa consiglierà invece di investire i risparmi in
Borsa e mantenere un sano "leverage". Questo comportamento viene incentivato
anche dal sistema fiscale, che consente un' altissima deducibilità degli
interessi passivi sui mutui. È un sistema costruito per dare carburante alla
crescita, e un certo livello d' indebitamento è funzionale. Altre nazioni - come
la Germania - hanno sempre gettato uno sguardo moralistico e pieno di
disapprovazione, sul comportamento da "cicale" degli americani. Loro obiettano -
keynesianamente - che chi risparmia troppo si condanna alla stagnazione. Oppure
a farsi trainare dalla crescita altrui. Questo è il rovescio della medaglia: il
consumismo americano genera deficit commerciali; questi ultimi sono stati per
almeno tre quarti di secolo il motore trainante dei successivi "miracoli"
economici tedesco e italiano, giapponese e infine cinese.
PERCHÉ
TANTE ARMI CIRCOLANO NEGLI STATI UNITI?
Massimo Teodori su Il Quotidiano del Sud il 2 novembre 2020. Perché in America
circolano ostentatamente persone munite perfino di armi pesanti che sembrano più
adatte a fare la guerra che non alla difesa della persona? Gli italiani hanno
difficoltà a capire come mai sia permesso a tali milizie paramilitari di
aggirarsi normalmente nelle strade dei centri abitati anche in prossimità di
edifici pubblici, scuole e chiese. La questione è tornata d’attualità da quando
Trump ha rivolto un messaggio a gruppi generalmente riconducibili ai
“suprematisti bianchi”, di stare all’erta in vista delle presidenziali in cui il
democratico Biden avrebbe l’intenzione di limitare il diritto di ciascun
americano di portare le armi come garantito dalla Costituzione. Il secondo
emendamento costituzionale recita che «Essendo necessaria alla sicurezza di uno
Stato libero una ben organizzata milizia, non si potrà violare il diritto dei
cittadini di possedere e portare le armi». Il fatto è che la norma fu scritta
nel 1789 quando la sicurezza individuale nell’America della frontiera era
garantita dalle stesse persone armate in mancanza di un corpo di polizia, e
l’esercito era formato dalla milizia volontaria che arruolava i singoli
cittadini che portavano con sé le proprie armi. Alcuni anni fa la Corte suprema
ha confermato in senso letterale quel diritto “originario” di fine Settecento,
fornendo così il pretesto per legittimare la circolazione delle persone armate
come se l’America d’oggi fosse il Far West di allora. Oggi i singoli Stati hanno
il potere di regolare le norme vigenti nel proprio territorio che vanno dalle
più permissive all’Ovest dove più forte è la base repubblicana – Texas, ad
esempio – alle più strette all’Est – New York, ad esempio – dove governano
tradizionalmente i liberal. Negli ultimi mesi sono state vendute centinaia di
milioni di armi di ogni tipo che gli americani hanno ammassato nelle loro case
in previsione delle elezioni. Si stima che oggi sia in circolazione mediamente
più di un’arma a testa per tutti i 330 milioni di cittadini d’ogni età e genere.
Auguriamoci che non escano fuori nel caso di elezioni dall’esito incerto.
Il team
segreto della Cia in Kenya per l’antiterrorismo.
Jacopo Lentini
su Inside Over il 2 novembre 2020. In Kenya, dal 2004, opera un’unità
paramilitare clandestina per la cattura di sospetti terroristi, addestrata e
coordinata dalla CIA, l’Agenzia Centrale d’Intelligence statunitense, con il
supporto dei servizi segreti britannici. È quanto rivelato da un’inchiesta
di Declassified UK, firmata dal giornalista investigativo Namir Shabibi, che ha
raccolto le testimonianze di decine di funzionari della CIA, del Dipartimento di
Stato Usa e delle agenzie di sicurezza keniote. Questo gruppo sotto copertura,
chiamato Rapid Response Team (RRT), è composto da circa 60 persone e appartiene
al General Service Unit, un’ala della polizia keniota. Se da un lato il RRT
svolge un ruolo di contrasto ad al-Shabaab, la fazione somala
dell’organizzazione terrorista al-Qaeda, dall’altro si è reso responsabile di
esecuzioni sommarie ed extragiudiziali. Nell’agosto 1998, le ambasciate Usa in
Kenya e Tanzania subirono un bombardamento quasi simultaneo, organizzato dal
ramo egiziano di al-Qaeda, che causò la morte di 224 persone, di cui 12
americani. Da quel momento, l’approccio statunitense alle agenzie di sicurezza
africane della regione cambiò totalmente: sei anni dopo, non senza difficoltà,
nacque il RRT. “Era una soluzione locale per un problema locale”, ha dichiarato
un ex ufficiale della CIA a Shabibi. William Bellamy, ambasciatore Usa in Kenya
dal 2003 al 2006, è la figura che ha creato l’intesa con le controparti keniote,
trovando come interlocutore privilegiato il Servizio Nazionale di Intelligence
(NIS), dopo aver riscontrato scetticismo tra le agenzie di polizia e militari
nella creazione di una multi-agenzia integrata, a causa della forte rivalità tra
di esse. Inoltre, in quegli anni, il Kenya adottava una politica di neutralità
riguardo ai conflitti nell’area, ponendosi come mediatore. Ad ogni modo, nel
2004, le reclute del RRT furono inviate per la prima volta negli Stati Uniti per
ricevere l’adeguato addestramento da parte della CIA, in luoghi tenuti segreti
alle reclute stesse. La CIA gestisce le operazioni sotto copertura del RRT
tramite un “ufficiale di collegamento” stanziato presso l’ambasciata Usa
di Nairobi. Ha inoltre finanziato regolarmente le missioni del RRT, fornitovi
armi e concesso benefit ai suoi componenti, che ricevono tramite l’ambasciata
anche un aumento salariale del 30%, non indifferente viste le basse paghe del
personale keniota.
Guerra
d’intelligence. Tra gli interventi “di alto profilo” compiuti dal RRT
contro al-Shabaab, si annoverano l’uccisione, ad agosto 2019, di un sospettato
legato all’attentato dell’hotel DusitD2 di Nairobi, avvenuto a gennaio dello
stesso anno, in cui sono morte 21 persone, e la neutralizzazione delle cellule
responsabili dell’attacco all’Università di Garissa del 2015, in cui morirono
148 persone. Prima ancora, nel 2009, l’unità segreta aveva sventato un piano di
uccidere l’allora Segretaria di Stato Usa Hillary Clinton, durante una visita in
Kenya di quell’anno. Grazie a travestimenti, veicoli con targhe finte e altre
tattiche, il RRT è riuscito a passare inosservato per 16 anni. Alcuni suoi
membri, per controllare alcuni sospettati, si sono anche infiltrati nel campo
profughi di Dadaab, a pochi chilometri dal confine somalo, fingendosi funzionari
del Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite, utilizzandone veicoli e
divise, a insaputa dello stesso. Declassified UK rivela che le missioni del RRT
sono spesso guidate, se non addirittura approvate, interamente dalla CIA, che si
avvale anche delle informazioni del NIS. Inoltre, l’aiuto dei servizi segreti di
Londra, che intrattengono relazioni di lunga data con la controparte keniota, è
fondamentale e si è intensificato a partire dal 2010, visto l’aumento
dei “foreign fighters” britannici che raggiungevano la Somalia attraverso il
Kenya. L’intelligence di Sua Maestà ha un ruolo tale da decidere anche le sorti
dei sospettati oggetto degli interventi del RRT: catturarli o ucciderli.
Esecuzioni
extragiudiziali e radicalizzazione. Nel 2011 il governo di Nairobi mandò il
proprio esercito in Somalia, ufficialmente a causa dell’aumento dei rapimenti,
da parte di al-Shabaab, di operatori umanitari e turisti nel nord e sulla costa
del Kenya. In realtà vi erano motivi legati al controllo della regione somala di
confine e di alcune infrastrutture legate al petrolio. Il Paese sembrava
comunque allinearsi con la “guerra al terrorismo” promossa dagli Stati Uniti nel
decennio precedente. Da quel momento, gli attacchi di al-Shabaab si
intensificarono, anche in funzione anti-americana, dal momento che gli Usa erano
un partner militare nella regione. “Ci attaccano di continuo, perché siamo visti
come pro-America, pro-occidente”, ha dichiarato l’ex vicepresidente keniota
Kalonzo Musyoka. Il RRT avrebbe ricevuto, talvolta, istruzioni di eliminare i
presunti terroristi, sapendo a priori che non sarebbero mai stati interrogati
una volta arrestati. Alcuni suoi membri hanno raccontato: “Quando ci hanno
addestrato sugli obbiettivi, ci hanno detto che i diritti umani vengono dopo”.
Sebbene questo team clandestino non sia nato con lo specifico compito di
uccidere i sospettati, non c’è stata alcuna conseguenza nel caso di vittime
ingiustificate, neanche se innocenti. Il dossier di Shabibi riporta, tra gli
altri, il caso di Omar Faraj, padre di famiglia ucciso per errore a Mombasa a
ottobre 2012, nel suo appartamento. Il RRT credeva di aver fatto irruzione
nell’abitazione di Fuad Abubakar Manswab, presunto ideatore di un attentato
sventato nella stessa città l’anno precedente. Dal punto di vista legale, il
codice americano prevede che le agenzie Usa come l’Esercito, il Dipartimento di
Stato e le forze di polizia, che assistono forze di sicurezza straniere,
controllino che queste ultime operino nel rispetto dei diritti umani,
tralasciando però il mondo dell’intelligence. Non a caso è la CIA a guidare tali
operazioni in Kenya. Qui, il governo di Nairobi non ha mai approfondito i casi
di uccisioni extragiudiziali legate all’antiterrorismo, derubricate in fretta a
operazioni di polizia contro soggetti definiti “armati”, anche in presenza di
testimoni che sostenevano il contrario. Solo nel 2019, nella regione di Mombasa
sono state riportate 43 esecuzioni extragiudiziali, il 50% in più dell’anno
precedente. Alcune organizzazioni nazionali e internazionali per i diritti
umani, tra cui Human Rights Watch, hanno segnalato come le uccisioni sommarie,
il cui target sono quasi sempre soggetti musulmani, contribuiscono a coltivare
nella popolazione islamica sentimenti di estremismo, anche anti-americano.
Secondo Musyoka “non c’è nulla che radicalizzi di più la gente delle esecuzioni
al di fuori dalla legge, perché vorranno vendetta”. “Abbiamo bisogno di gruppi
specializzati nell’antiterrorismo”, ha dichiarato Michael Ranneberg,
ambasciatore Usa in Kenya dal 2006 al 2011, a Declassified UK. “In molti Paesi
cerchiamo un’unità speciale con la quale collaborare, e se non esiste, qualche
volta ci adoperiamo per crearla e addestrarla”. Il perfezionista che diventò
"uno di famiglia".
CIA CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. La
CIA. Carlo Nordio per “il Messaggero” il 26 settembre 2020. Il 18 settembre
1947, su iniziativa del presidente Harry Truman, gli Stati Uniti istituirono la
Central Intelligence Agency: un organismo civile incaricato di raccogliere,
elaborare e analizzare, attraverso l'uso dell'intelligenza umana le informazioni
provenienti da tutto il mondo che potessero interessare la sicurezza nazionale.
Oggi questa intelligenza è assistita, se non sostituita, da una serie di
diavolerie tecnologiche in continuo sviluppo. Ma l'organismo mantiene il suo
nome, che in alcuni suscita disgusto, in altri ammirazione, in tutti interesse:
la Cia. Facciamone una breve storia. Allo scoppio del secondo conflitto mondiale
gli Stati Uniti non avevano un servizio centralizzato di spionaggio.
L'Intelligence sui movimenti dei potenziali nemici era affidata agli specialisti
dell'Esercito e della Marina, talvolta con risultati straordinari, come la
decrittazione del codice giapponese, talaltra con esiti deludenti, come la
mancata previsione dell'attacco a Pearl Harbor. L'unico ufficio efficiente per
mezzi e risorse era il Federal Bureau of Investigation (Fbi) che tuttavia si
occupava della criminalità interna, compresa la caccia alle spie e ai traditori.
Con queste incredibili carenze l'America entrò in guerra confrontandosi da un
lato con il Secret Intelligence Service britannico (il famoso Mi6 di James
Bond), dall'altro con il temibile Sicherheitsdienst (Sd) di Walter Schellenberg,
e per i primi anni del conflitto sul teatro europeo dovette brancolare nel buio.
Gli inglesi avevano a Bletchley Park la concentrazione dei più brillanti
cervelli del regno, e intercettavano - tramite il primo computer della storia
tutte le comunicazioni tedesche. Tuttavia non ne condividevano il contenuto con
il nuovo alleato, considerato ingenuo e poco affidabile nel mantenere i segreti.
Fu anche per questo che nel giugno del 1942 il presidente Roosevelt incaricò il
generale William Donovan di costituire l'Office of Strategic Services (Oss) con
funzioni informative e anche operative. Il suo rappresentante più noto fu Allen
Dulles, che da Ginevra tenne contatti con la Resistenza dei Paesi occupati e,
verso la fine del conflitto, con gli stessi nazisti per trattarne la resa.
Quella in Italia fu concordata con il generale delle Ss Karl Wolff, a suo tempo
incaricato da Hitler di rapire Pio XII. Alcuni militari dell'Oss furono
paracadutati dietro le linee nemiche per missioni speciali, compresa quella,
fallita, di sottrarre Mussolini dalle mani dei partigiani. Con la pace, l'Oss fu
messa in naftalina, ma presto Truman si convinse che il ruolo ormai mondiale
degli Usa, e l'avvento della guerra fredda richiedevano una stabile e ben
strutturata organizzazione spionistica. Fu così che, sulla residua struttura
dell'Oss, fu costruita la Cia. Formalmente, e secondo la sua stessa definizione,
si sarebbe dovuto trattare di una attività di raccolta ed elaborazione di dati.
In realtà nessun servizio di spionaggio ama affidarsi, per le connesse attività
operative, a uffici concorrenti, e preferisce far da sé, anche a rischio di
incontrarsi e di scontrarsi con organismi alleati. Questo accadeva persino nella
Germania hitleriana, dove Sd e Gestapo litigavano tra loro. Era naturale che lo
stesso avvenisse in democrazie più articolate e sotto differenti responsabilità
di gestione. Così i conflitti tra gli uomini dell'Fbi e della Cia sono stati
tali e tanti da aver ispirato persino dei film, dove in genere i primi sono
buoni e fedeli, i secondi deviati e cattivi...
I COMPLOTTI. In effetti la Cia, con un budget enorme e senza
obbligo di rendiconto, cominciò subito a operare sul campo, con risultati
incerti. E poiché nel mondo delle spie i successi rimangono segreti, mentre i
fallimenti prima o dopo emergono, l'immaginario collettivo ha visto e vede nella
Cia un covo di complottari spregiudicati e arroganti, che non si fermano davanti
a nulla e son capaci di tutto. È un'opinione in parte giustificata, perché negli
anni essa ha collezionato una tale serie di disastri e di scandali da renderla
persino sospetta di collusione col nemico. I più clamorosi si ricordano ancora,
a distanza di decenni. Il 1 maggio del 1960 un suo U2, aereo spia considerato
invulnerabile, fu abbattuto da un missile sovietico sul cielo di Sverdlovsk. Il
pilota, Francis Gary Powers, fu sottoposto a un umiliante processo pubblico, e
Kruschev annullò la programmata conferenza con il presidente Eisenhower. L'anno
successivo Kennedy ricevette una delusione ancora più cocente quando la Cia lo
convinse a invadere la Baia dei porci a Cuba, sicura di poter abbattere Fidel
Castro. Fu una catastrofe che, oltre a screditare il neopresidente fornì al
Cremlino il pretesto per piantare sull'isola i missili puntati sulle città
americane. Kennedy ne pretese la rimozione e il mondo fu sull'orlo
dell'Apocalisse nucleare. Fallimenti e scandali continuarono con tutte le
amministrazioni: con Johnson nel Laos, con Nixon nel Watergate, con Carter in
Iran, con Reagan in Nicaragua via via fino al grottesco rapimento dell'Imam di
Milano Abu Omar, dove i sequestratori furono facilmente individuati perché si
erano serviti delle carte di credito personali. La nostra magistratura
intervenne, e il mondo rise che gli agenti del famoso servizio segreto fossero
stati intercettati al telefono dalla Questura meneghina.
IL BILANCIO. In realtà vi furono anche molti successi, alcuni dei
quali hanno cambiato la storia. Per tutti, gli aiuti forniti a Solidarnosc, e
alla Chiesa polacca, che minarono il monolite comunista dell'Europa orientale
fino a procurarne la dissoluzione. E, infine, altra operazione sensazionale,
l'individuazione del nascondiglio di Bin Laden e la sua eliminazione. Il
bilancio complessivo è opinabile e, in mancanza di dati certi, è ovviamente
impossibile. Nella sua vita controversa, la Cia è stata guidata alternativamente
da militari e da civili. Tra i primi vi fu Walter Bedell Smith, che aveva
pianificato con Eisenhower lo sbarco in Normandia, e David Petreus, che dopo una
brillante carriera fu costretto alle dimissioni per una questione di donne. Tra
i secondi ricordiamo George Bush (senior) e l'attuale segretario di stato Mike
Pompeo. Oggi, per la prima volta, ne è al comando una donna, Gina Haspel, una
signora dal volto gentile ma dal cuore di ferro, a suo tempo accusata di aver
usato la mano pesante nei confronti dei prigionieri in Thailandia. Accuse che
ovviamente potrebbero esser rivolte ai tutti i suoi colleghi sulla Terra, o
almeno a quelli dei Paesi che si sentono minacciati nella sicurezza. Quando
Israele provò a discutere una legge che disciplinasse, in casi estremi, la
coazione fisica nei confronti dei terroristi, fu inondata di critiche, e non se
ne fece nulla. L'ipocrisia, omaggio che il vizio rende alla virtù, è di norma in
questo settore, dove il rude passage à tabac segue un canone universale: fatelo
sempre, non parlatene mai.
Da "rivistastudio.com" il 17 settembre 2020. «I risultati sono
tristi e scioccanti, e sottolineano che probabilmente c’è una falla
nell’insegnamento», ha detto Gideon Taylor, presidente della Conference on
Jewish Material Claims Against Germany che ha commissionato un sondaggio tra i
ragazzi americani dai 18 ai 39 anni, per capire il loro livello di conoscenza
dell’Olocausto. Ne è emerso che quasi due terzi dei giovani adulti americani non
sanno che 6 milioni di ebrei furono uccisi, e più di uno su 10 crede, anzi,
siano stati loro a causare l’Olocausto. Secondo lo studio, quasi la metà (48 per
cento) degli intervistati non sapeva nominare un singolo campo di
concentramento, alcuni nemmeno sapevano cosa fossero. Quasi un quarto degli
intervistati (23 per cento) ha affermato di credere che l’Olocausto fosse un
mito, o di essere stato “esagerato”. Uno su otto (12 per cento) ha affermato di
non aver assolutamente mai sentito parlare di quello che è stato uno dei più
grandi crimini contro l’umanità. Taylor ha aggiunto al Guardian: «Dobbiamo
capire perché non stiamo riuscendo ad educarli. Questo deve servire come un
campanello d’allarme per tutti noi, e come una road map su dove gli insegnanti
devono agire». Il sondaggio classifica gli Stati Uniti in base a un punteggio
basato su tre criteri: se i giovani conoscono l’Olocausto; se sono in grado di
nominare un campo di concentramento; e se sanno che 6 milioni di ebrei sono
stati uccisi. Lo stato con il punteggio più alto è stato il Wisconsin, dove il
42 per cento degli intervistati ha soddisfatto tutti e tre i criteri, seguito
dal Minnesota e dal Massachusetts. Gli stati con il punteggio più basso erano la
Florida al 20 per cento, il Mississippi al 18 per cento e l’Arkansas al 17 per
cento.
Nicolò Zuliani per termometropolitico.it il 31 ottobre 2020. Il
contachilometri della macchina è a fondo scala, i finestrini rotti fanno entrare
l’aria con un rombo caldo, nello specchietto retrovisore c’è un muro di volanti
della polizia e dei carabinieri. Il vicequestore tiene le mani sul volante e
guarda inorridito sul sedile del passeggero, dove un bel ragazzo stringe il
fucile: «Cattiverij n’è avut tropp, mo me truov ci cor cchius» dice il ragazzo.
«A facc ro cazz, Raffae’» geme il vicequestore. Weeeeeeo, weeeeeeeo, weeeeeeeo,
fanno le sirene dietro di loro. Raffaele Minichiello nasce nel 1949 a Melito
Irpino, un insignificante paesino distante venti chilometri da Benevento, in una
casa che non ha nemmeno l’elettricità. Cresciuto in una casa di campagna e una
comunità che tentava di rialzarsi dalla guerra, appena adolescente va a lavorare
nell’officina del padre, a Grottaminarda. Flirta con Rosalia, una ragazzina sua
coetanea. Nel 1962 il terremoto devasta i paesi e distrugge l’officina. I
genitori, stremati da una terra impietosa e da una vita miserabile, prendono
quel poco che gli resta e s’imbarcano su un piroscafo diretto in America.
Arrivati a Seattle le loro condizioni non migliorano molto. Raffaele è un
ragazzino analfabeta che parla solo dialetto e non riesce a integrarsi. Quando
si iscrive alla Foster High School, passa solo l’esame di disegno meccanico
grazie alla sua adolescenza tra viti e bulloni. In giro ci sono i reclutatori a
caccia di carne fresca da mandare in Vietnam, e lui si arruola nella Quinta
divisione dei Marines con grande gioia dei suoi genitori, che non lo devono più
mantenere. Durante l’addestramento a Pendleton viene notato per la capacità e la
velocità di smontare e rimontare qualsiasi arma. Lo mandano al fronte appena
compiuti 18 anni, il 15 dicembre 1967. Ci passa tredici mesi, guadagnandosi
svariate decorazioni tra cui quella più ambita: sopravvivere. Tornato negli
Stati Uniti, scopre il rancore della popolazione nei confronti dei veterani. In
città viene trattato come un appestato, le donne lo evitano e gli studenti
hippie che sono riusciti a saltare la leva lo deridono e insultano. Sopporta
finché può, poi chiede allo Stato che gli vengano pagati gli arretrati, 200
dollari, e di essere trasferito in Italia. Negli uffici si piglia insulti
razzisti e viene trattato alla stregua di un accattone anche dai colleghi. Tra i
ricordi di guerra e l’atteggiamento della popolazione, Raffaele comincia a bere
fino all’alcolismo. Una notte sfonda la porta dello spaccio della caserma,
intenzionato a prendere il corrispettivo di ciò che gli spetta in cibo e alcool,
ma si addormenta. La mattina dopo lo sbattono in galera per 10 giorni, poi lo
reintegrano in attesa di essere processato dalla corte marziale il 29 ottobre
1969. Raffaele ci pensa bene, poi all’alba del 28 decide che non vuole essere
processato: vuole tornare a casa. Deve solo percorrere metà globo terrestre.
Alle 6.00 di mattina, nel campo militare, allunga un paio di bigliettoni a un
collega perché lo sostituisca, poi compra un fucile mitragliatore e va
all’aeroporto di Los Angeles. Compra un biglietto per San Francisco. Per un paio
d’ore tiene d’occhio il viavai all’ingresso, poi intercetta una hostess che gli
scocca un’occhiata interessante. Scatta in piedi e comincia a flirtarci. È così
bravo che lei lo fa entrare da un ingresso secondario evitando i controlli. A
furia di baci, carezze e petting, Raffaele guadagna la pista di decollo. A quel
punto si stacca dalla hostess ed entra in un Boeing 707 della TWA. Quando
mancano 15 minuti al decollo tira fuori il fucile, fa scendere anziani, bambini
e donne, poi prende in ostaggio il pilota e due hostess, Charlene Del Monico e
Tracey Coleman. Entrambe lo trovano estremamente affascinante. Tracey fa da
mediatrice sia con la torre di controllo che con il comandante. Dice che
poveretto, è tanto un bel ragazzo, vuole solo andare a New York. Il comandante
decolla sia perché il fucile è un’opinione con all’interno venti argomenti
solidi, sia perché se un uomo riesce a fare tutto questo solo emanando
testosterone vuoi vedere come va a finire. Atterrano a Denver per un
rifornimento, e Tracey convince Raffaele a liberare quel poco di ostaggi che
rimangono: lei e Charlene si offrono di restare a bordo. Raffaele afferma quale
sarà la meta finale dopo New York: Roma. Nessuno protesta, tutti obbediscono in
un’allegra atmosfera di gita fuoriporta. Fanno scalo per rifornirsi nello
sperduto aeroporto di Bangor, nel Maine, poi all’aeroporto di Shannon, in
Irlanda. Nel tragitto sono tutti così tranquilli che Raffaele molla il fucile
per andare in bagno, e quando torna lo trova lì dove l’aveva lasciato. Elabora
il piano di fuga definitivo. Mister Lovalova in salsa mediterranea spiega che
una volta atterrati a Fiumicino lui farà salire un funzionario di polizia
importante; usandolo come scudo umano scenderà dalla scaletta per poi salire
assieme a lui su una macchina. L’incredibile è che succede esattamente quanto
detto. Il vice questore Pietro Gulì, con le mani alzate e senza giacca, sale la
scaletta e obbedisce agli ordini. Raffaele saluta affettuosamente le ragazze e
il comandante, poi tenendo la canna del fucile piantata nella nuca del
vicequestore sale a bordo di una Giulietta parcheggiata in pista. Partono.
Quando Pietro gli domanda la destinazione, negli occhi di Raffaele passa un
lampo: «Napule» dice. Mentre percorrono l’Ardeatina, arrivati in piena campagna,
Raffaele ordina al vicequestore di fermarsi, poi scende e scompare nella
campagna di corsa. Polizia e Carabinieri lo braccano senza sosta, ma non c’è
verso. Le sue foto e la sua storia finiscono sulle prime pagine dei giornali di
tutto il mondo, e un prete nella chiesetta del Divino amore lo riconosce,
segnalandolo. Lo arrestano senza che lui opponga resistenza, e una volta
circondato da giornalisti e telecamere sentenzia un italianissimo “n’agg fatt
nient”. Invece viene processato per traffico di armi internazionale. Rinviato a
giudizio il 6 aprile 1970, viene condannato a sette anni di reclusione;
nonostante gli innumerevoli sforzi degli USA per riaverlo, l’estradizione non
viene mai concessa. Esce per buona condotta dopo aver scontato solo un anno e
mezzo. Scarcerato, trova la Fede e oggi è un cittadino libero, non senza che
Sylvester Stallone, impressionato dall’impresa, decida di scrivere un film
basandosi sul suo personaggio. Rambo.
Carlo Baroni per corriere.it il 20 marzo 2017. In quell’America
era bello starci, ma anche scappare via. Poteva succedere di tutto o non
muoversi niente. Era il tempo di scendere in piazza o di ascoltare musica per
una settimana. L’America che andava sulla Luna e quella che sprofondava nel
fango del Vietnam. La bandiera a stelle e strisce sventolava in entrambi i
luoghi. Impregnata di orgoglio e di odio. L’America di Raffaele Minichiello: già
nel nome il destino da emigrante. Un Paese per farsi accettare, magari
indossando una divisa. La sua era più pesante. Macchiata di sangue e di una
guerra che era difficile da far capire a un americano, figuriamoci a chi lo
stava diventando. Il marine di Pier Luigi Vercesi (Mondadori) è la storia di un
ragazzo che, forse, non amava né i Beatles, né i Rolling Stones. E che è passato
alla storia per essere stato il primo a dirottare un aereo, tre mesi dopo lo
sbarco sulla Luna, quando niente sembrava impossibile. Anche se lui sostiene che
qualcuno ci aveva provato prima di lui. Però è solo il suo nome che è rimasto.
Anche perché il suo resta il più lungo dirottamento: da Los Angeles a Denver, da
Denver a New York, da New York a Bangor, nel Maine; poi Shannon, Irlanda; infine
l’atterraggio a Roma. Totale: 10.941 chilometri. Era venuto via da un paesino
del Sud Italia, Melito Irpino. L’anno, il 1963, e lui un adolescente. Qualche
giorno prima la terra aveva tremato ancora. Ci dovevi convivere con il
terremoto. Oppure decidere di andare via. Lontano. Dall’altra parte del mondo.
In un posto da dove non ti veniva voglia di tornare. Chi emigrava diventava un
altro. Come se cominciasse una nuova vita. Una seconda possibilità. Nella sua
casa in Irpinia non c’era neanche l’elettricità. Quelli che se ne erano già
andati descrivevano gli Stati Uniti come il Paese del Bengodi. E pensare che non
erano andati oltre New York. Raffaele aveva scavalcato un continente per finire
a Seattle. Prima di Bill Gates, prima che diventasse un posto trendy. Gli Usa
dove bastavano qualche idea e tanta buona volontà per farsi una casa e vivere
senza preoccupazioni. Raffaele si fa la solita trafila di chi chiede di avere
poco, che è già meglio del niente che si lascia dietro. L’America ti dà sempre
una possibilità, ma attento a non farti fregare. Sbagli e torni ad essere un
paisà, l’italiano che, se va bene, vuol dire spaghetti e mandolino, altrimenti è
solo mafia. Raffaele ha la faccia di un James Dean di provincia e magari anche
lo stesso destino contorto. La guerra è un’opportunità. Lui non si chiede se sia
giusta o sbagliata. È il suo grazie al Paese che l’ha ospitato. Quelli della sua
età gli sputano addosso. Ma sono i figli di papà che possono permettersi
l’università e i capelli lunghi. Tanto a difendere i loro privilegi ci saranno
sempre i fessi come Raffaele. Che magari ci credono, pensano che per il salto
sociale basti imbracciare un fucile. Ma il Vietnam non è solo parate e gesti
eroici. I berretti verdi di John Wayne e gli assalti con gli elicotteri. Ci sono
le stragi di civili. Quelli che il giorno prima ti ballavano sui piedi e
ridevano se provavi a mangiare il riso. Il nemico che, visto da vicino, non ti
viene più voglia di sparargli e capisci che cosa significa propaganda. Magari
diventi qualunquista, ma almeno cerchi di aprire gli occhi. Quando torna
Raffaele non è più lo stesso, ma ci crede ancora. Adesso fa l’addestratore per
le future reclute. La svolta è un impiegato sgarbato. Di quelli che ti
rispondono male e a te basterebbe una parola cortese. Duecento dollari che
ballano nella sua paga. Duecento dollari in meno e a lui questo non va giù. Non
è per i soldi. Ma l’idea di essere preso in giro, considerato meno che niente.
Così li ruba dallo spaccio. C’è la denuncia. E poi la possibile, probabile corte
marziale. Fango sulla divisa che non viene via. Un errore e tutto il buono fatto
prima non conta più niente. La vita è ingiusta, pensa Raffaele. E chissà forse i
ragazzi di Woodstock, che a lui sembravano un po’ storditi, hanno capito tutto.
Il mondo è dei furbi. Che non sono mai intelligenti. Per questo le cose girano
sempre nella maniera sbagliata. Quando sale sul volo Los Angeles-San Francisco,
ha in mente tutto, ma non sa niente. Ha un fucile che mette paura e la sorpresa
è così grande che si fatica a pensare al peggio. Dicono che persino una hostess,
Tracey Coleman, si innamori di lui. Pensano sia un pazzo, un ex marine
svalvolato. L’aereo torna a «casa». Sbarca a Roma, Raffaele chiede un’auto e
fugge. Lo catturano nel santuario del Divino Amore, riconosciuto da un
sacerdote. Ha la fortuna di incontrare un poliziotto sicuro di poterlo prendere
senza andare per le spicce che vuol dire sparare, uccidere. Anni dopo diranno
che è stato un gesto da Rambo, a Vercesi ricorda più Forrest Gump. L’ingenuità,
il candore di chi cambia la storia con gesti lievi e dirompenti.
Stefano Montefiori per il “Corriere della Sera” il 5 ottobre
2020. «Dico sempre ai miei amici che se cominciamo a verificare la vita di ogni
artista, non resterà granché al Louvre». Queste parole di saggezza, dubbiose
sull' utilità della cancel culture , arrivano oggi dalla Normandia, dove da 35
anni vive in esilio l' ex «Black Panther» che con la moglie dirottò verso
Algeri, nel 1972, il volo Delta 841 tra Detroit e Miami. L' incredibile storia
di Melvin e Jean McNair torna alla luce in questi giorni di manifestazioni in
tutto il mondo in solidarietà con il movimento Black Lives Matter. La società
americana non è cambiata abbastanza rispetto a quando Melvin McNair aderì al
Black Panther Party, alla fine degli anni Sessanta. Si è trasformata invece la
sua vita: dal ghetto in Carolina del Nord alla lotta politica estrema contro la
segregazione, a una vita tranquilla di assistente sociale a Caen, capoluogo del
Calvados a 6.000 km dalla patria abbandonata nel 1972, dove non potrà mai più
tornare. Melvin McNair nasce nel quartiere nero di Greensboro 72 anni fa. Perde
il padre a quattro anni, viene allevato dalla madre e dallo zio Joe, «il primo
poliziotto nero della nostra città». La prima volta che da bambino esce dal
ghetto e con la madre entra in un grande magazzino, Melvin sale sulla scala
mobile ma viene rimbrottato e insultato come «negro». È la prima umiliazione
indelebile, alla quale seguiranno quelle inflitte da commilitoni del Ku Klux
Klan durante il servizio militare a Berlino. Melvin è un ottimo studente,e
grazie al baseball ha una borsa di studio all' università. Ma al momento di
partire per la guerra del Vietnam, come Mohammed Alì considera che «nessun
vietcong mi ha mai chiamato negro», diserta ed entra nelle Pantere Nere con la
moglie Jean. Sono convinti: per loro non ci sarà mai un futuro negli Stati Uniti
d' America. Il 31 luglio 1972 Melvin e Jean McNair con tre complici danno il via
al primo e unico dirottamento della loro carriera di rivoluzionari. Con una
pistola nascosta dentro una Bibbia svuotata dalle pagine fanno atterrare il DC-8
con 100 passeggeri a Boston. Chiedono il pieno, un milione di dollari e panini.
Dopo un volo al suono di Stevie Wonder atterrano - senza spari né vittime - a
Algeri, all' epoca terra promessa dei militanti anti-imperialisti. Fuggiranno
poi in Francia, che nega l'estradizione. A Parigi il processo ai dirottatori
diventa un processo al razzismo, Melvin e Jean trovano l'aiuto di Jean-Paul
Sartre, James Baldwin, Yves Montand e Simone Signoret. Dopo pochi mesi di
carcere, i Mc Nair vivranno il resto dei loro giorni alla periferia di Caen,
come assistenti sociali al servizio dei ragazzi in difficoltà. Jean è morta nel
2014, e Le Monde racconta che in suo onore pochi giorni fa a Caen è stata
scoperta una targa. Melvin, pantera nera di Normandia, non violento da decenni,
segue i moti di piazza e le elezioni americane alla Cnn.
Usa, 23 anni in carcere: aveva rubato delle cesoie da
giardino. Le Iene News il 17 ottobre 2020. All’uomo,
che adesso ha 63 anni, è stata concessa pochi giorni fa la libertà vigilata. Era
stato condannato all’ergastolo perché recidivo, come prevede il sistema
giuridico della Lousiana. Un ergastolo per aver rubato delle cesoie per tagliare
le siepi. Siamo in Louisiana, Usa, dove ora all’uomo, che ha passato 23 anni in
carcere, è stata concessa la libertà vigilata. Come riporta Cbs News, Fair Wayne
Bryant era stato condannato all’ergastolo nel 1997 per aver rubato delle cesoie
da un garage. Il fatto che Bryant avesse alle spalle già 4 condanne, di cui una
per un crimine violento, ovvero un tentativo di rapina a mano armata, ha fatto
sì che per lui si attivasse lo stato di “recidivo” previsto dal sistema
giuridico della Louisiana. Il caso aveva attirato poco tempo fa l’attenzione per
il disappunto della presidente della Corte Suprema della Louisiana, unico membro
di colore della corte, che si era espressa in senso contrario al mantenimento
della sentenza. Gli altri cinque membri avevano invece votato a favore. La
presidente aveva scritto che la sentenza “era ampiamente sproporzionata al
crimine e non serviva uno scopo penale legittimo”. Ma stavolta, con tre voti a
favore e zero contrari, il “Committee on Parole” ha concesso la libertà vigilata
a Bryant. L’Associated Press riporta che né la severità della sentenza né le sue
implicazioni razziali sono state affrontate dalla commissione. I membri, due
bianchi e un afroamericano, si sarebbero concentrati sulla lunga fedina penale
di Bryant e sulla sua storia di abuso di droga e alcool. “Ho avuto un problema
di droga”, avrebbe ammesso l’uomo, come riporta l’Associated Press. “Ma ho avuto
24 anni per riconoscere il problema e comunicare con il Signore affinché mi
aiutasse”. I membri hanno preso in considerazione l’assenza di problemi
disciplinari in prigione e la sua partecipazione ai programmi per persone con
problemi di droga prima di concedere la libertà vigilata.
DAGONEWS il 17 ottobre 2020. Un uomo mostra la sua schiena
ricoperta di cicatrici. Il risultato delle ferite provocate dalle frustrate del
padrone. È solo una delle diapositive restaurate che ci sbattono in faccia la
straziante vita degli schiavi americani del 19° secolo. Alle immagini, in
origine in bianco e nero, è stato donato il colore per rendere ancora più
scioccante e vivido il ricordo di una ferita nella storia americana che
difficilmente potrà rimarginarsi. Tra le immagini c’è un negozio dei orrori dove
venivano fatte le vendite e le aste degli schiavi neri e una coppia con i
vestiti sporchi e lisi dopo la fuga dal loro padrone. «Credo che dare colore a
una foto apra una finestra sulla storia di queste persone che ci può aiutare a
capire il mondo di oggi» ha detto il restauratore Tom Marshall. Le immagini sono
state scattate nel 1850 e mostrano le terribili condizioni in cui erano
sottoposti gli schiavi fino al 1865 quando la barbara pratica fu resa illegale.
«I have a dream», il discorso integrale di Martin Luther King
del 28 agosto 1963. Il testo dello storico discorso
tenuto da Martin Luther King al termine della marcia sui diritti civili a
Washington. Pubblicato il 28 agosto 2020 su Il Corriere della Sera. Oggi sono
felice di essere con voi in quella che nella storia sarà ricordata come la più
grande manifestazione per la libertà nella storia del nostro paese. Un secolo
fa, un grande americano, che oggi getta su di noi la sua ombra simbolica, firmò
il Proclama dell’emancipazione. Si trattava di una legge epocale, che accese un
grande faro di speranza per milioni di schiavi neri, marchiati dal fuoco di una
bruciante ingiustizia. Il proclama giunse come un’aurora di gioia, che metteva
fine alla lunga notte della loro cattività. Ma oggi, e sono passati cento anni,
i neri non sono ancora liberi. Sono passati cento anni, e la vita dei neri é
ancora paralizzata dalle pastoie della segregazione e dalle catene della
discriminazione. Sono passati cento anni, e i neri vivono in un’isola solitaria
di povertà, in mezzo a un immenso oceano di benessere materiale. Sono passati
cento anni, e i neri ancora languiscono negli angoli della società americana, si
ritrovano esuli nella propria terra. Quindi oggi siamo venuti qui per
tratteggiare a tinte forti una situazione vergognosa. In un certo senso, siamo
venuti nella capitale del nostro paese per incassare un assegno. Quando gli
architetti della nostra repubblica hanno scritto le magnifiche parole della
Costituzione e della Dichiarazione d’indipendenza, hanno firmato un “pagherò” di
cui ciascun americano era destinato a ereditare la titolarità. Il “pagherò”
conteneva la promessa che a tutti gli uomini, sì, ai neri come ai bianchi,
sarebbero stati garantiti questi diritti inalienabili: “vita, libertà e ricerca
della felicità”. Oggi appare evidente che per quanto riguarda i cittadini
americani di colore, l’America ha mancato di onorare il suo impegno debitorio.
Invece di adempiere a questo sacro dovere, l’America ha dato al popolo nero un
assegno a vuoto, un assegno che é tornato indietro, con la scritta “copertura
insufficiente”. Ma noi ci rifiutiamo di credere che la banca della giustizia sia
in fallimento. Ci rifiutiamo di credere che nei grandi caveau di opportunità di
questo paese non vi siano fondi sufficienti. E quindi siamo venuti a incassarlo,
questo assegno, l’assegno che offre, a chi le richiede, la ricchezza della
libertà e la garanzia della giustizia. Siamo venuti in questo luogo consacrato
anche per ricordare all’America l’infuocata urgenza dell’oggi. Quest’ora non é
fatta per abbandonarsi al lusso di prendersela calma o di assumere la droga
tranquillante del gradualismo. Adesso ’ il momento di tradurre in realtà le
promesse della democrazia. Adesso é il momento di risollevarci dalla valle buia
e desolata della segregazione fino al sentiero soleggiato della giustizia
razziale. Adesso é il momento di sollevare la nostra nazione dalle sabbie mobili
dell’ingiustizia razziale per collocarla sulla roccia compatta della fraternità.
Adesso é il momento di tradurre la giustizia in una realtà per tutti i figli di
Dio. Se la nazione non cogliesse l’urgenza del presente, le conseguenze
sarebbero funeste.
L’afosa estate della legittima insoddisfazione dei negri non
finirà finché non saremo entrati nel frizzante autunno della libertà e
dell’uguaglianza. Il 1963 non é una fine, é un principio. Se la nazione tornerà
all’ordinaria amministrazione come se niente fosse accaduto, chi sperava che i
neri avessero solo bisogno di sfogarsi un pò e poi se ne sarebbero rimasti
tranquilli rischia di avere una brutta sorpresa. In America non ci sarà né
riposo né pace finché i neri non vedranno garantiti i loro diritti di
cittadinanza. I turbini della rivolta continueranno a scuotere le fondamenta
della nostra nazione finché non spunterà il giorno luminoso della giustizia. *
Ma c’é qualcosa che devo dire al mio popolo, fermo su una soglia rischiosa, alle
porte del palazzo della giustizia: durante il processo che ci porterà a ottenere
il posto che ci spetta di diritto, non dobbiamo commettere torti. Non cerchiamo
di placare la sete di libertà bevendo alla coppa del rancore e dell’odio.
Dobbiamo sempre condurre la nostra lotta su un piano elevato di dignità e
disciplina. Non dobbiamo permettere che la nostra protesta creativa degeneri in
violenza fisica. Sempre, e ancora e ancora, dobbiamo innalzarci fino alle vette
maestose in cui la forza fisica s’incontra con la forza dell’anima. Il nuovo e
meraviglioso clima di combattività di cui oggi é impregnata l’intera comunità
nera non deve indurci a diffidare di tutti i bianchi, perché molti nostri
fratelli bianchi, come attesta oggi la loro presenza qui, hanno capito che il
loro destino é legato al nostro. Hanno capito che la loro libertà si lega con un
nodo inestricabile alla nostra. Non possiamo camminare da soli. E mentre
camminiamo, dobbiamo impegnarci con un giuramento: di proseguire sempre avanti.
Non possiamo voltarci indietro. C’é chi domanda ai seguaci dei diritti civili:
“Quando sarete soddisfatti?”. Non potremo mai essere soddisfatti, finché i neri
continueranno a subire gli indescrivibili orrori della brutalità poliziesca. Non
potremo mai essere soddisfatti, finché non riusciremo a trovare alloggio nei
motel delle autostrade e negli alberghi delle città, per dare riposo al nostro
corpo affaticato dal viaggio. Non potremo mai essere soddisfatti, finché tutta
la facoltà di movimento dei neri resterà limitata alla possibilità di
trasferirsi da un piccolo ghetto a uno più grande. Non potremo mai essere
soddisfatti, finché i nostri figli continueranno a essere spogliati
dell’identità e derubati della dignità dai cartelli su cui sta scritto
“Riservato ai bianchi”. Non potremo mai essere soddisfatti, finché i neri del
Mississippi non potranno votare e i neri di New York crederanno di non avere
niente per cui votare.
No, no, non siamo soddisfatti e non saremo mai
soddisfatti, finché la giustizia non scorrerà come l’acqua, e la rettitudine
come un fiume in piena. Io non dimentico che alcuni fra voi sono venuti qui dopo
grandi prove e tribolazioni. Alcuni di voi hanno lasciato da poco anguste celle
di prigione. Alcuni di voi sono venuti da zone dove ricercando la libertà sono
stati colpiti dalle tempeste della persecuzione e travolti dai venti della
brutalità poliziesca. Siete i reduci della sofferenza creativa. Continuate il
vostro lavoro, nella fede che la sofferenza immeritata ha per frutto la
redenzione. Tornate nel Mississippi, tornate nell’Alabama, tornate nella
Carolina del Sud, tornate in Georgia, tornate in Louisiana, tornate alle
baraccopoli e ai ghetti delle nostre città del Nord, sapendo che in qualche modo
questa situazione può cambiare e cambierà. * Non indugiamo nella valle della
disperazione. Oggi, amici miei, vi dico: anche se dobbiamo affrontare le
difficoltà di oggi e di domani, io continuo ad avere un sogno. E un sogno che ha
radici profonde nel sogno americano. Ho un sogno, che un giorno questa nazione
sorgerà e vivrà il significato vero del suo credo: noi riteniamo queste verità
evidenti di per sé, che tutti gli uomini sono creati uguali. Ho un sogno, che un
giorno sulle rosse montagne della Georgia i figli degli ex schiavi e i figli
degli ex padroni di schiavi potranno sedersi insieme alla tavola della
fraternità. Ho un sogno, che un giorno perfino lo stato del Mississippi, dove si
patisce il caldo afoso dell’ingiustizia, il caldo afoso dell’oppressione, si
trasformerà in un’oasi di libertà e di giustizia. Ho un sogno, che i miei
quattro bambini un giorno vivranno in una nazione in cui non saranno giudicati
per il colore della pelle, ma per l’essenza della loro personalità. Oggi ho un
sogno. Ho un sogno, che un giorno, laggiù nell’Alabama, dove i razzisti sono più
che mai accaniti, dove il governatore non parla d’altro che di potere di
compromesso interlocutorio e di nullification delle leggi federali, un giorno,
proprio là nell’Alabama, i bambini neri e le bambine nere potranno prendere per
mano bambini bianchi e bambine bianche, come fratelli e sorelle. Oggi ho un
sogno. Ho un sogno, che un giorno ogni valle sarà innalzata, ogni monte e ogni
collina saranno abbassati, i luoghi scoscesi diventeranno piani, e i luoghi
tortuosi diventeranno diritti, e la gloria del Signore sarà rivelata, e tutte le
creature la vedranno insieme.
Questa é la nostra speranza. Questa é la fede che porterò con me
tornando nel Sud. Con questa fede potremo cavare dalla montagna della
disperazione una pietra di speranza. Con questa fede potremo trasformare le
stridenti discordanze della nostra nazione in una bellissima sinfonia di
fraternità. Con questa fede potremo lavorare insieme, pregare insieme, lottare
insieme, andare in prigione insieme, schierarci insieme per la libertà, sapendo
che un giorno saremo liberi. Quel giorno verrà, quel giorno verrà quando tutti i
figli di Dio potranno cantare con un significato nuovo: “Patria mia, é di te,
dolce terra di libertà, é di te che io canto. Terra dove sono morti i miei
padri, terra dell’orgoglio dei Pellegrini, da ogni vetta riecheggi libertà”. E
se l’America vuol essere una grande nazione, bisogna che questo diventi vero. E
dunque, che la libertà riecheggi dalle straordinarie colline del New Hampshire.
Che la libertà riecheggi dalle possenti montagne di New York. Che la libertà
riecheggi dagli elevati Allegheny della Pennsylvania. Che la libertà riecheggi
dalle innevate Montagne Rocciose del Colorado. Che la libertà riecheggi dai
pendii sinuosi della California. Ma non soltanto. Che la libertà riecheggi dalla
Stone Mountain della Georgia. Che la libertà riecheggi dalla Lookout Mountain
del Tennessee. Che la libertà riecheggi da ogni collina e da ogni formicaio del
Mississippi, da ogni vetta, che riecheggi la libertà. E quando questo avverrà,
quando faremo riecheggiare la libertà, quando la lasceremo riecheggiare da ogni
villaggio e da ogni paese, da ogni stato e da ogni città, saremo riusciti ad
avvicinare quel giorno in cui tutti i figli di Dio, neri e bianchi, ebrei e
gentili, protestanti e cattolici, potranno prendersi per mano e cantare le
parole dell’antico inno: “Liberi finalmente, liberi finalmente. Grazie a Dio
Onnipotente, siamo liberi finalmente”.
CON TRADUZIONE DIFFERENTE
«I have a dream», lo storico discorso di Martin Luther King in
difesa dei diritti civili. Pubblicato da Il Dubbio il
28 agosto 2020. Le parole pronunciate dal più celebre leader delle battaglie per
i diritti dei neri negli Usa al termine della marcia di protesta a Washington,
il 28 agosto 1963. Il famoso discorso pronunciato da Martin Luther King, il più
celebre leader delle battaglie per i diritti civili dei neri negli Stati Uniti,
al termine della marcia di protesta a Washington, il 28 agosto 1963. Sono felice
di unirmi a voi in questa che passerà alla storia come la più grande
dimostrazione per la libertà nella storia del nostro paese. Cento anni fa un
grande americano, alla cui ombra ci leviamo oggi, firmò il Proclama
sull’Emancipazione. Questo fondamentale decreto venne come un grande faro di
speranza per milioni di schiavi negri che erano stati bruciati sul fuoco
dell’avida ingiustizia. Venne come un’alba radiosa a porre termine alla lunga
notte della cattività. Ma cento anni dopo, il negro ancora non è libero; cento
anni dopo, la vita del negro è ancora purtroppo paralizzata dai ceppi della
segregazione e dalle catene della discriminazione; cento anni dopo, il negro
ancora vive su un’isola di povertà solitaria in un vasto oceano di prosperità
materiale; cento anni dopo; il negro langue ancora ai margini della società
americana e si trova esiliato nella sua stessa terra. Per questo siamo venuti
qui, oggi, per rappresentare la nostra condizione vergognosa. In un certo senso
siamo venuti alla capitale del paese per incassare un assegno. Quando gli
architetti della repubblica scrissero le sublimi parole della Costituzione e la
Dichiarazione d’Indipendenza, firmarono un “pagherò” del quale ogni americano
sarebbe diventato erede. Questo “pagherò” permetteva che tutti gli uomini, si, i
negri tanto quanto i bianchi, avrebbero goduto dei principi inalienabili della
vita, della libertà e del perseguimento della felicità. E’ ovvio, oggi, che
l’America è venuta meno a questo “pagherò” per ciò che riguarda i suoi cittadini
di colore. Invece di onorare questo suo sacro obbligo, l’America ha consegnato
ai negri un assegno fasullo; un assegno che si trova compilato con la frase:
“fondi insufficienti”. Noi ci rifiutiamo di credere che i fondi siano
insufficienti nei grandi caveau delle opportunità offerte da questo paese. E
quindi siamo venuti per incassare questo assegno, un assegno che ci darà, a
presentazione, le ricchezze della libertà e della garanzia di giustizia. Siamo
anche venuti in questo santuario per ricordare all’America l’urgenza
appassionata dell’adesso. Questo non è il momento in cui ci si possa permettere
che le cose si raffreddino o che si trangugi il tranquillante del gradualismo.
Questo è il momento di realizzare le promesse della democrazia; questo è il
momento di levarsi dall’oscura e desolata valle della segregazione al sentiero
radioso della giustizia.; questo è il momento di elevare la nostra nazione dalle
sabbie mobili dell’ingiustizia razziale alla solida roccia della fratellanza;
questo è il tempo di rendere vera la giustizia per tutti i figli di Dio. Sarebbe
la fine per questa nazione se non valutasse appieno l’urgenza del momento.
Questa estate soffocante della legittima impazienza dei negri non finirà fino a
quando non sarà stato raggiunto un tonificante autunno di libertà ed
uguaglianza. Il 1963 non è una fine, ma un inizio. E coloro che sperano che i
negri abbiano bisogno di sfogare un poco le loro tensioni e poi se ne staranno
appagati, avranno un rude risveglio, se il paese riprenderà a funzionare come se
niente fosse successo. Non ci sarà in America né riposo né tranquillità fino a
quando ai negri non saranno concessi i loro diritti di cittadini. I turbini
della rivolta continueranno a scuotere le fondamenta della nostra nazione fino a
quando non sarà sorto il giorno luminoso della giustizia. Ma c’è qualcosa che
debbo dire alla mia gente che si trova qui sulla tiepida soglia che conduce al
palazzo della giustizia. In questo nostro procedere verso la giusta meta non
dobbiamo macchiarci di azioni ingiuste. Cerchiamo di non soddisfare la nostra
sete di libertà bevendo alla coppa dell’odio e del risentimento. Dovremo per
sempre condurre la nostra lotta al piano alto della dignità e della disciplina.
Non dovremo permettere che la nostra protesta creativa degeneri in violenza
fisica. Dovremo continuamente elevarci alle maestose vette di chi risponde alla
forza fisica con la forza dell’anima. Questa meravigliosa nuova militanza che ha
interessato la comunità negra non dovrà condurci a una mancanza di fiducia in
tutta la comunità bianca, perché molti dei nostri fratelli bianchi, come prova
la loro presenza qui oggi, sono giunti a capire che il loro destino è legato col
nostro destino, e sono giunti a capire che la loro libertà è inestricabilmente
legata alla nostra libertà. Questa offesa che ci accomuna, e che si è fatta
tempesta per le mura fortificate dell’ingiustizia, dovrà essere combattuta da un
esercito di due razze. Non possiamo camminare da soli. E mentre avanziamo,
dovremo impegnarci a marciare per sempre in avanti. Non possiamo tornare
indietro. Ci sono quelli che chiedono a coloro che chiedono i diritti civili:
“Quando vi riterrete soddisfatti?” Non saremo mai soddisfatti finché il negro
sarà vittima degli indicibili orrori a cui viene sottoposto dalla polizia. Non
potremo mai essere soddisfatti finché i nostri corpi, stanchi per la fatica del
viaggio, non potranno trovare alloggio nei motel sulle strade e negli alberghi
delle città. Non potremo essere soddisfatti finché gli spostamenti sociali
davvero permessi ai negri saranno da un ghetto piccolo a un ghetto più grande.
Non potremo mai essere soddisfatti finché i nostri figli saranno
privati della loro dignità da cartelli che dicono: “Riservato ai bianchi”. Non
potremo mai essere soddisfatti finché i negri del Mississippi non potranno
votare e i negri di New York crederanno di non avere nulla per cui votare. No,
non siamo ancora soddisfatti, e non lo saremo finché la giustizia non scorrerà
come l’acqua e il diritto come un fiume possente. Non ha dimenticato che alcuni
di voi sono giunti qui dopo enormi prove e tribolazioni. Alcuni di voi sono
venuti appena usciti dalle anguste celle di un carcere. Alcuni di voi sono
venuti da zone in cui la domanda di libertà ci ha lasciato percossi dalle
tempeste della persecuzione e intontiti dalle raffiche della brutalità della
polizia. Siete voi i veterani della sofferenza creativa. Continuate ad operare
con la certezza che la sofferenza immeritata è redentrice. Ritornate nel
Mississippi; ritornate in Alabama; ritornate nel South Carolina; ritornate in
Georgia; ritornate in Louisiana; ritornate ai vostri quartieri e ai ghetti delle
città del Nord, sapendo che in qualche modo questa situazione può cambiare, e
cambierà. Non lasciamoci sprofondare nella valle della disperazione. E perciò,
amici miei, vi dico che, anche se dovrete affrontare le asperità di oggi e di
domani, io ho sempre davanti a me un sogno. E’ un sogno profondamente radicato
nel sogno americano, che un giorno questa nazione si leverà in piedi e vivrà
fino in fondo il senso delle sue convinzioni: noi riteniamo ovvia questa verità,
che tutti gli uomini sono creati uguali. Io ho davanti a me un sogno, che un
giorno sulle rosse colline della Georgia i figli di coloro che un tempo furono
schiavi e i figli di coloro che un tempo possedettero schiavi, sapranno sedere
insieme al tavolo della fratellanza. Io ho davanti a me un sogno, che un giorno
perfino lo stato del Mississippi, uno stato colmo dell’arroganza
dell’ingiustizia, colmo dell’arroganza dell’oppressione, si trasformerà in
un’oasi di libertà e giustizia. Io ho davanti a me un sogno, che i miei quattro
figli piccoli vivranno un giorno in una nazione nella quale non saranno
giudicati per il colore della loro pelle, ma per le qualità del loro carattere.
Ho davanti a me un sogno, oggi!. Io ho davanti a me un sogno, che un giorno ogni
valle sarà esaltata, ogni collina e ogni montagna saranno umiliate, i luoghi
scabri saranno fatti piani e i luoghi tortuosi raddrizzati e la gloria del
Signore si mostrerà e tutti gli essere viventi, insieme, la vedranno. E’ questa
la nostra speranza. Questa è la fede con la quale io mi avvio verso il Sud. Con
questa fede saremo in grado di strappare alla montagna della disperazione una
pietra di speranza. Con questa fede saremo in grado di trasformare le stridenti
discordie della nostra nazione in una bellissima sinfonia di fratellanza. Con
questa fede saremo in grado di lavorare insieme, di pregare insieme, di lottare
insieme, di andare insieme in carcere, di difendere insieme la libertà, sapendo
che un giorno saremo liberi. Quello sarà il giorno in cui tutti i figli di Dio
sapranno cantare con significati nuovi: paese mio, di te, dolce terra di
libertà, di te io canto; terra dove morirono i miei padri, terra orgoglio del
pellegrino, da ogni pendice di montagna risuoni la libertà; e se l’America vuole
essere una grande nazione possa questo accadere.
Risuoni quindi la libertà dalle poderose montagne dello stato di
New York.
Risuoni la libertà negli alti Allegheny della Pennsylvania.
Risuoni la libertà dalle Montagne Rocciose del Colorado,
imbiancate di neve.
Risuoni la libertà dai dolci pendii della California.
Ma non soltanto.
Risuoni la libertà dalla Stone Mountain della Georgia.
Risuoni la libertà dalla Lookout Mountain del Tennessee.
Risuoni la libertà da ogni monte e monticello del Mississippi. Da
ogni pendice risuoni la libertà.
E quando lasciamo risuonare la libertà, quando le permettiamo di
risuonare da ogni villaggio e da ogni borgo, da ogni stato e da ogni città,
acceleriamo anche quel giorno in cui tutti i figli di Dio, neri e bianchi, ebrei
e gentili, cattolici e protestanti, sapranno unire le mani e cantare con le
parole del vecchio spiritual: “Liberi finalmente, liberi finalmente; grazie Dio
Onnipotente, siamo liberi finalmente”.
DAGONEWS il 22 agosto 2020. Juliana Calistri, 46 anni, è
cresciuta a Chicago, ma ha sempre respirato aria italiana in casa. I nonni sono
cresciuti a Bagni di Lucca, in Italia, e sebbene suo padre fosse nato a Chicago,
ha imparato a parlare prima l’italiano che l’inglese. Ha sempre voluto ottenere
la cittadinanza italiana, ma secondo le leggi italiane, alle donne di
discendenza italiana nate all'estero, fino ad oggi era riconosciuta la facoltà
di trasmettere la cittadinanza solo ai figli nati dopo il 1 gennaio del 1948,
ovvero dopo l'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Il padre di Juliana
è nato nel ’47 e quindi non ha potuto ottenere la cittadinanza rinunciando negli
anni a lottare. Ma Juliana durante il lockdown ha capito che non doveva
arrendersi ed è arrivata alla storica sentenza del 2009 che aveva dato ragione a
chi si era opposta alla legge sul lignaggio materno. Ha contattato Italian
Citizenship Assistance, un'agenzia che aiuta le persone a ottenere i passaporti
italiani e si è unita a centinaia di altre persone che hanno contattato
l'agenzia negli ultimi mesi. Marco Permunian, il fondatore, ha raccontato: «Il
numero di persone che ci ha contattato tra maggio è aumentata di cinque volte
rispetto allo scorso anno». Juliana, infatti, è solo una delle tante persone,
figli di immigrati che sogna di tornare in Italia. Sognano di ritrovare la
libertà perduta nel loro Paese dopo che la pandemia e la politica degli ultimi
anni hanno mandato in frantumi i sogni di libertà degli immigrati. Ma la verità
è che avere un passaporto europeo è una sorta di polizza assicurativa, un modo
per garantire la libertà di movimento in futuro. Alcune nazioni, come Cipro,
Santa Lucia, Grenada, Malta, Turchia e Montenegro, offrono la cittadinanza a
persone che acquistano proprietà all'interno dei loro confini o investono. Altri
la offrono ai figli e ai nipoti di immigrati. Nell’ultimo periodo la richiesta
di cittadinanza per discendenza è diventata popolare tra gli americani con
radici in altri paesi. Ma nella maggior parte del mondo, la cittadinanza per
discendenza familiare è difficile o meno vantaggiosa da ottenere per un titolare
di passaporto statunitense, perché la cittadinanza viene trasmessa solo da
genitore a figlio, perché il paese non consente la doppia cittadinanza (il che
significa che l'americano dovrebbe rinunciare alla sua cittadinanza americana) o
perché il secondo passaporto non offre vantaggi come opzioni di viaggio ampliate
o istruzione gratuita. Ma chi punta sull’Italia non ci rinuncia facilmente. La
signora Triola, direttrice marketing di Wethos che vive a Los Angeles, ha
iniziato a cercare di ottenere la cittadinanza italiana nel 2018, ma ha lasciato
stare il progetto dopo aver avuto difficoltà a rintracciare i documenti e i
certificati dei nonni. Ma di recente, ha deciso di riprendere in mano la sua
domanda: «Sembra che ci sia più libertà se sei un cittadino UE». «Assistenza
sanitaria a prezzi accessibili e congedo parentale retribuito garantito sono
altri vantaggi dell'avere una cittadinanza italiana» ha continuato Triola. Dave
Gallo, 73 anni, un pensionato di San Francisco, ha avviato la procedura di
richiesta della cittadinanza italiana nel 2017 ed è stata approvata nel febbraio
di quest'anno. La pandemia ha confermato che ha fatto la scelta giusta: «A San
Francisco, non c'è niente per gli anziani tranne le case di riposo». Dopo aver
visitato l'Italia per la prima volta nel 2015, il signor Gallo ha scoperto che
sette cugini vivono ancora nel paese dei suoi nonni. E adesso sogna di tornare a
vivere in quel paesino del nord Italia dove c’è poco traffico lì, il costo della
vita è più economico, è circondato da vigneti e si vive la socialità in modo
differente: «La pandemia ha creato così tanta incertezza che nessuno sa come
sarà la vita per i prossimi 10-15 anni. Per una persona anziana, sarà ancora più
difficile. Dove voglio trascorrere il resto della mia vita?». Per il signor
Gallo, la risposta è chiara: «l'Italia».
Silvia Morosi per corriere.it il 23 agosto 2020. Condanna
all'ergastolo per Joseph DeAngelo, il killer del «Golden State». DeAngelo, 74
anni, ex agente di polizia, è stato arrestato nel 2018 dopo che il suo dna è
stato trovato su un sito di genealogia. L’uomo, che ha patteggiato per evitare
la pena di morte, ha ammesso 13 omicidi, oltre a numerosi stupri, furti con
scasso e altri crimini. Il procuratore distrettuale della contea di Sacramento
Anne Marie Schubert lo ha definito un «sociopatico in azione». Dopo essere
rimasto in silenzio durante le testimonianze delle vittime di questa settimana,
riporta la Bbc, DeAngelo venerdì si è rivolto a coloro che erano in tribunale,
togliendosi la maschera e alzandosi da una sedia a rotelle per parlare, poco
prima che il giudice Michael Bowman leggesse la sentenza. «Ho ascoltato tutte le
dichiarazioni. Ognuna di esse. E mi dispiace per tutti quelli che ho ferito», ha
dichiarato DeAngelo. Le sue parole non hanno commosso il giudice che ha
affermato di aver pronunciato in questo caso «la pena assolutamente massima che
la corte può legalmente sentenziare»: undici condanne all’ergastolo, senza
possibilità di libertà condizionale. Le vittime di DeAngelo hanno testimoniato
per tre giorni, raccontando le loro terribili esperienze. «I sopravvissuti hanno
parlato con chiarezza: l’imputato non merita pietà», ha insistito il giudice
mentre in aula scoppiavano gli applausi. Patricia Murphy, che all’epoca della
violenza di DeAngelo non aveva nemmeno 30 anni (era il settembre del 1976), lo
descrisse come un «mostro senz’anima» in un testo letto da una delle sue figlie,
Patti Cosper. «Spero che marcisca in prigione», ha dichiarato proprio
quest’ultima. Il «Golden State killer» (tutti i suoi reati furono commessi in
California, il cui soprannome è appunto «The Golden State, ndr.) — ribattezzato
dai media anche « The original night stalker» — ha commesso decine di omicidi e
stupri tra il 1975 e il 1986. L’età delle sue vittime variava dai 14 anni. La
maggior parte dei suoi crimini ha avuto luogo intorno a Sacramento, ma alcuni
sono avvenuti nella Baia di San Francisco e nell’estremo sud della costa della
California, mentre si trasferiva con sua moglie. L’uomo faceva irruzione nelle
case delle sue vittime di notte. Spesso aggrediva le donne sole quando
dormivano, o le coppie, legandole e poi violentando le donne davanti ai loro
compagni. Per incastrarlo ci sono voluti il dna lasciato sulle scene dei crimini
e i controlli incrociati effettuati con informazioni genetiche su un membro
della famiglia del serial killer scoperto su un sito web dedicato alla
genealogia. È stato arrestato solo nel 2018, più di tre decenni dopo che aveva
posto fine alle sue violenze. Il primo stupro del «Golden State Killer» risale
al 18 giugno 1976: la vittima, Jane, stava dormendo con il figlio di 3 anni
mentre il marito era andato al lavoro. Un uomo mascherato entrò nella camera da
letto con un coltello da macellaio, legò madre e figlio, li bendò, e poi
violentò la donna. Da quel momento il killer è diventato uno degli uomini più
ricercati d’America.
Da corriere.it il 23 agosto 2020. Prima l’ictus a maggio, poi il
divorzio dalla moglie Shawn dopo 22 anni di matrimonio, infine la perdita di due
figli nel giro di tre settimane: è stato un anno terribile per Larry King, il
leggendario giornalista americano, volto storico della Cnn. Il bilancio di
questo periodo tremendo arriva via social. «È con grande tristezza e il cuore
spezzato di un padre che confermo la recente perdita di due dei miei figli, Andy
e Chaia King — ha postato scritto Larry — Erano anime buone e gentili, e ci
mancheranno moltissimo. Andy è morto all’improvviso per un attacco cardiaco il
28 luglio e Chaia è morta il 20 agosto, dopo che le era stato diagnosticato un
tumore ai polmoni. Perderli è così sbagliato. Nessun genitore dovrebbe mai
seppellire un figlio». King si è sposato 7 volte. Aveva avuto Chaia dalla ex
moglie Alene Akins, ed aveva adottato Andy, nato da un precedente matrimonio di
Alene. Ha altri tre figli, avuti dalla moglie Shawn: Larry Jr., Cannon e Chance.
Colpito da un forte ictus a maggio, tre mesi dopo King aveva chiesto il divorzio
da Shawn. Il giornalista ha condotto il talk show Larry King Live su Cnn dal
1985 al 2010. Attualmente conduce Larry King Now su Hulu e RT America, nonché il
domenicale Politicking with Larry King sugli stessi due canali online.
Da rainews.it il 13 agosto 2020. Le immagini che vi mostriamo
arrivano da Key West, in Florida. Un bambino di soli 8 anni viene fatto voltare,
perquisito e poi ammanettato dalla polizia. Il video è stato ripreso dalla
bodycam di un agente nel dicembre 2018, ma viene diffuso ora dal legale della
madre, che ora ha deciso di sporgere denuncia. Il bambino, inserito in un
programma di sostegno scolastico, avrebbe colpito un'insegnante. La polizia,
chiamata subito dopo, prova ad ammanettarlo con difficoltà, proprio per le
dimensioni dei suoi polsi, troppo piccoli per le manette. La polizia locale ha
fatto sapere che i due agenti hanno seguito le procedure. La madre del piccolo
ha poi raccontato che il figlio è stato non solo ammanettato, ma anche portato
in cella, dove gli sono state prese le impronte digitali e gli è stato fatto il
test del dna. Dopo nove mesi di battaglia legale il piccolo è stato scagionato
da ogni accusa
Florida, in manette un bimbo di 8 anni: proteste in rete per
il video shock dell’arresto. Il Dubbio il 13 agosto
2020. L’episodio risale a due anni, in una scuola di Key West. A diffondere il
filmato è l’avvocato di famiglia, che intende fare causa all’istituto e alle
autorità municipali. La polizia d’oltreoceano torna a far parlare di sé. Questa
volta per l’arresto di un bambino di 8 anni in un scuola di Key West, in
Florida. La scena è ripresa in un video diffuso in rete a due anni
dall’episodio: gli agenti provano a stringere le manette ai polsi troppo sottili
del piccolo studente, rivolto con la faccia verso il muro. L’avvocato della
famiglia, Ben Crump (conosciuto per aver rappresentato anche diversi casi di
afroamericani soggetti a discriminazioni o abusi da parte della polizia, come
quello di George Floyd), ha annunciato che intende far causa contro la città di
Key West, il distretto scolastico della contea di Monroe e gli ufficiali
incaricati dell’arresto, per conto della madre del minore. Il bambino, affetto
da disabilità, sarebbe stato lasciato alle cure di un insegnante supplente che
“non sapeva o non era preoccupato” per i suoi bisogni speciali. Il docente lo
avrebbe spinto a muoversi in una zona della scuola in cui lui non voleva e il
bambino avrebbe risposto in modo aggressivo scagliandosi contro l’adulto. A quel
punto, l’istituto avrebbe chiamato la polizia. Le immagini del filmato hanno
scatenato un’ondata di polemiche sui social network: i più si chiedono quale sia
l’aiuto terapeutico per il minore se è stato autorizzato dalla scuola
l’intervento della polizia e l’arresto del bambino.
La deriva degli Stati Uniti: se la patria delle libertà è una
fabbrica di detenuti. La popolazione carceraria
americana è la quarta metropoli del Paese: una cifra quadruplicata negli ultimi
40 anni. Lanfranco Caminiti su Il Dubbio il 12 agosto 2020. «Ehi boss, mi levo
la maglietta». «Ehi boss, sto togliendo il cappellino». Giocavamo così, se si
può dire, nell’ora d’aria al passeggio dei carceri speciali rivolgendoci alle
guardie sulle garitte – io e Valerio, mi pare fossimo a Badu ‘e Carros o a
Rebibbia, che ci piccavamo di ricordare tutte le migliori battute dei film e
siccome che non ce li facevano vedere provavamo a mantenerne il ricordo. Queste
erano in Nick Mano fredda, una delle più belle interpretazioni di Paul Newman –
e la scena, che si ripeteva, era di detenuti legati uno all’altro, la chain
gang, che lavoravano a pulire strade o campi sotto un sole cocente, e sudavano
come bestie, sorvegliati da guardie con il fucile sempre pronto a sparare, e
ogni piccola mossa del corpo che facevano, ogni scarto dei gesti oltre quelli
del lavoro, dovevano prima comunicarla al boss, lo sceriffo che sovrintendeva.
Noi non lavoravamo, ma eravamo lo stesso come bestie guardate a vista. Oppure,
sempre da quel film lì, quando venivano a buttarci giù dalle brande di notte per
la “perquisa” e mettere tutto sottosopra con sadismo, e noi provavamo a dire di
no, ci stava da dio la battuta al capoguardia: «Dire che è il tuo lavoro, non lo
farà migliore, boss». Il carcere è nel nostro immaginario, conficcato ben bene.
Per quelli della mia età, c’era anche Quella sporca ultima meta – e quell’epica
partita a football americano contro le guardie, con Burt Reynolds, un tempo
glorioso quarterback e ora, per avere truccato partite, finito con la feccia in
carcere, ma capace di riscattarsi e riscattare i suoi compagni contro i progetti
di un perfido direttore. E poi sarebbero venuti Fuga da Alcatraz, Le ali della
libertà, Il miglio verde. E tant’altro ancora. Quando sono entrato in carcere,
pensavo di sapere tutto del carcere – lo avevo visto al cinema. È quello che
dice anche Angela Davis, nel suo libro sull’abolizione del carcere Aboliamo le
prigioni?, quando racconta: «Nel 1997, intervistando alcune donne in tre
prigioni cubane, ho scoperto con stupore che la maggior parte descriveva la
percezione del carcere che avevano in precedenza – vale a dire prima di finire
in prigione loro stesse – come derivante dai molti film hollywoodiani che
avevano visto. Tra le immagini che popolano la nostra mente, il carcere occupa
dunque un posto di rilievo». Figurarsi adesso – e poi con le serie tv di
successo, come Prison Break, cinque stagioni, o The orange is the new
black, sette stagioni, sulle carceri femminili. Eppure – credetemi sulla parola
– del carcere non sai nulla, finché non ci finisci dentro. Perciò, nel nostro
immaginario il carcere esiste, fin nei dettagli, e nello stesso tempo è la cosa
più rimossa che c’è; è il luogo di cui abbiamo più fotogrammi immagazzinati ma
anche il più invisibile; è lo spazio di cui crediamo di conoscere perfettamente
le regole – quelle imposte dallo stato, quelle vigenti tra i detenuti – ma che
diamo per scontato sia senza diritto comune, sottratto al diritto comune, con
leggi sue proprie. Il carcere è il fenomeno più incredibile di presenza/ assenza
nei nostri pensieri – come se una metà del cervello ne sapesse perfettamente
l’esistenza e l’altra metà non volesse saperne proprio nulla. Sappiamo, ma non
vediamo. Questa scontatezza del carcere fa somigliare il “processo” della colpa
e della pena – commetti un reato, sei giudicato, finisci in carcere – come una
cosa naturale, come un ciclo delle stagioni: se ora è estate, dopo viene
l’autunno, un percorso obbligato. E se è scontato, se è obbligato, se tutti lo
sanno – allora io sono esentato dalla responsabilità di interrogarmi. Se prendo
la marmellata che mi è stata vietata, sarò punito – e tutti i miei pensieri
ruoteranno intorno quest’unica domanda: come posso prendere la marmellata senza
finire in prigione? Non mi chiederò mai se la prigione sia il “posto giusto” per
avere preso la marmellata vietata. Angela Davis in prigione finì lei stessa per
la sua militanza politica, all’inizio degli anni Settanta, e da allora è
un’attivista contro il carcere come “unica soluzione”. Soprattutto negli Stati
uniti. Scrive la Davis: «Più di due milioni di persone negli Stati uniti ( su un
totale mondiale di nove milioni) popolano attualmente le prigioni, i
penitenziari, gli istituti minorili e i centri di detenzione per immigrati. La
gravità di queste cifre è resa ancora più evidente se si considera che
complessivamente la popolazione statunitense è inferiore al 5 percento del
totale mondiale, mentre gli Stati uniti possono vantare più del 20 percento
della popolazione carceraria» ( i dati sono di una decina d’anni fa, ma niente
fa credere che si siano modificati). A finire in carcere, in maniera
sproporzionata, sono le minoranze etniche – neri, ispanici soprattutto – in un
circolo vizioso senza possibilità di scarto che inizia dall’abbandono di interi
quartieri, privi di scolarizzazione adeguata, di assistenza sanitaria, di
possibilità di occupazione, e dove il percorso di un giovane porta quasi
ineluttabilmente a delinquere. Oppure, come alternativa, a entrare
nell’esercito. È Loïc Wacquant, in Punire i poveri, che spiega bene questo
meccanismo infernale tra ghetto e prigione: «Alla fine degli anni Settanta, la
prigione è improvvisamente tornata alla ribalta per offrirsi come la soluzione
al tempo stesso semplice e universale a tutti i problemi sociali più urgenti.
Problemi tra i quali figurava, al primo posto, l’evidente incapacità del ghetto
nero nel contenere al proprio interno una popolazione in sovrannumero, priva di
onore e considerata ora non solo come deviante e a rischio, ma anche come
estremamente pericolosa per via delle violente rivolte che, da Watts a Detroit,
hanno dilaniato le città statunitensi a metà degli anni Sessanta. Mentre le mura
del ghetto tremano e rischiano di crollare, quelle delle prigioni si allungano,
si allargano e si rinforzano. In breve tempo, il ghetto nero, trasformato in
strumento di pura esclusione a causa della contrazione simultanea della sfera
del lavoro salariato e dell’assistenza sociale, e ulteriormente destabilizzato
dalla maggiore penetrazione del dispositivo penale dello Stato, si è trovato
legato al sistema carcerario da una triplice relazione di equivalenza
funzionale, di omologia strutturale e di sincretismo culturale, cosicché essi
costituiscono attualmente un unico e solo continuum carcerario in cui è
rinchiusa una nutrita schiera di giovani uomini ( e, sempre più spesso, di
donne) neri che percorrono un circuito delimitato da questi due poli, secondo un
ciclo autoalimentato di marginalità sociale e legale dalle conseguenze personali
e collettive devastanti». Insomma, il carcere come una risposta alle questioni
sociali – esso stesso quasi come un “orribile welfare” proprio quando il welfare
comincia a essere smantellato. È l’indurimento delle pratiche di polizia per le
strade, dei procedimenti giudiziari e delle pene, e della detenzione che
costruisce questo “modello”, a partire dagli anni Ottanta: «Quando Reagan
inaugura la sua presidenza, la polizia procede a circa 10,4 milioni di arresti a
due terzi dei quali ( 69%) segue la carcerazione; quindici anni dopo, il numero
di arresti annuale arriva a 15,2 milioni e quasi tutti ( 94%) approdano al
carcere giudiziario. L’iperinflazione carceraria americana è difatti alimentata
dall’incremento concomitante di due fattori: la durata della detenzione e il
numero di condannati alla reclusione. Il prolungamento delle pene riflette
l’irrigidimento della politica giudiziaria negli Stati Uniti: moltiplicazione
dei reati che portano alla carcerazione, aumento della durata delle pene
inflitte sia per i crimini non violenti ( taccheggio, furto d’auto, possesso di
droga) che per quelli violenti, abolizione della riduzione di pena per alcuni
reati ( stupefacenti, offese al buon costume) e perpetuità automatica al terzo
crimine ( «Three Strikes and You’re Out» ), inasprimento generalizzato delle
sanzioni in caso di recidiva, applicazione del codice penale degli adulti ai
minori di sedici anni e limitazione, se non soppressione, della libertà
vigilata. È nel 1973, all’indomani della rivolta di Attica nel corso della quale
quarantatré persone tra prigionieri e guardie carcerarie tenute in ostaggio
furono massacrate nell’assalto lanciato dalle truppe, che la popolazione
carceraria degli Stati Uniti raggiunge il livello più basso dal dopoguerra. Il
ribaltamento della demografia carceraria statunitense dopo il 1973 si rivelerà
tanto brusco quanto stupefacente. Contro tutte le aspettative, la popolazione
penitenziaria del paese comincia ad aumentare vertiginosamente: essa raddoppia
in dieci anni e quadruplica in venti. Partito da meno di 380.000 nel 1975, il
numero delle persone dietro le sbarre sfiora 500.000 nel 1980 e supera il
milione nel 1990. Continua a crescere con un ritmo infernale dell’ 8% in media –
ossia, 2000 detenuti in più ogni settimana – durante gli anni Novanta, al punto
che, al 30 giugno 2000, l’America contava ufficialmente 1.931.850 detenuti. Se
fosse una città, il sistema carcerario statunitense sarebbe la quarta più grande
metropoli del paese, dietro Chicago» – è ancora Wacquant, che parla. È quello
che Angela Davis chiama il «complesso carcerario- industriale», di cui è
esemplare la California: «Tra il 1852 e il 1955 sorsero in California nove
prigioni. Nella seconda metà degli anni Sessanta non fu aperta nessuna prigione
e neppure durante il decennio successivo. Tra il 1984 e il 1989 furono
inaugurati nove istituti di pena: c’erano voluti più di cento anni per costruire
le prime nove prigioni californiane; in meno di un decennio quel numero è
raddoppiato e durante gli anni Novanta se ne sono aggiunti altri dodici, tra cui
due penitenziari femminili». Osservando la carta della California e la posizione
delle prigioni, queste hanno lentamente e letteralmente invaso gli spazi, come
se, dice la geografa Ruth Gilmore, l’espansione delle prigioni fosse «una
soluzione geografica a problemi socio- economici». Certo, spesso queste nuove
prigioni non sono state “imposte” ma sono state costruite con il consenso
dell’opinione pubblica – la gente voleva credere che altre prigioni avrebbero
ridotto il crimine e che avrebbero fornito posti di lavoro e sviluppo per le
comunità locali. Eppure, quando è iniziato il boom della costruzione delle
carceri, le statistiche ufficiali rivelavano già una diminuzione dei dati sulla
criminalità. Il punto è che non si può non mettere in correlazione la de-
industrializzazione e la reclusione di massa. Paradossalmente, per alcune
comunità locali, il carcere avrebbe rappresentato un volano di “sviluppo”. Non
solo, ma la “privatizzazione” della gestione delle prigioni ha significato anche
l’ingresso massiccio di aziende che sfruttano il lavoro carcerario – a un costo
significativamente più basso. E parliamo di aziende di prima grandezza – che
traggono profitti enormi non solo dalla fornitura alle carceri. All’inizio del
XXI secolo, le numerose società per la gestione di prigioni private operanti
negli Usa possedevano e amministravano strutture che ospitavano 91.828 detenuti.
Il Texas e l’Oklahoma vantavano il maggior numero di detenuti in prigioni
private, ma il New Mexico ospitava il 44 percento della sua popolazione
carceraria in strutture private, e stati come il Montana, l’Alaska e il Wyoming
avevano “ceduto” oltre il 25 percento della loro popolazione carceraria. È un
“fenomeno” che è andato crescendo e allargandosi, dagli Stati uniti
all’Australia, ma anche in Turchia. Che il carcere sia, negli Stati uniti, anche
una “questione razziale” lo si capisce – oltre che dai numeri di proporzione tra
bianchi, neri e ispanici incarcerati che corrispondono in modo rovesciato alla
presenza in società – proprio dal “lavoro forzato”. Perché la sua istituzione
ripercorre passo passo quella della schiavitù – e per molti versi ne fu una
versione peggiorativa. Negli Stati del Sud un nero in prigione era una rarità
prima della Liberazione, divennero la normalità dopo: chi visitava le prigioni
del Mississippi negli anni Settanta e Ottanta dell’Ottocento trovava «i
prigionieri che mangiavano e dormivano sulla nuda terra, senza coperte né
materassi e spesso senza vestiti… i detenuti morivano di sfinimento, polmonite,
malaria, congelamento…» ( da David Oshinsky, Worse than Slavery). Prima, come
schiavo il nero era comunque un bene in cui si era investito e che andava
mantenuto perché producesse, dopo era manodopera intercambiabile in un mercato,
quello del carcere, abbondante. Considerare scontato il carcere non ci fa
neppure interrogare se possano esistere possibilità alternative – ci sembra
impossibile, proprio come ci sembrerebbe impossibile invertire un fatto della
natura. Anche per la pena di morte, l’alternativa che viene prospettata è quella
del carcere a vita, in alternativa. Ricordava Jack Abbott, nel suo Nel ventre
della bestia, come fosse stato proprio Gary Gilmore, che aveva passato più di
metà della sua vita in carcere, a chiedere – dopo la sentenza del 1976 che lo
condannava per due omicidi – di essere giustiziato, finendo con l’essere il
primo dopo dieci anni che la pena di morte era stata sospesa. Fu fucilato nel
1977. Abbott pensava a un senso di “espiazione” – ma è difficile definire “vita”
un ergastolo senza alcuna possibilità di remissione in condizioni di assoluto
isolamento per decenni e decenni. Eppure, proprio come l’indurimento delle pene
e la “rapidità” dei procedimenti contro lo spaccio di droga sono stati tra i
“volani” più significativi dell’aumento della popolazione carceraria – e di
tutta la crescita del complesso carcerario- industriale – forse abolendone
alcuni meccanismi obbligati, ci sarebbero già significative riduzioni e delle
alternative. E lo stesso varrebbe per la prostituzione, a esempio. Il primo
passo è riconoscere che non esiste un’unica modalità della pena. E non pensare a
“soluzioni” che siano “il carcere in altra forma”, come gli arresti domiciliari
con il braccialetto elettronico. Il primo passo è rompere il legame tra delitto
e castigo.
Errori giudiziari, il procuratore dice basta: «Quasi tutti
afroamericani». Alessandro Fioroni su Il Dubbio l'11
luglio 2020. Il giudice Eric Gonzales di Brooklyn ha riesaminato decine di casi
di cittadini condannati senza prove: «La discriminazione è sistematica». «Per
noi, per costruire la fiducia della comunità, soprattutto ora, quando così tante
persone in questo paese esprimono rabbia e disperazione con il sistema, dobbiamo
fare i conti ed essere trasparenti sugli errori del passato». Le parole sono
quelle pronunciate dal procuratore distrettuale della contea di Kings, Brooklyn,
New York. Eric Gonzalez le ha pronunciate in concomitanza con la pubblicazione,
giovedì, di un rapporto che rappresenta una novità assoluta per gli Stati Uniti.
L’ufficio del procuratore infatti, insieme allo studio legale Wilmer Hale e
l’Innocence Project ha esaminato 25 condanne ai danni di uomini afroamericani.
Per questi casi esiste il fondato motivo che si tratti di decisioni sbagliate, o
peggio, dettate da un sistema giudiziario razzista. Per Nina Morrison del
Innocence Project «Questo rapporto mostra il devastante pedaggio umano causato
da questi aborti di giustizia – e come molti di questi avrebbero potuto essere
prevenuti prima che si tramutassero in condanne sbagliate». Complessivamente gli
anni di prigione riferiti ai casi esaminati ammontano a 426 anni di prigione,
una cifra enorme anche perché i protagonisti sono praticamente solo
afroamericani. Una realtà disvelata anche grazie ad un lavoro iniziato nel 2014
dalla Conviction Review Unit ( CRU). I reati attribuiti ai condannati sono
molteplici ( furto con scasso, incendio doloso, stupro, rapimento, rapina e
omicidio di vari gradi). Per molti si sono aperte le porte della prigione a
vita. Un altro vulnus per il diritto. Sono le statistiche a dimostrare infatti
che mentre gli afroamericani sono il 13% della popolazione, il 28,3% di essi
rappresenta il numero dei prigionieri che scontano l’ergastolo a partire dal
2009, e il 56,1% è costituito da persone che erano minorenni al momento
dell’arresto. Alcuni casi sono emblematici. Nel 1985 Scott Moore e Tony Stevens,
allora 16enni, furono condannati per omicidio, rapimento, rapina a mano armata,
la sentenza fu quella della prigione a vita. Moore ha scontato 29 anni di
carcere e Stevens è morto in prigione dopo 15 anni. In realtà non risultano
prove che i due guidassero un auto ( servita per l’omicidio) o che avessero una
patente. Mancano in molti casi quelle che la CRU chiama prove fisiche o
testimoniali, spesso si da credito a dichiarazioni non accertate e vincolate dal
pregiudizio. Sono stati così evidenziati vari livelli di cattiva condotta da
parte di polizia, pubblici ministeri e avvocati difensori, comprese confessioni
false o inaffidabili, errate identificazioni dei testimoni, problemi di
credibilità e plausibilità delle dichiarazioni. Ancora peggio è il fatto che per
almeno 10 sentenze su 25 sono state escluse o addirittura nascoste prove a
favore della difesa. Una situazione che ora potrebbe portare al ribaltamento di
numerose decisioni giudiziarie e alla cancellazione completa dei reati. Tutto
ciò mentre la società statunitense è ancora scossa dall’onda lunga delle
proteste per l’uccisione di George Floyd, un contesto che non è certo sfuggito
al procuratore Gonzalez: «Sono consapevole del fatto che pubblichiamo questo
rapporto in un momento in cui l’uccisione di George Floyd a Minneapolis e la
violenza razziale che ha suscitato, hanno riempito così tanti americani, incluso
me, di rabbia e disperazione».
GIULIA ZONCA per la Stampa il 3 luglio 2020. A incontro finito è
iniziata la vera lotta e non è ancora archiviata, 110 anni dopo «Il
combattimento del secolo», giriamo ancora intorno all'uguaglianza, ci facciamo
ancora a pugni. Il secolo è cambiato però l'eredità di Jack Johnson, primo
campione dei pesi massimi afroamericano, contro Jim Jeffries, noto come «La
grande speranza bianca», non si è risolta. Quattro luglio 1910: quando Johnson
manda a tappeto il rivale la gente si riversa in strada. La cintura dei pesi
massimi, quasi un simbolo di onnipotenza, non può andare a un nero. Non senza
rivolte, non senza spaccare un Paese in due, non nel 1910. La ferita non è più
così grave ma è tutt' altro che ricomposta e guardare quell'incontro è come
spiare il cuore del razzismo, le parole che lo sostengono, i pregiudizi che lo
tengono vivo. Siamo negli Stati Uniti del presidente Taft a cui chiedono di
arbitrare l'incontro più atteso. Lui saggiamente rifiuta la pagliacciata anche
se volere l'uomo che governa la nazione a decidere del destino di bianchi e neri
è una richiesta tanto assurda quanto maldestramente logica. I neri sono il 10,7
per cento della popolazione e ce ne sono ben pochi fra il pubblico. Tutti
bramano il ritorno del grande Jim che cinque anni prima si è ritirato imbattuto,
che non ha mai sbagliato, che deve riconsegnare l'orgoglio alla sua razza. Per
questo lo convincono a tornare e lo scrittore Jack London lo supplica di
«togliere il sorriso dalla faccia di Johnson». Se oggi «Via col vento» è sotto
accusa, anche «Zanna bianca» e «Il richiamo della foresta» rischiano. Johnson è
già campione in carica solo che è un titolo traballante: per evitare la
consacrazione, la polizia è salita sul ring della sua precedente sfida prima che
l'avversario cadesse giù e con lui le improbabili certezze di cui la maggioranza
si nutriva in quegli anni. «Il combattimento del secolo» non è boxe, è
propaganda: siamo prima di Louis contro Schmeling, prima di Frazier, di Foreman
e di Ali, siamo in una terra contaminata dal settarismo e in un epoca in cui
titolare «vince il negro» non è neppure scorretto. Johnson lo sa e vuole che i
suoi pugni stiano lì a difendere la comunità che rappresenta. Pure Jeffries è
consapevole del ruolo, non stringe la mano all'avversario e non è disprezzo, è
panico. Johnson è più giovane, più preparato, schiva veloce e sceglie colpi
intelligenti. Jeffries è pesante e lento, interpreta un pugilato di sola
potenza, alla Carnera. Per reggere la pressione e la curiosità, invece di
scegliere sparring partner che lo mettessero alla prova ha assoldato amici che
sostenessero la parte. Non è preparato, il suo tempo migliore è passato ed è
destinato alla catastrofe, una di quelle che restano. È il primo incontro
filmato e ci sarà la coda per vederlo, le botte per ritirarlo, si muoverà l'ex
presidente Theodore Roosevelt per chiedere di abbassare i toni e censurare il
film. Ora si discute sulla sua statua che sarà rimossa dall'entrata del Museo di
storia naturale di New York per non dare falsi messaggi. Non è la sua figura che
crea disagio, piuttosto la composizione del monumento in cui lui giganteggia
sopra un africano e un indigeno. Nel film del 1910 il gigante è solo Johnson,
c'è un'immagine in cui «La grande speranza bianca» gli scivola letteralmente
addosso, crolla tirando giù ogni stereotipo. È il quattro di luglio, il giorno
in cui gli Usa rinascono di continuo. È anche presto per capire che cosa è
successo, nessuno dei protagonisti trova quello che cerca, troppo coinvolti e
tormentati. Johnson sarà accusato di aver portato al suicidio sua moglie, bianca
come le due che verranno dopo. Resterà campione altri 5 anni poi finirà senza un
soldo, costretto a scappare per non essere arrestato. Morirà in un incidente
d'auto a 68 anni, mai più gigante dopo quell'attimo di eternità. Jeffries
tornerà alla sua fattoria senza più un nome, deriso e insultato, andrà in
bancarotta nonostante la borsa faraonica per l'epoca: 101.000 mila dollari più
bonus e diritti. Si pentirà per sempre di aver ceduto alla tentazione del
rientro e morirà solo e povero a 77 anni. La boxe non avrà un altro campione di
colore fino a Joe Louis, nel 1937. L'America è sempre in strada anche se adesso
i neri e i bianchi stanno dalla stessa parte e rifiutano di farsi definire dalla
pelle, alzano i pugni invece di tirarli. In rivolta contro chi è fermo al
combattimento del secolo che non finisce mai.
DAGONEWS il 4 luglio 2020. Lo storico David Starkey è stato
scaricato dal suo editore e licenziato e costretto a dimettersi da una serie di
importanti ruoli universitari dopo aver affermato che «la schiavitù non è stata
un genocidio perché così tanti dannati neri vivono in Africa e in Gran
Bretagna». HarperCollins ha definito le sue parole "disgustose" mentre Hodder &
Stoughton, che ha pubblicato il suo libro sulla Magna Carta nel 2015, ha
affermato che non avrebbe mai più lavorato con lui. La decisione è arrivata
poche ore dopo essere cacciato dalla Christ Church University di Canterbury, il
Fitzwilliam College ha accettato le sue dimissioni e ha perso la sua borsa di
studio all'Università di Cambridge dopo essere stato accusato di razzismo. Il
dottor Starkey ha anche rassegnato le dimissioni dal Mary Rose Trust e potrebbe
presto essere privato della sua laurea ad honorem dalla Lancaster University. La
discussione è iniziata quando l’accademico 75enne è stato intervistato dal
fondatore di BeLeave Darren Grimes. Durante l’intervista Starkey ha affermato:
«Il Black Lives Matter è un prodotto della colonizzazione dei bianchi. L'unica
ragione per cui questi giovani manifestanti neri sono qui è la schiavitù. La
schiavitù non è stata un genocidio, altrimenti non ci sarebbero così tanti
dannati neri in Africa o in Gran Bretagna, vero? Molti di loro sono
sopravvissuti».
Enrica Brocardo per “il Venerdì di Repubblica” il 13 luglio 2020.
Uscito nel 1973, Serpico, il film diretto da Sidney Lumet e interpretato da Al
Pacino, era quasi un instant movie. Il vero agente del dipartimento di polizia
di New York del quale raccontava la storia aveva lasciato la divisa solo sei
mesi prima, dopo essere sopravvissuto miracolosamente a una sparatoria. Il 3
febbraio 1971, durante un' irruzione nell' appartamento di uno spacciatore, era
stato colpito in faccia da un proiettile. Il sospetto - ma non ci fu mai un'
indagine - è che si fosse trattato di un agguato organizzato dagli altri agenti
per eliminarlo. Da anni, cercava infatti di denunciare la sistematica corruzione
in tutte le sezioni del dipartimento. Da allora, Frank Serpico, figlio di
immigrati da Marigliano, nel Napoletano, è diventato un simbolo: un eroe per la
gente, e il primo degli infami per molti poliziotti. «Diciamo che ancora oggi la
polizia di New York non nutre esattamente rispetto nei miei confronti» ci
conferma lui al telefono dalla sua casa in campagna, nel Nord dello Stato di New
York. Nella sua seconda vita, Serpico ha sostenuto moltissime iniziative con l'
obiettivo di denunciare gli abusi delle forze dell' ordine. E ancora oggi, a 84
anni, continua la sua battaglia. Recentemente su Twitter ha postato decine di
messaggi sull' omicidio di George Floyd, l'afroamericano ucciso da un poliziotto
bianco il 25 maggio a Minneapolis. «La violenza e il razzismo fanno parte dello
stesso sistema corrotto» ci dice. Poi ricorda un episodio che risale a quando
era ragazzino. «Avevo 13 o 14 anni, facevo il lustrascarpe all' angolo tra
Eastern Parkway e Franklin Avenue, un quartiere ebraico a Brooklyn. Di neri in
giro non ce n'erano. Una sera vidi una donna di colore, esile, non più giovane.
Era sdraiata su una panchina e un poliziotto bianco la stava picchiando con il
manganello. Ancora oggi ricordo il rumore dei colpi. Lei non emetteva un suono.
Credo che sia stata una delle ragioni per cui, anni dopo, entrai in polizia».
Da agente ha assistito a molti episodi di razzismo?
«Nei primi anni mi capitava spesso di fare arresti per stupro, le
vittime erano per lo più afroamericane. Il tenente mi rimproverava: "Perdi
tempo. Quando parliamo di nere, lo stupro non esiste". Una volta, invece, mi
capitò di aiutare una ragazza di colore a partorire, e quando uscii il mio capo
mi disse: "Non sarebbe stato meglio se avessi buttato quella cosa nella
spazzatura?". E, ancora, un giorno in cui ero di pattuglia, vidi una casa
avvolta dalle fiamme, riuscii a mettere tutti in salvo, compresi bambini e
neonati, prima dell' arrivo dei vigili del fuoco. Invece di farmi i complimenti,
mi ripresero perché ero in ritardo. Erano due famiglie di afroamericani».
Gli agenti neri come reagivano a un ambiente del genere?
«Alcuni di loro erano più violenti e brutali dei bianchi. Per
loro era ancora più importante riuscire a far parte del "club". Una volta, mi
misero in coppia con un sergente nero. Appena salito in macchina, mi disse:
"Dove posso tirar su 50 dollari al volo?". Gli risposi: "Non so se le banche
sono aperte". Quella stessa persona divenne capo di una divisione che per anni
ha fatto i soldi sul sangue degli afroamericani. Un'altra volta mi trovai a
lavorare in borghese con un agente di colore. Era peggio dei colleghi bianchi,
sapeva muoversi meglio tra la sua gente, sapeva come alzare il prezzo».
Da allora che cosa è cambiato?
«Niente. Oggi abbiamo David Clarke, l' ex sceriffo di Milwaukee,
un nero, forte sostenitore di Donald Trump che, da anni, dice che la violenza
nella polizia non esiste. Ma guardare un bianco che tiene il ginocchio sul collo
di un afroamericano per otto minuti fino a farlo soffocare è stato troppo. Chi
protesta vuole cambiare la legge che consente a un poliziotto di ammazzare senza
ragione e senza essere punito. Gli basta dire: "Mi sono sentito minacciato". Una
regola che funzionerebbe se non ci fossero agenti disonesti e corrotti».
Grazie alle telecamere dei cellulari, però, mentire è diventato
più difficile.
«È vero. Oggi internet è piena di filmati di atti brutali che
prima non sarebbero mai stati scoperti. Nel 1999 la polizia di New York
assassinò Amadou Diallo, un uomo di colore. Stava davanti alla porta di casa,
gli spararono 41 colpi e riuscirono a insabbiare la vicenda. Un agente del
dipartimento di polizia di New York, Adrian Schoolcraft, aveva registrato i suoi
superiori mentre ordinavano di dare la caccia a latini e neri. Riuscirono a
farlo internare in un ospedale psichiatrico dicendo che soffriva di problemi
mentali. È successo una decina di anni fa».
Il razzismo della polizia è solo un riflesso della società o c'è
un problema specifico?
«Robert Cattani, tenente della polizia di New York, bianco, dopo
essersi inginocchiato di fronte alla folla che protestava per l' uccisione di
George Floyd, ha mandato un' email ai colleghi per chiedere scusa. Ha scritto:
"Il poliziotto che c'è in me mi prenderebbe a calci". È sintomatico di una
cultura diffusa: molti pensano che il loro compito sia prendere a calci
qualcuno. Seguono la logica del noi contro loro, dove loro è la società. Si
riferiscono alle persone, in generale, chiamandole "gli stronzi". Molti non
lavorano in zone particolarmente problematiche, ma tutti amano dire che ogni
giorno rischiano la vita».
Qualche tempo fa ha detto che anche l' eccesso di equipaggiamento
e di armi troppo potenti fanno parte del problema.
«Quando ero in polizia, le cartucce che avevamo in dotazione
erano 38 Special. Oggi la polizia è dotata di armi calibro 40. Se hai un
equipaggiamento simile a quello di un soldato finisci per pensare e comportarti
come se fossi in guerra. E i tuoi nemici sono le persone che dovresti
proteggere».
Perché George Floyd è stato ucciso?
«Una serie di ragioni. Intanto, il razzismo. La gente dice: "Non
sono razzista, ho fatto sesso con una nera". Oppure: "Sono andato a letto con
un' asiatica". E ci credono davvero. C' è stato un tempo in cui noi italiani
eravamo i barbari. La differenza è che il colore della pelle non lo puoi
nascondere. Non ci sono molti bianchi che si svegliano la mattina e dicono a se
stessi: "Cosa posso fare per fermare la violenza contro gli afroamericani?". Ma
tutti i neri si svegliano la mattina e si domandano: "Oggi verrò picchiato da un
poliziotto?"».
Le altre ragioni?
«Ci sono persone troppo codarde per darsi al crimine e, così,
diventano agenti. La polizia usa sempre la stessa scusa: "Si tratta di poche
mele marce". Ma il punto è che la selezione non è adeguata, perché invece di
individui capaci di pensare con la propria testa, vogliono gente che esegua gli
ordini senza discutere. Quel tipo che ha ucciso Floyd, non mi va neppure di dire
il suo nome, non sarebbe mai dovuto diventare un poliziotto. Era in servizio
nonostante 17 lamentele per il suo comportamento. Tipi come lui pensano di
essere giudice, giuria e esecutore. Ma la vera questione è che a non funzionare
è l' intero sistema della giustizia».
Che cosa intende?
«Lo scorso 18 giugno Christopher Howell, 51 anni, la capacità
intellettiva di un bambino, è stato picchiato a morte dalle guardie mentre era
ammanettato nella sua cella. Aveva rubato alcuni caricabatterie per cellulare,
valore totale circa 50 dollari e per questo era stato condannato a quattro anni.
Beh, sa che cosa le dico? Che il giudice che ha emesso quella sentenza dovrebbe
essere incriminato per omicidio insieme alle guardie».
Dalle testimonianze reali alle serie Tv, come gli
afroamericani convivono con il demone del razzismo.
Roberta Caiano su Il Riformista il 29 Giugno 2020. Il caso George Floyd ha fatto
emergere uno dei problemi più antichi del mondo: la segregazione razziale. I
pregiudizi e le discriminazioni non solo sono sempre esistiti, ma sono ormai
permeati in ogni aspetto della nostra società nei confronti di tutto ciò che è
visto come “diverso”. La vicenda che ha visto coinvolto l’afroamericano morto
mentre era in custodia della polizia a Minneapolis, negli Stati Uniti, ha
scatenato una serie di proteste nelle principali piazze non soltanto americane
ma anche europee. La sua storia ha dato il via anche ad una serie di
testimonianze, rimaste silenziose, di altri afroamericani e in generale di
coloro che hanno subito soprusi e pregiudizi solo per il colore della pelle.
Soprattutto sui social sono state molte le persone che hanno voluto raccontare
quanto sia difficile tutt’oggi nella società moderna convivere con il fardello
di sentirsi diversi dall’altro.
LE TESTIMONIANZE – Sul celebre social Tik Tok, ad esempio, il
giovane 18enne afroamericano Cameron Welch ha realizzato un video in cui ha
elencato una lista di dieci regole, che gli ha insegnato la madre quando aveva
solo 11 anni, per evitare di avere problemi con la giustizia. Il decalogo del
giovane di Houston spiega, a suo modo, com’è la vita di un afroamericano negli
Usa e quali sono le regole da seguire per non avere problemi. La lunga lista di
Cameron affronta vari punti come l’atteggiamento da assumere in un negozio per
non essere accusato di furto, oppure come guidare per evitare di essere fermato
dalla polizia. Ma una delle storie che sta circolando sul web negli ultimi
giorni, anche se risale in realtà al 2018, riguarda un avvocato afroamericano
che ha condiviso sui social la vicenda che lo ha visto coinvolto. Sean
Carter vive in Arizona con la sua famiglia e ha ricevuto un pacco per errore.
Sebbene il pacco sia indirizzato a qualcuno che vive nel suo vicinato, Carter ha
voluto sollecitare la ditta spedizioni affinché ritirino il pacco e lo
consegnino presso il giusto domicilio. L’avvocato ha spiegato che, data la poca
distanza con il destinatario del pacco, avrebbe potuto andare lui o mandare i
suoi figli ma ha avuto una giusto motivo per non farlo. Come ha specificato nel
corso del post, “la risposta è perché siamo neri ed è estremamente pericoloso
inviare i nostri ragazzi a casa di qualsiasi famiglia che non conosciamo in
questo quartiere prevalentemente bianco”. Carter ha spiegato che esiste una
“possibilità realistica” che uno dei suoi vicini possa vedere i suoi figli come
una minaccia e chiamare la polizia o, peggio ancora, possa usare la pistola come
difesa. A questo proposito, Sean ha citato l’esempio del quattordicenne Brennan
Walker, che ha quasi perso la vita dopo aver tentato di chiedere informazioni in
una casa a Rochester Hills, Mich. La proprietaria della casa, pensando che
Walker stesse cercando di derubarla, ha chiesto l’aiuto di suo marito che lo ha
colpito con un colpo di pistola. “È per questo che questo fottuto pacchetto
rimarrà sulla mia veranda finché UPS (la ditta spedizioni, ndr) non lo
recupererà. Perché non posso fidarmi del fatto che i miei vicini bianchi non mi
vedranno come un avvocato istruito ad Harvard (o mio figlio studente onorario di
14 anni) ma come un maniaco omicida”, ha scritto Carter.
LA DENUNCIA DELLE SERIE TV – Molte serie TV hanno voluto
denunciare il dilagare del continuo razzismo nei confronti degli afroamericani
raccontando come queste persone convivono con il demone dei pregiudizi, spesso
rimettendoci anche la vita. E’ il caso della serie tv When they see us, tratta
da una storia vera. Il caso della jogger di Central Park è un fatto di cronaca
realmente accaduto nel 1989, quando la 28enne Trisha Meili fu aggredita e
stuprata nel cuore del parco di New York. La serie tv si concentra
principalmente sulla storia e la vita dei protagonisti condannati per il reato
ai danni della donna. Gli afroamericani Antron McCray, Kevin Richardson, Yusef
Salaam e l’ispanico Raymond Santana junior all’epoca dei fatti erano minorenni,
tranne il sedicenne Korey Wyse, anch’egli afro-americano e accusato insieme ai
compagni di essere il colpevole dell’aggressione. I ragazzi furono trascinati in
commissariato e costretti ad ammettere lo stupro, sebbene non ci fossero prove
concrete che li incastrassero. Interrogati senza genitori e senza avvocati, When
They See Us ripercorre lo strazio dei parenti e dei protagonisti che cercano di
farsi giustizia da soli per testimoniare la loro innocenza. Dopo una vita
passata a fare i conti con l’etichetta di “stupratori”, è stato difficile per
loro immettersi nella società e nel mondo del lavoro rifiutandosi di ammettere
un reato non commesso. La storia ha, in realtà, una svolta quando nel 2002 il
reale artefice del reato Matias Reyes confessa di essere stato lui ad aggredire
e stuprare la Meili. Le impronte genetiche hanno dato conferma alla sua
testimonianza, revocando così l’accusa nei confronti dei cinque ragazzi
innocenti vittime di pregiudizi solo per il colore della pelle. Un’altra serie
Tv che ha affrontato il tema delle "regole" da insegnare ai figli afroamericani
è Grey’s Anatomy, serie scritta e creata da Shonda Rhimes, in cui nel decimo
episodio della 14esima stagione un ragazzino di colore viene ricoverato in
ospedale dopo essere stato raggiunto da un colpo di pistola al collo mentre
cercava rientrare a casa sua arrampicandosi attraverso una finestra, per aver
dimenticato le chiavi. Arrivato in manette in ospedale perché scambiato per un
ladro, il ragazzo è ancora piantonato dalla polizia finché sono i medici a
battersi perché venga liberato e curato. Però le sue condizioni sono così
disperate che per il ragazzino non c’è più nulla da fare. Così una delle
dottoresse protagoniste della serie, afroamericana, affronta con suo figlio un
discorso molto toccante sulle linee-guida da seguire nel caso in cui la polizia
si ritrovi a fermarlo. La storia raccontata all’interno di una serie è in realtà
veritiera, come ci indicano i video di Cameron Welch e l’episodio del giovane
Brennan Walker sparato solo perché sospetto. La serie tv Station 19 nella terza
stagione, molto prima dei fatti di George Floyd, ha affrontato un caso simile
dando così l’idea che vicende del genere sono all’ordine del giorno. Uno dei
protagonisti afroamericani della serie televisiva, pompiere e medico, viene
fermato dalla polizia mentre guida con una velocità regolare ed è costretto a
gettarsi a terra e stendersi fino a quando i suoi documenti non testimoniano la
sua professione e che non stava commettendo alcun reato. Per quanto le serie tv
riportino storie di personaggi inventati, molto spesso cercano di raccontare
verità nascoste che non hanno una reale attenzione se non in casi eclatanti e/o,
purtroppo, tragici.
La Corte Suprema: «Metà Oklahoma ai nativi americani».
Stati Uniti, storica sentenza. Il Dubbio il 12 luglio 2020.
La corte Suprema degli Stati Uniti ha deliberato che metà del territorio dello
stato dell’Oklahoma è riserva dei nativi americani a tutti gli effetti, compresi
quelli fiscali e del sistema giudiziario penale: le autorità statali non hanno
giurisdizione sui nativi che compiano reati sul territorio assegnato alle tribù.
La decisione è stata presa con 5 voti a favore e 4 contrari e la sentenza è
redatta dal giudice conservatore Neil Gorsuch: si tratta di una delle più
importanti vittorie legali degli ultimi decenni per i nativi americani. «Oggi ci
viene chiesto se la terra promessa da questi trattati rimane una riserva ai fini
del diritto penale federale», afferma Gorsuch. «Poiché il Congresso non ha detto
il contrario», scrive il giudice, «noi manteniamo la parola del governo». Il
caso che è arrivato fino alla Corte Suprema è quello di Jimmy Mc-Girt, della
Nazione Muscogee, nota anche come Creek, che fu condannato dalle autorità
statali per abusi sessuali su un bambino di quattro anni commessi sul territorio
della tribù. McGirt ha sostenuto di poter essere processato soltanto dalle
autorità federali e che il Congresso non ha mai negato la sovranità della sua
tribù su questo territorio, che copre circa la metà dell’Oklahoma, mentre il
procuratore generale aveva sostenuto che questa zona non fosse mai stata una
riserva.
L'Oklahoma torna ai nativi (e lo Stato rischia il caos).
Metà del territorio ritenuto riserva degli indiani
d'America. Possibili ricadute su giustizia e tasse. Gaia Cesare, Sabato
11/07/2020 su Il Giornale. Ancora una volta un giudice conservatore nominato da
Donald Trump fa la differenza in una sentenza della Corte Suprema e sposta l'ago
della bilancia, schierandosi con i colleghi liberal. Stavolta la decisione pende
a favore dei Nativi d'America dell'Oklahoma. Con 4 voti contrari e 5 a favore -
tra cui quello di Neil Gorsuch, il giudice conservatore ex compagno di Barack
Obama alla facoltà di Legge di Harvard - la più alta corte federale degli Stati
Uniti ha stabilito che quasi la metà dello Stato dell'Oklahoma è da considerarsi
una riserva degli indiani d'America. Si tratta prevalentemente dei territori
dell'Est dello Stato, compresa la seconda città più importante ed estesa, Tulsa,
dove il presidente Trump ha tenuto l'ultimo controverso comizio divenuto il
principale indiziato per l'impennata di contagi da coronavirus nell'area. Per i
Nativi americani si tratta non solo di una vittoria ma soprattutto di una
promessa mantenuta. Non è un caso che proprio il giudice Gorsuch, che ha redatto
la sentenza, abbia fatto riferimento al Trail of Tears, il sentiero delle
lacrime, cioè la deportazione forzata, stabilita da una serie di trattati, di
circa 60mila Nativi d'America dagli Stati del Sud-Est americano come Georgia e
Alabama alle terre dell'Ovest, nelle riserve del West al di là del Mississippi.
A quel tempo l'Amministrazione Usa stabilì che le nuove terre sarebbero
appartenute alle tribù per sempre, ricorda il giudice Gorsuch. «Oggi ci viene
chiesto se le terre promesse in quei trattati rimangono una riserva indiana ai
fini della legge penale federale. Siccome il Congresso non ha stabilito
diversamente, manteniamo la parola del governo», spiega la Corte Suprema. Il
punto è che la decisione avrà conseguenze pratiche di un certo rilievo e
qualcuno teme possa trascinare l'Oklahoma nel caos. Con il pronunciamento della
Corte, i membri di alcune tribù giudicati colpevoli dai tribunali dello Stato
per reati commessi in Oklahoma potranno infatti contestare le condanne. E solo i
procuratori federali, d'ora in poi, avranno il potere di perseguire i Nativi
accusati di crimini in quella zona. Ma c'è di più. Secondo alcuni esperti di
diritto tributario la sentenza della Corte Suprema potrebbe anche voler dire che
i membri delle varie tribù che vivono all'interno dei confini dello Stato
possano essere esentati dal pagamento delle tasse. All'origine della decisione
della Corte Suprema c'è un caso di violenza sessuale. Il settantunenne Jimcy
McGirt, che sta scontando una condanna a 500 anni di prigione per abusi sessuali
su un minore, si era visto rifiutare dalle corti statali dell'Oklahoma la
richiesta di poter essere processato soltanto dalle autorità federali. Lui ha
sempre ricordato che il Congresso non ha mai negato la sovranità della sua tribù
- i Muscogee, noti anche come Creek - su parte del territorio dell'Oklahoma.
Eppure il procuratore generale aveva negato che la zona dove è avvenuto il reato
fosse una «riserva», cioè un territorio in cui soltanto le autorità federali
possono perseguire i Nativi d'America. Ora invece arriva la svolta. Una
rivoluzione per l'Oklahoma. Con la conseguente promessa, da parte delle 5 tribù
che compongono gli indiani d'America - Muscogee (Creek), Cherokee, Chickasaw,
Choctaw e Seminole - di voler collaborare per trovare una soluzione alle
problematiche giuridiche che la sentenza rischia di creare.
Storia dello schiavismo americano: le leggi di Jim Crow che
ispirarono i nazisti. Paolo Guzzanti su Il Riformista
il 9 Giugno 2020. Quale è la storia del razzismo americano? E dello schiavismo?
Fare un passo indietro sarà banale, ma è utile. Certamente, gli americani non
andavano in Africa a catturare schiavi i neri per portarli a casa a lavorare
nei cotton fields, nei campi di cotone della frusta, del caldo e dei canti per
reggere la fatica? In queste settimane di radicale e salutare rivoluzione
antirazzista può essere utile ricordare come andarono le cose. Io ho cominciato
a frequentare e vivere negli Stati Uniti, dove ho ancora due figli, dal 1997.
Non ho imparato tutto, ma abbastanza nel corso di molti anni. Negli Stati Uniti
troverete sempre scaffali di libri sulla condizione degli schiavi e degli
afroamericani. Ma è utile ricordare che la tratta degli schiavi in America è
opera soltanto degli europei: spagnoli, portoghesi, inglesi, francesi e
olandesi. Il Paese al mondo che ha più neri non è l’Uganda o la Nigeria e
nemmeno il Sud Africa, ma il Brasile perché il Portogallo importò milioni di
neri dalle sue colonie africane. In catene, ovviamente. Cristoforo
Colombo appena sbarcato sulle isole caraibiche, tentò di schiavizzare i nativi,
ma gli andò malissimo. I nativi, detti erroneamente indiani, non si facevano
schiavizzare. Piuttosto, morivano. I nativi indiani nel diciottesimo secolo
erano talmente potenti da poter stringere alleanze militari con la Francia o
l’Inghilterra, per cui quella che sui nostri libri si chiama “Guerra dei Sette
anni”, in America si chiama “Guerra indiana” perché i nativi combattevano anche,
anche fra loro, in reggimenti e plotoni autonomi, come nazioni. La schiavitù
degli africani è una piaga antica quanto l’Africa. Tutti i colonialisti europei,
francesi o inglesi, spagnoli o portoghesi, comperavano gli schiavi ai mercati
arabi in Africa. Gli arabi a loro volta si servivano di ras locali che facevano
razzie nell’interno e vendevano in catene le tribù sottomesse a trafficanti
islamici che dominavano il mercato dei beni per le potenze coloniali. Anche
nelle tredici colonie britanniche originali che dettero vita al nucleo dei
futuri Stati Uniti ribelli alla Corona inglese esisteva una vasta popolazione di
schiavi usati come mano d’opera bracciantile agricola. Secondo l’interessata e
sfacciata narrazione dei democratici, egemoni negli Stati del Sud, lo schiavismo
non era un insulto alla dignità umana, perché secondo loro gli schiavi –
considerati stupidi e incapaci di rispettare qualsiasi disciplina, potevano
secondo loro ringraziare Iddio per essere messi sotto la frusta dell’uomo bianco
che comunque garantiva loro un welfare: un tetto, cibo caldo d’inverno e le cure
essenziali. Naturalmente il padrone bianco considerava un suo privilegio abusare
sessualmente delle donne acquistate e spesso offerte in uso ai rampolli per puro
intrattenimento. Tutto ciò non costituiva una esclusiva dei bianchi americani
(di discendenza inglese) ma valeva anche per i francesi, spagnoli,
portoghesi e olandesi. Ed era considerato del tutto normale dal punto di vista
etico nelle potenze occidentali, che praticavano lo schiavismo nelle loro
colonie americane o altrove. A Venezia, la tratta degli schiavi neri era di uso
comune e se ne trovano le tracce nei quadri della pittura veneziana, ricca di
servitori neri in polpa e parrucca. Quando nacquero gli Stati Uniti con
la rivoluzione americana (il generale George Washington era già stato comandante
dell’esercito continentale inglese, giubbe blu anziché rosse) la questione della
schiavitù fu subito terreno di scontro fra chi aveva interessi nell’agricoltura
e chi voleva dare senso alla dichiarazione secondo cui “tutti gli uomini nascono
uguali”. Come sappiamo, i primi presidenti possedevano grandi schiavi che
facevano parte, come in tutto il continente non soltanto statunitense, del
patrimonio terriero. Il primo presidente libero dal peccato originale dello
schiavismo fu Abraham Lincoln, che fu anche il primo Presidente repubblicano,
poi assassinato. La notizia della sua elezione scatenò immediatamente la
secessione degli stati schiavisti. Oggi è molto diffusa fra gli storici
americani l’ammissione del fatto che la guerra civile fu una guerra fra
repubblicani antischiavisti e democratici schiavisti. Ma pochi ricordano oggi
che prima della guerra esisteva nel Nord degli Stati Uniti una borghesia di
cittadini americani neri, liberi, in genere uomini d’affari specialmente nello
Stato di New York, alcuni dei quali nel business del mercato degli schiavi per
il Sud. Questa significativa borghesia nera libera è anche la causa della
qualità della musica jazz. Il jazz, come ci ha insegnato la filmografia, nasce
dalle musiche per funerali e per i gospel, i Vangeli letti e cantati in chiesa.
Ma la musica jazz come noi la conosciamo nasce grazie alla borghesia nera ricca
e libera che impartiva ai figli una educazione aristocratica che in genere
comprendeva anche il viaggio in Europa e la frequentazione di università inglesi
e francesi, con una educazione musicale molto avanzata. Quando, dopo la guerra
civile che si concluse con la sconfitta degli schiavisti, furono introdotte le
infami leggi razziali – le cosiddette Leggi di Jim Crow – della segregazione,
specialmente negli Stati ex Confederati del Sud, tutta la ricca borghesia nera e
libera che si era sempre sentita parte della “upper class” americana, si ritrovò
di colpo retrocessa nei ghetti imposti dalla segregazione. Fu così che la classe
dei neri liberi con un alto livello di istruzione e di benessere, furono
costretti a condividere la loro sorte con la massa degli schiavi liberati, che
erano totalmente analfabeti e privi di qualsiasi abilità che non fosse quella
dei braccianti agricoli nei campi di cotone. Se uno vuole avere un’idea –
totalmente romantica e manipolata ma comunque molto istruttiva del mondo
di Dixieland – può sempre rivedersi magari per la quinta volta “Via col vento”,
la cui interprete nera, quella che aveva il ruolo affettuoso e protettivo
di Mamie, prese il primo Oscar concesso a una donna afroamericana. Non si sa
bene perché quella parte del Sud confederato chiamasse se stesso Dixieland. Una
larga area era appartenuta ai francesi, quando la Louisiana, la terra del Roi
Louis, comprendeva quasi tutto il Sud e fu svenduta per un pugno di dollari da
Napoleone alla ricerca di fondi per finanziare le sue guerre contro gli inglesi,
i quali a loro volta angariavano gli americani considerandoli traditori
filofrancesi, e anche perché fra loro c’era una enorme quantità di irlandesi
cattolici che odiavano l’Inghilterra e che facevano apertamente il tifo per
la Francia, così come durante la Prima guerra mondiale facevano il tifo per
la Germania. E in quel mondo, la banconota più usata era quella da “Dix
Dollars”, dieci dollari in francese e per questo detta poi Dixieland, la “terra
dei dieci dollari francesi” il cui inno – peraltro bello e popolare come musica
– non è cantabile perché è considerato giustamente un inno razzista. In questi
giorni successivi all’omicidio di George Floyd, vengono volentieri abbattute le
statue dedicate al generale Lee, comandante dei confederati sudisti e onorato
come protagonista della storia americana. Già gli ultimi cinque governatori e
sindaci del Sud avevano vietato di esporre la bandiera confederata, perché
considerata il simbolo degli schiavisti razzisti, e la morte di George
Floyd spinge giorno dopo giorno tutti i governatori e i sindaci a mettere al
bando senza indulgenze e compiacenze i simboli dell’America che fu sconfitta
nella guerra di Secessione, ma che è tuttora viva e vegeta. E, ovviamente,
razzista. La parte più marcia del razzismo americano non è più quella collegata
all’epoca degli schiavi, ma a quella successiva mostruosità della segregazione.
Quando si parla delle Leggi di Jim Crow, che stabilirono le regole della
segregazione dopo la guerra civile, non si parla di un legislatore chiamato Jim
Crow. “Jim Crow” era un nomignolo razzista che voleva dire più o meno “piccolo
negro” e proveniva da una canzoncina il cui ritornello diceva “Jump Jim Crow”, e
cioè più o meno “salta negretto”, facendo parte di una iconografia e un comune
sentire, secondo cui i neri non fanno che saltare e ballare. Il corpo
legislativo che imponeva la separazione fra bianchi e neri nelle scuole, posti
di lavoro, mezzi di trasporto, cinema, ristoranti e luoghi di riunione comprese
le chiese e i campi sportivi. Un secolo fa il presidente americano Wilson, il
democratico che si installò a Versailles alla fine della Prima Guerra
Mondiale per progettare un nuovo mondo senza guerra, emanò dei regolamenti
burocratici per evitare che le impiegate bianche e quelle nere dovessero subire
il disagio di lavorare nelle stesse stanze. Quando Hitler salì al potere nel
gennaio del 1933, la macchina razzista del nazional-socialismo si mise subito
all’opera per compiere il primo atto di antisemitismo: negare i diritti civili
ai tedeschi di discendenza ebraica, facendone di cittadini di serie B. Una
apposita commissione di esperti costituzionalisti e giuristi tedeschi scoprì che
le leggi americane di “Jim Crow” sembravano perfette: era possibile ed accettato
persino nella più grande democrazia del mondo, che una parte dei cittadini, per
motivi razziali non avesse tutti i requisiti per godere dei diritti concessi ai
cittadini razzialmente puri. Durante lo schiavismo era severamente vietato e
punito fornire istruzione ai “negroes”, che tuttavia imparavano a leggere nelle
chiese per cantare gli inni stampati e disposti sui banchi. I neri erano anche
esclusi, per una presunta manifesta incapacità, dagli sport e dalla musica, cioè
nei campi in cui i neri nella prima metà del secolo scorso cominciarono a
dominare quasi incontrastati. E naturalmente erano considerati inutilizzabili
come soldati perché trattati come codardi e refrattari a qualsiasi
autodisciplina. Durante la Prima Guerra Mondiale per la prima volta fu concesso
ad alcuni reggimenti di volontari “coloured” di battersi nelle trincee al fianco
dei reggimenti bianchi e naturalmente i soldati di colore dettero prova di
qualità insospettate che stupirono gli stati maggiori. Durante la Seconda Guerra
Mondiale ottennero di formare un gruppo “colored” di piloti da caccia che fece
faville e anche questo contribuì a far cadere blocchi di pregiudizi. Certo,
all’epoca in cui sia Kennedy che subito dopo Lyndon Johnson mandarono l’esercito
per garantire il diritto alla scuola e agli autobus non segregati, nessuno
poteva immaginare che un generale nero come Colin Powell potesse arrivare al top
della gerarchia militare o che un sindacalista di Chicago diventasse il primo
presidente nero degli Stati Uniti. Peraltro, giova sempre ricordare per non fare
confusioni, Barack Obama non discende dagli schiavi e dalla segregazione, ma da
un intellettuale kenyota, ex funzionario dell’amministrazione britannica,
passato a prendere una laurea alle Hawaii lasciando un pargolo in una bionda
studentessa del tutto wasp, cioè purissima bianca, anglosassone protestante.
Storia dello schiavismo americano: l’uso della sessualità per
fini produttivi. Paolo Guzzanti su Il Riformista il
12 Giugno 2020. Fu in Brasile che capii tutto (o quasi) sullo schiavismo in
America e il conseguente problema razziale. La questione razziale nasce nel
momento in cui gli schiavi, come anche i servi della gleba in Europa, i “Jacques
Bonhommes” in Francia, i mugiki nell’impero zarista, vengono non soltanto usati
come manodopera non pagata e quindi estorta con violenza (che è appunto la
conduzione servile, come nella Roma imperiale) ma mantenuti in uno stato
di inferiorità umana. La degradazione nella dignità risponde a una esigenza
funzionale: lo schiavo, quale che sia il colore della sua pelle, deve essere
declassato a sotto-uomo – in Germania l’übermench – e degradato nella sua
dignità. A tutti gli schiavi è stato in genere impedito di istruirsi per non
accedere ai ranghi culturali della classe dominante, salvo gli schiavi greci a
Roma, usati come tutori e insegnanti proprio perché quella era la funzione loro
richiesta. In alcuni Stati degli Usa l’istruzione degli schiavi era proibita e
punita, in altri solo sconsigliata e saltuariamente incoraggiata per motivi
religiosi e di solidarietà umana. Ma credo sia fondamentale – soltanto per
capire perché alla figura dello schiavo era necessario associare una condizione
subumana. Lo schiavo Jim Crow, nomignolo spregiativo, corrispondeva all’uomo
nero instupidito dalla fatica e dall’ignoranza, pericoloso per i suoi appetiti
sessuali considerato animale e violento, pigro, lagnoso, sempre pronto a ballare
e cantare, capace di un’unica forma di resistenza, la pigrizia. Alla quale il
padrone opponeva come antidoto la frusta e la forca. Ciò spiega il clima di
terrore e pregiudizio fra i bianchi del Sud dopo la liberazione degli schiavi,
mantenuti per decenni se non per secoli in uno stato sottomesso e culturalmente
vegetativo. La liberazione ebbe anche conseguenze italiane. Dovendo retribuire
gli ex schiavi con almeno due dollari al giorno, i landlords proprietari
dei cotton fields e le altre aziende agricole, cercarono mano d’opera
in Calabria e Sicilia da cui prelevarono un migliaio di famiglie che furono
installate a New Orleans negli anni Settanta del XIX secolo. Fu un’ondata
migratoria precedente e diversa da quella successiva che conosciamo perché era
concentrata a New York, dopo lo screening a Ellis Island. Quella di New Orleans
andò malissimo e finì in pogrom: i nuovi arrivati dall’Italia erano dannatamente
simili ai “negroes” appena liberati: scuri, bassi, analfabeti, descritti
dall’antropologo italiano Cesare Lombroso (altamente considerato negli Stati
Uniti) come persone di sangue misto a causa delle invasioni arabe e la presenza
di molti africani in Sicilia. Il disastro avvenne quando fu ucciso uno sceriffo
che indagava su una organizzazione mafiosa portata dagli italiani e che aveva
imposto il “pizzo” ai commercianti di New Orleans. Inoltre, i nuovi arrivati dal
Mezzogiorno italiano appena ricongiunto all’Italia dei Savoia e devastato dalla
repressione piemontese del banditismo, avevano stretto subito una alleanza
sociale e per così dire culturale, proprio con i “negroes”, partecipando a
fiorenti iniziative commerciali per scambi marittimi nei Caraibi. Molti italiani
furono arrestati, strappati alla polizia a furor di popolo e impiccati. Gli
altri furono espulsi e soltanto pochi risalirono gli Stati Uniti verso Nord,
raggiungendo l’emigrazione dei fuggiaschi politici, anarchici e ricercati dalla
polizia francese, dopo la disfatta di Napoleone III che Felice Orsini aveva
tentato di uccidere con bombe fabbricate a Londra sotto la regia di Mazzini.
Esiste un largo materiale fotografico su questa vicenda e la presenza dei
siciliani a New Orleans, con le donne della provincia di Palermo sedute fuori
della porta mentre fanno la maglia. Nel Brasile degli anni Ottanta realizzai
alcuni documentari sullo schiavismo dei portoghesi che trasferivano intere
popolazioni africane dalle loro colonie fin dal 1532 e che mantennero in catene
i loro servi fin quasi la fine dell’Ottocento. Lì scoprii una delle conseguenze
dello schiavismo: l’inizio dell’arte della chirurgia plastica che in Brasile ha
avuto sempre una ricerca d’avanguardia. E il motivo è semplice e terribile: le
schiave potevano dirsi fortunate e ottenere condizioni di vita meno oppressive,
finché erano giovani e sessualmente spendibili. In Brasile una donna diventava
vecchia a diciotto anni, perché le nuove leve erano reclutate fin dalla prima
adolescenza e anche qualche anno prima. Non so quante volte mi hanno raccontato,
con nomi di persone e di città diversi, la stessa leggenda. Quella di una moglie
brasiliana che si era accorta delle attenzioni che il marito dedicava alle
schiave giovani e che per rappresaglia gliele serviva cucinate a tavola, gli
occhi nella minestra di legumi. Naturalmente si tratta di una leggenda popolare,
ma faceva parte dell’autobiografia di una nazione. Infatti, una delle angherie
più ovvie e più torbide della schiavitù era quella dell’uso proprietario sia
della sessualità servile, che della loro riproduzione. Per la riproduzione, i
padroni più umani, religiosi e illuminati favorivano la formazione di vere
famiglie con padre, madre e figli nati in casa. Nel mondo creolo che un tempo
cominciava già in Florida, le schiave nate sotto il tetto del padrone erano
chiamate con l’appellativo “criadas”, cioè create in casa, come una stirpe
domestica mansueta, fedele, operosa e sostanzialmente stabile e adattata alla
condizione servile. Talvolta le famiglie venivano distrutte da un atto di
vendita che separava i componenti perché le leggi sulla proprietà permettevano
in quasi tutti gli Stati queste operazioni. Quando gli Stati Uniti conquistarono
l’indipendenza, decisero dopo feroci lotte politiche basate su criteri sia
economici che etici, di mantenere lo schiavismo introdotto dagli inglesi, ma
stabilirono anche che non si potessero più introdurre nuovi schiavi
dall’Africa o dall’America Latina. Ciò significava che per mantenere intatto il
patrimonio della manodopera servile era necessario mantenerla fertile con donne
fertili attive e riproduttori selezionati come gli stalloni o altri animali da
monta. Esiste una letteratura della memoria americana in cui, per via femminile,
sono narrate tra le altre forme di stupro, quella a puri fini riproduttivi
decisa dal landlord il quale pretendeva di selezionare le donne da procreazione
e i maschi fecondatori scelti per le loro caratteristiche fisiche e di
comportamento. A questo si aggiungeva, ovviamente, l’abuso sessuale diffuso e
persino scontato dei proprietari e del loro personale bianco, sulle donne nere
per puro intrattenimento. E anche su questa insostenibile memoria grava
un’ulteriore conseguenza per il popolo che poi sarà chiamato afroamericano: la
distruzione della famiglia. La comunità degli ex schiavi, quasi subito segregata
da leggi che limitavano i loro diritti civili e li separava dalla popolazione
bianca nelle scuole, chiese, autobus e ogni luogo di riunione, non aveva memoria
della famiglia. E l’avrebbe col tempo ricostruita solo in parte. Tuttora, come
ho potuto constatare insieme a chiunque voglia vedere con i suoi occhi,
specialmente negli Stati del Sud, una larga parte delle adolescenti nere cerca
la gravidanza che le permetterà di vivere di sussidi statali insieme ad un
bambino che molto raramente vedrà una figura paterna. I bambini diventano così
figli della strada nelle periferie, con i maschi che si radunano in bande e le
femmine che trascurano la scuola aspettando di diventare madri con un sussidio.
Questa è una situazione più volte denunciata dalle femministe nere americane e
anche da donne nere non femministe come Candace Owens che accusano il Partito
Democratico americano di avere storicamente seguitato ad abusare del popolo
afroamericano scoraggiando la formazione delle famiglie, incoraggiando sussidi
che mantengano le donne sotto controllo anche con un accesso estremamente
facilitato all’aborto per contenere le nascite dei neri e al tempo stesso
coltivandoli come bacino elettorale dopo aver favorito il loro esodo dal Sud
agricolo alle estreme periferie delle megalopoli e specialmente a Chicago, dove
d’estate si registra il più alto numero di vittime per sparatorie fra
adolescenti neri. Ma nella letteratura afroamericana esiste un genere ormai
classico: quello del rapporto fra l’uomo bianco e la donna nera che ha imparato
molto presto a destreggiarsi e difendersi e persino a capovolgere i ruoli nello
sfruttamento sessuale. Questa antica resilienza delle donne nere è ancora oggi
un elemento fondamentale per comprendere la società americana nei suoi
reconditi. Anche perché durante il XIX secolo si sono formate in Alabama,
Tennessee e molte contee della Georgia e della Florida del Nord, delle alleanze
di donne sole e forti, nere e bianche insieme, fuggite o sfuggite allo stesso
dominio bianco. È nato così uno stereotipo che si riconosce anche in una
letteratura e musica country, in cui la donna vive da sola, con il suo pick-up o
il suo cavallo, è sessualmente libera, è armata, è una esperta tiratrice e una
smaliziata giocatrice di poker, una affarista, spesso proprietaria di saloon e
di bordelli come Nell Kimball, la celebre autrice di Memorie di una maîtresse
americana, una storia che finisce durante la Prima guerra mondiale, nel 1917, e
che racconta una società radicalmente diversa da quella europea, con
protagoniste bianche e nere del tutto sradicate dalla famiglia, spesso inclini
al banditismo e al nostalgico fatalismo di amori brevi e disperati vissuti di
sera davanti al fuoco con la chitarra, un pony e una chitarra.
Storia dello schiavismo americano: tutte le sfumature dei neri
d’America. Paolo Guzzanti su Il Riformista il 16
Giugno 2020. Nessun Paese moderno ha avuto la stessa sorte degli Stati
Uniti nella secolare storia coloniale inglese, francese e anche spagnola, quanto
a schiavismo e razzismo. Lo stato delle cose oggi, nel pieno dell’ondata di
shock per gli omicidi di afroamericani da parte di una polizia spesso comandata
da neri anche in città il cui sindaco è nero, nasconde una tormentosa vicenda di
cui abbiamo smarrito il filo. Quando tutto cominciò, intorno al 1600 e dopo
molti falliti tentativi di schiavizzare i nativi, a partire da Cristoforo
Colombo per conto della Spagna prima di ricorrere agli africani, la servitù e la
vendita degli esseri umani, anche non africani, era normalmente praticata sia
dagli inglesi che dai francesi che dominavano insieme l’America del Nord. Sul
continente Nord Americano si svolse parte della Guerra Indiana, per noi Guerra
dei Sette anni, in cui i reggimenti inglesi fronteggiavano le giubbe blu
francesi: «Monsieurs les Anglaises, tirez le premiers», concedeva abbassando il
cappello la staffetta francese ai cannonieri nemici invitandoli a far fuoco per
primi per misurare la gittata dei loro cannoni. Sia i francesi che gli inglesi
deportavano volentieri tutti gli indesiderabili nelle colonie americane come
galeotti e come schiavi. La Guyana francese diventò la “ghigliottina secca” per
coloro che si voleva far sparire per sempre in Europa. Come ad esempio i
complici italiani dell’anarchico Felice Orsini che fu decapitato per aver
provocato una strage nel tentativo fallito di uccidere Napoleone III, che ebbero
la pena commutata alla Guyana da cui evasero con la complicità inglese per
essere poi mandati negli Stati Uniti ad arruolarsi nella cavalleria del generale
Custer, sicché uno di loro partecipò e sopravvisse alla battaglia di Little Big
Horn. Nelle colonie, la vita umana era sempre soggetta a servitù e si vendevano
al mercato, con gli africani, anche i Green negroes, gli irlandesi ribelli
biondi, bianchi e cattolici, incatenati e messi all’asta. L’Inghilterra deportò
in America un grande numero di scozzesi sconfitti nella lunga resistenza del
XVII secolo insieme con irlandesi vendibili, acquistabili come mano d’opera,
essendo pratica comune risarcire con anni di schiavitù le spese di deportazione
o di emigrazione sicché una gran quantità di donne furono costrette a
prostituirsi sotto padrone fino a estinzione. Nella Nouvelle France canadese
voluta da Louis XIV, il Re Sole che spingeva per una forte espansione in America
del Nord, poi svenduta da Napoleone al Presidente Jefferson, il popolo degli
Irochesi aveva carte blanche per schiavizzare i coloni inglesi e portare via
prigioniere a vita le donne con i loro figli. La Francia nel territorio della
grande Louisiana che oggi fa parte degli Stati Uniti ammetteva lo schiavismo
degli africani, ma con limitazioni fra cui il rispetto per l’unità familiare dei
neri e il diritto all’alfabetizzazione che invece era vietato in quasi tutte le
colonie britanniche. Altra situazione era fino a pochi decenni fa
drammaticamente visibile nel Belize – ex Honduras Britannico – e ad Haiti per
quanto riguarda il lato oscuro della Francia. Il Belize è un Paese
centroamericano abitato quasi esclusivamente da discendenti di schiavi africani
degli inglesi, di cui conservano alcuni accenti. La sua esistenza è una
conseguenza della coscienza sporca dei colonialisti inglesi quando fu necessario
chiudere la pratica schiavista offrendo come premio di consolazione una piccola
patria: arrangiatevi, noi non vogliamo più saperne. Haiti è un’altra curiosa
realtà figlia dello schiavismo francese, dove sono stati concentrati decine di
migliaia di africani trasferiti con la forza in ondate successive
dall’Africa poiché la mitica isola di Hispaniola – dove aveva messo per primo
piede Cristoforo Colombo – produceva una quantità miracolosa di frutta tropicale
e prodotti come lo zucchero e il caffè. Lo schiavismo in quest’isola produsse un
fenomeno di cui noi oggi in Europa non ci rendiamo conto, benché Malcolm X nella
sua famosa e illuminante biografia l’avesse illustrata perfettamente: la
formazione di gerarchie di schiavi che hanno nella posizione di dominio i neri
“bianchi”, con caratteristiche somatiche impercettibili, poi i mulatti, e via
via discendendo nella scala razziale e sociale, persone di pelle sempre più
nera. Nei Caraibi, in Florida, nella Louisiana, a Cuba, ad Haiti e nell’area che
va dalle Bahamas al Golfo del Messico, a Nouvelle Orleans si formò una nuova
varietà umana molto mista e socialmente vincente: quella dei creoli, accomunati
da una lingua più o meno comune ottenuta da commistioni di francese, inglese,
spagnolo, cheyenne o altre lingue indiane, dialetti africani e influenze
irlandesi. I creoli, oltre a dominare culturalmente il bacino del Golfo del
Messico avendo accesso all’istruzione e a un alto tenore di vita, commerciavano
anche in carne umana come forza lavoro contadina, o mercenari per servizi di
sicurezza, prostituzione organizzata con ricche catene di bordelli e vivevano ai
limiti delle confraternite di pirati dalla Tortuga ai grandi estuari dei fiumi
americani, dal Mississippi al Rio delle Amazzoni. Era tutta gente di colore
libera, ma organizzata in caste a loro volta divise gerarchicamente secondo il
colore della pelle. Tutti costoro formavano poi comunità ampie e transnazionali
con le numerose comunità di schiavi fuggiaschi e organizzati, come i maroons
delle colonie britanniche. I francesi abbandonarono formalmente la pratica dello
schiavismo con la Rivoluzione francese, che determinò la rivoluzione degli
schiavi di Haiti. Da allora la Francia usò gli ex schiavi e i creoli, i ribelli
africani come il leggendario Mackandall, una sorta di Spartaco, per combattere
gli inglesi sul territorio americano. La Francia organizzò molti contingenti di
volontari addestrati a Port-Au-Prince per sostenere la rivolta dei coloni
americani, molto prima che il generale La Fayette formasse un corpo di
spedizione per sostenere la Rivoluzione americana. La politica della dismissione
degli ex schiavi con concessioni di territori da governare come delle
vagheggiate terre promesse, è stata sempre fallimentare. Dopo la guerra civile
americana molti ex schiavi accettarono di creare un foyer in Africa nello Stato
della Liberia, con risultati pessimi. La fine della Guerra Civile portò alla
chiusura della pratica della schiavitù, ma introdusse una situazione se
possibile ancora peggiore: quella della segregazione razziale che è durata fino
all’inizio della presidenza di John Kennedy e fu definitivamente smontata
da Lindon Johnson con l’uso massiccio della forza militare per imporre agli
Stati ex schiavisti della Confederazione sconfitta nella terra che porta ancora
il nome di Dixieland, l’integrazione nelle scuole, sugli autobus, nei locali e
servizi pubblici. Fino agli anni Sessanta i neri non votavano ma erano
conteggiati per stabilire la densità di ogni constituency, o collegio
elettorale. I neri, non più schiavi, non votavano ma la loro presenza valeva per
uno strano calcolo cinque settimi di un uomo bianco. Le leggi che avevano creato
la segregazione, distrussero dal 1870 in poi la grande cultura separata e libera
dei creoli americani, trattati tutti come colored e dunque cittadini a metà,
privi dei privilegi anche razziali di cui avevano goduto e che aveva permesso
una diffusa educazione musicale, linguistica e professionale. I decenni della
segregazione avevano appiattito e umiliato una grande società multiculturale e
anche orgogliosamente americana. Tutte le varietà originarie dei popoli africani
da cui provenivano gli schiavi erano state annullate dalle politiche di
ibridazione e annichilimento delle lingue e il risultato finale è stato un
popolo di serie B, che ormai non somigliava più ad alcun originale: né a quello
africano, né a quello coloniale, né a quello creolo. La nuova massa di cittadini
uniti soltanto dal fatto di essere di colore, non aveva più patria, né memoria,
e soltanto in maniera molto fragile una famiglia. Questo nuovo popolo che ha in
parte assorbito l’immigrazione di latinos di origine nativa, benché di lingua
spagnola ha da un secolo e mezzo iniziato una lenta e dolorosa riconquista di
tutti i gradini di accesso alla società dei bianchi, anche con una larghissima
partecipazione dei bianchi del Nord. La storia di questa rimonta continua e
drammatica è la storia della conquista sia dei diritti civili, sia della parità
nella dignità e nel trattamento riservato dalle forze dell’ordine ai cittadini,
sulla base di mentalità segregazionista tuttora vigenti, cui partecipano spesso
gli stessi law enforcement, le forze di polizia nere o guidate da neri. La
storia della società americana è sempre piena di contraddizioni e crisi mortali,
cui quasi sempre segue una rinascita.
Storia dello schiavismo americano: in catene tra i liberi, la
memoria negata. Paolo Guzzanti su Il Riformista il 18
Giugno 2020. Ieri la Pepsi Cola ha deciso di cancellare la figura del suo brand:
una donna nera detta Aunt Jemima, col fazzolettone annodato sulla fronte, uno
dei tanti simboli ripresi dagli stereotipi razziali del bravo zio Tom, quello
dei buoni “negroes”, pacifici e soddisfatti del loro ruolo subalterno, come la
celebre Mami, la schiava vice-madre di capricciose ragazze bianche in Via col
Vento, interpretata nel 1939 da Hattie McDaniel, prima attrice nera a ottenere
un Oscar. Sempre ieri, Donald Trump ha tenuto un discorso alla nazione in cui ha
annunciato il piano per una radicale riforma di tutti i comportamenti delle
forze di polizia federali e locali, affette da tradizioni e addestramenti
razzisti, messi in atto anche da black officers, agenti neri al comando di capi
della polizia neri o di sindaci e sindachesse nere. Il protocollo che prevede il
ginocchio sul collo, quello che ha ucciso George Floyd, “I can’t breath”. Da una
mia piccola inchiesta personale ho appreso che anche le nostre forze di polizia
prevedono, nel caso di arresti dopo colluttazione, il blocco dell’arrestato con
il ginocchio piantato sulla scapola, ma non sul collo. Però, siamo lì.
L’America, chi la conosce lo sa, è una nazione fatta di protocolli. È anche il
Paese in cui si leggono più libri a testa, perché i libri più diffusi sono
quelli che contengono protocolli: come si fa a fare che cosa. Non importa cosa:
uno sbarco in Normandia, una festa per bambini, un rapporto sessuale
soddisfacente, una torta di compleanno, una esecuzione capitale, un giardino ben
tenuto. Quando gli americani arrivano in un Paese come l’Italia si aspettano di
trovare un luogo con regole diverse dalle loro, ma ben spiegate. Restano
interdetti quando scoprono che da noi non ci sono manuali e regole precise. Ciò
fa parte di una mentalità anglosassone, parzialmente condivisa con inglesi,
canadesi, australiani e neozelandesi, ma c’è un fattore ulteriore: soltanto
gli Stati Uniti sono un enorme melting pot, un fritto misto in cui non si può
insegnare la Storia perché ogni famiglia americana ha quella dei suoi avi,
cinesi o peruviani, siciliani o polacchi, e nessuno si vuol far imporre la
storia di qualcun altro, come capitava agli scolari algerini ai tempi del
colonialismo francese, quando dovevano ripetere che i loro antenati erano dei
biondi galli come Asterix. Anche gli afroamericani, neri discendenti dagli
africani rapiti e venduti, chiedono la loro storia e la trovano in centinaia di
ottimi libri, reportage, memoirs, romanzi, ma la verità è che la loro storia
è “broken”, infranta non soltanto dallo schiavismo, ma dalla ghettizzazione di
un mondo che è stato segregato per secoli e amputato nella memoria. Tutto ciò
che è accaduto in quel Paese dalla fine della Guerra Civile in poi, è stato un
lungo e doloroso processo di cicatrizzazione e conciliazione che però non avrà
mai fine perché il peccato originale di cui nessuno può rispondere oggi, ha
spezzato le identità. Quando milioni di italiani accettarono di buon grado di
emigrare in America, lo fecero con il desiderio di annullare la loro vecchia
identità e di assumere quella nuova, non per essere integrati, ma assimilati.
Chi ha la pelle di un colore diverso dal bianco non può mai pensare di
assimilarsi, come impararono gli americani di origine giapponese, chiusi in un
campo di concentramento nel 1941 quando cominciò la guerra contro il Giappone.
Gli americani di origine italiana o tedesca non fecero la stessa umiliante
esperienza. Dice il migliore degli analisti americani, George Friedman: «Noi
americani siamo diversi da tutti gli altri popoli perché abbiamo scelto di
vivere in questo Paese e diventare americani o perché non ci piaceva il Paese in
cui siamo nati, oppure perché al Paese in cui siamo nati non piacevamo noi».
Friedman è nato nel 1949 a Budapest da una famiglia ebrea sfuggita alla Shoah e
ha ragione. Tuttavia, la sua definizione non si applica a tutti coloro che in
America non sono andati per scelta, ma sono stati rapiti e venduti, che è
appunto quanto è capitato a coloro che hanno la pelle nera e che per molto tempo
ha subito anche una damnatio memoriae. Nel 1915 uscì un terribile film: The
Birth of a Nation (la nascita di una nazione) che fu acclamato come una vera
autobiografia dell’America bianca: nel film si mostra come Abraham Lincoln volle
sovvertire l’autonomia dei singoli Stati nei loro rapporti con
i “negroes” scatenando la guerra civile e rendendo necessaria la nascita del Ku
Klux Klan (una creatura del Partito democratico) e la legge di Lynch che
permetteva l’impiccagione dei neri ribelli. La compravendita di esseri umani era
evidentemente accettata anche dalla Chiesa che arbitrava le controversie
territoriali in America dei cattolicissimi regni di Spagna e Portogallo: la
linea di confine tra Brasile e territori spagnoli fu tracciata negli uffici
papali di Viterbo, dove certo non si ignorava lo schiavismo. Santa Romana Chiesa
raccomandava soltanto che gli africani fossero doverosamente battezzati e fosse
loro permesso di accedere alle messe e ai sacramenti, ma la libertà non era un
suo business. La sorte degli Stati Uniti fu e resta unica al mondo: un Paese
nato da un nucleo coloniale inglese – le tredici colonie originali da cui le
tredici strisce della bandiera – in cui gli schiavi erano stati introdotti dagli
inglesi, così come avevano fatto nei Caraibi e in America centrale e che
diventavano territori di emigrazione europea. La popolazione americana che visse
l’epopea del West e della corsa dei carri, fu un’epopea olandese, tedesca,
svedese (e tutto il Mid West statunitense è una filiazione tedesco-svedese) e
poi irlandese e scozzese. Gli inglesi alla fine del Seicento consentivano la
vendita di qualsiasi essere umano, anche bianchi e biondi irlandesi condannati
alla deportazione. Alla fine del processo di indipendenza americano, la nuova
entità politica era spaccata in due fra schiavisti e antischiavisti. Gli
schiavisti del Sud ereditavano territori e coltivazioni dell’antica e vastissima
Louisiana francese, detta Dixieland per l’uso della banconota francese da Dix
Dollars e l’invenzione della macchina detta “Cotton Gin”, la sgranatrice di
cotone che permetteva di commerciare grandi quantità di cotone a basso prezzo e
che aveva spinto i sudisti a pretendere il mantenimento dello schiavismo,
profondamente avversato al nord, dove pure esistevano schiavi, insieme a una
borghesia nera libera. Quando nel 1858 Abraham Lincoln, che teneva a battesimo
il Partito Repubblicano e che non aveva mai posseduto schiavi, si presentò
ai “Great Debates”, i grandi dibattiti contro l’opponente democratico e
schiavista Stephen Douglas per il seggio senatoriale dell’Illinois, alla fine
perse e non fu eletto. Ma i grandi dibattiti misero in chiaro una cosa: «Quel
che è certo – disse Lincoln – è che gli Stati Uniti non possono andare avanti
così: una parte schiavista e l’altra parte nemica dello schiavismo. Non possiamo
più reggere questa duplicità. Bisogna assolutamente arrivare a una unificazione.
Forse, diventeremo tutti schiavisti: e allora riporteremo gli schiavi anche dove
sono stati liberati. Oppure, abbatteremo lo schiavismo dove ancora esiste e
cancelleremo questa macchia dalla nostra coscienza collettiva». Le parole
di Lincoln erano chiare: l’America doveva emendarsi dal peccato originale
inglese e onorare la premessa etica della sua esistenza, fondata sul principio
secondo cui “tutti gli uomini sono nati uguali”. Tutti i primi presidenti
degli States, a cominciare da Washington, erano stati proprietari di schiavi e
alcuni di loro aveva persino avuto folta e colorata prole da amatissime schiave.
Lincoln era un giovane avvocato magro dall’aspetto troppo giovanile per essere
preso sul serio e per questo decise di farsi crescere quella curiosa barba senza
baffi che gli incorniciava il viso. Era chiaro che una sua elezione alla
Presidenza avrebbe significato la fine dei privilegi dei proprietari terrieri e
fu per questo che non appena cominciarono ad emergere i risultati, avvenne la
secessione e scoppiò una guerra che divise Stati e famiglie, combattuta contro
un nemico che parlava la stessa lingua e abitava nelle stesse città e che costò
fra morti e mutilati, poco meno di un milione di perdite. Lincoln fu assassinato
e dopo un grande processo, otto persone furono impiccate pubblicamente e la loro
agonia fu fotografata nei dettagli. Fra gli impiccati per la congiura che aveva
portato alla morte del presidente anti-schiavista, Mary Surratt che gestiva la
pensione in cui si erano riuniti i cospiratori. Fu la prima donna giustiziata
negli Stati Uniti e il racconto del suo supplizio è raccapricciante: disperata
per i dolori di una dismenorrea debilitante, essendo troppo leggera fu
appesantita da grossi blocchi di legno e strozzata dal cappio per venti minuti
prima che morisse. Nessun Paese al mondo ha pagato un prezzo così alto a una
causa sociale e morale. Ma la vera guerra scoppiò più tardi, con le successive e
lente conquiste degli spazi civili dei diritti e della dignità, dell’istruzione
e persino quello di combattere e morire per la propria patria, come accadde
nelle Prima Guerra Mondiale e il diritto allo sport, allo spettacolo,
all’istruzione, all’università, alle unioni miste che, peraltro, oggi non sono
affatto così diffuse e desiderate come negli anni Settanta e Ottanta. Una
famiglia di miei amici neri di New York mi dicono: «Oggi, se ci fai caso, i neri
se ne stanno per conto loro e così fanno gli asiatici e i bianchi. Ci sono
amicizie e matrimoni, sesso e amicizie fra colori diversi, ma con molto meno
entusiasmo di un tempo. Lo vedi alle fermate degli autobus: i neri tendono a
stare fra loro e così i bianchi e gli asiatici. Lo stesso accade nei locali
pubblici. Nessuno oggi crede che l’inter-razzialità sia una virtù ed è finita
l’era in cui si sognava l’americano perfetto, un ibrido di colori e
un’arlecchinata di antenati. Oggi ognuno vuol essere simile ai suoi genitori ed
amici, e anche i matrimoni misti e il sesso con quelli diversi da te, non è
considerato un obiettivo desiderabile: al massimo, non desta più scandalo.
L’America è fatta di diversi che chiedono più rispetto che commistione, ognuno a
casa sua, sia pure sotto una stessa bandiera».
Estratti da “L’aquila e il pollo fritto”, di Vittorio Zucconi
(Mondadori), raccolti da Giorgio Dell’Arti e pubblicati da “la Repubblica” l'8
giugno 2020.
Legno. George Washington girava con una dentiera di legno.
Cina. Saliti sull'aereo dopo la lunga visita in Cina, Nixon, lo
staff e i giornalisti trovarono ad attenderli una montagna di hamburger. Urlo
del presidente: «Bentornati a casa, ragazzi».
Io so. «Io so che cosa stai facendo, frocio» (il predicatore
evangelico Ted Haggard puntando il dito contro la telecamera. Più tardi fu
sorpreso in albergo in compagnia di un giovanotto).
Lincoln. Per seppellire Lincoln, si allestì un treno che partì da
Washington alle otto del mattino di venerdì 21 aprile 1865 e alla velocità di
otto chilometri l'ora raggiunse in tredici giorni Chicago. A ogni villaggio - a
un tratto pieno del triplo degli abitanti - il treno stava fermo due minuti.
All'arrivo, lo striscione: «Riposa sereno, Abe. Ora ti amano anche i nemici».
Esequie. Secondo Zucconi, l'America regola i propri conti con i
grandi personaggi che uccide (Lincoln, Martin Luther King ecc.) attraverso
esequie colossali. Con Kennedy la questione è ancora aperta perché «il corpo fu
trasportato in fretta, quasi clandestinamente, la sera stessa dell'omicidio, da
Dallas a Washington, nel timore di trame e attacchi bellici, in piena guerra
fredda. (...) Una nazione che non poté riconciliarsi con i resti del suo
presidente non avrebbe potuto riconciliarsi con la sua fine e non lo ha mai
fatto».
Chili. Reagan morto pesava 50 chili, la bara invece - zinco,
mogano massiccio, ottoni - tre quintali e mezzo.
Stile. Stile di Zucconi. Bush come «Peter Pan nucleare»,
l'hamburger come «polpetta di misteriose frattaglie di bovino», il mensile
patinato Playboy come «Disneyland della pugnetta», ecc.
Parte. Per sentirsi in parte, Helen Echlin, caduta poi in
depressione e in seguito scrittrice, faceva la telefonista erotica in tacchi a
spillo e giarrettiere.
Partiti. I padri fondatori si illudevano che sarebbe stato
possibile amministrare il paese con i piccoli consigli dei villaggi, poi la
guerra contro Giorgio III li convinse che ci voleva un governo centrale. Così
nacquero i partiti, ma all'inizio veniva detto "Repubblicano" il partito
centralista e "Federalista" quello delle autonomie locali. Solo più tardi (1828)
il partito centralista cambiò nome e da "Repubblicano" divenne "Democratico",
mentre "Repubblicani" divennero i "Federalisti". La percezione dei democratici
come formazione di sinistra è falsa: l'emancipazione e la lotta alla schiavitù
furono repubblicane, nel 2010 sedeva ancora in Senato un democratico novantenne
(Robert Byrd) che aveva fatto parte del Ku Klux Klan. Fu Roosevelt (peraltro
«patrizio, sdegnoso, superbo erede della nobiltà newyorchese») a spostare a
sinistra i democratici col programma di investimenti pubblici progettato per
battere la crisi del '29. Sicché poi Clinton, spostando nuovamente la
collocazione del partito, poté chiamarsi «Nuovo democratico».
Istantanee. Reagan, nella sua stanza d'ospedale, sorpreso ad
asciugare per terra «per non mettere nei guai l'infermiera ». Richard Avedon,
che all'inizio realizzava le fototessere dei marinai che sarebbero servite per
il riconoscimento in caso di annegamento.
Numeri. Qualche numero: negli Usa entrerebbero comodamente trenta
Italie, l'ultimo farmaco antitumorale - la vastatina - regala ai morenti un anno
di vita, ma costa centomila dollari, a New York si parlano 170 lingue, gli Stati
Uniti spendono in armamenti più di tutte le altre nazioni messe insieme, gli
Stati Uniti hanno ricevuto più Nobel scientifici di tutte le altre nazioni messe
insieme, le 800 basi militari sparse nel mondo permetterebbero a un presidente
di fare il giro del pianeta senza lasciare mai il suolo americano, gli ultimi
modelli d'ascensore vanno a sessanta all'ora, ecc.
Davide Falcioni per "fanpage.it" il 29 maggio 2020. "Nel 2020 ci
sarà una crisi che potrà essere paragonabile alle altre grandi prove sostenute
dai nostri antenati" e che rappresenterà "il prossimo grande punto cardine della
storia. Potrà essere un disastro ambientale, una minaccia nucleare oppure un
fallimento catastrofico dell'economia mondiale". Era il 1991 quando due studiosi
statunitensi, William Strauss e Neil Howe, predissero il futuro preconizzando
quello che sarebbe avvenuto solo 29 anni più tardi con la pandemia di covid-19:
i due lo scrissero in un libro intitolato Generazioni partendo dalla tesi che la
storia statunitense si svolge in cicli di ottant'anni circa. Le opinioni
di William Strauss e Neil Howe, come ricorda il New York Times, hanno
influenzato leader come Bill Clinton e Al Gore, ma anche conservatori vicini a
Donald Trump: mentre Strauss è morto ormai da 13 anni, ben prima di poter
verificare se le sue idee sarebbero state corrette, Howe ha potuto
effettivamente constatare che la "grande crisi del 2020" teorizzata 29 anni fa è
effettivamente piombata non solo sugli Stati Uniti, ma anche sul resto del
mondo. Ebbene, secondo Neil Howe l'attuale leadership statunitense non sarà
capace di trascinare il paese fuori dalle sabbie mobili della crisi. Spetterà
invece a una nuova generazione di politici, tutti nati a poco prima dell'inizio
del nuovo millennio, assumersi la responsabilità di guidare gli Stati Uniti.
Howe, in particolare, si riferisce a personaggi come Alexandria Ocasio-Cortez,
30 anni, Pete Buttigieg, 38 anni, e il senatore Josh Hawley del Missouri, 40
anni. In un'intervista Howe ha spiegato come non sia affatto un caso che i
politici della sua generazione – i cosiddetti boomer – abbiano preso molto sotto
gamba la pandemia di coronavirus facendosi trovare impreparati. Sono invece
stati i giovani a mostrarsi molto più responsabili, oltre che preoccupati. Starà
quindi a loro guidare il post pandemia ideando un programma economico e sociale
come nel secolo scorso avvenne con il New Deal o la scoperta del vaccino per la
poliomelite. Howe e Strauss in un loro libro scritto nel 1997 aggiunsero, a
proposito della crisi del 2020, che il partito che sarebbe stato al potere in
quel momento "sarebbe stato poi fuori dai giochi per una generazione". Se anche
questa previsione si rivelerà azzeccata per i Repubblicani il futuro potrebbe
essere a tinte fosche.
(ANSA il 29 Maggio 2020) - Donald Trump ha firmato l'ordine
esecutivo sui social media. Lo rende noto la Casa Bianca. Il presidente ha
spiegato che con suo provvedimento i social media non avranno più immunità
legale contro eventuali cause per i contenuti delle loro piattaforme. Donald
Trump ha annunciato che la sua amministrazione perseguirà una legislazione ad
hoc sui social, in aggiunta al suo ordine esecutivo. Il presidente ha detto di
aspettarsi sfide legali al proprio provvedimento ma presume che il suo governo
le affronterà bene. Donald Trump ha accusato Twitter di assumere "posizioni
editoriali" e di fare "attivismo politico" quando interviene sui cinguettii
degli utenti. Il presidente ha poi equiparato i social ad un monopolio.
Massimo Gaggi per “il Corriere della Sera” il 29 Maggio 2020. La
decisione di Donald Trump di intervenire con un ordine esecutivo presidenziale
nel delicatissimo campo dell' informazione diffusa dalle reti sociali è
criticabile da almeno tre punti di vista. In primo luogo per le motivazioni: il
presidente non nasconde di essersi mosso non per correggere gli squilibri che si
sono creati man mano che i pionieri della Silicon Valley sono diventati giganti,
ma per punire reti che teme possano danneggiarlo (o non supportarlo
adeguatamente) nella corsa verso la rielezione. C' è poi il dato istituzionale:
secondo molti giuristi tentare di alterare il quadro definito dalle leggi del
Congresso con atti amministrativi è una forzatura. Infine, è tutta da verificare
l' efficacia dello strumento messo in campo: non sarebbe la prima volta che
Trump emette un ordine esecutivo che non porta a risultati concreti perché
inapplicabile o perché viene subito contestato nei tribunali. Quella sulla
regolamentazione delle piattaforme sociali si delinea come una battaglia senza
eroi e, per adesso, con molti sconfitti: sconfitti i giganti della Silicon
Valley che si sono sempre opposti a ogni forma di regolamentazione anche
esercitando pressioni lobbistiche schiaccianti. Pretendevano di essere
ambasciatori del bene assoluto e di non avere responsabilità davanti alla
politica e alla società. Ma sconfitto è anche il Congresso che, quando il vento
è cambiato e si sono create le condizioni per intervenire, non ha saputo andare
oltre i processi mediatici e proposte di legge che sembravano più rappresaglie
che progetti di riforma. C' è, infine, la sconfitta postuma di Obama che per
otto anni ha visto crescere gli squilibri informativi e le diseguaglianze
tecnologiche senza intervenire, salvo sentenziare, poco prima di lasciare la
Casa Bianca, che quella delle diseguaglianze sarà la sfida decisiva del futuro.
Trump, come al solito, si muove con prepotenza e con gli occhi fissi sulle urne
del 3 novembre, ma va a toccare un problema reale: l' irresponsabilità dei
grandi tycoon della Silicon Valley che pretendono di autoregolamentare la loro
immensa influenza sulla formazione della pubblica opinione soprattutto in campo
politico. Aziende spesso prive di cultura politica e istituzionale decise a
massimizzare il profitto invadendo anche il campo dell' editoria, forti di un'
assoluta impunità. Solo in tempi recenti questi gruppi si sono posti il problema
di limitare la circolazione di post e video falsi o offensivi. Scoprendo la
difficoltà di costruire un controllo dei contenuti capillare ed equilibrato.
Ieri il New York Post ha mostrato che il capo del «controllo dei fatti» di
Twitter, Yoel Roth, ha una storia di attivista politico di sinistra che ha
espresso giudizi durissimi su Trump. Cosa che ha consentito al presidente di
sostenere che «sono editori di parte, non entità neutrali: è come se una società
telefonica censurasse le vostre chiamate». I leader di queste industrie,
intanto, si sono divisi su cosa è giusto fare, come dimostra la contrapposizione
di ieri tra il capo di Twitter, Jack Dorsey, e il fondatore di Facebook Mark
Zuckerberg: col primo che ha cercato di difendere la scelta di sottoporre a fact
checking un tweet nel quale il presidente giudicava fraudolenti i voti inviati
per posta (tesi falsa ma sostenibile, visti alcuni, limitati precedenti di uso
improprio del voto a distanza) mentre un altro post nel quale Trump accusa un
giornalista suo avversario di essere un assassino non è stato cancellato. Un
modo di procedere approssimativo che ha dato a Trump la possibilità di accusare
le piattaforme digitali di «censura selettiva» mentre Zuckerberg ha sentenziato
che i social media non possono pretendere di essere gli arbitri della verità.
Twitter censura di nuovo Trump: “Media manipolati”.
Notizie.it il 19/06/2020. Per Donald Trump i media sono
manipolati e Twitter lo censura. Continua la querelle Twitter contro Donald
Trump: il noto social network censura nuovamente il Presidente degli Stati
Uniti. Si tratta del secondo episodio simile nello spazio di poche settimane.
Questa volta, a far arrabbiare il social dei cinguettii, è un video postato da
Donald Trump in cui si fa riferimento alla presunta manipolazione dei media. E
così Twitter ha deciso di censurare nuovamente il Tycoon. “Manipulated media”,
la scritta comparsa sotto un tweet in cui Donald Trump ha postato una versione
‘taroccata’ di un video molto popolare sui social, virale fin dal 2019. Il video
in questione, rilanciato da Donald Trump, è quello di due bimbi, uno bianco e
uno afroamericano, che corrono l’uno verso l’altro alla fine abbracciandosi. Nel
video postato dal presidente statunitense si vede invece il bimbo bianco
inseguire quello nero e sotto la scritta: “Bambino terrorizzato fugge da bambino
razzista”. Un video inaccettabile per Twitter che ha deciso di censurare quanto
postato da Trump. Lo scorso 5 giugno, quando Trump fu censurato per la prima
volta da Twitter, il Tycoon commentò così: “Sui social media una manciata di
realtà controllano una vasta porzione di tutte le comunicazioni pubbliche e
private negli Stati Uniti. Hanno avuto il potere incontrollato di censurare,
limitare, modificare, modellare, nascondere, alterare, praticamente qualsiasi
forma di comunicazione tra cittadini privati”.
Il presidente
censurato nuovamente da Twitter. Trump come Superman, voleva indossare una sua
maglietta uscendo dall’ospedale. Redazione su Il Riformista il 12 Ottobre 2020.
Un nuovo capitolo nella battaglia tra Twitter e Donald Trump. Il social network
ha infatti segnalato il tweet del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in
cui afferma di essere immune al Covid-19. Questo tweet “viola le regole di
Twitter sulla diffusione di informazioni fuorvianti e potenzialmente dannose sul
Covid-19. Tuttavia, Twitter ha stabilito che potrebbe essere d’interesse del
pubblico che il tweet rimanga accessibile”, si legge sul social network, che
nasconde il messaggio del tycoon. Trump aveva twittato di essere andato incontro
a “una totale e completa approvazione dai medici della Casa Bianca ieri. Questo
vuol dire che non posso prenderlo (immune) e che non posso trasmetterlo. Molto
bello da sapere”. Non solo. Altro scandalo è nato per le rivelazioni del New
York Times: il giornale ha riferito che Trump aveva intenzione indossare una
maglietta di Superman sotto la camicia, per poi mostrarla come segno di forza,
una volta dimesso dall’ospedale militare Walter Reed. Trump avrebbe condiviso la
sua idea in diverse telefonate con i collaboratori, senza poi metterla in
pratica: alla base della pensata l’intenzione di non volere apparire fragile
agli occhi dell’opinione pubblica dopo il ricovero. Proprio sfruttando la
malattia, Trump attacca lo sfidante Joe Biden che “ieri tossiva in modo
orribile. Non so che cosa significhi. Ma i media non lo dicono” e “non era una
cosa bella da guardare”. Tuttavia, secondo l’ultimo sondaggio Abc-Washington
Post, il Dem è avanti 12 punti a livello nazionale, con il 54% dei consensi a
fronte del 42% del repubblicano. Ancora una volta il divario è più ampio sul
tema della pandemia: l’ex vice di Obama risulta in vantaggio di 17 punti sul Gop
per quanto riguarda la gestione del coronavirus.
Irene Soave per "corriere.it" il 27 maggio 2020. Sport già
difficile prima della pandemia, la convivenza tra abitanti di una stessa città,
vicinato, condominio non sembra essersi giovata del confinamento. Lo racconta
bene questo video, oggi condiviso decine di migliaia di volte e in apertura di
siti come la Cnn e il New York Post. Central Park, a passeggio sulla «Ramble»,
un’area del parco più selvatica dove si possono avvistare animaletti e uccelli
con facilità. Per questo i cani vanno tenuti al guinzaglio. Una donna ha con
sé un cocker spaniel libero di nome Henry. Un passante la ferma e le chiede di
legarlo. Dei due contendenti poche ore dopo si saprà tutto. Lui si
chiama Christian e ha 57 anni; lei Amy (hanno lo stesso cognome — che scegliamo
di omettere da questo testo per ragioni che vi appariranno presto evidenti — ma
non sono parenti), e ne 41, e presto iniziano a litigare. «Il cane stava
rovinando delle piante», scrive lui su Facebook: per mostrare alla padrona che
il cane non le obbedisce, tira fuori dalla tasca un biscottino per cani. «Li
porto con me apposta per queste occasioni», scrive su Facebook: è un amante del
birdwatching e non deve essere la prima volta che attacca briga con qualche
padrone di cani, perché è attrezzato. Lei gli urla contro, lui impassibile
inizia a filmarla. Ed è qui che Amy gioca la carta più scorretta possibile. «Ora
chiamo la polizia», dice, in video, «e dico che c’è un uomo afroamericano che mi
minaccia»: sottolinea bene «afroamericano», come a richiamare il lungo storico
di abusi di polizia su cittadini neri, per il quale c’è pure un termine
tecnico, «shooting bias» (negli Stati Uniti, se sei nero, è 3,5 volte più facile
che la polizia ti spari; in qualche Stato è 20 volte più facile). Lui: «Prego,
chiamali». Al telefono Amy ripete tre volte «c’è un afroamericano che mi
attacca, che mi minaccia». Ha un tono di voce sempre più agitato, come se lui le
stesse addosso, ansima, piange, urla. Lui, fermo, si limita a filmarla da metri
di distanza. Le riprese si interrompono con la donna che mette il guinzaglio al
cane e lui che le dice «Grazie». L'antipatia fin qui va tutta alla padrona del
cagnolino, scorretta e fuori di sé, che gioca spregevolmente la carta del
razzismo. Poche ore dopo, però — la lite è di ieri mattina — il paladino del
senso civico Christian fa girare il video sui social: migliaia di condivisioni
in poche ore, gogna per la signora Amy , di cui ora sappiamo anche che ha 41
anni e lavora come manager per una compagnia di investimenti. Anzi, lavorava:
l'azienda, in un tweet, annuncia che l’ha messa in aspettativa. Le tv di tutto
il mondo la cercano e lei, scrive la Cnn, «non risponde al telefono». Persino il
canile dove aveva da poco preso il piccolo Henry lo ha rivoluto indietro: il
profilo Instagram che Amy aveva creato per fotografarlo, ora chiuso, mostrava
che il cagnolino si era fatto male qualche volta, e molti commenti da ieri
insinuavano che lei fosse una pessima padrona (mentre chiama la polizia nel
video strattona il cane). La polizia sul posto era intervenuta: ma entrambi, Amy
e Christian, erano già andati via. E la palla era già passata a un tribunale più
severo, quello social.
Il matematico che aveva previsto le rivolte americane.
Pubblicato venerdì, 31 luglio 2020 da Sandro Iannacone su La
Repubblica.it. Otto anni fa lo studioso Peter Turchin aveva calcolato il rischio
di tensioni sociali, che si ripresenterebbe ogni 50 anni. E così è stato,
complice la pandemia, la polizia violenta e le politiche di Trump. E' la
cliodinamica, la modellizzazione matematica delle dinamiche storiche. Fallace,
secondo alcuni esperti. "Troppe variabili per aspettarsi dei cicli regolari di
eventi". Quando si dice ''azzeccare una previsione''. Otto anni fa, in tempi non
sospetti, il matematico, biologo evoluzionista ed ecologo statunitense Peter
Turchin, della University of Connecticut, ebbe ad affermare che gli Stati Uniti,
nel 2020, avrebbero attraversato un periodo di rivolte e turbamenti
particolarmente violenti. Ed effettivamente così è stato, in virtù di una
concomitanza di eventi particolarmente infelici, tra cui spiccano naturalmente
la pandemia di Covid-19, gli atti violenti della polizia e le politiche
di Donald Trump. Potenza delle coincidenze? Nient’altro che fortuna? Può darsi.
Per togliersi il dubbio, comunque, potrebbe valer la pena dare un’occhiata più
approfondita al lavoro di Turchin, se non altro per capire cosa lo portò a
formulare previsioni tanto nefaste quanto precise. Le affermazioni di Turchin
sono contenute in un articolo pubblicato il 9 luglio 2012 sul Journal of Peace
Research, intitolato "Dinamiche dell’instabilità politica negli Stati Uniti tra
il 1780 e il 2010". Nel lavoro, lo scienziato descrisse e analizzò 1590 eventi
di violenza sociopolitica – rivolte, linciaggi e atti di terrorismo – avvenuti
durante gli ultimi due secoli: tra i più rimarchevoli, per esempio, troviamo la
guerra civile del 1870, le tensioni razziali e i sentimenti anticomunisti degli
anni Venti, la guerra del Vietnam e i movimenti per i diritti civili degli anni
Settanta. Concentriamoci sulle date: Turchin notò che gli eventi più violenti e
significativi tendono a ripetersi più o meno ogni cinquant’anni. Da qui a
formulare la previsione per il 2020 (mezzo secolo dopo le vicende del Vietnam e
le conseguenti rivolte, per l’appunto) il passo è stato breve: "Estendendo in
avanti la sequenza del 1870, del 1920 e del 1970", si legge nell’articolo, "si
deduce che il prossimo picco di instabilità negli Stati Uniti si registrerà
intorno al 2020. Si tratta di una semplice proiezione, non di una previsione
scientifica (che richiederebbe la comprensione dei singoli meccanismi alla base
degli scoppi degli episodi di violenza politica): l’analisi delle cause
strutturali delle onde di instabilità va oltre lo scopo di questo lavoro".
Turchin, insomma, non si è espresso sul perché delle violenze; si è limitato a
registrare che eventi di questo tipo sembrano accadere con regolarità nella
storia. C’è di più: "Il mio modello", prosegue, "suggerisce che il prossimo
picco di violenze sarà peggiore di quello del 1970, dal momento che le variabili
demografiche come stipendi medi, standard di vita e differenze tra le classi
sociali sono molto peggiori di allora". Il lavoro di Turchin fa parte di un
campo di studio detto "cliodinamica", ovvero (la definizione è sempre sua),
"l’area di ricerca multidisciplinare incentrata sulla modellizzazione matematica
delle dinamiche storiche". Una descrizione che ricorda molto, tra l’altro, la
celebre "psicostoria" del ciclo della Fondazione di Isaac Asimov, con la quale
era possibile, tramite metodi probabilistici e statistici, prevedere
l’evoluzione futura di una determinata società. La cliodinamica, comunque, è
tutt’altro che accettata unanimemente dalla comunità scientifica: all’epoca
della pubblicazione del lavoro di Turchin, per esempio, Massimo Pigliucci,
filosofo della scienza al Cuny-Lehman College, spiegò che "i fattori in gioco
sono così tanti e così variabili che ci sono poche ragioni per aspettarsi dei
cicli regolari di eventi, o una teoria unificata per spiegarli". Turchin sembra
però essere convinto del contrario, anzi rincara la dose: oltre al ciclo di
mezzo secolo, è convinto di averne identificato anche un altro, della durata di
2-300 anni, che può aumentare o sopprimere le ondate di violenza del ciclo di
durata più breve a seconda della sovrapposizione temporale tra i due. "Il ciclo
più lungo", spiega Turchin, "è quello che al momento comprendiamo meglio, e che
sembra essere una caratteristica universale di tutte le società complesse:
dall’Impero Romano alla Francia medievale, passando per l’antica Cina, tutte le
società sembrano oscillare tra periodi di pace e di guerra della durata di circa
100-150 anni". In ogni caso, il prossimo appuntamento è per il 2070.
Usa, la strage degli sceriffi: 5 morti al giorno causati dalle
forze dell’ordine. Marica Fantauzzi su Il Riformista
il 24 Giugno 2020. Black Lives Matter. Le vite dei neri contano. Ma anche quelle
dei bianchi e dei latinos. Se infatti è certo che nella polizia americana il
razzismo e la mano pesante nei confronti delle minoranze siano merce comune è
altrettanto comprovato che esiste un problema di violenza e grilletto facile che
travalica la linea del colore. Il quadro emerge nitido dai dati raccolti
dall’associazione Nessuno tocchi Caino, che da anni ormai pubblica un report
annuale sugli omicidi ascrivibili alle forze dell’ordine, incrociando i dati
ufficiali diffusi dall’Fbi con quelli di molti altri istituti di ricerca,
come Fatal Encounters, il più preciso e dettagliato o Fatal Force,
del Washington Post, spesso anche sensibilmente diversi. I morti per diversi
tipi di “Incontri Fatali” con le forze dell’ordine sono stati nel 2019, secondo
Fatal Encounters e secondo i dati riportati da Nessuno Tocchi Caino, 1798.
All’11 giugno di quest’anno le vittime erano 928. La grande maggioranza è stata
colpita da armi da fuoco: 1346 persone l’anno scorso, 670 quest’anno. La seconda
voce in ordine di letalità recita un laconico “Veicolo” e rinvia di solito agli
inseguimenti: 361 morti nel 2019, 212 quest’anno. Ha mietuto vittime anche
il Taser, l’arma elettronica che dovrebbe limitarsi a stordire: 31 perone uccise
l’anno scorso, 14 nei primi mesi del 2020. La divisione delle vittime per gruppo
etnico è meno semplice: nel 2019 i bianchi son stati 628, i neri 424, i latinos
233. Ci sono vittime di diverse origini etniche, ma in quantità poco rilevante
mentre i 455 morti “di razza non specificata” incidono sulla possibilità di
trarre conclusioni inoppugnabili. La stessa cosa si verifica del resto nell’anno
in corso: i bianchi sono 292, i neri 184, i latinos 88 ma le vittime “non
specificate” sono ben 349. Anche in mancanza di dati completi sembra possibile
affermare che la percentuale di neri uccisi e senza dubbio esorbitante, essendo
questi ultimi solo l’11% della popolazione totale ma anche che nel complesso la
tendenza delle forze dell’ordine a uccidere non si arresta infatti ai confii dei
ghetti neri o latini. La fascia d’età nella quel si contano più casi di incontri
fatale è quella fra i 31 e i 50 anni seguita da quella tra i 22 e i 30 anni ma
l’anno scorso son stati uccisi anche 14 bambini al di sotto dei 12 anni. La
sproporzione tra machi e femmine, nel macabro Body Count, è massiccia: nel 2019
sono periti 1606 maschi e 176 femmine, quest’anno, per ora, 828 maschi e 88
femmine. Nonostante casi sporadici di vittime delle quali la polizia non ha
comunicato il genere e di un paio di transgender, il dato è in questo caso
definitivo ed esaustivo. Un numero così esorbitante di persone uccise dalla
polizia non sarebbe possibile senza il tacito appoggio alla politica del pugno
duro da parte di una percentuale alta della popolazione, tanto più che
negli Usa i comandanti della polizia, come i Procuratori, cioè i rappresentanti
dell’accusa, sono elettivi. Dunque non stupisce che il numero degli agenti
inquisiti e condannati per questi omicidi sia inversamente proporzionale a
quello delle vittime. Tra il 2008 e il 2018 sono stati accusati di omicidio 54
agenti. Tra questi 23 sono stati assolti, 12 condannati e 19 sono in attesa di
giudizio. Per i condannati, la pena media è stata di 4 anni. Nessuno tocchi
Caino cita anche la ricerca del sito mappingpoliceviolence.org, secondo cui nel
99% dei casi di uccisioni da parte della polizia non viene intentata alcuna
azione legale. Tra gli inquisiti finisce con la condanna una causa penale su 4.
Sulla base di questi dati si possono trarre due conclusioni certe. La prima è
che all’origine dell’uso spregiudicato delle armi e della violenza da parte
della polizia c’è una sensazione fondata di impunità. La seconda è che senza la
complicità di una parte importante della popolazione questa impunità non
potrebbe aver luogo a procedere. Le manifestazioni di queste settimane sembra
abbiano almeno incrinato, ma con il forte rischio di una parentesi destinata a
richiudersi una volta spenti gli incendi. Ma la questione decisiva è la seconda
e da questo punto si vedrà presto se le manifestazioni, come già successo negli
ani ‘60, incideranno sulla mentalità diffusa e di conseguenza sulla licenza di
uccidere per la polizia.
Da "iltempo.it" il 27 maggio 2020. La morte durante l'arresto di
George Floyd a Minneapolis ha sconvolto il mondo ed è l'ultimo caso negli Stati
Uniti in cui l'eccesso dell'uso della forza da parte della polizia nei confronti
di un afroamericano porta a conseguenza tragiche. I media anglosassoni hanno
cominciato a scavare sugli agenti licenziati dopo la morte dell'uomo e hanno
scoperto che due di loro erano stati al centro di inchieste interne per il loro
operato in servizio. Il poliziotto che tiene il ginocchio sul collo di
Loyd, Derek Chauvin, 44enne in servizio da quasi vent'anni, era finito sotto
indagine per una sparatoria con morti nel 2006. Lo scrive il Daily Mail. Un
altro degli uomini coinvolti, Tou Thao, avrebbe patteggiato una sanzione di
25mila dollari per uso eccessivo della forza tre anni fa. La vicenda ha
riportato al centro del dibattito pubblico la questione razziale negli Usa. Tra
i primi a scendere in campo sono stati i giganti dell'Nba. L'ex
giocatore Stephen Jackson era un amoco di infanzia della vittima e lo ha
ricordato sui social: ''Tutti sanno che ci chiamavamo l'un l'altro Gemello. Era
andato in Minnesota per cambiare la sua vita guidando camion, gli avevo mandato
due o tre scatole di vestiti, stava facendo la cosa giusta. E voi avete ucciso
mio fratello. Ora andrò a Minneapolis, farò tutto ciò che mi è possibile per non
far passare la vicenda sotto silenzio''. Tra i campioni intervenuti per
denunciare gli eccessi della polizia contro gli afroamericani anche LeBron
James che ha postato una foto Colin Kaepernick inginocchiato durante l'inno
nazionale per protesta contro la brutalità della polizia nei confronti delle
minoranze accanto a quella di Floyd sotto il ginocchio del poliziotto.
La teoria del complotto. Il
complotto di George Floyd, la "false flag" del poliziotto-attore dietro la morte
del 46enne di Minneapolis. Redazione su Il Riformista l'11 Giugno 2020.
Alessandro Meluzzi, uno degli opinionisti di riferimento della destra sovranista
targata Salvini-Meloni, con i suoi interventi riportati costantemente dagli
account social di Lega e Fratelli d’Italia, ha condiviso una clamorosa bufala
sulla morte di George Floyd, l’afroamericano 46enne morto lo scorso 25 maggio
per mano di Derek Chauvin, il poliziotto che per oltre otto minuti si è
inginocchiato sul suo collo impedendogli di respirare. Meluzzi, già
parlamentare, che su Twitter ricorda di essere psichiatra e “Primate della
Chiesa Ortodossa Italiana Autocefala Antico-Orientale”, ha condiviso infatti la
bislacca teoria che vede nella morte di Floyd una “false flag”, con il falso
decesso dell’afroamericano inscenato per generare un complotto contro il
presidente Donald Trump e “creare uno stato di emergenza negli Stati Uniti”. Il
vero nome del “pseudopoliziotto”, secondo i complottisti, sarebbe “Ben Bailey”,
con l’uomo inquadrato dal video che sarebbe quindi un attore. Una teoria
smontata dal sito americano Boomlive, che riporta tutti i fascicoli personali
dei poliziotti coinvolti nella morte di Floyd, da Chauvin ai colleghi J.
Alexander Kueng, Thomas Lane e Tou Thao. Non solo. Il New York Times ha anche
pubblicato gli audio delle chiamate ai soccorritori nell’immediatezza
dell’accaduto, mentre online sono presenti anche articoli su precedenti problemi
con l’uso eccessivo della forza da parte di Chauvin e Thao.
DAGONEWS il 27 maggio 2020. Caos per le strade di Minneapolis
dopo la morte di George Floyd, un uomo afroamericano di 46 anni ucciso da un
poliziotto che gli ha premuto un ginocchio sul collo durante l’arresto.
L’ennesimo caso di violenza su un uomo di colore da parte della polizia che ha
fatto esplodere le rivolte in strada con migliaia di persone che si sono riunite
sotto a un distretto di polizia con i cartelli "Non riesco a respirare" e
"Justice 4 Floyd". I poliziotti di Minneapolis in tenuta antisommossa hanno
risposto ai manifestanti sparando proiettili di gomma e lanciando lacrimogeni.
Alcuni avevano le facce sporche di latte per limitare gli effetti dei gas
lacrimogeni, altri manifestanti hanno affrontato a viso aperto la polizia
lanciando mattoni e pietre contro veicoli della polizia. Altri semplicemente
fuggivano sotto la pioggia di proiettili. In una foto, un uomo è stato visto
alzare le mani in un gesto diventato famoso a Ferguson nel 2014, in seguito
all’omicidio del 18enne nero Michael Brown ucciso da un bianco poliziotto. I
quattro poliziotti coinvolti nella morte di George sono stati licenziati. Lo ha
reso noto il sindaco di Minneapolis che ha commentato: «Questa è la decisione
più giusta». L'Fbi, intanto, sta indagando sulla morte dell’uomo. «La nostra
comunità continua ad essere traumatizzata, una volta di più, esigiamo risposta»,
ha detto la consigliera comunale Andrea Jenkins. A far scoppiare le proteste
sono stati una serie di video diventati virali in cui si vede George steso a
terra mentre il poliziotto gli tiene un ginocchio sul collo: «Non riesco a
respirare! Non riesco a respirare! Non uccidermi», gridava l'uomo mentre molti
passanti si sono fermati per riprendere la scena con i telefonini. La polizia ha
poi confermato la morte dell’uomo definita «un incidente medico» dopo che gli
agenti sono intervenuti per una denuncia di truffa.
Afroamericano soffocato, in centinaia protestano a
Minneapolis. Indignazione sui social. Anche l'Nba sotto shock.
Pubblicato mercoledì, 27 maggio 2020 da Katia Riccardi su La
Repubblica.it Afroamericano soffocato, in centinaia protestano a Minneapolis. La
sorella: "Licenziare gli agenti non è abbastanza". In piazza la rabbia per la
morte di George Floyd, l'uomo trascinato via dalla macchina dalla polizia e
deceduto poco dopo in ospedale. Gli agenti sono ricorsi al lancio di gas
lacrimogeni. La famiglia chiede il processo dei poliziotti coinvolti. "Non
respiro", ha detto George Floyd, l'afroamericano soffocato da un agente che
durante l'arresto, gli ha messo un ginocchio sul collo, come mostra un video
diventato virale. Morto senza respirare, non per Covid, ma per razzismo. Oggi
centinaia di persone sono scese in piazza per protestare contro la violenza
della polizia. Contro il razzismo, nel nome di Floyd. I manifestanti sono scesi
per le strade con le mascherine, come richiesto dalla legge che neanche Trump
rispetta più. I cartelli tra le mani con scritto "no giustizia, no pace", "black
lives matter" e "basta linciarci". Hanno sfilato scadendo lo slogan "Non posso
respirare", dal luogo dove Flyod è stato ucciso fino al distretto locale di
polizia. Qui sono intervenuti agenti in tenuta anti sommossa che hanno usato gas
lacrimogeni per disperdere la folla. La gente chiede che vengano resi noti i
nomi dei quattro agenti e le incriminazioni mosse nei loro confronti. Sul caso
oltre all'agenzia investigativa del Minnesota sta indagando l'Fbi.Shawanda Hill
(a destrar), la fidanzata di George Floyd vicino al luogo dove è stato ucciso
dalla polizia di Minneapolis, Minnesota. Floyd, 46 anni, aveva figli ed è stato
descritto come un dipendente modello dal proprietario del Conga Latin Bistro
dove lavorava come guardia di sicurezza. Al momento dell'arresto-era disarmato
ed è stato ammanettato faccia a terra quando l'agente gli ha messo il ginocchio
sul collo. Ieri sera il sindaco Jacob Frey, un democratico, aveva annunciato il
licenziamento degli agenti coinvolti mostrati dal video pubblicato su Facebook:
non solo non ascoltavano le grida dell'uomo ma neanche quelle dei passanti che
chiedevano di togliere il ginocchio del collo dell'uomo. All'inizio la polizia
ha detto che l'uomo aveva "opposto resistenza all'arresto". Neanche il sindaco
ha accettato la spiegazione dicendo che "è apparso chiaro, la prima
dichiarazione non era accurata". "Per cinque minuti abbiamo visto un agente
bianco che premeva il suo ginocchio sul collo di un uomo nero indifeso", ha
detto Frey spiegando che il coinvolgimento dell'Fbi è dovuto di fronte ad un
fatto di questo genere. L'Nba sotto shock: Kerr protesta su Instagram Ma le
proteste non sono solo a Minneapolis. Per l'ex giocatore Nba Stephen Jackson,
Floyd era un "fratello". Erano cresciuti insieme in Texas. "Tutti sanno che ci
chiamavamo l'un l'altro 'Gemello'. Era andato in Minnesota per cambiare la sua
vita guidando camion, gli avevo mandato due o tre scatole di vestiti, stava
facendo la cosa giusta. E voi avete ucciso mio fratello. Ora andrò a
Minneapolis, farò tutto ciò che mi è possibile per non far passare la vicenda
sotto silenzio". ha scritto Jackson su Instagram. Anche LeBron James ha postato
sulle sue storie di Instagram il video dell'episodio e poi ha pubblicato una
foto in cui si mettono una di fianco all'altra l'immagine del poliziotto
inginocchiato sul collo di Floyd e quella di Colin Kaepernick inginocchiato
durante l'inno nazionale per protesta contro la brutalità della polizia nei
confronti delle minoranze. Il tutto scrivendo: "Adesso capite!!??!!?? O siete
ancora confusi?? #StateAllerta". Anche Steve Kerr, capo-allenatore dei Golden
State Warriors, su Twitter ha ripostato il video scrivendo "Questo è un
omicidio. È disgustoso". Quando il giocatore di football americano Colin
Kaepernick iniziò a inginocchiarsi durante l'inno nazionale suonato prima di
ogni partita di football americano e che i giocatori ascoltano stando in piedi,
molti si scagliarono contro di lui. Lo chiamavano anti americano, irrispettoso.
Ma la sua era una protesta pacifica contro l'ingiustizia razziale e la brutalità
della polizia. Alle domande dei giornalisti, Kaepernick risponedva che non
voleva onorare un paese in cui la minoranza nera era ancora oppressa. Il suo
gesto fu imitato da molti giocatori professionisti, inizialmente nella NFL e poi
in altri sport, attirando una considerevole attenzione. Dopo aver rescisso il
suo contratto con i San Francisco 49ers a marzo 2017, Kaepernick rimase senza
contratto. Dopo che ieri un ufficiale di polizia di Minneapolis si è
inginocchiato sulla schiena e sul collo di George Floyd, uccidendolo, il gesto
di Kaepernick, ha assunto un altro significato. Bernice King, figlia di Martin
Luther King, Jr. ha pubblicato le due foto una accanto all'altra. L'America in
ginocchio che uccide, l'altra che protesta. "Se sei infastidito o leggermente
infastidito dal 1° ginocchio, ma oltraggiato dal 2°, allora, secondo le parole
di mio padre, sei 'più devoto all'ordine che alla giustizia'. E più appassionato
di un inno che presumibilmente simboleggia la libertà di quanto tu lo non sia
della libertà di vivere di un uomo nero".
Afroamericano ucciso, secondo giorno di proteste a
Minneapolis. Trump: "Faremo giustizia". Pubblicato
giovedì, 28 maggio 2020 da La Repubblica.it. Lanci di sassi e di bottiglie
contro la polizia e alcuni negozi saccheggiati nella seconda serata di proteste
a Minneapolis, dove centinaia di persone hanno manifestato davanti al
commissariato di polizia a cui appartenevano i quattro poliziotti licenziati e
accusati di aver ucciso George Floyd, un afroamericano di 46 anni. Minneapolis,
poliziotto immobilizza col ginocchio un afroamericano fino a togliergli il
respiro in riproduzione....Altre centinaia di persone si sono ritrovate davanti
all'abitazione del poliziotto immortalato in un video in cui si vede che soffoca
Floyd premendo sul suo collo con un ginocchio. Il presidente Donald Trump
assicura giustizia. "Su mia richiesta, l'Fbi e il dipartimento di Giustizia
stanno indagando su questa tragica morte in Minnesota di George Floyd", ha
dichiarato il tycoon, segnalando di aver chiesto di accelerare le indagini.
Anche Joe Biden, candidato democratico alle elezioni presidenziali aveva chiesto
l'apertura di una indagine dell'Fbi e ha scritto su Twitter "George Floyd
meritava il meglio e la sua famiglia merita giustizia. La sua vita contava".
Simona Pierini per leggo.it il 2 maggio 2020. «I romani hanno la
reputazione di aggirare le regole, nel traffico e nella vita». Questo passaggio
è apparso all’interno di un lungo e articolato reportage del New York Times a
firma di Jason Horowitz, lo stesso giornalista che documentò il dramma di
Bergamo in un crudo e imponente fotoracconto accompagnato dalle immagini del
fotografo Fabio Bucciarelli. L’articolo odierno intitolato “Rome Has Been
Sacked, Conquered and Abandoned. Now It’s the Pandemic’s Turn” (tradotto: Roma è
stata saccheggiata, conquistata e abbandonata. Ora è il turno della Pandemia)
Horowitz immortala l’immagine della Capitale che si avvia alla fine della
quarantena verso la fase due. Riporta cenni storici partendo dalla Roma
imperiale ripercorrendoli fino all’epoca fascista, alla Liberazione e, infine,
all’arrivo del virus. «La turbolenta storia della città ha forgiato un carattere
irriverente, anti-autoritario e, in qualche modo, cinico. Può sopravvivere al
coronavirus?», si chiede il New York Times nell’incipit del servizio. Ad
accompagnare il testo questa volta ci sono le foto della città in lockdown
scattate dalla fotografa Nadia Shira Cohen. «Per celebrare la leggendaria
fondazione della città e la sua gloria passata - scrive Horowitz - di solito c'è
una parata affollata di rievocatori vestiti da gladiatori e da vergini vestali.
Il coronavirus ha preso il suo posto, lasciando strade stranamente abbandonate
che evocano qualcosa di più vicino a un disastroso licenziamento nel VI secolo,
quando la popolazione di Roma precipitò verso lo zero». Ne segue una descrizione
della Capitale vuota nei suoi simboli: da Fontana di Trevi a Campo de’ Fiori,
dal Gianicolo a Ponte Sisto dove la “presenza degli artisti di strada è
sostituita dalle germani reali (un volatile, ndr.)”. «In un certo senso, la
città è fiorita sotto l’epidemia», aggiunge Horowitz, «senza lo scarico di
automobili e quel fumo denso di cipolle che fuoriescono dalle trattorie» e
sostenendo come “il virus non sia chiaramente un pericolo per la bellezza di
Roma”, ma chiedendosi: «Cosa farà al suo spirito?». E prova a rispondersi così:
«Mi chiedevo se questi mesi, forse anni, di quarantena o di convivenza con il
virus avrebbero cambiato irrevocabilmente i romani o sarebbero diventati un
altro di una lunga serie di difficoltà che hanno plasmato un carattere romano
noto per irriverenza, anti-autoritarismo e più di una goccia di cinismo». E
prosegue parlando del supposto tentativo dei cittadini di "aggirare" attraverso
varie interpretazioni date alla parola “congiunti” pronunciata dal premier
Giuseppe Conte durante il discorso del 26 aprile le disposizioni per la fase
due. E lo fa citando prima un articolo del Messaggero che mostrava simpatici
meme pubblicati sui social dagli utenti, poi le opere di Zerocalcare e la sua
"Rebibbia Quarantine". Poi, parlando dei cittadini della Capitale, scrive: «I
romani hanno la reputazione di aggirare le regole - nel traffico e nella vita. I
“fan” la chiamano accattivante creatività; i critici la definiscono inciviltà
insopportabile. Vivere con il virus lo migliorerà o lo eliminerà?». Seguita da
una serie di frasi - forse un po' figlie di uno stereotipo - sul «dolce non far
niente» dei giovani «che viene elevato a una forma d'arte pubblica». Infine
elenca una varietà di situazioni notate durante una sua passeggiata come «un
negozio di dolci che vendeva illegalmente uova di cioccolato fuori da una porta
semichiusa», o un incidente tra un autobus e uno scooter provocato dalla voglia
di passare per primi. C’è anche da dire che non ha omesso numerosi elogi per la
responsabilità mostrata da tantissimi romani nel periodo di quarantena. Ma ad
accompagnarli alcuni luoghi comuni contro una città che certamente mostra dei
difetti, delle incongruenze nel quotidiano, ma che ha saputo rispondere con
forza e con grande coraggio a un virus che l’ha spaventata. Un popolo, quello
romano, che fa la fila per andare in soccorso a una persona in difficoltà appena
incontrata in strada. Che ti mostra la via più breve per raggiungere un luogo
durante una vacanza turistica, che ti consiglia l’osteria dove mangiare bene e
spendere poco. Un affresco della Capitale, vista con occhio affettuoso ma - ci
permettiamo di dire - forse eccessivamente ricco di antichi luoghi comuni.
Paolo Mastrolilli per “la Stampa” il 28 maggio 2020. I
lacrimogeni, i proiettili di gomma, persino gli slogan, sono identici a quelli
che sentivamo a Ferguson, New York, Baltimora, quando nel mezzo del mandato del
primo presidente nero nella storia degli Stati Uniti era scoppiata la rabbia del
movimento Black Lives Matter. Ora resta solo da capire se gli scontri di
Minneapolis in morte dell' afro americano George Floyd, soffocato da un
poliziotto bianco, sono una reazione istintiva ma passeggera, oppure la
scintilla di una nuova stagione di proteste che minaccia di trascinarsi fino
alle presidenziali di novembre. E magari scontrarsi coi sovranisti, scesi in
piazza con i fucili per opporsi alle quarantene del coronavirus: «Loro hanno le
armi, ma le abbiamo anche noi», avverte Hawk Newsome, presidente di Black Lives
Matter a New York. «Il nostro Paese - aggiunge la candidata al Congresso nel
Bronx Chivona Newsome - sta scivolando verso la guerra razziale». Lunedì sera
quattro poliziotti di Minneapolis, Dereck Chauvin, Thomas Lane, Tou Thao e
Alexander Kueng, avevano fermato Floyd, nero di 46 anni nato a Houston,
buttafuori al ristorante Conga Latin Bistro. L' accusa era di aver usato un
biglietto falso da 20 dollari in un negozio. Gli agenti lo avevano ammanettato e
steso a terra, davanti al Cup Foods all' angolo tra Chicago Avenue e East 38th
Street. Chauvin lo teneva bloccato col ginocchio sul collo, quando alcuni
passanti si erano messi a riprendere la scena. George chiedeva aiuto: «Non posso
respirare». Ma Chauvin non aveva mollato, fino a quando lo aveva soffocato a
morte. Il video è diventato virale, e martedì sera quell' angolo di Minneapolis
si è trasformato in un campo di battaglia, con lacrimogeni, proiettili di gomma,
scontri. La gente ha marciato verso il 3rd Precint, il commissariato di Chauvin,
lanciando pietre e ripetendo il grido di Floyd: «Non posso respirare!». Il capo
della polizia ha licenziato i quattro agenti, ora sotto inchiesta da parte dell'
Fbi e della procura della Hennepin Country. «Devono incriminarli per omicidio»,
ha chiesto la sorella di George, Bridgett, rappresentata dall' avvocato dei
diritti civili Benjamin Crump. Il caso ha mobilitato il campione di basket
LeBron James, che ha pubblicato una foto di Chauvin col ginocchio su collo di
Floyd, vicino a quella di Colin Kaepernick, quarterback dei San Francisco 49ers,
cacciato perché si inchinava durante l'inno prima delle partite, per protestare
contro la brutalità dei poliziotti: «Ecco perché lo faceva. Adesso capite?».
Queste scene ricordano le proteste di Black Lives Matter, fondato nel 2013 dopo
l' assoluzione di George Zimmerman, guardia giurata che aveva ammazzato il
giovane nero Trayvon Martin, mentre andava a trovare il padre nel suo condominio
in Florida. Poi la polizia aveva soffocato Eric Garner a New York, sparato
contro Michael Brown a Ferguson, fatto morire Freddie Gray a Baltimora mentre lo
trasportava al commissariato, e le rivolte avevano incendiato l' America. Con
Trump alla Casa Bianca sono stranamente finite, a parte gli scontri di
Charlottesville dell' agosto 2017, quando il neonazista James Fields aveva
investito e ucciso Heather Heyer. Per capire se quella rabbia sta riesplodendo
cerco al telefono Hawk Newsome, presidente di Black Lives Matter a New York. Mi
risponde da Minneapolis, tra i manifestanti: «In America uccidere i neri in
strada è legale. La gente è così a favore della polizia, da essere contro la
giustizia». La ragione è sempre il razzismo: «Viviamo in un Paese fondato sulla
supremazia bianca, che continua a reggersi sul suprematismo, dalla Casa Bianca
ai commissariati. I poliziotti occupano le nostre comunità, come i guardiani
degli schiavi occupavano le piantagioni. E l'America bianca non ha alcun
desiderio di cambiare». Gli chiedo se la prima presidenza nera non è servita a
nulla, e allora mi passa la candidata al Congresso Chivona Newsome: «Obama ha
ispirato i neri a credere che potevano avere di più, ma non ha fatto nulla per
fermare la brutalità della polizia. Restiamo prede, vittime di crimini di
guerra. Se uno di noi viene assalito, la gente si chiede cosa ha fatto per
meritarselo». La situazione è peggiorata con Trump: «Come può non essere
razzista, uno che dopo gli attacchi dei suprematisti a Charlottesville ha detto
che c' erano brave persone da entrambe le parti? L' America è un Paese razzista,
è giusto che il mondo lo veda. Hanno tolto i cappucci del Ku Klux Klan, e
indossato i cappelli rossi di "Maga", lo slogan elettorale di Trump. Hanno
cambiato vestito, non politica». Ma perché le proteste erano esplose con Obama,
e sono quasi finite con Trump? «Dopo un po' ti stanchi di marciare. Abbiamo
perso la speranza». Allora interviene Hawk: «Per tre anni si è parlato solo di
diritti delle donne e immigrati. Ora che ci sono le presidenziali e riscoprono i
neri, perché noi reggiamo in piedi il Partito democratico. Ma non ci stiamo più.
Alzeremo la testa: se un fratello nero vedrà un altro fratello aggredito,
interverrà fisicamente a difenderlo. Minneapolis è la sveglia. Torneremo a
combattere, per prenderci il potere che l' America non vuole dare». Sono parole
dure, che sembrano annunciare lo scontro con i sovranisti: «Loro hanno le armi,
ma le abbiamo anche noi». Chivana lo interrompe: «Questo dimostra che presidente
è Trump. Tutti vedono che il clima di ingiustizia sociale ci sta portando verso
la guerra razziale, ma invece di fingere almeno di riunificare il Paese, lui
punta a spaccarlo per aizzare la sua base». Non c' è speranza neanche nell'
alternativa: «Biden ha dimostrato quanto sia fuori, con i suoi commenti dell'
altro giorno sui neri che non sono neri se non lo votano. Lui ha lavorato pure
con i segregazionisti, non può rappresentarci. Dobbiamo farlo da soli, con la
forza».
Afroamericano ucciso da polizia, rivolta in Usa: stato
emergenza a Minneapolis, 30 arresti a New York. La condanna dell'Onu.
Pubblicato venerdì, 29 maggio 2020 da La Repubblica.it.
Centri commerciali devastati, auto in fiamme, strade invase dai lacrimogeni,
collegamenti pubblici sospesi. Il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey ha
dichiarato l'emergenza locale, dunque chiedendo aiuto allo Stato, per riportare
"l'ordine e la calma" dopo le proteste per la morte di George Floyd,
l'afroamericano di 46 anni ucciso dalla polizia. Proteste anche in molte altre
città d'America, tra cui New York Oakland, in California, e Denver, in
Colorado.Cortei e sit in anche a Chicago e San Francisco. Almeno 30 persone sono
state arrestate a New York dove centinaia di persone sono scese in strada a
Manhattan per protestare contro la morte di George Floyd ed esprimere la propria
rabbia contro la violenza della polizia nei confronti degli afroamericani.
Momenti di tensione attorno a City Hall, la sede del municipio, dove c'è stato
un lancio di bottiglie e di altri oggetti verso gli agenti. Un manifestante è
stato arrestato per possesso di armi, altri per aver gettato in strada i secchi
dell'immondizia e aver bloccato la circolazione. Spari in strada a Denver. A
Denver, in Colorado, è scattato il lockdown dello State Capitol, l'assemblea
statale, dopo che alcuni colpi di arma da fuoco sono stati sparati mentre era in
corso una manifestazione per protestare contro la morte di George Folyd, a
Minneapolis, per mano della polizia. La situazione è tesa e molti dimostranti
hanno bloccato alcune arterie stradali della citta. Fermate gli omicidi degli
afroamericani da parte della polizia. E' l'appello agli Stati Uniti dell'Alto
commissario dell'Onu per i diritti umani Michelle Bachelet che condanna
l'uccisione di George Floyd, afroamericano di 46 anni, che sta scatenando
rivolte in tutti gli Stati Uniti. "Questa è l'ultima di una lunga lista di
uccisioni di afro americani disarmati", ad opera di agenti di polizia o gente
comune, ha dichiarato Bachelet in una nota elencando alcune delle vittime
recenti, da Breonna Taylor a Eric Garner.
Proteste, roghi e un morto: le immagini.
Omicidio George Floyd, Minneapolis brucia: casa poliziotto
protetta da centinaia di agenti. Redazione su Il Riformista il 28 Maggio 2020.
Travolta dalle violente proteste scatenate dall’uccisione di un
altro afroamericano da parte della polizia, Minneapolis brucia. I video
dell’arresto finito in tragedia lunedì sono stati diffusi online e hanno
scatenato un’ondata di nuove manifestazioni contro il razzismo istituzionale,
sulla scia del movimento Black lives matter nato dopo che nel 2012 il 17enne
disarmato Trayvon Martin fu ucciso in Florida da un vigilante. Nei filmati si
vedono i poliziotti di Minneapolis mentre arrestano il 46enne George Floyd,
chiamati da un negoziante per il sospetto che avesse usato denaro falso, e poi
un agente bianco che blocca l’uomo a terra. Gli preme un ginocchio sul collo
per 8 minuti: Floyd fatica a respirare e chiede aiuto, ma il poliziotto non
cambia posizione. Il 46enne, alla fine, è immobile. Quattro agenti di polizia
sono stati licenziati e il sindaco di Minneapolis Jacob Frey, chiedendo che il
poliziotto venga incriminato, ha dichiarato a Cbs: “Se Floyd fosse stato bianco,
sarebbe vivo“. Sui muri di Minneapolis e di altre città sono comparse scritte
con le parole ‘I can’t breathe‘ (non riesco a respirare), frase che diventò un
macabro slogan dopo che Eric Garner nel 2014 lo ripeté prima di morire soffocato
dalla stretta al collo infertagli da un poliziotto. Nello stesso anno era stato
ucciso dalla polizia anche il 18enne Michael Brown a Ferguson, scatenando altre
violente proteste. E ora a Minneapolis sembrano cadere nel vuoto gli appelli
alla calma. Per due notti di fila, centinaia di persone sono scese in strada con
cartelli che chiedevano il rispetto della popolazione afroamericana. Ma gruppi
di persone hanno anche appiccato incendi e saccheggiato negozi, lasciando una
scia di danni lunga chilometri, e la polizia ha usato gas lacrimogeni e
proiettili di gomma. Il sindaco ha chiesto al governatore Tim Walz l’intervento
della Guardia nazionale e ha aggiunto: “Per favore, Minneapolis, non lasciamo
che una tragedia ne causi un’altra”. La seconda notte di proteste ha registrato
anche un decesso: un uomo è stato ritrovato ucciso da colpi d’arma da fuoco,
secondo la polizia forse colpito da un negoziante. Le manifestazioni, intanto,
si sono allargante ad altre città. In California centinaia di persone hanno
bloccato una strada di Los Angeles e rotto i vetri delle finestre di una sede
della polizia. Sui social media dilagano in tutto il mondo i post e le
fotografie contro le violenze razziste. A dare forza al movimento è stata anche
la presa di posizione di alcune celebrità, come il fuoriclasse dell’Nba Lebron
James che si è allenato con una maglietta con la scritta I can’t breathe, o il
regista Spike Lee che ha condiviso vari post di denuncia. Il ministero della
Giustizia e l’Fbi a Minneapolis intanto hanno promesso una “efficace indagine
criminale” e di portare avanti il caso come priorità, dopo che mercoledì il
presidente Donald Trump aveva domandato di velocizzare le indagini.
Phoenix, muore ragazzo bloccato dalla polizia sull'asfalto
rovente. Pubblicato sabato, 22 agosto 2020 da La
Repubblica.it. Fa discutere a Phoenix, in Arizona, la morte di un ragazzo di 28
anni fermato dalla polizia e bloccato a terra, sull'asfalto rovente, per sei
minuti. La vittima è Ramón Timothy López, un giovane padre di origine ispanica,
che secondo la famiglia soffriva di schizofrenia paranoica. Era sposato e aveva
due bambini, l'ultimo nato solo pochi mesi fa. Il fatto risale al 4 agosto ma
solo ora, dopo le accuse di ennesima brutalità, la polizia reso pubblici i
filmati girati con le bodycam dagli agenti intervenuti sul luogo, vicino
all'incrocio tra la 51esima Avenue e Indian School Road: erano stati chiamati da
una donna che denunciava il comportamento anomalo dell'uomo accusandolo di atti
osceni. Al loro arrivo era appena uscito da un negozio dove aveva rubato una
bibita, scagliata poi contro gli agenti. In tre lo hanno bloccato a terra,
mentre lui chiedeva di essere liberato. Quando lo hanno ammanettato e portato in
auto si sono accorti che non reagiva più. Trasportato in ospedale da
un'ambulanza, è stato dichiarato il suo decesso. I risultati dell'autopsia non
sono ancora noti. Il giorno dell'arresto di Lopez, la temperatura alle 10.30 era
di oltre 37 gradi e l'asfalto poteva benissimo superare i 60 gradi. Suo
fratello, David González, ha dichiarato all'emittente locale Knxv-Tv: "Nessuno è
perfetto, ma non se lo meritava". "Gli stavano sopra con tutto il loro peso
sull'asfalto caldo. Chi non avrebbe reagito? Stava combattendo per la sua vita,
e ha perso", ha aggiunto. Sul caso è intervenuto anche l'avvocato delle famiglie
di George Floyd e Breonna Taylor, Ben Crump, che ha espresso il suo sdegno su
Twitter. "Ancora? Gli agenti di Phoenix hanno bloccato Ramón Timothy López, che
soffre di schizofrenia, sul pavimento rovente dove presto ha smesso di
rispondere ed è morto. Un altro fallimento del Phoenix Police Department nel
servire e proteggere! Quando gli agenti si renderanno conto che la forza
eccessiva è sempre sbagliata ?!", ha scritto il legale.
Usa, afroamericano ucciso da polizia Violenti scontri in
strada. La polizia di Stato della Lousiana sta
effettuando indagini per accertare la dinamica dei fatti. L’afroamericano, il
31enne Trayford Pellerin, forse era armato di un coltello. Gabriele Laganà,
Domenica 23/08/2020 su Il Giornale. Tensione sempre più alta negli Usa a seguito
dell’uccisione di un altro afroamericano ad opera della polizia. La nuova
tragedia, sulla quale stanno indagando le forze dell’ordine dello Stato
della Louisiana, è avvenuta nella serata di venerdì. A perdere la vita, il
31enne Trayford Pellerin: secondo la prima ricostruzione, il giovane avrebbe
cercato di entrare in un minimarket armato di coltello quando gli agenti del
dipartimento di Lafayette hanno aperto il fuoco. Secondo la dichiarazione della
Polizia della Louisiana, gli agenti sono intervenuti intorno alle 20 nel negozio
dopo una chiamata che parlava di "una persona armata di coltello". Inoltre nel
comunicato si spiega che all’arrivo degli uomini delle forze dell’ordine,
Pellerin si trovava nel parcheggio del negozio ed aveva un coltello. Gli agenti
hanno cercato di arrestarlo ma lui si è allontanato. A quel punto gli ufficiali
lo hanno seguito a piedi e hanno usato i taser per bloccarlo. Ma il tentativo è
fallito. Mentre il 31enne cercava di entrare in un minimarket situato lungo la
NW Evangeline Thruway i poliziotti hanno sparato. La scena è stata registrata in
video. Rikasha Montgomery, un testimone, ha detto a The Advertiser che l'afroamericano
impugnava un oggetto che sembrava un coltello e continuava a camminare lungo la
strada mentre alcuni agenti gli sparavano alle spalle con i taser. Inoltre, come
ha raccontato ancora, i poliziotti gli hanno gridato al 31enne di stendersi a
terra. "Hanno sparato quando l'uomo ha raggiunto la porta di una stazione di
servizio Shell. Quando ho sentito gli spari, non ho potuto tenere il telefono
fermo- ha detto-. Mi sono spaventato. Sono traumatizzato. Sei così abituato a
sentirne parlare... ma non avrei mai pensato di sperimentarlo". Per fermare il
sospetto sarebbero stati sparati almeno 11 colpi. Ciò lo si deduce dai rumori
catturati nel video. Pellerin è stato subito portato in un ospedale ma i medici
hanno solo potuto constatarne il decesso. La polizia di Stato della Lousiana ha
detto che nessun agente è rimasto ferito e che le indagini sono "attive e in
corso". L'avvocato per i diritti civili Benjamin Crump ha dichiarato alla Cnn
che la famiglia di Pellerin ha chiesto il licenziamento degli agenti
coinvolti. "Ci rifiutiamo di lasciare che questo caso si risolva come tanti
altri: in silenzio, senza risposte e giustizia", ha detto il legale che
rappresenta anche le famiglie di Floyd e Taylor. "Pellerin era timido,
intelligente ma soffriva di ansia e potrebbe essere stato spaventato dagli
ufficiali", ha raccontato la madre Michelle a The Advocate. La donna, poi, ha
aggiunto: "Invece di dargli una mano, gli hanno dato dei proiettili".
Un altro nero ucciso dalla polizia, rivolta per Trayford
Pellerin. Il Corriere della Sera il 24 agosto 2020. E'
un giovane afroamericano, lo si vede camminare per strada mentre cerca di
sfuggire ai poliziotti che lo inseguono. A un certo punto gli agenti cercano di
fermarlo con i taser, ma lui va avanti e quando si avvicina all'ingresso di un
negozio, in una stazione di servizio, gli sparano addosso: almeno una decina di
colpi lo feriscono. Si accascia a terra. Tre agenti si avvicinano al suo corpo
senza vita con le pistole ancora puntate. Poi arrivano gli altri colleghi: tutti
intorno, sono una decina. La scena ripresa con il cellulare da una passante a
Lafayette, in Louisiana, sta girando sui social facendo risalire l'indignazione
verso i soprusi razziali della polizia già denunciati nell'ondata di proteste
seguite alla morte di George Floyd, Rayshard Brooks e Breonna Taylor. La Cnn
riferisce che l’episodio risale a venerdì sera: secondo la ricostruzione della
Polizia della Louisiana, che ha aperto un'indagine sul caso, gli agenti sono
stati chiamati in un minimarket di Lafayette in risposta a una chiamata che
parlava di «una persona armata di coltello». Non riuscendolo a fermare neanche
con l’uso dei Taser, sono ricorsi alle armi da fuoco. Il giovane si chiamava
Trayford Pellerin. Secondo la famiglia potrebbe aver avuto una crisi di nervi.
«Mio figlio era timido, intelligente ma soffriva di ansia e potrebbe essere
stato spaventato dagli ufficiali — ha detto la madre Michelle al sito del
magazine The Advocate — Aveva cercato l'aiuto di un medico all'inizio di quest'anno.
Invece di dargli una mano, gli hanno dato dei proiettili». L'avvocato per i
diritti civili Benjamin Crump ha dichiarato alla Cnn che la famiglia di Pellerin
ha chiesto il licenziamento degli agenti coinvolti. «Ci rifiutiamo di lasciare
che questo caso si risolva come tanti altri: in silenzio, senza risposte e
giustizia», ha detto Crump, che rappresenta anche le famiglie di Floyd e Taylor.
Il grido «Black Lives Matter» torna ad alzarsi forte. Da ieri, quando si è
tenuta la veglia sul luogo dove Pellerin ha perso la vita, la gente è tornata in
piazza, prima pacificamente. Poi in serata sono cominciati gli scontri. Gli
ufficiali in tenuta anti sommossa hanno sparato fumogeni per far disperdere la
folla.
Louisiana, afroamericano ucciso da polizia: a Lafayette
scoppia la protesta per Trayford Pellerin. Gli agenti
hanno fermato l'uomo di 31 anni in un parcheggio. Secondo il rapporto "era
armato di coltello ed è scappato dopo essere stato colpito coi taser". Gli hanno
sparato mentre cercava di entrare in un minimarket. La polizia di Stato della
Louisiana sta conducendo le indagini. In un video pubblicato sui social media si
riescono a sentire circa 11 colpi di arma da fuoco. La Repubblica il 23 agosto
2020. La polizia di Stato della Louisiana sta indagando sulla morte di Trayford
Pellerin, afroamericano di 31 anni colpito a morte venerdì sera dopo essere
stato fermato dai poliziotti del dipartimento di Lafayette. Gli agenti sono
stati chiamati in un minimarket della città di 130mila abitanti, poco dopo le 20
di venerdì in risposta a una chiamata che parlava di "una persona armata di
coltello", questo secondo la dichiarazione della Polizia di Stato della
Louisiana. Quando sono arrivati gli agenti, Pellerin si trovava nel parcheggio
del negozio, aveva un coltello, si legge nella dichiarazione. Hanno cercato di
arrestarlo ma lui si è allontanato e gli ufficiali lo hanno seguito a piedi.
Hanno usato i taser per bloccarlo, si legge sempre nella dichiarazione, "ma sono
stati inefficaci". A quel punto gli hanno sparato mentre cercava di entrare in
un minimarket lungo la NW Evangeline Thruway. La sparatoria di venerdì sera è
stata registrata in video. Anche il testimone Rikasha Montgomery ha girato un
video della sparatoria, ha detto a The Advertiser che l'afroamericano impugnava
quello che sembrava un coltello e continuava a camminare lungo la strada mentre
alcuni agenti gli sparavano alle spalle con pistole stordenti. Gli ufficiali gli
hanno gridato di stendersi a terra, ha detto Montgomery, 18 anni. "Hanno sparato
quando l'uomo ha raggiunto la porta di una stazione di servizio Shell. Quando ho
sentito gli spari, non ho potuto tenere il telefono fermo", ha detto. “Mi sono
spaventato. Sono traumatizzato. Sei così abituato a sentirne parlare... ma non
avrei mai pensato di sperimentarlo". Nel video pubblicato sui social media si
riescono a sentire circa 11 colpi sparati dagli agenti. Pellerin è stato portato
in un ospedale dove è stato dichiarato morto. Dopo il caso di George Floyd a
Minneapolis e Breonna Taylor a Louisville, Kentucky, e di tutti gli altri nomi,
il suo è un altro nome morto in silenzio sul quale l'America di Black Lives
Matter è tornata a urlare. La polizia di Stato ha detto che nessun agente è
rimasto ferito e che le indagini sono "attive e in corso". Il dipartimento di
polizia di Lafayette non ha rlasciato commenti. La morte di Pellerin arriva
verso la fine di un'estate che ha visto diffuse proteste contro l'ingiustizia
razziale e la brutalità della polizia in seguito alle uccisioni di
afroamericani. L'avvocato per i diritti civili Benjamin Crump ha dichiarato
alla Cnn che la famiglia di Pellerin ha chiesto il licenziamento degli agenti
coinvolti. "Ci rifiutiamo di lasciare che questo caso si risolva come tanti
altri: in silenzio, senza risposte e giustizia", ha detto Crump, che rappresenta
anche le famiglie di Floyd e Taylor. "La famiglia e la gente di Lafayette
meritano onestà e responsabilità da parte di coloro che hanno giurato di
proteggerli, la polizia di Lafayette", ha aggiunto. Da sabato, quando si è
tenuta la veglia sul luogo dove Pellerin ha perso la vita, la gente è tornata in
piazza, dapprima pacificamente. In serata sono cominciati gli scontri. Gli
ufficiali in tenuta antisommossa hanno sparato fumogenei sabato sera per far
disperdere la folla, ha detto l'agente Derek Senegal. "Nessun gas lacrimogeno",
ha aggiunto. "Il nostro intento non sarà quello di lasciare che le persone
disturbino la nostra città e mettano in pericolo i nostri cittadini, i nostri
automobilisti e i nostri quartieri", ha detto il capo della polizia ad
interim Scott Morgan. Sono stati effettuati arresti, ha detto Morgan, senza
specificare un numero. "Sosteniamo i diritti del Primo Emendamento delle
persone", ha detto lo sceriffo della parrocchia di Lafayette Mark Garber.
"Tuttavia, quando si tratta di distruzione di proprietà, non daremo fuoco a
Lafayette". "Pellerin era timido, intelligente ma soffirva di ansia e potrebbe
essere stato spaventato dagli ufficiali", ha detto la madre Michelle a The
Advocate. Aveva cercato un aiuto professionale all'inizio di quest'anno, ha
detto: "Invece di dargli una mano, gli hanno dato dei proiettili". Secondo la
famiglia Pellerin potrebbe aver avuto una crisi di nervi.
Da il "Corriere della Sera" il 24 agosto 2020. Undici colpi a
due-tre metri di distanza. Così Trayford Pellerin, afroamericano di 31 anni, è
stato ucciso venerdì scorso dalla polizia a Lafayette, cittadina della
Louisiana, nel Sud degli Stati Uniti. Il nuovo caso riaccende le tensioni e le
proteste nel Paese, sulla lunga scia dell'uccisione di George Floyd, il 25
maggio scorso a Minneapolis e in vista della manifestazione, per ora confermata,
promossa dal reverendo Al Sharpton a Washington, venerdì 28 agosto. Gli
investigatori stanno ricostruendo che cosa sia successo esattamente a Lafayette.
I media americani, però, hanno già trasmesso il video girato con il telefonino
da una ragazza diciottenne, Rikasha Montgomery. È notte. La sequenza si apre con
un giovane in maglietta bianca che cammina verso una stazione di servizio. Lo
tallonano tre-quattro agenti, mentre almeno un paio di macchine della polizia
fanno manovra per avvicinarsi. È Trayford. Ha un coltello in mano e non si cura
dei richiami dei suoi inseguitori. Attraversa lo spiazzo del distributore, dove
un automobilista che sta facendo rifornimento, si gira appena. Oggettivamente
non sembra una situazione fuori controllo. Il giovane, però, non si ferma e
punta verso il negozio della stazione di servizio. È quasi sulla soglia. I
poliziotti gli intimano di non muoversi, per l'ultima volta. Rikasha per
l'agitazione sposta il cellulare, perdendo il centro della scena. Si sentono i
colpi di una o più pistole. Sono tanti, alla fine ne verranno contati 11. Ecco
ora si vede di nuovo Trayford. Disteso a terra, immobile. In un attimo accorrono
altri uomini in divisa, sfrecciano auto con il lampeggiante. Ma il giovane
afroamericano è già morto. Il Dipartimento di Polizia ha diffuso una sommaria
versione dei fatti. Pellerin girava armato e aveva appena spaventato i clienti
di un altro market nelle vicinanze. Gli agenti hanno provato a immobilizzarlo
con petardi stordenti, senza riuscirci. Ma le autorità non hanno spiegato perché
fosse necessario colpire «il sospetto» con undici pallottole, anziché, per
esempio, sparare alle gambe. I tiratori erano talmente vicini che avrebbero
potuto scegliere il bersaglio. La madre di Trayford ha dichiarato che suo figlio
era «intelligente, timido e che era in cura per una forma di fobia sociale». Una
condizione di disordine mentale che procura ansia, paura. È un aspetto che farà
discutere: negli Stati Uniti molte persone con disturbi della personalità non
sono assistite in modo adeguato. Nel frattempo sabato e domenica gli attivisti
sono scesi in strada, chiedendo «giustizia per Trayford». Nella notte ci sono
stati scontri tra gruppi di manifestanti e la polizia. Marja Broussard,
presidente della sede locale della Naacp (National Association for the
Advancement of Colored People), ha chiesto un confronto diretto con il sindaco
di Lafayette, il repubblicano Josh Guillory. L'organizzazione ha anche
condannato le violenze notturne, «causate da gente venuta da fuori».
Usa, polizia spara alla schiena un ragazzo nero: proteste per
Jacob Blake. Vincenzo Sbrizzi per "today.it" il 24
agosto 2020. Potrebbe essere ancora una volta un video a raccontare la verità
sul ferimento di un afroamericano da parte di alcuni agenti di polizia negli
Stati Uniti. Ieri sera a Kenosha, cittadina a 40 miglia da Milwaukee, Jacob
Blake è stato ferito gravemente da alcuni colpi di arma da fuoco esplosi da
agenti di pattuglia. Secondo le prime ricostruzioni la vittima stava provando a
entrare in un'auto parcheggiata in un'area residenziale. In quel momento sarebbe
stato colpito da diversi proiettili alla schiena. L'uomo è stato poi soccorso e
trasportato all'ospedale di Milwaukee dove è ricoverato in condizioni disperate.
La scena sarebbe stata ripresa in un video girato da un passante. È quanto
riporta il New York Times. Non è chiaro se sia stato pubblicato sui social ma al
momento è sicuramente a disposizione delle autorità che non sono state tenere
con gli agenti intervenuti.
Le parole del governatore. A metterci la faccia è stato il
governatore dello stato del Wisconsin, Tony Evers che ha usato parole durissime
contro i poliziotti. Le sue esternazioni sono state postate su Twitter a più
riprese. È stato lui stesso a rivelare che l'uomo era stato colpito alla schiena
denunciando un'escalation di uso eccessivo della forza negli interventi contro i
neri nel suo stato. "Anche se non abbiamo ancora tutti i dettagli, quello che
sappiamo per certo è che non è il primo uomo o persona di colore a essere stato
colpito, ferito o ucciso senza pietà per mano di agenti delle forze dell'ordine
nel nostro stato o nel nostro Paese". Ha poi twittato un messaggio diretto di
vicinanza alla persona ferita coinvolgendo anche la moglie Kathy. “Stasera,
Jacob Blake è stato colpito alla schiena più volte, in pieno giorno, a Kenosha,
nel Wisconsin. Kathy e io ci uniamo alla sua famiglia, ai suoi amici e ai vicini
sperando sinceramente che non morirà per le ferite”. La sparatoria è avvenuta
intorno alle 17 dopo che gli agenti sono stati chiamati per una denuncia di un
possibile caso di violenza domestica. Questa è stata la versione data dal
dipartimento di polizia che però non ha rilasciato ulteriori dichiarazioni a
chiarimento del tipo di intervento. Non è ancora chiaro se la sparatoria fosse
collegata all'intervento o se sia accaduta successivamente. Sembra però essere
piuttosto chiaro l'eccesso di zelo degli agenti che potrebbero aver abusato del
loro potere sparando colpevolmente alle spalle di una persona di colore.
Le proteste. Dopo il ferimento di Blake, gli abitanti della
cittadina sono scesi in strada per protestare. Lo hanno fatto marciando e
postando i video della protesta che non ha lesinato momenti di tensione con
alcuni oggetti dati alle fiamme. Le proteste sono proseguite fino a tarda notte
e hanno richiesto l'intervento di altri agenti di polizia. È stato questo il
momento di più alta tensione. I filmati dei disordini sono stati postati sui
vari social media e rappresentano una scena che si ripete tristemente negli
Stati Uniti. Brucia ancora la ferita dell'uccisione di George Floyd, soffocato
da un agente, che ha rivitalizzato in tutto il Paese il movimento “Black lives
matter” nato nel 2014 dopo la morte, in circostanze analoghe, di un altro
afro-americano, Eric Gamer.
Wisconsin, un morto e 3 feriti negli scontri dopo il ferimento
di Jacob Blake. Pubblicato mercoledì, 26 agosto 2020
da La Repubblica.it. KENOSHA (Wisconsin) - E' di un morto e tre feriti il
bilancio degli scontri fra manifestanti e polizia a Kenosha in Wisconsin dopo il
ferimento da parte della polizia di un ragazzo afroamericano Jacob Blake colpito
alle spalle dalle pallottole della polizia e rimasto paralizzato secondo quanto
denunciato dalla famiglia.
Da Il "Corriere della Sera" il 26 agosto 2020. Domenica 23
agosto, a Kenosha nel Wisconsin, un poliziotto gli ha sparato sette volte alla
schiena, da mezzo metro. Ora Jacob Blake, afroamericano di 29 anni, giace in un
letto d'ospedale, paralizzato dalla vita in giù. I medici non si sbilanciano: il
giovane è in gravi condizioni e se riuscisse a sopravvivere potrebbe perdere
l'uso delle gambe. Gli investigatori stanno ancora ricostruendo la dinamica.
Anche se il video girato da un testimone è di un'agghiacciante chiarezza. Quella
domenica, alle 17.15, una pattuglia risponde a una chiamata: c'è una lite in un
quartiere residenziale. La prima inquadratura della clip mostra Blake che si
dirige verso la portiera del suo Suv. Lo seguono tre agenti con le pistole
spianate. Il giovane sta per entrare in macchina, ma a quel punto uno dei
poliziotti gli tira la canottiera bianca e poi gli spara alle spalle. Sul sedile
posteriore del veicolo ci sarebbero stati i tre figli piccoli di Jacob. Il nuovo
caso ha riacceso le proteste di Black Lives Matter. L'epicentro ora è questa
cittadina di 100 mila abitanti sul lago Michigan, finora conosciuta solo dai
viaggiatori più curiosi per i fossili di Mammut custoditi nel museo pubblico. La
tensione è alta: i cortei iniziano in modo pacifico e, nella notte, terminano
con distruzioni, incendi e assalti a qualche negozio. È uno scenario che in
parte ricorda quello di Minneapolis (Minnesota), nelle settimane successive
all'uccisione di George Floyd, soffocato dal ginocchio di un poliziotto. Le
immagini in arrivo da Kenosha mostrano la polizia che risponde con i gas
lacrimogeni al fitto lancio di bottiglie e petardi. Lunedì 24 agosto, David
Beth, sceriffo della Contea ha chiesto rinforzi: «Ho a disposizione circa 200
agenti. Sono troppo pochi, non ce la facciamo a garantire la sicurezza
pubblica». Il governatore dello Stato, il democratico Tony Evens, ha inviato un
contingente della Guardia Nazionale, dichiarato lo stato d'emergenza e imposto
il coprifuoco a partire dalle 20. L'onda si è già propagata in altre città. Si
segnalano sit-in e battaglie con le forze dell'ordine a Portland, in Oregon, e a
Seattle, Stato di Washington. Manifestazioni anche a New York e Minneapolis, qui
con qualche incidente. Il movimento di Black Lives Matter, sostenuto da altre
organizzazioni storiche per la difesa dei diritti civili, come la Naacp
(National Association for the Advancement of Colored People, fondata nel 1909),
stanno cercando di far confluire l'indignazione nel raduno in programma a
Washington, venerdì 28 agosto. In quello stesso giorno del 1963, 57 anni fa,
Martin Luther King parlò dai gradini del Lincoln Memorial, davanti a una folla
enorme. «I have a dream». Questa volta il leader sarà di una caratura
decisamente diversa, il reverendo Al Sharpton, 65 anni, che vive un'imprevista
stagione di visibilità. L'appuntamento è confermato, nonostante il rischio che
la massa di persone possa trasformarsi in un altro focolaio di Covid-19.
Identificato agente che sparò a Blake.
(ANSA il 27 agosto 2020) - Le autorità del Wisconsin hanno
annunciato in una conferenza stampa di aver identificato il poliziotto che ha
sparato sette colpi alla schiena all'afroamericano Jacob Blake a Kenosha,
ferendolo gravemente e suscitando una nuova ondata di proteste dopo la morte di
George Floyd. Si tratta di Rusten Sheskey, un agente con sette anni di servizio
al dipartimento di polizia di Kenosha. E' stato lui, secondo la ricostruzione
dell'attorney generale del Wisconsin, ad aver sparato sette colpi alla schiena
dell'uomo mentre lo teneva per la camicia dopo che i suoi colleghi avevano usato
il taser senza successo e il giovane stava entrando nella sua auto. Auto nella
quale poi la polizia ha trovato un coltello sotto il pianale nel lato guidatore.
Per ora l'attorney general del Wisconsin non ha annunciato alcuna accusa nei
confronti degli agenti coinvolti nel ferimento di Blake. "L'indagine prosegue",
ha detto.
DAGONOTA il 26 agosto 2020. È di due morti e un ferito il
bilancio della guerriglia nelle strade di Kenosha, in Wisconsin, affollate per
la terza notte consecutiva dai manifestanti del movimento “Black Lives Matter”,
in seguito al ferimento dell’afroamericano Jacob Blake (che è rimasto
paralizzato). Alcuni video che circolano on line mostrano gli scontri tra i
manifestanti e persone armate, con il rumore dei colpi di pistola in sottofondo
e alcuni giovani a terra. In particolare, in un filmato, si vede un uomo bianco
con un fucile semiautomatico che scappa e urla "Ho appena ucciso qualcuno"
mentre la folla lo insegue. in un altro video l'uomo inciampa e cade per strada,
raggiunto da un inseguitore che gli dà un calcio e un altro che arriva e lo
colpisce con lo skateboard. A quel punto lui spara da seduto e scappa mentre
arriva la polizia.
Usa, salgono a 2 i morti in sparatoria Wisconsin.
(LaPresse/AP il 26 agosto 2020) - Una seconda persona è morta
nella sparatoria avvenuta nella notte a Kenosha, in Wisconsin, durante le
proteste scoppiate per il ferimento dell'afroamericano Jacob Blake da parte
della polizia. Lo sceriffo della contea di Kenosha, David Beth, ha riferito che
una delle vittime è stata colpita alla testa, un'altra al petto, mentre la terza
persona ferita non sarebbe in pericolo di vita. Lo sceriffo ha detto al Journal
Sentinel che persone armate avevano pattugliato le strade della città nelle
ultime notti, ma non sapeva se l'assassino fosse tra loro. "Sono una milizia",
ha spiegato Beth, "Sono come un gruppo di vigilanti". Le autorità non hanno
arrestato nessuno durante la sparatoria, ma gli investigatori stanno esaminando
il video che ha ripreso l'accaduto. Lo sceriffo si è detto fiducioso che un uomo
verrà presto arrestato. Il video girato con un cellulare, e pubblicato online,
mostra un uomo bianco con un fucile semiautomatico che corre in mezzo a una
strada e alcuni agenti di polizia lo seguono. Si sente chiedere da qualcuno tra
la folla "Cosa ha fatto?", e un'altra persona risponde che l'uomo ha sparato a
qualcuno. L'uomo armato inciampa e cade, e mentre è raggiunto dalla folla, spara
tre o quattro colpi da seduto, colpendo almeno due persone. Con la folla che si
disperde, l'uomo armato si alza e continua a camminare per la strada mentre
arrivano le auto della polizia. L'uomo alza le mani e cammina verso le auto
degli agenti, tra le grida di chi lo accusa di aver aperto il fuoco contro la
folla.
Biagio Chiariello per fanpage.it il 27 agosto 2020. Si chiama
Kyle Rittenhouse e ha 17 anni. Avrebbe ucciso due persone a Kenosha, in
Wisconsin, nella terza notte di proteste scoppiate e sfociate in violenze dopo
che domenica la polizia ha sparato alla schiena a Jacob Blake, causandogli la
paralisi dalla vita in giù. David Beth, sceriffo della contea, ha dichiarato che
da giorni a Kenosha autodefiniti "miliziani" armati pattugliavano le strade,
spacciandosi per "vigilanti". Ha anche detto che non è noto se l'assalitore
fosse uno di loro. Nella notte di ieri alcuni di loro armati con fucili, pistole
ed elmetti si sono ritrovati davanti a una pompa di benzina “per proteggere i
negozi e le proprietà” dai manifestanti. La tensione tra gli altri manifestanti
sale. Vicino all’edificio c’è anche Kyle Rittenhouse, 17 anni: ha un fucile
semiautomatico AR-15. “Stiamo proteggendo i cittadini e una persona della folla
mi ha appena spruzzato dello spray al peperoncino negli occhi”, racconta il
ragazzo che a un certo punto viene inquadrato mentre, scappando dai
manifestanti, si volta e apre il fuoco. Rittenhouse colpisce la prima persona
alla testa e poi inizia a fuggire, ma inciampa e viene aggredito dalla folla.
Continua comunque sparare. In un filmato, lo sei sente urlare: "Ho ammazzato
qualcuno!”. Sotto i suoi colpi cadono altre due persone, una delle quali rimane
a terra. Rittenhouse si avvicina alla polizia con le mani in alto, ma
inizialmente le camionette partono verso il luogo dei ferimenti, lasciandolo
libero. La polizia ha poi informato dell'arresto di Kyle Rittenhouse, della
vicina Antioch in Illinois, bianco e ammiratore della polizia. Preso in
custodia, è accusato di omicidio di primo grado. Il Guardian lo descrive come un
17enne bianco ammiratore della polizia.
Francesco Semprini per "lastampa.it" il 27 agosto 2020. Proprio
mentre le piazze degli Stati Uniti si infuocano nuovamente sulla scia dei fatti
del Wisconsin, è Vanity Fair a mantenere alta l’attenzione sul tema razziale. La
rivista dedica la copertina del numero di settembre a Breonna Taylor,
l'afroamericana di 26 anni uccisa lo scorso marzo dalla polizia mentre dormiva
nella sua casa a Louisville in Kentucky. La foto in copertina mostra un ritratto
di Breonna realizzato da Amy Sherald, la stessa artista che ha dipinto il
ritratto dell'ex First Lady degli Stati Uniti Michelle Obama e ora esposto alla
National Portrait Gallery di Washington. Nell'articolo all'interno a firma di
Ta-Nehisi Coates e intitolato «A Beautiful Life» (Una vita bella) viene
ripercorsa la storia della sua vita attraverso gli occhi e la voce della madre
Tamika Palmer. Dopo la sua morte, Breonna è diventata uno dei volti delle
proteste negli Stati Uniti contro la polizia violenta e contro il razzismo nei
confronti degli afroamericani. Sul caso si attendono ancora risposte. Taylor è
stata uccisa da alcuni agenti, appunto, mentre dormiva nella sua abitazione lo
scorso marzo. Da allora sono trascorsi mesi ma le autorità di Louisville e del
Kentucky non hanno ancora fornito spiegazioni sull'accaduto, nonostante il
pressing da più parti. Ieri, intanto, migliaia di persone sono scese in piazza
dopo il caso del 29 enne Jacob Blake, colpito alla schiena da almeno sette colpi
di arma da fuoco sparati da un agente. È avvenuto a Kenosha, in Wisconsin,
località che dista 100 km da Chicago. Ha «otto buchi sul suo corpo, è
paralizzato dalla vita in giù», ha denunciato il padre. Le immagini mostrano il
ragazzo, che aveva cercato di intervenire in un «incidente casalingo», in
un'area residenziale che si avvicina a un Suv mentre tre agenti lo seguono da
vicino. Blake apre lo sportello dell'auto e cerca di entrare quando uno dei
poliziotti lo afferra per la maglietta e gli spara alla schiena. L’episodio da
nuovamente fuoco alle polveri della protesta, con immediate manifestazioni per
le strade della città dove la nottata è stata all'insegna di fortissime tensioni
e violenza: i manifestanti hanno infranto vetrine dei negozi, buttato giù
cartelli stradali e dato alle fiamme alcune auto. Emergenza alla quale le forze
dell'ordine hanno risposto con l'uso di gas lacrimogeni. «Sosteniamo le proteste
pacifiche ma non possiamo e non consentiremo ai manifestanti di distruggere
proprietà e mettere a rischio la sicurezza», hanno avvertito le autorità, che
hanno arrestato almeno 11 persone nel corso delle manifestazioni. Il coprifuoco
imposto e la presenza della Guardia Nazionale non bastano. A Kenosha le proteste
non si fermano ed il Wisconsin si scopre il nuovo epicentro delle proteste
antirazziste, così come tre mesi fa lo era stata Minneapolis, in Minnesota, dove
il 26 maggio è stato ucciso George Floyd, un altro cittadino afroamericano, in
seguito al violento arresto da parte di quattro agenti bianchi. Il governatore
del Wisconsin, Tony Evers, dichiara lo stato di emergenza, mentre le proteste si
allargano ad altre città, fra le quali New York e Los Angeles. Il razzismo è
stato anche uno dei temi della convention repubblicana. Il candidato democratico
alle presidenziali, Joe Biden, fresco di nomina democratica per la corsa alla
Casa Bianca chiede un'immediata indagine «completa e trasparente»: «Dobbiamo
smantellare il razzismo di sistema e onorare il principio che sancisce che tutti
gli uomini e le donne sono creati uguali e soprattutto che devono essere
trattati in modo equo». «L'America non è razzista», ha detto Nikki Haley, l'ex
ambasciatrice all’Onu nella prima giornata di Convention repubblicana. «Dobbiamo
mettere fine al razzismo ma i poliziotti sono degli eroi americani», ha
rincarato la dose Donald Trump Jr, difendendo la politica di ordine e legalità
del padre e scagliandosi contro i democratici. «Immaginate un mondo dove i mali
del comunismo e del terrorismo islamico non hanno la possibilità di diffondersi.
Dove gli eroi sono festeggiati e i bravi ragazzi vincono. Potete avere questo
mondo - afferma il figlio del presidente -. Dovete rieleggere Donald Trump»
Caso Jacob Blake, 17enne bianco spara e uccide due
manifestanti: Fox News lo giustifica. Le Iene News il
27 agosto 2020. La città di Kenosha, nel Wisconsin, è attraversata da molte
proteste dopo l’ennesima aggressione della polizia ai danni di un afroamericano:
un agente ha sparato 7 colpi nella schiena a Jacob Blake, ferendolo gravemente.
Durante le proteste un 17enne è sceso in strada armato di fucile ed è stato
arrestato per l’omicidio di due persone. Ma per Tucker Carlson, conduttore di
Fox News non nuovo a simili uscite, il suo gesto è comprensibile. L’ennesima
aggressione della polizia ai danni di un afroamericano ha riacceso il fuoco
delle proteste del Black Lives Matter negli Stati Uniti: Jacob Blake,
afroamericano, è stato colpito alla schiena da sette pallottole che lo hanno
ferito gravemente a Kenosha, nel Wisconsin. Subito sono esplose manifestazioni e
rivolte in tutto il Paese, con migliaia di persone in strada per difendere il
diritto all’incolumità della comunità afroamericana. A Kenosha, però, è successo
anche qualcos’altro: un ragazzo bianco di soli 17 anni è sceso in strada armato
di fucile e ha ucciso due manifestanti. E’ stato arrestato e accusato di
omicidio. Ma a far scalpore non è solo il gesto del 17enne: un noto conduttore
di Fox News, network statunitense conservatore e molto vicino a Donald Trump, ha
giustificato in diretta l’azione del ragazzo. Tucker Carlons, già noto in
passato per le sue posizioni estremiste, ha detto: “A Kenosha c’è l’anarchia per
le strade, le autorità le hanno abbandonate: siamo davvero sorpresi che i
saccheggi e gli incendi siano degenerati in omicidio? Siamo davvero scioccati
dal fatto che i 17enne con i fucili decidano di mantenere l’ordine quando nessun
altro lo fa?”. Le parole del conduttore hanno ovviamente causato un’altra
rivolta, questa volta sui social network: decide di commentatori, personaggi
famosi e migliaia di persone lo hanno accusato di razzismo, chiedendo a Fox News
di allontanarlo. “Se non lo faranno subito, saranno tutti complici di questi
rantolii razzisti e omicidi”, ha commentato un ex membro dell’amministrazione di
Bill Clinton. Mancano meno di tre mesi alle elezioni presidenziali, e il clima
negli Stati Uniti continua a diventare sempre più incandescente.
Jacob Blake, il padre: «Mio figlio è ammanettato al letto
d’ospedale». Pubblicato da Il Dubbio il 28 agosto
2020. La denuncia dell’uomo: «È in arresto, ma non si sa per cosa. Dove può
andare dato che è paralizzato?» Jacob Blake, rimasto paralizzato dopo che gli
agenti gli hanno sparato più volte alle spalle, è ammanettato al letto
dell’ospedale dove è ricoverato in Wisconsin. Lo ha rivelato il padre del 29enne
afroamericano la cui vicenda sta provocando una nuova ondata di proteste di
Black Lives Matter. «Non può andare da nessuna parte, perché hanno dovuto
ammanettarlo al letto?», ha detto il padre, secondo quanto ha riportato il
Chicago Tribune. Mentre sta andando avanti un’inchiesta federale sulla
sparatoria, il procuratore locale ha detto che le circostanze sono ancora da
chiarire facendo riferimento ad un coltello ritrovato sulla scena. Blake senior
afferma che suo figlio è in arresto, ma che non è chiaro per quali accuse.
Nessuna delle autorità coinvolte ha risposto a una richiesta di commento da
parte dei giornali. Il governatore del Wisconsin, tuttavia, ha detto «diavolo
sì» quando gli è stato chiesto se è preoccupato di sentire che Blake è
presumibilmente ammanettato al suo letto. Nel frattempo, il mondo dello sport ha
continuato a mostrare solidarietà. L’avvocato di famiglia sta combattendo per
assicurarsi che Blake possa tornare a casa una volta dimesso dall’ospedale. È
stato anche riferito che il Dipartimento di Giustizia ha aperto un’indagine
sulla sparatoria. Secondo il New York Times, «L’Fbi ha detto mercoledì che
avrebbe condotto l’inchiesta federale in collaborazione con le autorità del
Wisconsin». Questo è il secondo caso su cui sta indagando il Dipartimento di
Giustizia, l’altro è l’omicidio di George Floyd, commesso il 25 maggio. Tuttavia
i difensori dei diritti civili e anche alcuni avvocati all’interno della
Divisione dei diritti civili del Dipartimento di giustizia dubitano che tale
indagine verrà realmente svolta prima delle elezioni presidenziali, soprattutto
considerando che Donald Trump ha costruito la sua campagna di rielezione in
parte attorno al suo fedele sostegno alle forze dell’ordine.
Lo sport americano si ferma per il caso Blake: dopo l’Nba stop
anche nel baseball, calcio e tennis. Estratto
da lastampa.it il 27 agosto 2020. La campagna ha invaso altre discipline, a
partire dal baseball con i Brewers - di Milwaukee come i Bucks, a una
cinquantina di chilometri da Kenosha dove si è svolto il dramma di domenica
- si sono rifiutati di scendere in campo contro Cincinnati. Altre due partite di
baseball (Mlb) sono state quindi rinviate. Lo stesso nel campionato di football
nordamericano (Mls), dove cinque delle sei partite in programma sono state
boicottate dai giocatori.
Davide Chinellato per gazzetta.it il 27 agosto 2020. Il giorno
più lungo dell’Nba non è ancora finito. Riprenderà alle 17 italiane, quando i
giocatori torneranno a vedersi dopo il burrascoso incontro della notte italiana
seguito al boicottaggio che ha fermato ai playoff. Alla stessa ora, i
proprietari Nba si incontreranno virtualmente col commissioner Adam Silver per
capire cosa fare. La stagione è in pausa fino ad allora, il destino delle tre
partite rinviate ieri e delle tre in programma oggi (improbabile si giochi),
come del resto dei playoff e della bolla di Disney World, appeso alla volontà
dei giocatori. Sono loro che hanno deciso di portare la battaglia per la
giustizia sociale al livello successivo, quello in cui sono pronti a giocarsi
tutto per forzare quel cambiamento che tanto chiedono. Alcuni giocatori sono
addirittura pronti a dire basta. Quelli di Lakers e Clippers, guidati da LeBron
James e Kawhi Leonard, avrebbero votato contro la ripresa della stagione, uniche
due squadre a farlo, nelle due ore e mezza di incontro tra i giocatori seguito
al boicottaggio delle partite di mercoledì. E’ stato un incontro intenso,
acceso, con le emozioni a fior di pelle per una situazione che tutti gli atleti
vedono come prioritaria ma per cui non c’è ancora un piano d’azione. Era quello
che doveva emergere dall’incontro, ma gli animi erano ancora troppo accesi per
arrivare a quella identità di vedute che Chris Paul, come presidente
dell’associazione giocatori, ha cercato a lungo di trovare. Diversi giocatori
hanno preso la parola, qualcuno anche per chiedere come mai Milwaukee abbia
deciso da sola di far partire quel boicottaggio a cui i giocatori stavano
pensando ma che nessuno aveva ancora proclamato (“Non è ancora stato deciso
nulla” aveva ricordato Andre Iguodala, vice presidente Nbpa, due ore prima il
mancato inizio di Milwaukee-Orlando). La scelta dei Bucks di non scendere in
campo in gara-5 contro Orlando ha comunque solo innescato un sentimento
deflagrato poi in modo così netto da coinvolgere anche tutto il resto dello
sport americano, fermatosi per solidarietà.
L’INCONTRO — Dentro la sala coi giocatori all’inizio c’erano
anche i coach, invitati a fare sentire la propria voce. “Questa è una protesta
dei giocatori, noi li supportiamo al 110% qualsiasi cosa decidano” aveva detto
ieri Brad Stevens. Doc Rivers, elogiato da molti atleti sui social dopo il
discorso a cuore aperto seguito alla vittoria dei suoi Clippers in gara-5 contro
Dallas, ha detto loro che dovevano usare l’arma più importante che hanno, il
loro talento, per continuare a far sentire la propria voce. Il sindacato ha
anche ricordato agli atleti quanto pesanti sarebbero le ripercussioni economiche
se il resto della stagione dovesse saltare: 1 miliardo di dollari di mancati
stipendi, il serio rischio di una serrata dei proprietari dopo la rinuncia da
parte della lega all’accordo collettivo attualmente in vigore (la deadline che
entrambe le parti hanno per uscirne è stata recentemente posticipata al 15
ottobre). Poi ai coach è stato chiesto di uscire e gli animi si sono
surriscaldati. Al momento di un primo voto, il no di Lakers e Clippers avrebbe
ulteriormente fatto salire la tensione, tanto che le due squadre, con LeBron in
testa, se ne sarebbero andate sbattendo la porta.
CHE SUCCEDE ORA— Se ne riparlerà oggi, con tutte le opzioni
ancora sul tavolo. La battaglia sociale per i giocatori è la priorità numero
uno, il motivo per cui hanno accettato di entrare nella bolla, di non vedere le
proprie famiglie per mesi, di rinunciare a diverse libertà per portare avanti la
stagione e approfittare di un palcoscenico su cui sono puntati i riflettori del
mondo per far sentire la loro voce. “Non vogliamo continuare a giocare e
dimenticarci di quello che sta succedendo nel mondo, perché tocca anche noi,
tocca tutti - aveva detto Jayson Tatum ieri in una delle tante conferenze stampa
di giocatori e coach dedicate all’idea del boicottaggio -. Non siamo
semplicemente giocatori, siamo esseri umani. Con emozioni e sentimenti”. “Devi
essere pronto a fare sacrifici importanti per far capire alla gente quanto è
importante quello che chiedi” aveva detto ieri Andre Iguodala. L’idea di non
riprendere la stagione resta quella di una minoranza, sia per le pesanti
ripercussioni economiche sia perché i giocatori sono consapevoli che hanno
ancora più gli occhi del mondo puntati addosso dopo questo boicottaggio. E che
il loro messaggio può continuare ad essere ascoltato, innescando quel
cambiamento che i giocatori tanto vogliono. Se Lakers e Clippers continuassero a
non voler riprendere, però, l’associazione giocatori potrebbe avere dei
problemi. E non è detto che basti quell’unità di intenti con gli atleti che
tutti i proprietari hanno finora dimostrato finora perché si torni in campo, non
prima di venerdì, per tornare a chiedere cambiamento e giustizia come gli atleti
fanno da mesi.
ANNA GUAITA per il Messaggero il 28 agosto 2020. Campi vuoti per
48 ore, con il basket, il football, il calcio e il tennis che interrompono i
campionati e gli allenamenti. Quei sette colpi di pistola sulla schiena di Jacob
Blake a Kenosha, nel Wisconsin, sono echeggiati nella società americana come un
tuono e hanno dato nuova energia sia alle manifestazioni nelle città che alla
protesta degli atleti. Ma è stato il fatto che un giovane bianco di 17 anni
abbia potuto circolare indisturbato imbracciando un fucile, durante le
manifestazioni a Kenosha, e uccidere due dimostranti e ferirne un terzo, che
mercoledì ha causato il congelamento per protesta delle attività sportive. Dopo
un incontro fra i rappresentanti delle squadre Nba in ritiro nella bolla di
Disney in Florida è stato deciso ieri di non interrompere del tutto il
campionato e di riprendere le partite. Gli interessi commerciali hanno avuto un
peso determinante nel raggiungere la decisione di riprendere le partite, ed
evitare una catastrofe finanziaria che si sarebbe andata ad aggiungere a quella
già causata dalla pandemia e dai mesi di quarantena. Lo «sciopero» resta
comunque un fatto storico anche per l'immediata solidarietà espressa dagli altri
sport, perfino dal golf, e la promessa comune di continuare a battersi per la
giustizia. Il basket rimane lo sport più attivo ed esplicito nel suo impegno
contro il razzismo. Doc Rivers, l'allenatore dei Clippers, la squadra che con i
Lakers è la favorita per il campionato, si è sfogato: «E' incredibile che
continuiamo ad amare questo Paese, mentre questo Paese non ci ama». Vari
giocatori hanno raccontato di aver ricevuto telefonate da tanti amici,
spaventati per il futuro dei figli: «Parlando francamente, nella nostra comunità
la situazione è un disastro», ha detto LeBron James, il campione dei Lakers che
si batte per proteggere il diritto di voto nelle comunità di colore.
GLI ALTRI CASI. Anche i giocatori di football però sono diventati
politicamente sempre più attivi da quando l'ex quarterback dei San Francisco
49ers, Colin Kaepernick, scelse di inginocchiarsi durante l'inno nazionale,
invece che stare in piedi con la mano sul cuore. Era il 26 agosto 2016 quando
Kaepernick lanciò questa protesta pacifica in sostegno di Black Lives Matter, e
da allora il suo gesto è stato abbracciato da molti sia nel football che in
altri sport. Fece sensazione quando la campionessa di calcio Megan Rapinoe si
inginocchiò anche lei durante i mondiali di calcio femminile l'anno scorso in
Francia, campionato vinto dalla sua squadra. La Rapinoe è stata la prima atleta
bianca a imitare Kaepernick e la sua squadra ha poi seguito l'esempio dei
Philadelphia Eagles, che dopo aver vinto il campionato di football nel 2018
rifiutarono l'invito di andare alla Casa Bianca da Donald Trump.
I PRECEDENTI. Peraltro non è la prima volta che la società
americana riceve una forte scossa dal mondo dello sport. Basti ricordare come
Cassius Clay (Muhammad Alì) dette voce agli obiettori di coscienza quando si
rifiutò di andare in guerra in Vietnam nel 1966, o quando i velocisti Tommie
Smith e John Carlos elettrizzarono la comunità afro americana alzando il pugno
guantato di nero durante le Olimpiadi del 1968 in difesa dei diritti civili.
Davanti alle proteste degli atleti, ieri, il genero di Trump, Jared Kushner ha
avuto un aspro commento: « Possono pagarsi il lusso di prendersi una serata di
congedo». Il commento voleva chiaramente far leva sul risentimento abbastanza
diffuso nei confronti degli atleti superpagati, una tattica usata da Trump
stesso. Significativamente, nei discorsi che si tenevano contemporaneamente
nell'ambito della Convention del partito repubblicano, nessuno ha fatto cenno
alle proteste degli atleti, ma ieri sera Donald Trump (che intendeva piuttosto
pronunciare un discorso incentrato sul tema della «legge e ordine») è sbottato:
«La Nba è diventata come un'organizzazione politica».
Polveriera USA, scontri tra manifestanti pro e contro Trump:
un morto a Portland. Redazione su Il Riformista il 30
Agosto 2020. Infiammano gli scontri a Portland. La città dell’Oregon a ferro e
fuoco per via dei contatti tra i manifestanti del movimento antirazzista Black
Lives Matter e i sostenitori del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Un
uomo è stato ucciso a colpi di pistola ieri sera, intorno alle 20:45, nel centro
della città. In corso un’indagine per omicidio. Portland era stata già epicentro
di manifestazioni e scontri dopo l’uccisione dell’afroamericano George Floyd, lo
scorso maggio a Minneapolis; episodio che aveva scatenato proteste e
manifestazioni in tutto il mondo. La polizia ha fatto sapere che una
manifestazione politica stava attraversando il centro della città quando ci sono
stati “casi di violenza tra manifestanti e contro-manifestanti. Gli ufficiali
sono intervenuti e in alcuni casi hanno effettuato arresti. OregonLive ha
riportato “scontri” e “momenti di tensione” tra i gruppi, sebbene la polizia non
abbia detto se la sparatoria fosse collegata alle manifestazioni. Negli ultimi
giorni una nuova ondata di proteste si è estesa negli Stati Uniti dopo il
ferimento del 29enne afroamericano Jacob Blake, domenica scorsa, a Kenosha, nel
Wisconsin. Proprio nella città due uomini sono stati uccisi a colpi di arma da
fuoco nei giorni scorsi: arrestato un 17enne, armato di un fucile d’assalto,
arrivato dal vicino Illinois. Venerdì circa 50mila persone hanno manifestato con
il movimento anti-razzista Black Lives Matter a Washington ricordando il
discorso “I have a dream” dell’attivista e premio Nobel per la pace Martin
Luther King del 28 agosto 1963.
Da ilsole24ore.com il 30 agosto 2020. Una persona è stata uccisa
sabato sera a Portland a seguito di scontri tra manifestanti di Black Lives
Matter e sostenitori del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo ha reso
noto la polizia. La città dell'Oregon è stata un epicentro delle proteste da
quando la polizia ha ucciso George Floyd nel Minnesota a fine maggio. La
sparatoria è avvenuta intorno alle 20:45 in centro, ha detto la polizia. E' in
corso un'indagine per omicidio. Il raduno pro-Trump ha attirato in città
centinaia di camion pieni di sostenitori di estrema destra del presidente
americano. I fan di Trump e i contromanifestanti si sono scontrati per le
strade, con persone che sparavano con pistole da paintball dai camioncini e
manifestanti che lanciavano oggetti contro di loro. Un video, ripreso dal lato
più lontano della strada, mostra un piccolo gruppo di persone in strada
all'esterno di quello che sembra essere un parcheggio. Scoppia uno sparo e un
uomo crolla in strada. La polizia di Portland ha twittato che una manifestazione
politica stava “percorrendo tutto il centro della città e che “ci sono stati
alcuni casi di violenza tra manifestanti e contro-manifestanti. Gli ufficiali
sono intervenuti e in alcuni casi hanno effettuato arresti”. OregonLive ha
riportato “scontri” e “momenti di tensione” tra i gruppi, sebbene la polizia non
abbia detto se la sparatoria fosse collegata alle manifestazioni. L'uomo colpito
e ucciso indossava un cappello con le insegne di Patriot Prayer, un gruppo di
estrema destra che in passato si è scontrato con i manifestanti di Black Lives
Matter. Patriot Prayer, fondato a Portland nel 2016 da Joey Gibson, si descrive
come sostenitore della libertà di parola e oppositore della presenza pubblica
nell’economia e nella società. I nazionalisti bianchi e i gruppi di estrema
destra, come Proud Boys e Hell Shaking Street Preachers hanno partecipato ai
raduni organizzati da Patriot Prayer, scatenando polemiche e disordini. La
sparatoria giunge al termine di una settimana di forti tensioni negli Stati
Uniti, iniziata quando la polizia di Kenosha, Wisconsin, ha sparato
ripetutamente a un nero, Jacob Blake, provocando nuove proteste contro il
razzismo e la brutalità della polizia, tra cui il rinvio delle partite dei
professionisti dello sport, a cominciare dai playoff dell’Nba di basket. Trump
ha risposto alle proteste affermando la necessità di una risposta più dura da
parte dello Stato. Portland è stata teatro di manifestazioni notturne dopo la
morte per soffocamento di George Floyd per opera di un poliziotto a Minneapolis
a maggio.
Il nuovo caso che sconvolge gli Stati Uniti.
New York, afroamericano morto asfissiato: la polizia lo aveva
incappucciato e bloccato sull’asfalto. Redazione de Il Riformista il 3 Settembre
2020. L’episodio risale allo scorso 30 marzo. Ma solo oggi la famiglia della
vittima ha deciso di diffondere le immagini. Il video sta facendo il giro dei
social e sta sconvolgendo gli Stati Uniti. Il caso è quello di Daniel Prude,
30enne afroamericano. Gli agenti lo avevano fermato, ammanettato e incappucciato
prima di premere il suo viso sull’asfalto per alcuni minuti. L’uomo è deceduto
il giorno dopo in ospedale, dove era stato ricoverato in fin di vita. Prude
soffriva di disturbi mentali. Era originario di Chicago. Quando è stato fermato
dagli agenti correva nudo per strada. Si trovava a Rochester, New York, per una
visita con la sua famiglia. La polizia è intervenuta dopo che a chiamarla era
stato il fratello di Daniel, Joe, per denunciarne la scomparsa dall’abitazione
in cui si trovavano. L’uomo ha obbedito all’ordine di mettersi a terra con le
mani dietro la nuca.
Da ansa.it il 3 settembre 2020. Nuovo video shock in America. Un
afroamericano di 30 anni con disturbi mentali che correva nudo per strada a
Rochester, sobborgo alle porte di New York, è morto asfissiato dopo che gli
agenti che lo avevano fermato lo hanno ammanettato mettendogli poi un cappuccio
e premendo il suo viso sull'asfalto per almeno due minuti. La morte è
sopravvenuta sette giorni dopo in ospedale, dove l'uomo era stato ricoverato in
fin di vita. L'episodio risale al 30 marzo, ma solo ora la famiglia ha diffuso
le immagini. La vittima si chiamava Daniel Prude, 30 anni, originario di
Chicago. Era appena arrivato a Rochester per una visita con la sua famiglia. La
polizia è intervenuta dopo che il fratello Joe ha chiamato il numero di
emergenza 911 per denunciare la scomparsa del fratello dall'abitazione in cui si
trovavano, spiegando che Daniel soffriva di disturbi mentali. Il video mostra
l'uomo correre svestito per strada, ma quando i poliziotti intervenuti gli
ordinano di mettersi a terra obbedisce e mette le sue mani dietro la nuca.
Appare però molto agitato e urla mentre lo ammanettano. Gli agenti poi gli
infilano la testa in una maschera "antisputo", una sorta di cappuccio usato per
proteggere i poliziotti dalla saliva delle persone fermate, soprattutto in tempi
di pandemia. Si sente Prude supplicare di togliere quel cappuccio che non lo fa
respirare, ma per tutta risposta un agente sbatte la sua testa in terra e poi
con due mani gliela tiene premuta contro l'asfalto, urlando all'uomo "basta
sputare!". Intanto le urla si trasformano in gemiti e grugniti, mentre un altro
agente gli mette un ginocchio sulla schiena. Gli agenti cominciano a
preoccuparsi solo quando l'uomo comincia a vomitare, poco prima di rimanere
completamente privo di conoscenza. Gli agenti sono ora sotto indagine da parte
della procura di New York. La perizia di un medico legale parla di "omicidio
causato dalle complicazioni di un'asfissia dovute a una coercizione fisica".
Polizia lo incappuccia, afroamericano muore asfissiato.
E' accaduto a New York, la vittima aveva disturbi mentali. La
Repubblica il 03 settembre 2020. Nuovo video shock in America.
Un afroamericano di 30 anni con disturbi mentali che correva nudo per strada a
Rochester, sobborgo alle porte di New York, è morto asfissiato dopo che gli
agenti che lo avevano fermato lo hanno ammanettato mettendogli poi un cappuccio
e premendo il suo viso sull'asfalto per almeno due minuti. La morte è
sopravvenuta sette giorni dopo in ospedale, dove l'uomo era stato ricoverato in
fin di vita. L'episodio risale al 30 marzo, ma solo ora la famiglia ha diffuso
le immagini. La vittima si chiamava Daniel Prude, 30 anni, originario di
Chicago. Era appena arrivato a Rochester per una visita con la sua famiglia. La
polizia è intervenuta dopo che il fratello Joe ha chiamato il numero di
emergenza 911 per denunciare la scomparsa del fratello dall'abitazione in cui si
trovavano, spiegando che Daniel soffriva di disturbi mentali. Il video mostra
l'uomo correre svestito per strada, ma quando i poliziotti intervenuti gli
ordinano di mettersi a terra obbedisce e mette le sue mani dietro la nuca.
Appare però molto agitato e urla mentre lo ammanettano. Gli agenti poi gli
infilano la testa in una maschera "antisputo", una sorta di cappuccio usato per
proteggere i poliziotti dalla saliva delle persone fermate, soprattutto in tempi
di pandemia. Si sente Prude supplicare di togliere quel cappuccio che non lo fa
respirare, ma per tutta risposta un agente sbatte la sua testa in terra e poi
con due mani gliela tiene premuta contro l'asfalto, urlando all'uomo "basta
sputare!". Intanto le urla si trasformano in gemiti e grugniti, mentre un altro
agente gli mette un ginocchio sulla schiena. Gli agenti cominciano a
preoccuparsi solo quando l'uomo comincia a vomitare, poco prima di rimanere
completamente privo di conoscenza. Gli agenti sono ora sotto indagine da parte
della procura di New York. La perizia di un medico legale parla di "omicidio
causato dalle complicazioni di un'asfissia dovute a una coercizione fisica".
Stati Uniti, agenti uccidono afroamericano: scoppiano
manifestazioni a Los Angeles. Pubblicato martedì, 01
settembre 2020 da La Repubblica.it. Un afroamericano è stato colpito e ucciso
dagli agenti nel quartiere di Westmont, a sud di Los Angeles. Secondo quanto
riferisce la polizia la sparatoria è avvenuta ieri alla fine di un inseguimento
e dopo che la vittima avrebbe colpito uno degli agenti. Alcune ore dopo la
sparatoria, una folla si è radunata sulla scena, ha iniziato a protestare a
chiedere risposte, scandendo i cori che caratterizzano la protesta del movimento
di protesta in corso da mesi, "Dì il suo nome", "Niente giustizia, niente pace"
e "Le vite dei neri contano" (Black Lives Matter). Dopo mezzanotte più di 100
manifestanti hanno marciato sulla Imperial Highway, dove hanno continuato la
protesta. Questa sparatoria arriva due mesi dopo la controversa morte del
diciottenne Andres Guardado a Gardena, che ha causato settimane di
manifestazioni. Guardado, salvadoregno americano di 18 anni, è morto colpito
alla schiena il 18 giugno scorso. La dinamica è stata simile a quella che il
vice sceriffo Brandon Dean ha descritto oggi e che riporta il Los Angeles Times.
I due agenti della stazione di South Los Angeles stavano pattugliando in auto su
Budlong Avenue quando hanno visto un uomo che andava in bicicletta senza
rispettare il codice stradale dei veicoli. Non ha saputo dire quali infrazioni
avesse commesso. Quando gli agenti hanno cercato di fermarlo, l'uomo ha lasciato
cadere la bicicletta ed è corso a nord, su Budlong, scappando per un isolato
con i poliziotti che lo inseguivano. Lo hanno bloccato poco dopo, al 1200 di
West 109th Place, l'uomo ha preso a pugni in faccia uno dei due. Nel farlo ha
lasciato cadere un fagotto di vestiti che stava trasportando. Il vice sceriffo
ha aggiunto che dentro gli agenti hanno visto una pistola, così hanno sparato,
uccidendolo. Non ha identificato l'uomo e lo ha descritto solo come un
afroamericano sulla trentina. Dean ha detto di non sapere quante volte l'uomo è
stato colpito, ma ha riferito che era stato colpito più di 20 volte in modo
impreciso. Un video girato nel quartiere mostra due agenti correre dietro a un
uomo che sembrava trasportare un fascio di vestiti. Poi si vedono gli stessi
agenti con le pistole estratte, apparentemente dopo aver sparato all'uomo. Il
testimone Gerardo De La Torre, 18 anni, stava giocando ai videogiochi nella sua
camera da letto sopra la strada, West 109th, quando ha sentito un decina di
spari seguiti dalle urla. È uscito e ha visto un gruppo di persone confrontarsi
con i poliziotti. Dopo cinque minuti, ha detto, 12 auto della polizia si sono
fermate all'incrocio, con le sirene, a terra un uomo morto. Ha detto che ci sono
ancora due fori di proiettile nella staccionata di legno fuori da casa sua. "Non
mi piace quello che sta succedendo qui", ha detto, "è come se fosse stata aperta
la stagione di caccia". Gli investigatori devono ancora interrogare agenti e
molti altri testimoni, ha detto Dean. Non hanno esaminato filmati di
sorveglianza o video di cellulari che potrebbero aver catturato la scena. Nessun
poliziotto è rimasto ferito.
Da "ilmessaggero.it" l'1 settembre 2020. Un afroamericano è stato
colpito e ucciso dagli agenti della contea di Los Angeles a South Los Angeles.
Secondo quanto riferisce la polizia la sparatoria è avvenuta alla fine di un
inseguimento e dopo che la vittima avrebbe preso a pugni in faccia uno degli
agenti. Nella notte sono scoppiate le proteste e numerosi manifestanti si sono
radunati sul luogo della sparatoria con momenti di tensione. Secondo la
ricostruzione della polizia i due agenti coinvolti avrebbero visto la vittima in
sella alla sua bicicletta e avrebbero deciso di fermarlo per un controllo. A
quel punto l'uomo - che la famiglia ha identificato con i media come Dijon
Kizzee, 29 anni - avrebbe abbandonato la bici dandosi alla fuga. Quando gli
agenti lo hanno raggiunto l'uomo avrebbe opposto resistenza e avrebbe sferrato
un pugno contro uno dei poliziotti. Poi avrebbe lasciato cadere alcuni indumenti
a terra. A quel punto gli agenti hanno aperto il fuoco. «Gli agenti hanno notato
che all'interno dei capi di abbigliamento lasciati cadere c'era una pistola
semiautomatica nera - è stato spiegato - A quel punto si è verificata la
sparatoria». L'uomo è stato colpito più volte ed è morto sul colpo.
Trump: Biden manovrato da persone che si muovono nell'ombra. Joe
Biden è manovrato da persone che agiscono nell'ombra, quelle che controllano le
strade nelle proteste razziali: è l'accusa lanciata da Donald Trump in una
intervista a Fox News. Secondo il presidente, a muovere i fili del suo rivale
sono «persone di cui non si è mai sentito parlare, persone che sono nell'ombra»
e che «stanno controllando le strade». Rispondendo all'obiezione se non si
tratti di una teoria cospirativa, il tycoon ha evocato un aereo carico di
delinquenti in uniforme partito lo scorso weekend per fare grandi danni e
un'indagine in corso. «C'è stata gente che è salita su un aereo da una certa
città nel weekend e l'aereo era quasi completamente pieno di delinquenti, che
indossavano uniformi scure, nere, con attrezzature e questo e quello», ha
denunciato. «Un sacco di persone erano sull'aereo per fare grandi danni», ha
aggiunto. Quando gli è stato chiesto di fornire ulteriori dettagli, Trump ha
spiegato che l'episodio è oggetto di indagine. «Ve lo dirò prima o poi», ha
promesso.
Biden avanti nei sondaggi: meglio di Clinton nel 2016. Joe Biden
resta saldamente in testa dopo le convention, almeno secondo l'ultimo sondaggio
di Morning Consult, avanti di 8 punti su Donald Trump: meglio di Hillary Clinton
nel 2016, quando l'ex first lady allo stesso punto della campagna elettorale era
in vantaggio di soli 3 punti sul tycoon. Nel dettaglio Biden gode del favore del
51% degli elettori americani contro il 43% di Trump. In particolare è avanti di
12 punti sul fronte dell'elettorato femminile, grazie anche alla scelta di
Kamala Harris come vice.
Massimo Gaggi per corriere.it il 9 settembre 2020. Di nuovo
poliziotti scriteriati che usano le armi da fuoco con incredibile leggerezza. Di
nuovo agenti che trattano un malato di mente come un criminale qualunque,
pretendendo obbedienza da una persona incapace di intendere e di volere.
Stavolta succede a Salt Lake City, nello Utah e di nuovo, come nel caso emerso
qualche giorno fa a Rochester, nello Stato di New York, la vittima è una persona
disarmata con gravi problemi mentali. E se Black Lives Matter si mobiliterà di
nuovo, non sarà di certo per il colore della pelle della vittima: Linden Cameron
è un ragazzino bianco di 13 anni che soffre di autismo. Venerdì scorso la madre
era tornata al lavoro dopo molti mesi d’interruzione per via della pandemia.
Rientrando a casa ha trovato il figlio in preda a una crisi nervosa,
probabilmente scatenata dal suo improvviso allontanamento. Incapace di tenergli
testa, Golda Barton aveva chiamato il 911 (il 113 americano) per chiedere aiuto.
Sperava in un’ambulanza e in un ricovero in ospedale. Invece è arrivata una
pattuglia della polizia con gli agenti che hanno urlato al ragazzo di mettersi a
terra. Ancor più terrorizzato, Linden non ha obbedito e dopo qualche attimo uno
degli agenti ha sparato colpendolo tre volte all’addome e a una spalla. Ora è
ricoverato in ospedale in condizioni gravi ma, pare, non in immediato pericolo
di vita. Un caso che ha dell’incredibile, peggiore di quello di Rochester dove i
poliziotti non hanno sparato nè tirato fuori armi: avevano messo un cappuccio
antisputi a Daniel Prude temendo contagi da Covid-19 e da Hiv e,
immobilizzandolo a terra, non si sono resi conto che lo stavano soffocando. Poi
hanno parlato del suo decesso come di un caso di overdose (oltre ad avere gravi
problemi mentali, Prude aveva fatto uso di stupefacenti). Nello Utah, invece (il
fatto risale a venerdì) il portavoce della polizia inizialmente ha detto che gli
agenti hanno dovuto agire perché Linden aveva un’arma e stava minacciando altri
cittadini. Ma poi ha dovuto correggere il tiro (ora non parla più di
ritrovamento di un’arma) dopo che la madre, in lacrime davanti alle telecamere,
lo ha smentito: «Non aveva armi, voleva attirare l’attenzione e poi è fuggito:
ho detto loro delle sue condizioni psichiche, li ho pregati di usare il livello
minimo di forza possibile. Ma loro l’hanno inseguito e dopo qualche secondo ho
sentito i colpi. Li ho raggiunti mentre lo portavano via e non mi hanno nemmeno
detto se mio figlio era vivo o morto». È sempre più evidente che, al di là di
atteggiamenti razzisti che emergono in alcune circostanze, molti agenti
americani, decisi a non rischiare nulla nel contatto fisico con la persona da
arrestare e protetti da norme che li autorizzano a sparare se si sento
minacciati, reagiscono con un eccesso di violenza non appena si delinea una
situazione potenzialmente pericolosa. A Salt Lake City c’erano già stati casi di
reazioni eccessivamente violente degli agenti e perfino dei loro cani
poliziotto. Il sindaco e le altre autorità cittadine avevano sollecitato una
riforma della polizia e un addestramento più approfondito. Gli agenti, che
avevano già studiato le tecniche di de-escalation per far scemare le tensioni,
avevano promesso di seguire un nuovo corso su come trattare i cittadini con
problemi psichici. Doveva iniziare sabato, il giorno dopo la sanguinosa cattura
di un povero malato di mente.
DAGONEWS il 14 settembre 2020. Il vice dello sceriffo della
contea di Clayton, in Georgia, è stato licenziato dopo essere stato ripreso
mentre picchia ripetutamente un uomo di colore durante un normale controllo di
routine per un fanalino rotto. Roderick Walker, 26 anni, è stato arrestato e
picchiato dopo che gli agenti lo hanno fermato mentre viaggiava in auto con la
sua ragazza, il figlio di cinque mesi e il figlio della donna. Gli agenti hanno
chiesto all’uomo di scendere nonostante non fosse alla guida e si sarebbero
alterati quando l’uomo ha chiesto loro per quale motivo sarebbe dovuto scendere
visto che non era al volante. L’arresto è stato filmato da un passante che ha
ripreso la brutalità con cui i due agenti si sono scagliati contro l’uomo. Nelle
immagini si vede l’uomo che tenta di liberarsi mentre i due poliziotti sono
sopra di lui. Improvvisamente il vice sceriffo inizia a colpirlo ripetutamente
in faccia mentre la fidanzata dell’uomo urla disperatamente. Dopo che le
immagini sono diventate virali il vice sceriffo è stato licenziato nonostante
abbia detto di aver reagito dopo essere stato morto. Roderick Walker ha negato
di aver morso l’agente, ma è stato arrestato per aver intralciato il lavoro gli
agenti e per percosse. Williams ha chiesto il suo rilascio su cauzione e ha
detto di aver chiesto al Georgia Bureau of Investigation di riesaminare il caso.
Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera” il 9 settembre 2020.
Proteste e battaglie in Oregon per il 102esimo giorno consecutivo dall' inizio
delle manifestazioni contro il razzismo innescate dalla morte di George Floyd,
ucciso dalla polizia a Minneapolis. Dall' interno conservatore di questo Stato
democratico della West Coast sono ripartite le autocolonne delle milizie della
destra nazionalista, dirottate dalla polizia fuori Portland per evitare nuovi
incidenti tragici come l' uccisione, il 29 agosto, di un membro del Patriot
Prayers da parte di un attivista dei gruppi Antifa, poi morto anche lui in uno
scontro con la polizia. Stavolta a muoversi sono state le milizie armate dei
Proud Boys. Arrivate nella capitale, Salem, si sono scontrate davanti al
Parlamento coi manifestanti di Black Lives Matter, attaccati con spray
urticanti, pallottole di vernice e a pugni. La polizia è poi riuscita a sedare i
tumulti e ha arrestato alcuni miliziani. Intanto anche Louisville, in Kentucky,
è arrivata al 102esimo giorno consecutivo di proteste e scontri. E anche qui il
rischio che le manifestazioni si trasformino in tragedia è accentuato dalla
comparsa di diversi gruppi paramilitari: con l' aggravante che a quelli dei
suprematisti bianchi e della destra nazionalista (dagli Oath Keepers ai 3
Percenters, passando per gli Angry Vikings e gli American Patriots, oltre alle
sigle già citate) ora si contrappone una formazione di attivisti afroamericani
anch' essi armati fino ai denti: la Nfac (sta per Not Fucking Around Coalition,
che, slang a parte, potremmo tradurre con «coalizione di quelli che fanno sul
serio»). Louisville è uno degli epicentri della protesta in America perché qui
alcuni mesi fa Breonna Taylor è stata uccisa dalla polizia nel suo letto. Da
mesi i manifestanti chiedono l' arresto degli agenti che l' hanno colpita. I
miliziani neri sono comparsi la prima volta il 4 luglio in Georgia alle
manifestazioni di Stone Mountain Park, un monumento confederato scolpito su una
montagna non lontana da Atlanta che secondo gli Antifa andrebbe eliminato come
le statue di personaggi storici razzisti abbattute nei mesi scorsi. A Louisville
hanno sfilato una prima volta il 25 luglio, una manifestazione segnata da un
incidente che poteva essere tragico: un miliziano di colore, cadendo dopo aver
messo un piede in fallo, ha sparato una raffica ferendo tre suoi compagni.
Centinaia di miliziani neri sono tornati ora in città per sostenere Black Lives
Matter nella protesta contro il Kentucky Derby, una delle più importanti gare
ippiche d' America che si è svolta nel week end del Labor Day: un sacrilegio
secondo i manifestanti che hanno assediato l' ippodromo, difeso dalla polizia e
della Guardia Nazionale. I miliziani Nfac si sono concentrati in un parco vicino
alla zona delle proteste mentre in città arrivavano gli uomini armati di varie
organizzazioni di destra - dagli Angry Vikings ai Sons of Liberty - per
affrontarli. La polizia all' inizio si è limitata a difendere l' ippodromo, ma
quando la città è stata invasa da gruppi armati contrapposti, è riuscita a
creare un' intercapedine tra i due fronti, evitando incidenti. Stavolta è andata
bene ma, con centinaia di uomini che si confrontano con armi semiautomatiche e
il colpo in canna, le tensioni possono esplodere in qualunque momento. E, anche
senza scontri cruenti, diverse città americane vivono in un clima di minaccia
permanente: oltre a Portland, Louisville e le città teatro di altre violenze
razziali come Kenosha, Minneapolis e Rochester, la macchina della protesta è
sempre attiva anche in alcune grandi metropoli - da Seattle a Chicago - mentre
scontri cominciano a registrarsi anche nelle città dell' America «profonda», da
Boise in Idaho ad Albuquerque in New Mexico. Difficile che la situazione
migliori nei prossimi due mesi, coi miliziani di destra che inneggiano a Trump e
ai teorici delle cospirazioni QAnon e il presidente che soffia sul fuoco. Mentre
quelli neri, guidati dall' ideologo armato John Jay Fitzgerald Johnson,
vagheggiano una secessione del Texas nel quale gli afroamericani dovrebbero
costruire il loro Stato, indipendente dagli Usa. Anche dopo il voto del 3
novembre, qualunque sia il suo esito, è difficile che questi gruppi animati da
un istinto di ribellione e dal desiderio di ostentare forza fisica anche a costo
di arrivare allo scontro, svaniscano nel nulla.
Da corriere.it il 23 settembre 2020. Uno scambio di battute.
Alcune più concitate, altre amichevoli. Hasani Best, poco prima di morire, ride
con l'agente che gli sparerà da lì a pochi minuti. Lo mostra il video rilasciato
martedì dal Procuratore generale del New Jersey che racconta gli ultimi istanti
di Best, l'afroamericano 39enne ucciso da un agente il 21 agosto. Gli agenti
erano intervenuti chiamati da alcuni vicini insospettiti da un diverbio tra Best
e una donna che era con lui in casa: al loro arrivo i poliziotti hanno trovati i
due sul pianerottolo di casa e l'uomo che impugnava un coltello. Le immagini
mostrano proprio Best con il coltello in mano: gli agenti gli intimano di
appoggiarlo a terra. Poco dopo, partono i colpi di pistola.
Dijon Kizzee, l’autopsia: morto dissanguato dopo 15 colpi.
Notizie.it il 23/09/2020. I risultati dell'autopsia su
Dijon Kizzee: era vivo e respirava, ma i poliziotti lo hanno lasciato morire
dissanguato. Le dinamiche dell’omicidio di Dijon Kizzee, ventinovenne
afroamericano ucciso dalla polizia negli Stati Uniti dopo essere stato fermato
per strada, sono ancora tutte da chiarire. Gli esiti dell’autopsia hanno
tuttavia ricostruito gli ultimi tragici istanti vissuti dall’uomo prima di
morire. Dijon Kizzee stava guidando la sua bicicletta a South Los Angeles quando
è stato fermato dalla polizia per avere violato il codice della strada
sbagliando lato della strada. Il ventinovenne afroamericano, davanti al segnale
di fermo delle autorità, aveva invertito il senso di marcia ed era in procinto
di fuggire a piedi. L’inseguimento sarebbe tuttavia terminato
con una sparatoria che ha portato alla morte di Kizzee. Non è ancora chiaro chi
abbia estratto per primo le armi e se realmente anche il ragazzo avesse una
pistola con sé. I dubbi in merito agli eventi sono dunque ancora tanti. A dare
alcune risposte in merito è stata l’autopsia indipendente chiesta dai familiari.
Dijon Kizzee, secondo i risultati dell’autopsia indipendente, sarebbe stato
colpito con 15 colpi di pistola. Gli ultimi spari sarebbero arrivati, inoltre,
quando l’afroamericano era già a terra sanguinante a causa delle numerose ferite
d’arma da fuoco. Il ventinovenne non sarebbe dunque morto sul colpo, bensì a
seguito di atroci sofferenze. Nessuno, in questi ultimi istanti, sarebbe
intervenuto per sincerarsi delle sue condizioni di salute. Le autorità sarebbero
infatti rimaste inermi di fronte alla morte dell’uomo per dissanguamento. “Ciò
che l’esame – ha spiegato l’avvocato Carl Douglas – dimostra è che Dijon Kizzee
era vivo e respirava e si contorceva dal dolore quando gli agenti hanno
continuato a girargli intorno senza avvicinarsi”. Secondo i legali, inoltre,
l’afroamericano non avrebbe avuto nessuna arma in mano e non sarebbe stato
avvertito prima degli spari.
Usa, agente che uccise Breonna Taylor solo negligente, scoppia
la rivolta. Pubblicato mercoledì, 23 settembre 2020
da La Repubblica.it. Un solo agente incriminato per la morte di Breonna Taylor,
l'afroamericana uccisa nella sua abitazione lo scorso marzo e divenuta uno dei
volti del Black Lives Matter. Un'incriminazione per condotta negligente e
pericolosa, per la quale rischia se condannato fino a 15 anni di carcere, non
per l'uccisione della ragazza 26 enne. Gli altri due poliziotti che
accompagnavano Brett Hankinson non sono stati accusati. La decisione del gran
giurì lascia l'amaro in bocca dopo 100 giorni di proteste nelle strade di tutta
America. E scatena in molti la rabbia: a Louisville, nel Kentucky dove Tayler è
stata uccisa, i manifestanti invadono le strade e si scontrano con la polizia.
Nella città è previsto scattare il coprifuoco alle 21 ora locale: è stato deciso
in anticipo dal sindaco per cercare di stemperare gli animi ed evitare una notte
di violenza. Ma sono molte le città americane dove sono in corso proteste per
chiedere giustizia per Breonna Taylor. Era marzo quando gli agenti hanno fatto
irruzione in piena notte nell'abitazione della ragazza, che stava dormendo con
il suo fidanzato. Non avendo capito cosa stava accadendo e non avendo
riconosciuto che si trattava della polizia, il compagno di Taylor - Kenneth
Walker - ha sparato e colpito a una gamba uno degli agenti. I tre poliziotti
hanno risposto sparando 32 colpi, molti dei quali hanno raggiunto e ucciso
Taylor. Per il grand giurì la reazione degli agenti era giustificata perché
Walker ha sparato per primo. La decisione del gran giurì è "offensiva", dice Ben
Crump, il legale della famiglia Taylor. Kamala Harris, la candidata democratica
alla vicepresidenza, ammette di non aver avuto modo di leggere la decisione ma
afferma: "Non c'è dubbio che la famiglia di Breonna Taylor meritava giustizia
ieri, la merita oggi e la meriterà domani", afferma. I legali di uno dei tre
agenti coinvolti nel caso sono soddisfatti. "La morte di Breonna Taylor è una
tragedia. Ma gli agenti non hanno agito in modo non professionale. Hanno svolto
il loro compito e non hanno infranto la legge", spiega Kent Wicker, legale di
Jonathan Mattingly, uno degli agenti coinvolti nel caso. Nell'annunciare la
decisione del gran giurì il procuratore del Kentucky, Daniel Cameron, ammette
che molte persone non saranno soddisfatte dal risultato. Cameron spiega che
Mattingly e l'agente Myles Cosgrove - colui che ha sparato il colpo definito che
ha ucciso la ragazza - "secondo la legge del Kentucky erano giustificati
all'uso della forza per proteggersi. Questa giustificazione ci impedisce di
perseguirli per la morte di Taylor". Brett Hankison invece è stato incriminato
per negligenza, ovvero per l'aver sparato in direzione di un appartamento nelle
vicinanze mettendo a rischio la vita di altre persone.
Afroamericano ucciso dalla polizia: scontri a Filadelfia.
Notizie.it il
27/10/2020. L'afroamericano 27enne Walter Wallace è stato ucciso dalla polizia.
Scoppia la protesta a Filadelfia. Altre proteste violente negli Stati Uniti che,
questa volta, toccano la città di Filadelfia dove la polizia ha ucciso a colpi
di pistola l’afroamericano Walter Wallace.
Un altro
afroamericano ucciso dalla polizia. Ancora una volta si tratta di un uomo
afroamericano: il 27enne Walter Wallace è stato ucciso dalla polizia nella città
americana perché in possesso di un coltello, per strada. L’uomo è stato ferito
da diversi colpi di pistola partiti dai poliziotti, che gli hanno sparato perché
non aveva gettato l’arma. La morte dell’uomo ha provocato violente
proteste nella città di Filadelfia, dove 30 agenti sono rimasti feriti, 10
persone arrestate e diversi negozi saccheggiati, secondo il bilancio.
La sparatoria.
La sparatoria è avvenuta nella zona ovest di Filadelfia, più precisamente nel
quartiere di Cobbs Creek, a maggioranza afroamericana. Tanya Little, portavoce
della polizia, fornisce la sua versione dei fatti: gli agenti sono giunti a
seguito di una segnalazione di una persona con un’arma; una volta arrivati
avrebbero ordinato all’uomo di deporre il coltello, ma lui invece « è avanzato »
verso di loro e a quel punto entrambi gli agenti hanno sparato « diverse
volte ». Fortunatamente, non sono rimasti feriti né poliziotti né passanti.
Il padre della vittima, Walter Wallace Sr., ha affermato che il figlio era in
cura e aveva problemi di salute mentale.
Le proteste.
Secondo l’Inquirer, decine di manifestanti intonavano lo slogan « Black lives
matter ». Centinaia di persone hanno protestato a seguito dell’uccisione di
Wallace, e sono andate avanti fino alle prime ore di martedì 27 ottobre durante
le quali sono scoppiati scontri con la polizia.
Philadelphia, seconda notte di disordini dopo la morte di
Walter Wallace. Da "tgcom24.mediaset.it" il 28 ottobre
2020. Seconda notte di proteste e disordini a Philadelphia, dopo l'uccisione del
27enne afroamericano Walter Wallace da parte della polizia. Mentre un corteo ha
marciato pacificamente lungo le vie della città, in alcune zone si sono ripetute
scene di vandalismi e saccheggi di negozi. La polizia ha invitato i residenti di
sette distretti a restare in casa per il pericolo di violenze. Wallace è stato
ucciso dagli agenti mentre brandiva un coltello per strada. Diverse centinaia di
uomini della Guardia nazionale della Pennsylvania sono stati dispiegati a
sostegno delle forze dell'ordine su richiesta del governatore dello Stato, il
democratico Tom Wolf. La dirompente violenza delle proteste ha portato a un
ulteriore dispiegamento di agenti per tentare di arginare l'assalto da parte di
gruppi di vandali dei negozi lungo le vie della città. Nella prima serata di
disordini sono stati quasi cento gli arresti e una trentina i poliziotti feriti.
Wallace, un 27enne affetti da problemi psichici, è stato raggiunto da
diversi colpi di pistola di poliziotti che gli hanno sparato perché non aveva
gettato l'arma. Proteste anche a Washington per la morte di Karon Hylton, 20
anni, deceduto durante un inseguimento della polizia: il ragazzo stava guidando
un motorino elettrico senza casco quando è stato travolto da un’auto. Alcune
immagini mostrano una donna, identificata come la madre del ragazzo, che urla
davanti a una stazione della polizia. Secondo alcuni testimoni sarebbe stata
colpita dai gas lacrimogeni durante gli scontri esplosi subito dopo con la
polizia.
DAGONEWS il 28 ottobre 2020. Il giorno delle elezioni e quello
dopo, Rodeo Drive, la mecca del lusso a Beverly Hills, sarà chiusa alle auto e
ai pedoni. Una mossa preventiva voluta dal capo della polizia per il timore che
possano esserci scontri e che i negozi di lusso possano essere assaltati. Il
capo della polizia di Beverly Hills, Dominick Rivetti, ha detto che il suo
dipartimento entrerà in "allerta massima" e che le aziende potrebbero scegliere
di chiudere o limitare le attività. La polizia, infatti, ha incoraggiato alcune
aziende a chiudere i loro negozi di fascia alta visto che proprio quelle aree
sono state già teatro di proteste dopo la morte di George Floyd. «Con
l'avvicinarsi del giorno delle elezioni - ha detto Rivetti - e con la
possibilità dell’aumento delle proteste in tutta la regione, la città sta
adottando un approccio preventivo». Rodeo Drive sarà chiusa al traffico
veicolare e pedonale il 3 e 4 novembre.
Ecco chi sono i Patriot Prayer.
Roberto Vivaldelli il 4 settembre 2020 su Inside Over. Il nome dei Patriot
Prayer è salito all’onore delle cronache per via dei violenti scontri a Portland
con i manifestanti Antifa e Black Lives Matter che hanno portato alla morte, lo
scorso 31 agosto, di un sostenitore del presidente Usa Donald Trump. Come
riportato da Fox News, Patriot Prayer è la creazione dell’attivista conservatore
ed ex candidato al Senato di Washington Joey Gibson. L’uomo che è stato ucciso a
colpi di arma da fuoco a Portland nella schermaglia con i manifestanti Black
Lives Matter era un sostenitore di Patriot Prayer, gruppo che non ha grande
importanza a livello nazionale ma che è ben noto nel Pacifico nord-occidentale.
La vittima della sparatoria è stata identificata da Gibson come Aaron “Jay”
Danielson, di Portland, soprannominato Jay Bishop. Come sottolinea il Corriere
della Sera, Patriot Prayer è un’organizzazione ultra-conservatrice fondata nel
2016 dal trentaseienne Joey Gibson per sostenere Donald Trump e “liberare i
conservatori della Costa Ovest”. È spesso presentato come un gruppo nato a
Portland, in Oregon, dove è molto attivo. In realtà è originario di Vancouver,
nello stato di Washington, lo stesso da cui proviene il suo fondatore.
Marcatamente anti-cinese e anti-islamica, Patriot Prayer è un’organizzazione
anti-statale: le bandiere presenti alle loro manifestazioni sono quelle di
Gadsden, con il vessillo che ritrae il celebre serpente a sonagli su sfondo
giallo e la scritta Don’t tread on me, associata al libertarismo di destra.
"Non siamo suprematisti bianchi". Gibson rifiuta con veemenza
l’etichetta di “suprematisti bianchi” che molti affibbiano al suo gruppo.
“Fanculo i suprematisti bianchi! Fanculo i neonazisti!”, ha detto a un raduno
dell’agosto 2017 che ha organizzato a Seattle. “Non mi serve questo tipo di
pensiero. È sbagliato”. “Sono giapponese”, ha poi dichiarato a Fox News a
margine di una manifestazione tenutasi a San Francisco nell’agosto 2017 .
“Abbiamo tre oratori neri, una coppia ispanica, un ateo, un transessuale. Siamo
estremamente diversi. È davvero irresponsabile per i leader definirmi un
suprematista bianco. È completamente infondato”. “Abbiamo così tante persone che
stanno lavorando a sangue freddo nella costa occidentale per difendere la
libertà di parola in alcune delle città più oscure e intolleranti degli Stati
Uniti d’America” ha sottolineato nel corso di una manifestazione del settembre
2017 a Washington, a sostegno di Donald Trump. E ancora: “Ci sono così tante
cose in questo Paese e in questo momento da sistemare, dobbiamo svegliarci.
Troppi di noi stanno dormendo”. Nonostante le dichiarazioni del leader, nel
gruppo di sono infiltrati anche personaggi riconducibili ai suprematisti bianchi
o all’estremismo di destra, in generale.
Chi è Joey Gibson. Come riporta il sito ufficiale
dell’organizzazione, Joey Gibson si proclama “un sostenitore della libertà” che
crede “sia imperativo per i seguaci di Cristo portare la Chiesa nelle strade,
nei consigli comunali, al campidoglio, nei tribunali o ovunque vediamo
ingiustizie correre incontrastate”, compresa “Hong Kong,” . Gibson crede che
“rimanere in silenzio significhi esprimere consenso” e vive secondo il motto
“la ribellione ai tiranni è obbedienza a Dio “. Secondo il sito web di Patriot
Prayer, il suo fondatore “ha viaggiato per il Paese tenendo discorsi e
supplicando patrioti e credenti di difendersi ora perché crede che questa sia
“l’ultima possibilità”. Gibson, inoltre, “ha organizzato dozzine di marce e
manifestazioni a sostegno della libertà di parola, dei diritti sulle armi, per
la libertà sanitaria” . Ha partecipato “a numerose campagne a livello comunale
fino al livello federale e gestisce le pubbliche relazioni per diversi
sostenitori che lottano per la libertà”. I legami con la polizia Usa e la
vicinanza ai Proud Boys. Come sottolinea il Correre della Sera, secondo Sergio
Olmos, giornalista americano che ha dedicato mesi di studio ai Patriot Prayer,
il gruppo ha spesso tenuto stretti legami con la polizia malgrado fosse noto che
i suprematisti bianchi frequentavano i suoi raduni. Nel 2019, ci furono
centinaia di messaggini telefonici scambiati tra la polizia di Portalnd e Gibson
che mostrarono come insieme si coordinassero durante le proteste, anche con
“dritte” per evitare di essere arrestati. Un indagine interna valutò infine che
non c’era nessuna azione sbagliata da parte degli agenti che si erano scambiati
messaggi amicali con Gibson. Secondo Vegas Tenold, ricercatore investigativo per
il Center on Extremism dell’Anti-Defamation League’s Center, quella dei Patriot
Prayer “è un’ideologia è estremamente vaga. Sono cristiani, a favore del Primo
emendamento. Questa è l’unica cosa certa”, ha spiegato Tenold a Insider. “Ci
sono molti membri che militano anche nei Proud Boys”.”Ci sono molte persone che
erano con Joey Gibson che ora sono con i Proud Boys, e penso che viceversa”, ha
detto. Ma a differenza di Patriot Prayer, i Proud Boys vantano gruppi locali in
tutto il Paese che operano – per la maggior parte – indipendentemente l’uno
dall’altro, ha psservato Tenold. Patriot Prayer è un gruppo regionale molto più
piccolo. I membri dell’organizzazione di Gibson partecipano alla maggior parte
delle grandi manifestazioni dell’alt-right e spesso si scontrano con gli Antifa,
gli estremisti della sinistra radicale Usa.
Presenza fissa a Portland. Joey Gibson vive a Vancouver,
Washington, e ha definito Portland “disgustosa” e piena di “così tanta
oscurità”. Ha invitato i membri del suo gruppo e i suoi sostenitori ad essere
armati durante i raduni: “Tutti dovrebbero portare sempre con sé armi,
specialmente le persone nella nostra situazione”. Secondo Fox News, Il gruppo si
è radicato a Portland nell’estate del 2017, quando Gibson ha organizzato una
grande manifestazione in città meno di una settimana dopo che un suprematista
bianco ha pugnalato a morte due uomini che erano corsi in difesa di due
adolescenti neri su un treno. L’imputato, Jeremy Christian, condannato a due
ergastoli consecutivi all’inizio di quest’anno, aveva partecipato a una
manifestazione dei Patriot Prayer diversi mesi prima, sebbene fosse stato
espulso dagli organizzatori per aver mostrato simpatie naziste. Patriot Prayer
ha tenuto diverse altre marce e manifestazioni a Portland nel 2017 e nel 2018 e
Gibson è stato arrestato la scorsa estate per disordini scoppiati tra i
sostenitori del gruppo e gli attivisti di sinistra in un pub dopo una
manifestazione.
Chi si nasconde dietro le proteste Black lives matter.
"Siamo marxisti indottrinati". Dicono di combattere razzismo
e ingiustizie ma gli stessi fondatori proclamano di volere un futuro comunista
per gli Usa. Lorenza Formicola, Domenica 06/09/2020 su Il Giornale. «Siamo
anticapitalisti. Crediamo che i neri non otterranno mai la liberazione sotto
l'attuale sistema capitalista», scriveva il Movement for Black Lives (M4BL), a
giugno. Sullo sfondo le immagini, che hanno percorso avanti e indietro l'Oceano,
della ripartenza del campionato NBA nella «bolla» di Orlando (tutti in ginocchio
in onore del Black Lives Matter). Poi lo stop di gara 5, il 26 agosto, per il
caso Blake. Bizzarro che lo sport capitalista per eccellenza, fatto al 99% da
neri, dove gira più denaro che nel calcio europeo, celebri il movimento, per sua
stessa ammissione, più razzista, anti capitalista e comunista. «Abbiamo una
struttura ideologica. Alicia (Garza) e io siamo qualificate. Siamo marxisti
indottrinati», diceva a luglio Patrisse Cullors, cofondatrice del Black lives
matter (BLM) e «attivista queer». «Se questo Paese non ci dà ciò che vogliamo,
distruggeremo il sistema. Metaforicamente e in senso letterale». Il BLM viene
venduto come un movimento che combatte il razzismo e le ingiustizie, ma sono i
suoi stessi fondatori e discepoli a raccontarne l'anima marxista che sogna di
trasformare gli Stati Uniti e il mondo intero in una distopia comunista. Tra i
loro mentori ed educatori ci sono ex membri del Weather Underground, gruppo
terroristico comunista che, negli anni '60 e '70, tra attentati e rivolte, provò
a portare la falce e il martello negli USA al grido di «Siamo un'organizzazione
di guerriglia. Siamo comunisti, clandestini negli Usa». La Cullors è stata
educata da uno di loro. E tanti ex, oggi, sono eminenze grigie del movimento
BLM. Il BLM dice di odiare la famiglia naturale e sogna di riuscire ad abolirla,
insieme alla polizia, le prigioni, l'eteronormatività e il capitalismo. Lo
ripetono sempre nelle interviste disponibili anche su YouTube, quando minacciano
di «distruggere tutto» se le loro richieste non saranno soddisfatte. Oggi
addestrano gli iscritti, come le Black Panthers degli anni '60. Il guerrafondaio
movimento nasce dalla menzognera premessa che gli Stati Uniti sono «in guerra»
con gli afro-americani. Un mito dell'era Obama che, oltre a esser stato
sbugiardato dagli editoriali degli stessi giornaloni Usa, e che ignora la catena
di responsabilità tutte dem dei vari casi Floyd, è innamorato del vandalismo
iconoclasta. Secondo i dati del FBI, antecedenti l'omicidio Floyd, un nero ha 11
volte più probabilità di essere ucciso da un altro nero che da un bianco. Il BLM
non vanta neanche una delle verginità più in voga oggi, quella del fiscalmente
corretto. Non è registrato come organizzazione no-profit, raccoglie milioni di
dollari in donazioni, ma le finanze sono poco limpide. Le donazioni vengono
raccolte da ActBlue, la nota piattaforma di raccolta fondi legata al Partito
Democratico e alle cause più disparate della sinistra-sinistra: dalla campagna
presidenziale di Sanders alle associazioni transgender fino a Biden. In effetti,
i leader del BLM hanno confermato che l'ossessione fondamentale è quella di
rimuovere Trump. Il M4BL, che sostiene «leader giovani, neri, queer, trans,
femministe, clandestini», ha come sponsor fiscale l'Alliance for Global Justice,
un «gruppo anticapitalista» a sua volta finanziato dalla Tides Foundation, la
Arca Foundation e ovviamente dalla Open Society Foundations. E trasferisce
denaro a più di due dozzine di organizzazioni, tra cui LGBTQ Black Immigrant
Justice Project e The Undocumented and Black Convening. Il Black Lives Matter
nasce nel 2013, quando George Zimmerman, responsabile della vigilanza di
quartiere, veniva assolto dalle accuse di omicidio di un 17enne afroamericano.
Alicia Garza, un'afroamericana di Oakland, in California, pubblicò su Facebook
«una lettera d'amore alle persone nere». La Cullors, afroamericana di Los
Angeles, ripubblicò la lettera con l'hashtag #BlackLivesMatter. Il resto è una
storia lunga sette anni dove la causa dell'antirazzismo è diventata marginale e
le istanze sempre più estremiste: ideologia gender, agenda anti-famiglia, l'idea
che il razzismo sia sistemico, l'abolizione di razze, classi sociali, sessi,
religioni per un mondo più «uguale e libero». Uno studio accademico intitolato
«The Queering of Black Lives Matter», descrive in modo molto dettagliato come le
questioni relative all'orientamento di genere abbiano la priorità sulla lotta al
razzismo. C'è un'enfasi tale sull'omosessualismo che già nel 2016 un lunghissimo
pezzo sul NewYorker si domandava se il BLM fosse «un movimento gay che si
maschera da movimento nero». Tante pizzerie negli Usa oggi sottolineano che il
20% del conto andrà al BLM. E sarà pure un modo per farsi pubblicità, ma,
intanto, potrebbero, sempre sul retro del cartone, raccontare anche la storia di
Susan Rosenberg, la donna che ne gestisce le donazioni e che ieri giocava a fare
la terrorista nel M19 - l'organizzazione comunista Usa che, come il BLM, riuniva
lesbiche nel sogno di rovesciare con la lotta armata il governo. La Rosenberg
oltre a far scappare di galera la Shakur - la prima donna a essere definita dal
FBI «la più pericolosa dei terroristi» -, è stata protagonista di attentati e
omicidi che le sono costati la condanna a 58 anni di galera. Ma ne ha scontati
solo 16, prima di essere graziata da Bill Clinton. Il pallino del razzismo,
però, resta. La co-fondatrice di BLM Toronto, Yusra Khogali, infatti sosteneva
già quattro anni fa che «i bianchi non sono esseri umani, ma subumani con un
difetto genetico recessivo». A una manifestazione del BLM di Filadelfia è stata
interdetta la partecipazione dei «non neri». I leader del BLM affermano che la
loro organizzazione si oppone alla tradizione cristiana, è anti semita e anti
israeliana, pratica stregoneria, lotta per abbattere le statue di Gesù perché
bianco e sostiene l'aborto. Evidentemente non tutte le vite nere contano.
Il paradosso del Black Lives Matter.
Andrea Massardo su Inside Over il 24 agosto 2020. Ha fatto
scalpore nel Regno Unito la vicenda attorno a Kenya Scarlett, una donna
britannica impiegata al G4S – uno dei più grandi centri di test anti-Covid del
Paese – che ha denunciato alla stampa il suo licenziamento, a suo dire causato
da atteggiamenti razzisti all’interno dell’azienda sanitaria. Come riportato dal
quotidiano britannico The Guardian, secondo Scarlett tutto sarebbe nato da un
episodio dello scorso giugno, quando durante le fotografie ricordo del team nel
quale operava il personale si sarebbe opposto alle sue richieste di posare con
il saluto “nero” del BLM. A seguito di ciò, le sarebbe stato emesso un richiamo
– mai consegnatole – che si è trasformato in licenziamento dopo una discussione
con uno dei manager della società. E questo accadimento – contestualizzato
all’interno di quanto sta succedendo anche sul piano internazionale – avrebbe
generato ancora una volta lo sdegno da parte dell’opinione pubblica britannica.
Tuttavia, secondo la ricostruzione fatta sino a questo momento dal The
Guardian i fatti potrebbero essersi svolti diversamente da quanto affermato
dalla donna – non unica persona di razza mista operante all’interno della
struttura. E in modo particolare, il licenziamento avrebbe fatto seguito a
episodi multipli di insubordinazione portati avanti nei mesi e che si sarebbero
conclusi con pesanti insulti nei confronti della dirigenza aziendale durante
l’ultimo giorno di lavoro, a seguito del quale abbandonò il posto d’impiego.
“Al G4S non si licenzia per razzismo”. Secondo quanto riferito
dagli ex colleghi di Scarlett e dai dirigenti della società, nessuno avrebbe mai
mosso critica alcuna nei confronti delle opinioni politiche della donna, anche
quando sono state portate avanti in modo particolarmente vigoroso. E in modo
particolare, il richiamo a seguito dell’episodio legato alla foto di gruppo era
dovuto non alla richiesta della donna – sul quale i manager non hanno posto
obiezioni – bensì sul battibecco nato dopo il rifiuto di una parte del personale
di inginocchiarsi con il pugno alzato e che avrebbe fatto infuriare Scarlett. A
seguito dell’episodio e del richiamo, la donna sarebbe stata infatti chiamata a
spiegare la sua posizione, con la dirigenza che ha sottolineato anche in
quell’episodio come le richieste della donna fossero legittime e condivisibili e
che il richiamo fosse causato invece dalla violenza verbale da lei utilizzata. E
per quanto riguarda il licenziamento, invece, sarebbe stato dovuto alle parole
forti – condite da bestemmie e insulti per personale e struttura – utilizzate
nel dialogo verbale con un dirigente societario. Come detto infatti dallo stesso
direttore della struttura, Martin Hall, e non confutato dal personale, il
razzismo non sarebbe minimamente ala base del licenziamento della donna – come
provato dall’ambiente multietnico del G4S. E nonostante Scarlett si sia detta
disposta a perseguire la società anche tramite vie legali, non ci sarebbero
preoccupazioni da parte dell’istituto: il licenziamento, infatti, sarebbe dovuto
esclusivamente all’ennesima scenata in pubblico fatta dalla donna.
Il paradosso del BLM. Dopo l’episodio della morte del cittadino
americano George Floyd il mondo ha visto la rinascita dei movimenti neri che
avevano segnato la seconda metà del secolo scorso, soprattutto nei territori di
lingua anglofona. Da quel momento in avanti, sono state molteplici le accuse di
razzismo dirette ai politici, ai dirigenti societari e in generale alle persone
poste in posizioni di potere, non diversamente da quanto successo anni fa con il
movimento #MeToo per i diritti delle donne. Ma dietro a queste accuse – come
successo anche in quell’occasione -non sempre si celano reali comportamenti
razzisti, quanto più l’odio ed il disprezzo per un determinato stile di vita
sociale tipico della popolazione bianca anglofona. È in questo modo dunque che
un licenziamento altro non può essere che un comportamento razzista, così come
un arresto o così come la risposta delle forze dell’ordine a seguito di attacchi
dei manifestanti compiuti con ordigni molotov. Ogni comportamento tenuto dal
forte – anche se giustificato e in sé corretto – diviene razzista, spostando
ancora una volta l’attenzione verso una crisi sociale che, invece di migliorare,
sembra peggiorare sempre di più. E in questa situazione, in conclusione, nasce
quello che sarà uno dei più grandi paradossi di questo secolo e che rischia di
mettere troppe volte il “furbo” dalla parte della “vittima” e la “vittima” dalla
parte del “colpevole”.
Il BLM è un attacco alle tradizioni? Come evidenziato anche dal
fatto recentemente accaduto in Gran Bretagna, il movimento del BLM – al quale la
donna aderiva, venendo intervistata dallo stesso Guardian gli scorsi mesi – si è
trasformato da denuncia delle ingiustizie ad attacco nei confronti della cultura
occidentale. In particolare, è diventato una critica di quelle figure e di
quegli stili di vita propri della popolazione bianca europea ed americana – come
accaduto nel caso del G4S. È un attacco ai successi personali ed ai valori
tradizionali, portato avanti purtroppo sotto lo sguardo ed il compiacimento
anche di molti esponenti politici – principalmente appartenenti al mondo
progressista. Ma in tutto questo, però, che cosa é legittimo se ad essere
accusate sono persone che non hanno infranto regolamento alcuno ed hanno
semplicemente esercitato quelli che che sono i propri diritti (come licenziare
un membro insubordinato del personale, indipendentemente dal suo colore della
pelle)? In questa situazione, però, tutto potrebbe diventare il cerino pronto a
far scoppiare una nuova ondata di proteste, facendo leva su quella che è
soltanto una delle tante sfaccettature – e versioni – di una vicenda ben più
articolata. Una situazione la quale, però, rientra all’interno delle logiche di
paura e di continua pressione sociale tanto cara alle sinistre e che combinata
alle difficoltà economiche odierne contribuisce a creare il clima di
“terrore” sul quale si fonda la propaganda progressista del XXI secolo.
Così brucia la società occidentale.
Il virus dell'odio, ma anche il conformismo e il politicamente corretto. Ecco i
mali della società americana che ancora oggi si scopre vittima di divisioni che
non ha mai saputo superare. Matteo Carnieletto e Andrea Indini, Domenica
06/09/2020 su Il Giornale. Lo scontro, negli Stati Uniti, è razziale, non è
politico. O meglio: è uno scontro atavico, tanto antico da essere intriso nelle
viscere di ogni cittadino, da condizionare la politica e a tracimare nello
scontro tra repubblicani e democratici. In Questa strana e incontenibile
stagione (Sur), scritto e pubblicato in piena pandemia, Zadie Smith centra
appieno il problema puntando il dito contro il virus che sta appestando gli
Stati Uniti, ovvero quello del disprezzo che spinge "chi guarda la siepe del
proprio giardino" a vedere "un popolo di appestati: appestati dalla povertà,
prima e più di ogni altra cosa". Un virus che "si annida saldamente sia nei
cuori dei repubblicani che dei democratici". La differenza è che questi ultimi
stanno usando politicamente questo problema per avvelenare la campagna
elettorale per le presidenziali di novembre. "Se il virus e le disuguaglianze
che crea dovessero mai lasciarci, negli Stati Uniti certi eccessi si
attenuerebbero - spiega la scrittrice inglese - non scomparirebbe del tutto
(nessun paese sulla faccia della terra può sostenere di non averne) ma certe
cose non verrebbero più considerate normali".
Un male che nasce da lontano. "I cant't breath". L'urlo strozzato
in gola, gli occhi fuori dalle orbite e quelle immagine rimandate in loop come
un disco incantato. È morto così George Floyd, all'incrocio tra la 38ª e la
Chicago Avenue a Minneapolis. È morto soffocato, sotto il peso di un
poliziotto. "Non riesco a respirare, per favore - urlava - il ginocchio al
collo, non riesco a respirare". Era il 25 maggio e il presidente Donald Trump si
trovava invischiato nella peggiore emergenza sanitaria dell'ultimo secolo. Non
poteva sapere che da lì a poco avrebbe dovuto gestire un'altra emergenza, ben
più lacerante. Non appena l'Hennepin County Medical Center, l'ospedale dove
l'afroamericano venne trasportato d'urgenza dopo aver perso conoscenza, ne
decretò il decesso e le immagini dell'arresto iniziarono a essere condivise sui
social e a fare il giro del mondo, proteste e tumulti dilagarono in tutto il
Paese. Adesso è una guerra fratricida. In strada i militanti dei Black lives
matter e degli Antifa si confondono tra i manifestanti anti Trump così come la
destra più estrema e radicale rimpolpa i cortei a sostegno del tycoon. E il
sangue non smette di scorrere. Lo scorso 29 luglio, a Portland, un supporter del
presidente, il 39enne Aaron J. Danielson, è stato ammazzato con un colpo sparato
a bruciapelo. È l'odio di un popolo che sembra non conoscere requie e che, con
l'effetto ciclico di un'onda, si trova ad esserne nuovamente invischiato. È lo
stesso odio di cui parla, per esempio, James Ellroy nel suo ultimo, bellissimo
romanzo, Questa tempesta (Einaudi). Forte della convizione che, come ebbe a
dire Benito Mussolini, "solo il sangue muove le ruote della storia" (parole
riportate dall'autore stesso in testa al libro), l'opera, che
dopo Perfidia (Einaudi) è il secondo capitolo della nuova tetralogia di Los
Angeles, getta il lettore in un girone buio quando, all'indomani dell'attacco a
Pearl Harbor, gli Stati Uniti si sono scoperti più deboli e hanno dato il via ai
violentissimi rastrellamenti contro i cittadini giapponesi (da lì alla fine del
conflitto ne verranno arrestati ben 100mila). Sono settimane incandescenti dove
l'odio dilaga nelle strade e colpisce qualsiasi etnia. È una guerra per bande
che non risparmia nessuno. Ellroy è bravissimo a descriverle, senza fare sconti
a nessuno, una giungla d'odio e violenza in cui si muovo sanguinari
simpatizzanti del führer, incendiari comunisti che sognano il trionfo di Stalin,
sinarquisti messicani che brigano contro il presidente Roosvelt. E ancora: il
rancore dei bianchi contro gli afro, gli scontri tra la comunità cinese e quella
giapponese, il traffico dei clandestini dal Centro America. Con sfumature molto
diverse, certe scene raccontate dall'autore di American Tabloid e LA
Confidential riecheggiano le violenze che vediamo sui media in questi mesi.
Un'America profondamente divisa. In una intervista rilasciata
a Vice nel 2010, quando aveva appena dato alle stampe Caccia alle
donne (Bompiani), Ellroy aveva fatto un'analisi disincantata di se stesso e di
quello che, visto nello specchio del politicamente corretto, non deve
esistere. "Sono un americano religioso, eterosessuale di destra, sembra quasi
che sia nato in un'altra epoca. (...) Sono un cristiano nazionalista,
militarista e capitalista", ha ammesso sapendo che tutto questo gli ha spesso
creato problemi. "La gente pensa che queste mie posizioni siano choccanti - ha
tagliato corto - non sento il bisogno di giustificare le mie opinioni". Non per
tutti è così. Perché se da una parte, come sottolineato da Zadie Smith,
l'America è dilaniata dal virus del disprezzo, dall'altra rischia di essere
fagocitata da un altro virus: quello della censura imposta dal politically
correct. E qui veniamo a un altro romanzo Tanti piccoli fuochi di Celeste Ng
(Bollati Boringhieri). Pubblicato nel 2017 torna ora negli scaffali delle
librerie grazie alla fortunata serie televisiva interpretata dalle bravissime
Reese Witherspoon e Kerry Washington e distribuita dai primi di giugno da
Amazon. Facciamo un salto alla fine degli anni Novanta, quando il mito
dell'America riplende ancora (a torto o a ragione) in tutto il mondo. Siamo alle
porte di Cleveland. Shaker Heights è un quartiere chiuso dove vive l'upper
class democratica. Famiglie da cartolina, buoniste, impegnate nel sociale,
devote alle regole che si sono date per mandare avanti la propria comunità e
proteggerla dai propri mali. Elena Richardson ne è l'emblema: bianca, ricca,
redattrice del quotidiano locale, moglie di uno stimato avvocato, madre di
quattro figli (due maschi e due femmine, of course) e vittima nonché artefice di
quelle stesse diaboliche correzioni stigmatizzate da Jonathan Franzen vent'anni
fa. Sull'altro lato della strada c'è la sua antitesi: Mia Warren è una madre
single, nera, artista a tempo perso che si mantiene facendo lavori saltuari e
soprattutto senza fissa dimora. Quando i due mondi si incontrano, la Richardson
non può che dimostrarsi caritatevole perché lei, da giovane, ha "marciato con il
dottor King" e ha difeso i diritti delle donne. Così, prima le offre un
contratto d'affitto stracciato, poi le dà un lavoro. Ed è qui che si infrange
il conformismo dem facendo divampare tanti piccoli fuochi che finiranno per dare
alle fiamme l'intera dimora dei Richardson.
Il rischio americano. Shaker Heights è un topos. Il paradigma di
un'America dilaniata che continua a lottare contro se stessa. Gli effetti sono
"drogati" da una visione di parte: una lettura buonista che non fa sconti alla
borghesia bianca ma che la condanna a prescindere. Così, sebbene Mia Worren
abbia cresciuto la figlia per strada, Pearl è l'unica responsabile e fa
impallidire i quattro figli di Elena. Allo stesso modo gli errori di Mia
vengono, in un certo qual modo, scusati dalle circostanze mentre quelli di Elena
costantemente condannati. Non che quest'ultima non sia da biasimare (in
primis l'incapacità di accogliere le scelte della quarta figlia). Eppure... per
tutto il romanzo si fa portatrice di alcuni valori che la società
occidentale dovrebbe continuare a difendere e che, invece, i sensi di colpa dei
democratici continuano a cedere in uno scontro che, anno dopo anno, non sta
portando da nessuna parte se non a indebolire tutti quanti. Per la Smith, per
esempio, la domanda che gli Stati Uniti dovrebbero porsi è la seguente: "Esiste
un desiderio abbastanza forte di un'America diversa?". Perché questo avvenga, a
suo dire, la classe dirigente deve prendere coscienza del fatto che "il virus
non infetta solo gli individui di intere strutture di potere", ma piega "tutte
le persone economicamente sfruttate, a prescindere dalla razza". In realtà,
quello che manca agli Stati Uniti (e di riflesso a Shaker Heights) è la capacità
di unire i cittadini, indipendentemente dal colore della pelle, in vista di un
obiettivo comune e condiviso. È quello che hanno fatto tutti gli imperi, da
quello romano a quello britannico, e che ha ben descritto Rutilio Namaziano nel
suo Ritorno: "Desti una patria ai popoli / dispersi in cento luoghi: / furon
ventura ai barbari / le tue vittorie e i gioghi: / ché del tuo dritto ai sudditi
/ mentre il consorzio appresti, / di tutto il mondo una città facesti".
Questo vulnus, questa ferita, si riaffaccia non appena appaiono nuove
difficoltà. Le strade distrutte ed incendiate degli ultimi mesi lo rappresentano
plasticamente. Tanti piccoli fuochi, che da decenni bruciano un impero
dimezzato.
Gli ultimi otto minuti di George Floyd e la versione della
polizia: “Incidente medico”. Redazione su Il
Riformista il 28 Maggio 2020. Ha tenuto il ginocchio sul collo di George Floyd,
46enne afroamericano, per oltre otto minuti, incurante dei ripetuti appelli
dell’uomo che faticava a respirare e che poco dopo ha smesso di parlare e
muoversi. Contro l’agente Derek Chauvin, 44enne (da 19 in servizio) licenziato
insieme ad altri tre colleghi della polizia di Minneapolis, l’America è scesa in
piazza per il secondo giorno di fila ripetendo più volte le ultime parole del
46enne afroamericano (“I cant’t breathe”). Forti tensioni si sono registrate sia
davanti al commissariato di polizia che all’esterno della casa dell’agente
stesso, che ora potrebbe essere accusato di omicidio. Questo l’auspicio del
sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, che dopo aver visto il video, che ha fatto
il giro del mondo, ha dichiarato di non aver visto nulla per giustificare quel
tifo di forza utilizzata dall’agente Chauvin. “Non riesco a respirare, non
uccidermi” l’appello di Floyd, arrestato lunedì sera (25 maggio) dai poliziotti
al 3700 di Chicago Avenue South perché “appariva sotto gli effetti di droga”.
L’uomo è finito a terra, con la testa contro il marciapiede e il ginocchio del
poliziotto a fare pressione sul collo, perché avrebbe “opposto resistenza”. La
drammatica scena è stata ripresa dai cellulari di alcuni presenti che hanno così
smentito la ridicola versione della polizia di Minneapolis che attraverso un
portavoce ha provato ad archiviare in un primo momento la vicenda come
“incidente medico“.
LE PROTESTE – Da due giorni vanno avanti le protesta a
Minneapolis così come, soprattutto via social, in tutto il Paese. Lanci di sassi
e di bottiglie contro la polizia e alcuni negozi saccheggiati. Questo il
bilancio della seconda giornata di manifestazioni contro le violenze utilizzate
dalle forze dell’ordine. Numerosi manifestanti si sono scontrati con la polizia
a Minneapolis, negli Stati Uniti dopo la morte di un uomo afroamericano mentre
veniva arrestato dagli agenti di polizia. George Floyd è morto soffocato: uno
dei poliziotti ha premuto il ginocchio sul collo dell’uomo, che sosteneva di non
essere in grado di respirare, per bloccarlo a terra. Quattro agenti di polizia
coinvolti nell’arresto sono stati licenziati e il sindaco di Minneapolis si è
scusato con la comunità nera della città. Mentre i video dell’episodio sono
diventati virali sui social media, i manifestanti si sono radunati sul luogo
dell’incidente, quindi hanno marciato verso una stazione di polizia dove hanno
danneggiato alcune finestre e un’auto. I militari, in tenuta antisommossa, hanno
usato gas lacrimogeni per sedare la protesta.
TRUMP E BIDEN – Il presidente Donald Trump assicura giustizia.
“Su mia richiesta, l’Fbi e il dipartimento di Giustizia stanno indagando su
questa tragica morte in Minnesota di George Floyd”, ha dichiarato il tycoon,
segnalando di aver chiesto di accelerare le indagini. “George Floyd meritava di
meglio e la sua famiglia merita giustizia. La sua vita contava. Sono grato per
l’azione rapida a Minneapolis per licenziare gli agenti coinvolti, devono essere
ritenuti responsabili delle loro terribili azioni. L’Fbi dovrebbe condurre
un’indagine approfondita”. Così su Twitter il candidato democratico alle
primarie Joe Biden dopo la morte dell’afroamericano a Minneapolis, soffocato per
il fermo di un poliziotto, che ha scatenato un’ondata di proteste e shock in
tutto il Paese. NBA – “George Floyd è stato chiaramente assassinato da un
ufficiale di polizia di Minneapolis. Quante volte dobbiamo vedere uomini neri
uccisi alla televisione nazionale? Questo succede da troppo tempo. Dobbiamo
iniziare a vedere le persone di colore come esseri umani e non come animali”.
Questo il duro post sul suo profilo Twitter dell’ex campione della Nba, Magic
Johnson, in riferimento alla morte di un afroamericano deceduto dopo essere
stato fermato e bloccato da alcuni agenti di polizia a Minneapolis. Sulla stessa
lunghezza d’onda anche LeBron James che su Instagram nelle scorse ore ha
pubblicato una foto in cui indossa una maglia con la scritta “Non posso
respirare”.
La famiglia chiede esami indipendenti.
“George Floyd non è morto per asfissia”: l’autopsia che fa
discutere. Redazione su Il Riformista il 30 Maggio 2020. George Floyd non è
morto per asfissia traumatica o per strangolamento. È il risultato dell’autopsia
del medico legale della contea di Heppepin sul corpo del 46enne afroamericano
ucciso dopo un violento intervento del poliziotto Derek Chauvin che per quasi
nove minuti ha premuto il ginocchio sul suo collo. Il caso è avvenuto a
Minneapolis, nello Stato del Minnesota, e ha causato un imponente movimento di
protesta in tutto il Paese. Secondo il patologo responsabile dell’asfissia, la
morte dell’uomo sarebbe sopravvenuta a seguito di una serie di fattori
combinati. L’intervento dell’agente Derek Chauvin è solo uno di questi insieme
con patologie pregresse e una potenziale sostanza intossicante nel
corpo. L’esito ha suscitato numerose critiche e scandalo. La famiglia della
vittima ha chiesto di avere una autopsia indipendente. I parenti di Floyd non si
fidano, come riportato dall’avvocato, delle autorità di Minneapolis. Chauvin è
stato arrestato ieri per omicidio colposo, secondo Bloomberg. Secondo il
vicepresidente del consiglio comunale della città, Andrea Jenkins, i due si
conoscevano: avrebbero lavorato insieme in un locale come addetti alla
sicurezza. L’indiscrezione avrebbe trovato conferme in altre fonti. In piazza
migliaia di persone in tutti gli Stati Uniti. Nuove manifestazioni si terranno
nel week end. Un’altra vittima, dopo la prima a Minneapolis, si è verificata a
Detroit. Tensioni anche nei pressi della Casa Bianca, dov’era scattato
il lockdown, e ad Atlanta, alla sede dell’emittente televisiva Cnn. Ieri una
troupe del canale era stata arrestata (poi subito rilasciata) in diretta mentre
documentava le tensioni a Minneapolis. Un episodio che aveva causato scandalo in
tutto il mondo. Di nuovo in strada il movimento Black Lives Matter, nato nel
2017 dopo che un vigilante aveva ucciso il 17enne disarmato Trayvon Martin. Il
presidente americano, Donald Trump, ha comunicato di aver parlato con la
famiglia di George Floyd. “Ho parlato con i membri della famiglia, persone
fantastiche”, ha affermato. Il tycoon era stato criticato per precedenti
commenti su Twitter in cui attaccava i manifestanti.
Morte Floyd, l'autopsia ufficiale conferma: "E' stato un
omicidio". Pubblicato lunedì, 01 giugno 2020 da La
Repubblica.it. Il medico legale che ha effettuato l'autopsia sul corpo di George
Floyd ha affermato che il 46enne afroamericano è morto per "un arresto cardiaco
causato dalla pressione esercitata sul suo collo" dai poliziotti che lo avevano
fermato. Dunque si è trattato di un "omicidio". In un rapporto preliminare si
escludeva che questa fosse la causa della sua morte. Per il settimo giorno di
seguito migliaia di americani, sfidando il coprifuoco, sono scesi in strada in
diverse città americane per protestare per la morte di George Floyd. A
Washington la folla si è di nuovo radunata davanti alla Casa Bianca blindata. La
polizia ha sparato gas lacrimogeni contro i manifestanti. L'obiettivo è sembrato
quello di disperdere la folla in vista del discorso che il presidente Donald
Trump terrà tra poco nel giardino delle Rose della Casa Bianca. Lunghi cortei si
stanno snodando a New York, Philadelphia, Atlanta. Per Washington Dc, intanto, è
stato chiesto un rinforzo compreso tra 600 e 800 uomini delle Guardie Nazionali
da cinque Stati. Lo rende noto il Pentagono precisando che serviranno a
contenere le "proteste civili" per la morte di Flyod.
Licenziato il capo della polizia di Louisville.
“George Floyd asfissiato per compressione del collo”: l’esito
dell’autopsia indipendente. Redazione de Il Riformista l'1 Giugno 2020.
Asfissiato per compressione del collo e della schiena. È l’esito che recita
l’autopsia indipendente chiesta dalla famiglia di George Floyd, l’afroamericano
di 46 anni ucciso dopo l’intervento violento della polizia a Minneapolis, nello
Stato del Minnesota, e dell’agente George Chauvin, licenziato e arrestato con
l’accusa di omicidio di terzo grado. Il risultato è stato reso noto dai legali
della famiglia e della vittima che aveva chiesto esami indipendenti dopo che la
prima autopsia aveva dato risultati opposti. “L’autopsia mostra come Floyd non
avesse nessun problema di salute che abbia causato o contribuito alla sua
morte”, ha dichiarato uno degli avvocati. “Non ci sono elementi fisici che
supportano una diagnosi di asfissia traumatica o di strangolamento – si leggeva
nel precedente referto medico – Gli effetti combinati dell’essere bloccato dalla
polizia,delle sue patologie pregresse (coronaropatia e ipertensione, ndr) e di
qualche potenziale sostanza intossicante nel suo corpo hanno probabilmente
contribuito alla sua morte”. Tale referto aveva scatenato ulteriormente la
rabbia dei manifestanti e in particolare della popolazione afroamericana. Nel
video, girato da un testimone, della morte di Floyd si vede il poliziotto
premere per quasi nove minuti con il ginocchio contro il collo, immobilizzando
l’uomo al suolo. “I can’t breathe“, la frase pronunciata dalla vittima negli
ultimi momenti di vita e diventata ormai simbolica. Intanto gli Stati Uniti si
preparano alla settima notte di scontri. Sono almeno 40 le città che hanno
dichiarato il coprifuoco. Molte hanno chiesto l’intervento della Guardia
Nazionale. Le proteste scatenate dalla morte di Floyd si sono allargate in tutto
il Paese. Quattro i morti fino a questo momento. Diverse aggressioni, da parte
delle forze di polizia, anche ai danni dei giornalisti. Forze dell’ordine, in
alcuni casi, hanno solidarizzato con i manifestanti dicendo: “Non siamo tutti
uguali”. Alta tensione anche a Washington, dove alcuni manifestanti si sono
pericolosamente avvicinati alla Casa Bianca. Il Presidente Donald Trump si
sarebbe rifugiato nelle scorse ore in un bunker nel palazzo presidenziale. Nelle
ultime ore avrebbe sollecitato le forze dell’ordine a impiegare le maniere forti
contro le proteste – come aveva già fatto nei giorni scorsi. Secondo alcuni
osservatori si tratta degli scontri più estesi e gravi da quelli esplosi nel
1968, quando a Memphis venne assassinato il leader e attivista afroamericano,
Martin Luther King Jr.
George Floyd aveva il Coronavirus: il risultato dell’autopsia.
Antonino Paviglianiti il 04/06/2020 su Notizie.it.
George Floyd è risultato positivo (asintomatico) al Coronavirus: lo rivela il
risultato dell'autopsia. L’autopsia sul corpo di George Floyd evidenzia che
l’uomo rimasto vittima di un’aggressione da parte della polizia era positivo
al Coronavirus. A rivelarlo è l’esame autoptico ufficiale, quello condotto dal
personale medico della contea Hennepin. Ma non è stato il Covid-19 a contribuire
alla sua morte, si segnala nel referto medico: George Floyd era infatti
asintomatico. Intanto, continuano le proteste negli Stati Uniti anche nella
notte del 4 giugno, nonostante non si segnalino notizie di violenza e
saccheggi. Sono, però, novanta le persone arrestate a New York. Resta alta la
soglia dell’attenzione, mentre è ormai scontro aperto tra Donald Trump e il
Pentagono. Secondo i medici, la positività al Coronavirus non avrebbe
contribuito al decesso del 46enne assassinato da Derek Chauvin che ha tenuto il
proprio ginocchio sul collo della vittima per più di cinque minuti. La morte di
Floyd ha portato ad accese e violente proteste in tutti gli Stati Uniti,
ma scontri si sono registrati anche nel resto del mondo (tra cui Parigi). La
sommossa popolare ha trovato l’appoggio anche di Barack Obama. L’ex presidente
americano, predecessore del Tycoon, ha evidenziato come queste proteste possono
far risvegliare l’anima del Paese sopito ormai da troppo tempo: “È tempo di
cambiamenti – ha dichiarato l’ex inquilino della Casa Bianca – io sono con voi e
appoggio le vostre ragioni”. Intanto, però, le proteste Usa causano anche morti.
Il bilancio delle vittime si è aggravato nelle ultime ore con la conferma, da
parte della polizia di San Francisco, dell’uccisione – per errore – di un
ragazzo di 22 anni. Un poliziotto, infatti, ha freddato il giovane con cinque
colpi di pistola poiché pensava fosse armato. In realtà, il ragazzo aveva vicino
a sé un martello ma era inerme.
Simone Pierini per "leggo.it" il 4 giugno 2020. George Floyd,
morto nel corso di un arresto a Minneapolis lunedì scorso, era positivo al
coronavirus. È quanto emerso dalla nuova autopsia condotta sul corpo dell'uomo,
riferisce la Cnn, secondo cui il tampone nasale condotto post mortem è
risultato «positivo al Covid19». Il medico legale Andrew Baker ha spiegato che
questo tipo di test condotto in sede di autopsia può rilevare la positività
anche «settimane dopo l'insorgere della malattia e la sua risoluzione». In ogni
caso, ha sottolineato, «il risultato dell'autopsia riflette una positività
asintomatica ma persistente» che non ha avuto alcun ruolo nella morte
di Floyd. Nel frattempo almeno 90 persone sono state arrestate nella notte a New
York durante le nuove proteste. Il capo del dipartimento della polizia della
città, Terrance Monahan, ha riferito che la situazione ieri sera è stata
relativamente tranquilla e che non si sono registrati saccheggi. La notte
precedente gli arresti erano stati 280. Peggio è andato a New Orleans
con lacrimogeni contro i manifestanti e arresti ad Atlanta. A New Orleans, in
Louisiana, la polizia è ricorsa ai lacrimogeni per disperdere i manifestanti
accusati di non aver rispettato «l'ordine di non tentare di attraversare la
Crescent City Connection», il ponte sul Mississippi. «Escalation e confronto
fanno male a tutti noi», si legge in un tweet del New Orleans Police Department
(Nopd). La polizia di Atlanta, in Georgia, ha invece confermato l'arresto di 43
persone fermate durante le proteste di ieri, che qui sono comunque state per lo
più pacifiche dopo giorni di tensione alle stelle e violenze. Sono almeno 200
invece le unità della Guardia nazionale mobilitate nella contea di San Diego, in
California, su richiesta dello sceriffo Bill Gore. «Sosterranno le forze di
sicurezza locali per evitare atti di vandalismo - si legge in un tweet del
Dipartimento dello sceriffo della contea di San Diego - Contribuiranno a
proteggere le nostre comunità garantendo al contempo il diritto di tutti a
protestare». «Lavoreranno - spiega un altro tweet - al fianco delle forze
dell'ordine per garantire, durante le proteste, la sicurezza di infrastrutture
cruciali (edifici pubblici, tribunali, reti elettriche..) per evitare saccheggi
e incendi». Le proteste che dilagano negli Stati Uniti dalla morte
dell'afroamericano George Floyd, durante un fermo di polizia a Minneapolis, sono
un'occasione per un «risveglio» politico, per «cambiare l'America», nonostante
il momento «tragico» e «incerto». Così l'ex presidente Barack Obama, che ha
chiesto «a ogni sindaco di questo Paese» di riformare la polizia e che, nelle
prime dichiarazioni dall'inizio delle proteste, ha parlato direttamente agli
afroamericani: «Le vostre vite contano», ha detto. Queste giornate, ha
affermato, «offrono un'opportunità per lavorare tutti insieme», per «cambiare
l'America e portarla all'altezza dei suoi ideali». «Voglio che sappiate che voi
contate - ha detto l'ex presidente nel discorso in streaming durante un evento
organizzato dalla My Brother's Keeper Alliance, un programma della Obama
Foundation - Voglio che sappiate che le vostre vite contano, che i vostri sogni
contano». Obama ha parlato «direttamente ai giovani e alle giovani di colore in
questo Paese che - ha proseguito - hanno assistito a troppa violenza, e troppo
spesso parte di questa violenza viene da persone che avrebbero dovuto servirli e
proteggerli». Ai manifestanti pacifici ha ricordato che hanno «il potere di
cambiare le cose».
Da "lastampa.it" il 4 giugno 2020. Un video straziante di George
Floyd è apparso online mercoledì su Twitter. Nella clip non datata, il 46enne
ucciso a Minneapolis, incoraggia le giovani generazioni a porre fine alla
violenza armata. Il breve video è finito sui social mentre i manifestanti sono
scesi ancora per le strade di Minneapolis chiedendo l'arresto dei
poliziotti coinvolti nella sua morte. L'uomo si rivolge direttamente alla
telecamera chiedendo ai ragazzi di "tornare a casa" e smettere di usare le armi
citando all'inizio della clip la morte del figlio di un'amica probabilmente
ucciso in un conflitto armato.
La figlia di Floyd commuove l’America: “Mi manca, giocava
sempre con me”. Il Dubbio il 3 giugno 2020. La
piccola di sei anni intervistata con la madre che spiega: “Non le ho detto come
è morto…” “Mio papà mi manca, giocava sempre con me e da grande vorrei diventare
un medico per aiutare gli altri”. Sono le parole di Gianna, la figlia di sei
anni di George Floyd, intervistata assieme alla madre su Abc News. “Non sono
ancora riuscita a dirle cosa è successo. Le ho solo detto che suo padre è morto
perché non poteva respirare”, ha dichiarato la mamma, Roxie Washington. Intanto
il premier inglese Boris Johnson ha rotto oggi il silenzio del governo Tory
britannico sulla morte di George Floyd, condannando l’episodio avvenuto a
Minneapolis e allo stesso tempo difendendo il diritto alla protesta, purché in
forme pacifiche: negli Usa come nel Regno Unito, dove qualche migliaio di
persone è tornato radunarsi in queste ore a Londra. Alcuni enti della polizia
del Regno Unito hanno dichiarato di essere rimasti “inorriditi” dalla morte di
George Floyd negli Stati Uniti. Lo riporta il quotidiano britannico
“Independent”. La dichiarazione congiunta è firmata dal Consiglio nazionale dei
capi di polizia, dal College per la polizia e dall’Associazione dei
sovrintendenti di polizia. I tre enti britannici hanno sottolineato la necessità
di giustizia e responsabilità negli Stati Uniti, ma hanno anche ammesso che c’è
“ancora da fare” nel Regno Unito. “Affronteremo pregiudizi, razzismo o
discriminazione ovunque li vedremo”, riporta la dichiarazione. I tre enti hanno
ammesso che essere un agente di polizia è “complesso e impegnativo” e che a
volte non si è all’altezza. “Quando non lo siamo, non abbiamo paura di mostrare
dove sono le ingiustizie o di prenderci le nostre responsabilità”, sostengono
gli enti di polizia del Regno Unito. Il Consiglio, il College e l’Associazione
di polizia hanno detto di “essere con tutti coloro intorno al globo che sono
inorriditi e terrificati dal modo in cui George Floyd ha perso la vita”. “Siamo
anche inorriditi – si prosegue nella nota – dalla violenza e dai danni fatti in
così tante città degli Stati Uniti da allora. I nostri pensieri vanno a tutti
coloro che hanno subito le conseguenze di questi eventi, e speriamo che la pace
e l’ordine possano presto tornare nelle strade”.
Anna Lombardi per repubblica.it il 30 maggio 2020. Minneapolis
brucia ancora. E ad ardere c'è perfino un commissariato. Gli 800 poliziotti in
campo non bastano a mantenere la calma. Il governatore democratico Tim Walz ha
mobilitato pure la guardia nazionale: 500 uomini schierati, per ora, a difesa di
banche, farmacie e supermercati: facendo pure da scorta ai vigili del fuoco. Si
fa sempre più violenta la protesta per la morte di George Floyd, afroamericano
di 46 anni, soffocato lunedì dall'agente che lo aveva preso in custodia, dopo
averlo fatto scendere dalla sua auto perché "sembrava drogato". Insensibile ai
suoi lamenti, l'agente Derek Chauvin, 44 anni e già protagonista di numerosi
altri episodi razzisti e violenti, ha continuato a premergli il ginocchio sul
collo per 9 terribili minuti. Tentando poi di farlo passare per un "problema
medico". Ieri è stato arrestato, dopo che video girato con un cellulare dove si
vede l'agonia di George, mandato a loop da giorni su tutte le televisioni, aveva
già smentito la sua ricostruzione. E' stato proprio quel video a far esplodere
la rabbia di Purple City, la città dove nacque (e morì) la star del rock Prince,
secondo un copione già visto a Ferguson nel 2014, dopo la morte del diciottenne
Michael Brown, l'atroce morte che ispirò il movimento Black Lives Matter.
L'episodio più grave di stanotte è sicuramente quello accaduto al terzo
distretto di polizia. Gli agenti avevano eretto una recinzione intorno alla loro
sede, ma è stata abbattuta dalla folla. A quel punto il capo della polizia
Medaria Arradondo - che aveva subito reagito dicendosi "disgustato" dalla
gestione tragica dell'arresto di Floyd - ha fatto evacuare l'edificio
"nell'interesse della sicurezza personale". Una scelta approvata anche dal
sindaco della città Jacob Frey: "La distruzione di calcio e malta non è grave
quanto distruggere una vita umana". Alcuni manifestanti sono dunque riusciti a
entrare, appiccando diversi incendi pure all'interno. E ora si teme per certe
armi ed esplosivi che erano dentro e potrebbero essere stati portati via. I
loro compagni fuori intanto gridavano: "No Justice, No Peace", nessuna pace
senza giustizia. Perché certo, i quattro poliziotti che hanno gestito l'arresto
finito in tragedia sono stati subito licenziati. Ma sono ancora a piede libero
mentre nei loro confronti si sta conducendo un'inchiesta. E sono in tanti a
chiedersi il perché. La protesta intanto si estende a tutti gli Stati Uniti con
arresti, proteste e spari in strada: da Los Angeles, a New York, a Denver. Fino
a Louisville, Kentucky, dove ci si è decisi a chiedere giustizia pure per
Breonna Taylor, infermiera afroamericana uccisa pochi giorni fa dalla polizia
nel suo stesso appartamento dove avevano fatto irruzione per errore. Donald
Trump è furioso. Nel pieno della pandemia e con l'economia a rotoli gli mancava
solo la protesta antirazzista. E invece di cercare di placare gli animi, attacca
tutti: i manifestanti, già bollati come "criminali". E pure il sindaco Frey:
"Meglio che riporti al più presto la calma o farò intervenire l'esercito.
"Quando iniziano i saccheggi iniziano gli spari", minaccia con un tweet, subito
"segnalato" dal social in quanto divisivo, ma oscurato solo parzialmente "perché
di pubblico interesse". Anche perché sparare sulla folla, nel caos dell'America,
in questo momento, sarebbe davvero molto grave. Il governatore Walz promette
un'inchiesta "piena e veloce" per l'uccisione di Floyd e, rivolgendosi ai
cittadini aggiunge: "La vostra pena è vera, questo è uno dei capitoli più bui
della storia" dello Stato. Anche Barack Obama fa sentire la sua voce: "Tutto ciò
non dovrebbe essere normale nell'America del 2020", ha detto l'ex presidente che
lancia un appello perché nel Paese si possa creare una "nuova normalità dove
l'intolleranza e il trattamento diseguale tra cittadini non infettino più le
nostre istituzioni e i nostri cuori". Intanto, la morte di Floyd rischia di
avere serie ripercussioni pure sulla scelta della numero due di Joe Biden. Sul
podio delle papabili c'era infatti la senatrice del Minnesota Amy Klobuchar, ex
procuratrice distrettuale dell'area. Ebbene nel 2006 aveva affrontato un caso
che riguardava proprio Derek Chauvin, l'uomo che ha soffocato il quarantenne
afroamericano. All'epoca era nel team di poliziotti che spararono e uccisero
Wayne Reyes: un uomo che aveva appena pugnalato la fidanzata e minacciava con
un'arma gli agenti. All'epoca Klobuchar non lo incriminò: in fondo si trattava
di un intervento in un brutto caso di violenza domestica. Ma ora l'ombra di
quella scelta rischia seriamente di metterla fuori dai giochi per la Casa
Bianca.
Da lastampa.it il 29 maggio 2020. Dilaga la rivolta negli Stati
Uniti a seguito delle proteste per la morte di George Floyd, l'afroamericano di
46 anni arrestato dalla polizia. Centri commerciali devastati, auto in fiamme,
strade invase dai lacrimogeni, collegamenti pubblici sospesi a Minneapolis. La
Guardia nazionale del Minnesota ha annunciato su Twitter la mobilitazione delle
sue unità mentre «Abbiamo attivato più di 500 soldati per Saint Paul,
Minneapolis e le comunità limitrofe - si legge - La nostra missione è proteggere
le vite, tutelare le proprietà e il diritto a manifestare in modo pacifico». La
gente è scesa in piazza anche in altre città degli Stati Uniti, da Memphis a Los
Angeles, da Denver a New York. I procuratori hanno promesso un'indagine «rapida»
pur di allentare la tensione. Su tutti i notiziari anche sono passate le
immagini sconvolgenti dell'arresto, avvenuto lunedì sera: si vede uno dei
quattro agenti, identificato come Derek Chavin, 44 anni, tenere bloccato a terra
Floyd, premendo il ginocchio sul collo, mentre l'uomo continua a ripetere «non
respiro, amico, non respiro, sento male dappertutto, io resto fermo, ma non
farmi morire». Il poliziotto continua a premere il ginocchio per alcuni minuti e
a dire «rilassati». L'afroamericano, sospettato di truffa ma risultato
innocente, si era sentito male. Ricoverato in ospedale, era morto dopo un'ora.
Il dipartimento di polizia aveva classificato il caso come «incidente medico»,
ma il video di un testimone che ha ripreso le fasi dell'arresto è finito in
rete, portando alla luce il caso. I quattro agenti sono stati subito licenziati,
ma alla gente non basta. Vogliono l'arresto. Il presidente Donald Trump ha
definito il video in cui George Floyd viene soffocato fino alla
morte «uno spettacolo scioccante». Il capo della Casa Bianca ha lanciato un
appello perché finiscano gli scontri. Appello caduto nel vuoto. Nella notte un
incendio è esploso all'esterno del commissariato degli ex agenti coinvolti nella
morte di George Floyd e l'edificio, assediato dai manifestanti, è stato
abbandonato. Un corteo ha marciato verso il centro della città chiedendo
giustizia e scandendo slogan contro la polizia e Donald Trump. Non distante dal
luogo in cui Floyd è stato soffocato, un gruppo di facinorosi ha tentato di
assaltare un mall ma è stato respinto dai gas lacrimogeni della polizia. I media
locali riportano come i manifestanti sono riusciti ad entrare nel commissariato
frantumando i vetri delle finestre, vandalizzando gli uffici e dando alle fiamme
parte dell'edificio. Quest'ultimo è stato evacuato per sicurezza, dopo che gli
agenti hanno esploso alcuni proiettili di gomma contro i dimostranti. Altri
edifici della zona sono stati distrutti appiccando dei fuochi. A Denver, in
Colorado, è scattato il lockdown dello State Capitol, l'assemblea statale, dopo
che alcuni colpi di arma da fuoco sono stati sparati mentre era in corso una
manifestazione per protestare contro la morte di George Folyd, a Minneapolis,
per mano della polizia. E proteste anche a New York dove almeno 30 persone sono
state arrestate durate una manifestazione di protesta. Momenti di tensione
attorno a City Hall, la sede del municipio, dove c'è stato un lancio di
bottiglie e di altri oggetti verso gli agenti. Un manifestante è stato arrestato
per possesso di armi, altri per aver gettato in strada i secchi dell'immondizia
e aver bloccato la circolazione.
Morte di George Floyd, nuovi dettagli nei filmati. "Non
respiro". "Allora smettila di urlare". Le trascrizioni
dei video girati con la body cam degli agenti. L'afroamericano ha ripetuto la
frase "I can't breathe" 20 volte prima di morire. La Repubblica il 9 luglio
2020. "I can't breathe", "Non respiro". Prima di morire, il 25 maggio, soffocato
da un poliziotto, George Floyd ha ripetuto questa frase 20 volte. A fornire
nuovi dettagli sull'agonia dell'afroamericano ucciso a Minneapolis è la
trascrizione dei filmati della "body camera" degli agenti di polizia accusati
della sua morte. Ad un certo punto Floyd dice all'agente Derek Chauvin: "Mi stai
uccidendo". Ma lui risponde: "Allora smettila di parlare, smettila di urlare. Ci
vuole tanto ossigeno per parlare". L'agente Chauvin deve rispondere dell'accusa
di omicidio di secondo grado per aver provocato la morte di Floyd, premendo con
il suo ginocchio sul collo di Floyd per oltre 8 minuti. Gli altri tre poliziotti
- Thomas Lane, J Alexander Kueng e Tou Thao - sono accusati di favoreggiamento e
omicidio. Le trascrizioni sono state presentate al tribunale del Minnesota dai
legali di Thomas Lane. Accusato di favoreggiamento, Lane afferma che era in
servizio solo da quattro giorni e ha obbedito agli ordini di Chauvin, che aveva
19 anni di esperienza. Ad un certo punto Lane chiede se non sarebbe meglio
voltare Floyd sul fianco, ma Chauvin, continuando a premere con il ginocchio sul
suo collo, risponde di no.
Andrea Marinelli per corriere.it il 9 luglio 2020. Ha gridato «I
cant’ breathe» — non respiro — almeno 20 volte George Floyd, prima di morire a
Minneapolis sotto il ginocchio di un poliziotto bianco. Ha invocato la madre
morta e i figli, chiedeva aiuto: «Mi uccideranno, mi uccideranno», ripeteva
mentre l’agente Derek Chauvin, quel 25 maggio, continuava a restare
inginocchiato sul suo collo. «Basta parlare, basta urlare», gli intima a un
certo punto Chauvin:«Ci vuole un sacco di ossigeno per parlare». Gli ultimi
istanti della vita di Floyd hanno ispirato le manifestazioni contro la brutalità
della polizia e per la giustizia sociale che hanno riempito strade e piazze di
tutto il pianeta, le immagini girate da una passante sono state trasmesse da
centinaia di reti televisive e visualizzate su milioni di telefonini, ma
l’intera conversazione avvenuta in quei terribili 8 minuti e 46 secondi non era
mai stata resa pubblica finora: la trascrizione dei video registrati dalle body
cam degli agenti è stata presentata ieri in tribunale dall’avvocato di uno dei
quattro — Thomas Lane, 37 anni, che al momento dell’omicidio era stato assunto
da pochi giorni — per scagionarlo. Lane e gli altri due agenti — Alexander Kueng
e Tou Thao — sono stati licenziati dalla polizia di Minneapolis, sono tutti
accusati di favoreggiamento di omicidio e rischiano fino a 40 anni di carcere.
La stessa condanna che potrebbe ricevere il responsabile materiale della morte
di Floyd, che nei suoi 19 anni di servizio aveva collezionato 18 denunce per
comportamento violento: arrestato il 29 maggio, Chauvin è accusato di omicidio
di secondo grado. Secondo la trascrizione — un documento di 82 pagine, a cui se
ne aggiungono altre 60 di deposizione di Lane —prima ancora di finire a terra,
mentre gli agenti cercano di farlo salire nella volante, Floyd dice di essere
claustrofobico e di non riuscire a respirare. «Rilassati», gli risponde allora
l’agente Thao, mentre Kueng fa presente che sembra riesca a parlare bene e Lane
gli consiglia di fare un respiro profondo. «Avevo l’impressione che qualcosa non
andasse», afferma nella sua deposizione l’agente Lane, il primo a puntare la
pistola contro Floyd quando si rifiuta di tenere le mani in evidenza. Gli agenti
— intervenuti perché Floyd era accusato di aver pagato un pacchetto di sigarette
con una banconota da 20 dollari falsa — ritenevano che l’uomo avesse assunto
droga, dettaglio confermato dall’autopsia, e gli avevano trovato addosso anche
una pipa da crack: per questo — dopo un primo momento in cui Floyd sembrava
cooperare — lo avevano ammanettato e poi immobilizzato a terra, vicino a alla
volante. «Sono spaventato», ribatte Floyd quando gli chiedono se è fatto di
qualcosa, poi comincia a ripetere le parole «I can’t breathe»: a quel punto Lane
avrebbe proposto a Chauvin di girarlo sul fianco, ma il collega rifiuta. «Sta
fermo qua dove lo abbiamo messo», gli risponde Chauvin, prima che Lane — dopo
aver visto Floyd sanguinare dalla bocca — chiami l’ambulanza: i soccorsi però
non arrivano tempestivamente e, nel frattempo, Lane aumenta l’urgenza della
richiesta, passando da «codice 2» a «codice 3». «Penso che stia svenendo», dice
a un certo punto Lane a Chauvin, mentre i passanti — come si sente anche nei
video circolati ovunque — cominciano a notare che l’uomo a terra non respira
più: a quel punto gli agenti cercano, senza successo, il polso di Floyd. «Non lo
trovo», afferma Kueng. Passano altri due minuti, durante i quali Chauvin
continua a tenere il ginocchio sul collo di Floyd, finché non arriva
l’ambulanza. Floyd, ormai morto, viene trasportato in ospedale. A bordo con lui
c’è l’agente Lane, che ora, in tribunale, continua a dichiararsi non
responsabile.
Ida Artiaco per "fanpage.it" il 29 maggio 2020. Sale la tensione
negli Stati Uniti in seguito alla morte di George Floyd, il 46enne
afroamericano soffocato da alcuni agenti di polizia durante un controllo nei
giorni scorsi. Il giornalista della Cnn Omar Jimenez e tutta la troupe sono
stati arrestati in diretta tv mentre raccontavano le proteste scoppiate a
Minneapolis, Minnesota. La vicenda è stata immediatamente riportata sui social
media, con decine di colleghi del reporter che hanno rilanciato la notizia su
Twitter. Dopo le proteste, i giornalisti sono stati rilasciati. Lo ha annunciato
la stessa Cnn spiegando che Jimenez, insieme ai colleghi Bill Kirkos e al
fotoreporter Leonel Mendez, sono stati rilasciati dalla struttura di pubblica
sicurezza della contea di Hennepin, nel centro di Minneapolis. Al momento non è
ancora chiaro il motivo del fermo. Stando alle prime informazioni disponibili,
gli agenti avrebbero chiesto all'uomo di spostarsi e al suo rifiuto lo avrebbero
bloccato. "Non riesco a credere a ciò a cui ho appena assistito – ha scritto
Cindi Avila -. Stavano facendo solo il loro lavoro ed improvvisamente sono stati
ammanettati". "Jimenez è stato preso in custodia dalla polizia durante una
trasmissione in diretta delle proteste a Minneapolis, dopo essersi chiaramente
identificato con gli ufficiali", si legge in una nota dell'emittente
statunitense sul proprio sito web, che aggiunge: "Anche la sua troupe, tra cui
un produttore e un operatore di macchina da presa, è stata arrestata". Il
giornalista si trovava a Minneapolis per raccontare le proteste dopo la morte di
George Floyd. "Scene drammatiche a Minneapolis dopo che la polizia è arrivata
sulla scena e ci sono stati scontri con i manifestanti – aveva detto poco prima
dell'arresto -. Gli agenti, alcuni in tenuta antisommossa, si sono
immediatamente messi in azione, usando spray al peperoncino e manganelli per
disperdere la folla vicino alla stazione di polizia. Sono anche stati visti
spingere almeno una persona, mentre i manifestanti hanno risposto lanciando
proiettili contro gli ufficiali".
Governatore del Minnesota: "Arresti inaccettabili, mi scuso". Il
governatore del Minnesota si è scusato per l'arresto della troupe della CNN a
Minneapolis. Lo ha rivelato la stessa emittente statunitense spiegando che il
presidente CNN Jeff Zucker ha parlato al telefono con il governatore dello
stato, Tim Walz, in seguito all'arresto. Walz si sarebbe scusato "profondamente"
per quello che è successo e avrebbe assicurato di essere al lavoro per far
rilasciare immediatamente i giornalisti. Lo stesso governatore ha descritto gli
arresti come "inaccettabili", ribadendo che la troupe aveva chiaramente il
diritto di essere lì.
George Floyd, le rivolte in tutti gli Stati Uniti. Da lunedì
scorso, giorno della morte di George Floyd, le proteste a Minneapolis si stanno
lentamente trasformando in vere e proprie rivolte. L'uomo, afroamericano di 46
anni, è stato ucciso il 26 maggio durante un fermo di polizia e dopo che un
poliziotto bianco gli aveva premuto con violenza per diversi minuti il ginocchio
sul collo quando era disarmato e immobilizzato, tra le proteste dei passanti e
mentre lui stesso urlava: "Non riesco a respirare". Nelle scorse ore
manifestanti hanno anche dato alle fiamme il commissariato di polizia, dopo che
gli agenti avevano eretto della barricate che sono state poi abbattute dalla
folla. Per far tornare sotto controllo la situazione è arrivata anche la Guardia
Nazionale, ma non è bastato a placare gli animi. Intanto, la protesta si sta
estendendo a macchia d'olio in tutti gli States, con la gente che è scesa in
piazza anche in altre città, da Memphis a Los Angeles, da Denver a New York.
Anna Lombardi per “la Repubblica” il 29 maggio 2020. «Ne ho visti
troppi di giovani uomini morire così. E ogni volta mi spezza il cuore, perché so
che la loro morte sarà stata vana. George Floyd ha sofferto atrocemente e senza
motivo. Sei anni prima era toccato a Eric Garnier, allo stesso modo. Non saranno
gli ultimi. Purtroppo, fatti come quelli di Minneapolis, accadranno ancora». Al
telefono dalla sua casa di Los Angeles, la voce dello scrittore Percival
Everett, 64 anni, è stanca. È uno dei più stimati autori afroamericani, e ha
affrontato il tema del razzismo in romanzi come "Io non sono Sidney Poitier".
Col suo ultimo lavoro, "Telephone", ha provato a dare uno scossone all'
ineluttabilità delle cose, dando tre finali diversi al racconto (impossibile
scegliere, la copertina è la stessa e i testi si somigliano tranne alcune
cruciali parole). Ora però dice di non poterne davvero più: «Continua a
succedere. Qui se sei nero sai che il prossimo potresti essere tu. Ne ho appena
parlato con i miei figli. Abbiamo avuto una conversazione molto dura».
Che cosa vi siete detti?
«Henry e Miles hanno 12 e 14 anni. Cominciano a uscire da soli ed
è ora che capiscano. "Non importa chi è tuo padre e quanto puoi essere educato"
gli ho detto. "Se sei un ragazzo afroamericano troverai sempre chi ti
considererà un pericolo". Gli ho spiegato che se un poliziotto li ferma devono
fare tutto quello che chiede. Inginocchiarsi, sdraiarsi, lasciarsi umiliare. Mi
creda, non è una bella cosa da dire ai tuoi figli. È stato straziante. Ma per un
ragazzo afroamericano è importante capire di non dover dare mai a nessuno il
pretesto di fargli del male».
Nemmeno George Floyd si era opposto all' arresto...
«Le immagini sono terribili. Il problema è che alcuni poliziotti
- non tutti, va detto - agiscono così perché sanno di essere impuniti. La fanno
sempre franca. Le storie di afroamericani fermati senza una ragione e
maltrattati sono quotidiane. Nessuno ci fa nemmeno più caso».
Minneapolis è in fiamme. Ci sono proteste anche a Los Angeles, a
Memphis. Una risposta violenta alla violenza dove può portare?
«Non la approvo, ma la comprendo. Quei poliziotti sono stati
licenziati ma non basta. Forse verranno arrestati, ma non basterà ancora. La
gente chiede giustizia sapendo che sarà difficile ottenerla. Il processo ai
poliziotti di Los Angeles autori del pestaggio di Rodney King nel 1992, che
scatenò la rivolta, fu una farsa. Nella giuria non c' erano neri. Quegli agenti
vennero scagionati. Succede ogni volta. Ecco perché la gente chiede giustizia
con tanta furia. Sa che non l' avrà».
All' epoca dei fatti di Ferguson che nel 2014 portarono alla
nascita del movimento Black Lives Matter, c' era ancora Barack Obama. Con Donald
Trump la situazione è cambiata?
«Certo. All' epoca le istituzioni almeno riconoscevano certi
comportamenti come inaccettabili. Trump, ricordiamocelo, non volle condannare la
marcia dei neonazisti a Charlottesville, tre estati fa, dove pure morì una
ragazza. Ora chiede giustizia: ma coma fa, se lui è il primo a non riconoscere
come sbagliati certi comportamenti? Il senso di impunità di certa gente, è pure
colpa sua».
Il razzismo sembra un male a cui non si trova cura perfino nel
pieno di una pandemia. Penso a episodi "minori" come il caso della signora a
Central Park, New York, che ha chiamato la polizia perché un afroamericano la
aveva chiesto di tenere il cane al guinzaglio...
«L' America è cambiata e indietro è impossibile tornare. Ma l'
immaginario dell'"uomo nero" costruito da letteratura e film è duro da
abbattere. Il razzismo è diverso da una malattia perché non c' è bisogno che ci
siano tanti "contagiati" per renderlo pericoloso. Basta un solo "malato". Un
solo poliziotto violento. Una sola donna spaventata. E a finire nei guai,
perfino a morire, è quasi sempre un innocente che voleva solo farsi i fatti
suoi».
«Se quel ragazzo fosse stato bianco questo non sarebbe successo»,
ha detto il sindaco di Minneapolis...
«È così e lo sappiamo tutti. Per questo ho parlato ai miei figli.
"C' è gente, lì fuori, che non guarda a chi siete realmente. Vede solo il colore
della vostra pelle. Vede solo quel che vuole vedere", ho detto loro».
Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera” il 30 maggio 2020.
L'America, si dice spesso, è una pentola a pressione: una società piena di
energia ma con un fondo selvaggio, violento e col «peccato originale» (parole di
Joe Biden di ieri) dello schiavismo che rimane una ferita aperta nonostante la
fine della segregazione e la stagione dei diritti civili. Una società compressa
da leggi rigide, da una giustizia penale durissima e da una polizia che spesso
fa un uso eccessivo della forza. Ogni tanto la pentola scoppia: razzismo e
brutalità degli agenti provocano incidenti o vere rivolte. La più grave, quella
del 1992 a Los Angeles per il caso Rodney King: 63 morti e 2400 feriti. Anche
negli ultimi decenni si sono scatenate guerriglie urbane, assai meno cruente, da
Ferguson a Baltimora. Ma a Ferguson, dopo incendi e saccheggi notturni, la gente
capì che stava distruggendo la sua stessa comunità. Il coprifuoco funzionò e i
black block arrivati da fuori vennero isolati. A Baltimora i saccheggi li fecero
studenti liceali appena usciti di scuola: le famiglie reagirono e bastò l'
appello di un leader nero che era stato al fianco di Martin Luther King, Elijah
Cummings, a placare gli animi. La reazione all' uccisione di George Floyd è cosa
diversa: un incendio che si propaga in tutto il Paese con eruzioni di violenza
spontanea e atti di guerriglia urbana ben organizzati. Ci sono movimenti neri
esasperati che non predicano più la resistenza non violenta, mentre il
governatore del Minnesota che - decisione senza precedenti - ha mobilitato
l'intera Guardia Nazionale, avverte: gruppi anarchici e della supremazia bianca
cercano di alimentare il caos. E crescono i timori di interferenze straniere
(soprattutto Russia) per destabilizzare gli Usa, come già avvenuto nel 2016.
Ancora nel tunnel del coronavirus, l' America vive la sua ora più buia. Con un
presidente che, anziché calmare gli animi, adotta lo slogan coniato dallo
sceriffo di Miami 50 anni fa: «Se saccheggiate, spariamo».
Francesco Semprini per “la Stampa” il 31 maggio 2020. L' America
è in rivolta. L'onda di proteste per l'uccisione dell' afroamericano George
Floyd, ucciso da un poliziotto bianco lunedì scorso, travolge tutto il Paese
sfociando in violenza. Mentre Donald Trump allerta il Pentagono a tenersi
pronto, le forze di polizia e la Guardia nazionale potrebbero non essere
sufficienti a domare la protesta. La Costituzione non prevede la mobilitazione
dell' esercito in casi di volte interne, ma sulla base dell' Insurrection Act
del 1807, questo intervento potrebbe essere invocato. L' unico precedente nella
storia risale alla rivolta di Los Angels del 1992, allarmante coincidenza
storica, ma non l' unica. Anche a Barack Obama capitò tutto questo nell' ultimo
anno del suo primo mandato: era il febbraio del 2012 quando Trayvon Marti,
afroamericano 17 enne, fu ucciso a colpi di arma da fuoco a Sanford, in Florida,
da una guardia giurata. Prima di una serie di episodi in cui le vittime sono
stati neri e gli autori poliziotti bianchi. E le proteste, otto anni dopo,
sembrano ripercorrere lo «Spoon river» di quelle vittime. Tensione alle stelle
ad Atlanta, dove un' auto è stata data alle fiamme e alcuni dimostranti hanno
rotto i vetri del quartiere generale della Cnn, e hanno riempito di scritte il
logo dell' emittente tv. Ma qui la protagonista è stata il capo della polizia,
Erika Shields, scesa in strada per parlare ai manifestanti: si è detta
disgustata e aggiunge che vuole vedere incriminato il poliziotto che ha ucciso
Floyd. A New York i manifestanti si sono radunati davanti al Barclays Center
dove la folla ha polverizzato ogni misura di sicurezza contro il Covid. Veicoli
della polizia sono stati bersagliati, uno dato alle fiamme. Tante le vetture
distrutte e le vetrine dei negozi infrante. A Lower Manhattan un uomo ha
picchiato un agente con un tirapugni. In totale sono state arrestate oltre 200
persone, tra cui una donna accusata di tentato omicidio per aver gettato una
bottiglia Molotov in un' auto della polizia con gli agenti a bordo. Il bilancio
è drammatico ovunque. Un agente della polizia è stato ucciso e un altro è
rimasto ferito da colpi di arma da fuoco ad Oakland, in California. Un altro
agente è rimasto ferito a Los Angeles, mentre a Detroit, in Michigan, è stato
ucciso un ragazzo di 19 anni da spari probabilmente indirizzati contro una folla
che manifestava per la morte di Floyd. Trump tuona contro i gruppi organizzati:
«Antifa e sinistra radicale». E aggiunge: «Come mai tutti questi luoghi che si
difendono così male sono governati da democratici liberal?» E alle forze dell'
ordine dice: «Siate duri, combattete (e arrestate quelli cattivi), forza». Lo
stesso presidente venerdì sera è rimasto bloccato alla Casa Bianca circondata
dai manifestanti e messa brevemente in lockdown per precauzione. Trump si
complimenta con gli agenti del Secret Service: «totalmente professionali». E poi
si lancia in un tweet destinato a dar fuoco alle polveri. «Se i dimostranti
avessero superato la recinzione a dar loro il benvenuto sarebbero stati cani
feroci e armi nefaste». Le manifestazioni al 1600 di Pennsylvania Avenue sono
puntualmente riprese. Il presidente, a cinque mesi dal voto di Usa 2020, si
sente assediato, contro di lui si è scatenata la tempesta perfetta, anche
perché, oltre al contagio delle proteste, rischia di tornare il contagio da
Coronavirus.
Soffocato con il ginocchio sul collo: la triste fine di George
Floyd. Orlando Sacchelli il 29 maggio 2020 su Il
Giornale. Alla fine, per riportare un minimo di calma sono arrivati i soldati
della Guardia nazionale. Oltre 500 uomini in divisa sono stati dispiegati a
Minneapolis, dopo le gravi violenze scoppiate a seguito della morte di George
Floyd, il 46enne afroamericano che dopo essere stato arrestato ha subito una
grave forma di violenza da parte di un poliziotto ed è morto soffocato. A
chiedere la Guardia nazionale è stato il sindaco Jacob Frey, dopo che la città
era stata messa a ferro e fuoco. Ad accendere la miccia della violenza è stato
un video, terribile, in cui si vedono gli ultimi momenti di vita di Floyd. Un
poliziotto, Derek Chauvin, lo tiene fermo sdraiato a terra, ammanettato a pancia
in giù, schiacciandogli il collo con il ginocchio. La scena va avanti per
diversi minuti, nonostante l’arrestato implori aiuto e gridi “non riesco a
respirare, mi state uccidendo”. Niente da fare, il poliziotto continua a
premergli il ginocchio sul collo. Alcuni passanti, rivolgendosi all’agente, gli
chiedono di smetterla e di controllargli il polso. Qualcuno dice: “Non si
muove”. Un altro: “Gli esce sangue dal naso”. Alla fine il poliziotto si alza.
Il corpo di Floyd viene caricato su una barella. Per lui non c’è più niente da
fare. Fa male vedere quella scena. Ma va vista, per capire fino a che punto
possa arrivare il male dell’uomo (guarda il video). La questione razziale,
pretesto per le sommosse, non credo c’entri molto. Anche se qualcuno potrà
pensare che a un bianco non sarebbe capitato. A mio avviso è soprattutto un
problema di umanità (calpestata) e di limiti all’esercizio della forza da parte
di chi ne detiene il monopolio. L’aggravante, ovviamente, è la divisa indossata
dall’uomo che ha soffocato Floyd. E anche del suo collega, che resta in piedi, a
guardare, senza intervenire e porre fine alla violenza brutale. L’agente
Chauvin, già licenziato insieme agli altre tre colleghi che hanno preso parte al
brutale arresto, è stato arrestato.
Il caso Floyd sfocia in rissa politica. “Non posso restare a
guardare quello accade a una grande città americana, Minneapolis”, ha scritto il
presidente Donald Trump su Twitter. “Un’assenza totale di leadership. O il
debolissimo sindaco radicale Jabob Frey riporta la città sotto controllo, o
invierò la Guardia nazionale e farò io il lavoro”. Nella seconda parte del suo
messaggio, poi censurata da Twitter, il presidente scrive: “Questa teppaglia sta
disonorando la memoria di George Floyd, e io non lascerò che accada. Ho appena
parlato con il governatore Tim Walz (governatore del Minnesota, ndr) e gli ho
detto che l’esercito è al suo fianco. Se ci saranno difficoltà assumeremo il
controllo, ma quando il saccheggio inizia, le armi sparano”. Twitter ha moderato
quest’ultimo tweet, lasciando tuttavia agli utenti la possibilità di
visualizzarlo: “Questo Tweet ha violato le regole di Twitter sull’esaltazione
della violenza. Tuttavia, abbiamo deciso di non oscurarlo poiché potrebbe essere
di pubblico interesse”.
Joe Biden ha risposto accusando Trump di aver incitato alla
violenza contro i cittadini statunitensi dopo aver minacciato di schierare i
militari a Minneapolis per sedare le violenze. “Non citerò il tweet del
presidente – ha scritto su Twitter -. Non gli darò risalto. Ma sta incitando
alla violenza contro i cittadini americani in un momento di dolore per così
tanti. Sono furioso, e dovreste esserlo anche voi”.
Si fa sentire anche l’ex presidente Barack Obama, convinto che
quanto accaduto sia soprattutto una questione di razzismo. “È naturale augurarsi
un ritorno alla normalità dopo la crisi sanitaria ed economica del Covid-19 ma
dobbiamo ricordare che per milioni di americani, essere trattati in modo diverso
a causa della razza è tragicamente, dolorosamente ed esasperatamente normale,
sia che si tratti di del sistema sanitario o del sistema giudiziario o di fare
jogging strada, o semplicemente di guardare gli uccelli in un parco. Non
dovrebbe essere normale nell’America del 2020. Non può essere normale. Se
vogliamo che i nostri figli crescano in una nazione all’altezza dei suoi grandi
ideali, possiamo e dobbiamo essere migliori”.
Il ginocchio poliziotto. Alessandro
Bertirotti il 28 maggio 2020 su Il Giornale. È tutta questione di… patologia. E,
così, muore un altro afroamericano, George Floyd, in diretta e per sette minuti
lunghissimi, ad opera di un “ginocchio poliziotto”. Un fallimento totale, e
socio-culturale, di integrazione etnica. E ci troviamo all’interno di quella
società che il mondo occidentale ha sempre considerato il luogo della
democrazia, in cui la salvaguardia della libertà e della individualità personale
sono considerate qualcosa di sacro. E se il risultato della sacralità è questo,
occorre qualche riflessione. La salvaguardia della libertà di tutti, prevede
necessariamente l’adesione ad un gruppo di regole che una data comunità scrive
per se stessa, proprio perché non esiste libertà se non all’interno di
una sicurezza compartecipata. E questo dovrebbe valere per tutti, o almeno, per
un numero soddisfacente di persone.
Ora, mi sembra che atteggiamenti di questo genere, specialmente
quando provengono dalle forze dell’ordine, che dovrebbero essere un punto
di riferimento non solo per la legalità, ma per il concetto stesso di sicurezza,
siano completamente lontani dalle conquiste dei diritti civili, quelli che gli
Stati Uniti hanno sempre dichiarato di rappresentare. Aldilà della situazione
precisa alla quale mi riferisco in questo articolo, indipendentemente o meno
dalla colpevolezza della persona catturata, atteggiamenti di così evidente
aggressività gratuita, non sono ammissibili. Mai, in nessun paese che voglia
definirsi civile. È anche vero che in alcuni Paesi degli Stati Uniti esiste la
pena di morte, e che in altri Paesi orientali si spara alla nuca, per
giustiziare i condannati ed in altri ancora si impiccano le persone. Insomma,
abbiamo certo occasione di desiderare altre azioni, in questo mondo. Ora, sul
caso specifico stanno indagando le autorità statali e quelle federali, anche se
non è stato ancora formulato un capo d’accusa. È anche vero, che con prontezza
gli agenti coinvolti sono stati licenziati e dovranno certamente rispondere
delle loro azioni. “Lasciatemi, non riesco a respirare”: ecco le ultime
drammatiche parole di Floyd. Secondo le prime ricostruzioni, una pattuglia era
stata allertata per la presenza di un uomo che in auto sembrava essere sotto
l’influenza di sostanze stupefacenti. Giunti sul posto, i poliziotti hanno
intimato all’uomo di scendere dalla vettura, ma l’afroamericano ha cominciato ad
opporre resistenza. Gli agenti lo hanno così bloccato a terra e, mentre
cercavano di ammanettarlo, uno di loro gli ha tenuto un ginocchio premuto sul
collo. L’uomo, visibilmente in sofferenza nel video, implora più volte di essere
liberato dal ginocchio soffocante. Quando arriva l’ambulanza è troppo tardi:
morirà poco dopo. Il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, sospende dapprima i
poliziotti (con body-cam) e poi li licenzia, affermando che “quello che ha visto
è terribile. Quell’uomo non avrebbe dovuto morire. Essere un nero in America non
dovrebbe essere una sentenza di morte”. Zio Covid-19 fa emergere quello che
siamo, prima ancora di riuscire a modificare i nostri comportamenti in meglio,
oppure in peggio. A questo punto, non saprei cosa pensare, ma continuo
a sperare nel meglio.
Basta con la narrativa politicamente corretta: Donald Trump
contro i tafferugli cittadini si comporta come il democratico Obama.
Mirko Giordani il 30 maggio 2020 su Il Giornale. La morte di
George Floyd è una tragedia, ma mettere a ferro e fuoco una città intera come
Minneapolis non è una buona idea. Gli afroamericani hanno sofferto fortissime
discriminazioni, specialmente nel sud degli Stati Uniti. Martin Luther King
morì, assassinato a Memphis, nella lotta per l’uguaglianza tra gli afroamericani
e i cosiddetti bianchi. Trump ha subito stigmatizzato la morte di Floyd ed il
suo omicida, perché di questo stiamo parlando, è stato arrestato ieri.
Nonostante ciò, la comunità afroamericana di Minneapolis e varie altre comunità
in giro per gli Stati Uniti stanno causando danni immani a cose e persone.
Donald Trump ha fatto capire che non è tollerabile un clima da guerra civile e
subito, da Elizabeth e giù tutto il pantheon democratico ad accusarlo di
razzismo, di fascismo e di fomentare l’odio razziale. Ma facciamo un piccolo
passo indietro, Aprile 2015 a Baltimora, quando un giovane afroamericano,
Freddie Gray, morì quando era sotto custodia della polizia. Anche in quel caso,
a Baltimora scoppiarono violente proteste da parte della comunità nera. A quel
tempo il presidente degli Stati Uniti era ancora il democratico Barack Obama
che, udite udite, reagì esattamente come Trump, intimando la fine delle
proteste. Non contento, il Governatore del Maryland richiese l’intervento della
Guardia Nazionale, non proprio uno scherzetto. Come vedete, la politica
americana, sia che il Presidente sia Democratico o Repubblicano, ai tafferugli
reagisce sempre allo stesso modo: con fermezza. Perché la morte di un povero
cittadino afroamericano sotto custodia della polizia, così come avvengono
altrettante morti di cittadini bianchi, non può essere la scusa per distruggere
una città. Nelle democrazia, se un pubblico ufficiale ha sbagliato, paga nei
tribunali. Non siamo nei Simpson, dove un Boh qualsiasi si mette alla testa
della folla inferocita.
Uccisione George Floyd: coprifuoco in 25 città, 1400 gli
arresti. A Ferguson, nel Missouri, l’edificio del
dipartimento di Polizia è stato danneggiato ed evacuato durante le proteste. Il
Dubbio il 31 maggio 2020. Ordinato il coprifuoco. Coprifuoco in oltre 25 città
di 16 Stati americani. In una decina di queste, tra cui la capitale Washington
DC, è intervenuta la Guardia nazionale. E finora sono state arrestate circa
1.400 persone. Continua la rivolta dopo l’uccisione a Minneapolis, lunedì,
dell’afroamericano George Floyd, Per la sua morte, è stato arrestato Derek
Chauvin, poliziotto 44enne, che dovrebbe comparire in tribunale lunedì. Nel
filmato che documenta il violento arresto di Floyd, Chauvin è immortalato in
ginocchio sul collo dell’uomo per diversi minuti, mentre lo stesso afferma
ripetutamente di non riuscire a respirare. Il bilancio più pesante degli scontri
si è registrato però a Indianapolis, nell’Indiana, dove una persona è stata
uccise e altre tre sono rimaste ferite a colpi d’arma da fuoco. Si tratta della
terza vittima dall’inizio della proteste. In tutto il Paese sono stati dati alle
fiamme commissariati e mezzi della polizia, saccheggiati i negozi e distrutte le
vetrine. Decine di migliaia di manifestanti sono scesi in strada chiedendo
accuse più severe e altri arresti per la morte di Floyd. Le proteste, in gran
parte pacifiche, sono sfociate in violenza in molte aree, con automobili ed
edifici incendiati e la polizia schierata in assetto antisommossa con gas
lacrimogeni e proiettili di gomma. A Ferguson, nel Missouri, l’edificio del
dipartimento di Polizia è stato danneggiato ed evacuato durante le proteste,
come riferito in un tweet dal dipartimento della contesa di St Louis. Tutto il
personale non essenziale è stato evacuato dall’edificio. Fuochi d’artificio,
mattoni, pietre e bottiglie sono stati lanciati contro gli ufficiali di polizia
durante le proteste. Già nel 2014 a Ferguson si erano svolte violente proteste
dopo che Michael Brown, un adolescente afroamericano di 18 anni, era stato
ucciso a colpi di arma da fuoco da un ufficiale di polizia bianco ad agosto del
2014. Tim Walzs, governatore del Minnesota, ha mobilitato l’intera Guardia
nazionale, mentre tutte le principali autostrade che conducono a Minneapolis
sono state chiuse per non fare entrare chi viene da fuori espressamente per
alimentare la rivolta. A New York nuove violenze degli agenti, in particolare
dopo la pubblicazione di un video che mostra un’auto della polizia andare contro
i manifestanti. Immagini che il sindaco Bill de Blasio ha definito
«sconvolgenti» ma senza accusare gli agenti che «in questi giorni hanno subito
cose orribili». Notte di scontri e tafferugli anche davanti alla Casa Bianca,
con vetrine distrutte e cassonetti incendiati. Il presidente Donald Trump ha
esortato a “sanare” la morte di George Floyd, ma dichiarando che «non permetterò
a una folla arrabbiata di dominare, sono determinato a proteggere la democrazia
e lo stato di diritto». Il suo sfidante alla Casa Bianca, Joe Biden, ha
condannato le violenze. «Protestare contro tale brutalità è giusto e necessario,
è una risposta assolutamente americana ma bruciare le comunità e distruggere
inutilmente non lo è», ha dichiarato.
Morte Floyd: la protesta oscura la Casa Bianca, evacuati i
Trump, Los Angeles vittima dei saccheggi. Pubblicato
lunedì, 01 giugno 2020 da Federico Rampini su La Repubblica.it L'ordine è
tornato a Minneapolis dove la polizia con il supporto della Guardia Nazionale è
riuscita a riprendere il controllo delle strade ma in molte decine di città sono
continuate le proteste. L’ordine torna a Minneapolis dove la polizia
spalleggiata da 13.000 soldati della Guardia Nazionale è riuscita a riprendere
il controllo della città, ma la tensione divampa in altri focolai, a Washington
dove la Casa Bianca finisce sotto assedio e “oscurata”; a Los Angeles; a
Philadelphia. In molte decine di città di tutta l’America anche domenica sono
continuate le proteste al sesto giorno dalla morte di George Floyd,
l’afroamericano ucciso da un poliziotto a Minneapolis. Se nel corso della
giornata i cortei di massa hanno riempito le piazze in modo pacifico, con
l’arrivo dell’oscurità e allo scattare del coprifuoco hanno preso il sopravvento
le frange più violente. A Washington alcuni manifestanti sono riusciti ad
appiccare un piccolo incendio a pochi metri dai cancelli della Casa Bianca, in
Lafayette Square. Il Secret Service che protegge il presidente e la sua famiglia
ha dovuto spostare Donald e Melania Trump nel bunker di emergenza sotto la Casa
Bianca. L’evacuazione del presidente e della First Lady è durata circa un’ora,
con le fiamme ben visibili dalla sede del potere esecutivo, prima che il
Metropolitan Police Department riuscisse a sgomberare Lafayette Square. Durante
l’operazione “salvare Trump e Melania”, per sicurezza sono state spente quasi
tutte le luci nel palazzo presidenziale, per ridurne la visibilità dalla piazza.
Sull’altra costa una delle aree più chic nell’area metropolitana di Los Angeles
è stata teatro di una scena che è diventata emblematica. Alle otto di sera
locali la celebre Third Street Promenade di Santa Monica, in tempi normali il
luogo dello "struscio" e dello shopping, è stata presa d'assalto da bande
organizzate con la distruzione di vetrine, il saccheggio sistematico di negozi
di articoli sportivi e abbigliamento. Le forze di polizia, secondo ricostruzioni
attendibili, erano state concentrate ai lati di un corteo di protesta che si è
svolto in modo pacifico. A poca distanza è cominciato un viavai di auto da cui
scendevano gruppi che scassavano le vetrine e correvano nei negozi di marca per
fare razzia. La razzia è continuata indisturbata, ripresa dalle telecamere e
trasmessa in tutta l'America. Uno spettacolo di caos e di anarchia, di ordine
sociale al collasso, come nei peggiori momenti della storia di questo paese: i
violenti anni Sessanta, o il 1992 durante gli scontri per il verdetto su Rodney
King. Scene simili si sono viste anche a Philadelphia in Pennsylvania, capitale
storica degli Stati Uniti prima di Washington: anche questa città-simbolo ha
visto negozi presi d’assalto, svuotati da bande di giovani. In altre località
alle prese con razzie, come Portland nell’Oregon, le autorità locali hanno
dovuto estendere il coprifuoco. L’attenzione si è allontanata per la prima volta
da Minneapolis, il luogo della tragedia che ha dato origine alle proteste. Al
sesto giorno di scontri, le autorità del Minnesota hanno finito per avere la
meglio. La mobilitazione senza precedenti dei 13.000 soldati della Guardia
Nazionale domenica ha invertito i rapporti di forze, e ha permesso alle forze
dell’ordine di riprendere il controllo del territorio. L’unico momento di
tensione grave si è verificato quando un camionista ha tentato di investire
alcuni manifestanti: bloccato dalla folla, pestato, è stato arrestato dalla
polizia e piantonato in ospedale. Ma questa domenica si è chiusa sotto il segno
di un nuovo incubo. La grande massa degli americani – non solo di colore – che
sta protestando per le violenze della polizia, teme che il senso di questa
grande rivolta venga snaturato e deviato. Negli scontri con la polizia si sono
distinti i professionisti della guerriglia urbana; dietro di loro è spuntato lo
sciacallaggio di chi approfitta del caos per scatenarsi a ripulire i negozi e
fuggire col bottino. I danni provocati aggravano una situazione già drammatica:
le scene di razzie nei negozi infieriscono su centri urbani che erano vuoti da
tre mesi per il lockdown, vetrine sbarrate, esercizi pubblici già sull’orlo del
fallimento, un paesaggio di depressione economica che sarà ancora più difficile
ricostruire dopo quest’altra ondata di distruzioni.
Proteste per la morte di Floyd, arrestata la figlia del
sindaco di New York. Pubblicato lunedì, 01 giugno 2020
da La Repubblica.it La notizia è stata pubblicata dal New York Post . Nuovi
tafferugli davanti alla Casa Bianca. Chiara de Blasio, la figlia 25enne del
sindaco di New York, è stata arrestata sabato sera in una protesta a Manhattan
per la morte di George Floyd. Lo scrive il New York Post, citando le forze
dell'ordine. La giovane è finita agli arresti dopo che la polizia ha dichiarato
illegale un assembramento tra la 12ma strada e Broadway, dove erano scoppiati
alcuni tafferugli ed erano state bruciate auto delle forze di sicurezza. Nuovi
tafferugli a Washington davanti alla Casa Bianca, dove la polizia ha usato i
lacrimogeni e gli spray urticanti per rispondere al lancio di oggetti da parte
di alcuni manifestanti, che protestano non solo contro la morte di George Floyd
ma anche contro il presidente Donald Trump. In piazza Lafayette i dimostranti
hanno acceso un grande falò. A New York due avvocati sono stati arrestati per un
attacco con molotov a un'auto della polizia avvenuto durante il weekend. Si
tratta di Urooj Rahman, 31 anni, legale per i diritti umani, e Colinford King
Mattis (32), socio di uno studio legale dopo essersi laureato a Princeton.
(ANSA l'1 giugno 2020) - Chiara de Blasio, la figlia 25/enne del
sindaco di New York, è stata arrestata sabato sera in una protesta a Manhattan
per la morte di George Floyd. Lo scrive il New York Post, citando le forze
dell'ordine. La giovane è finita in manette dopo che la polizia ha dichiarato
illegale un assembramento tra la 12ma strada e Broadway, dove erano scoppiati
alcuni tafferugli ed erano state bruciate auto delle forze di sicurezza.
Polemica a New York tra il sindaco dem Bill de Blasio e la giovane star del
partito, la deputata Alexandria Ocasio-Cortez, per il Suv della polizia lanciato
contro la folla dei manifestanti che lo avevano accerchiato nelle proteste per
la morte di George Floyd. Il primo cittadino ha sottolineato che gli agenti
potrebbero non aver avuto altra scelta ma la 'pasionaria' dem ha twittato che
"lanciare un Suv su una folla non dovrebbe mai essere considerato una cosa
normale. Non conta chi lo fa, non conta per quale motivo". "In qualità di
sindaco, questo dipartimento di polizia è sotto la sua responsabilità. Questo
momento richiede leadership e capacità di rendere conto da parte di tutti noi.
Difendere o trovare delle scuse per il Suv della polizia sulla folla è
sbagliato", ha aggiunto, invitando il sindaco alla de-escalation delle tensioni.
Anna Guaita per “il Messaggero” l'1 giugno 2020. Sono 21 gli
Stati contagiati dall'esplosione delle proteste razziali esplose nel Minnesota
dopo l'uccisione di un nero disarmato da parte della polizia. In 15 di questi è
stata schierata la Guardia Nazionale e in 39 città i sindaci hanno dovuto far
ricorso al coprifuoco nel tentativo di controllare l'onda della violenza, che ha
prodotto 4 morti tra Detroit, Indianapolis e Minneapolis. Anche se la quarta
notte è stata meno terribile di quelle precedenti. A Minneapolis, la città
teatro dell'uccisione di George Floyd, la polizia statale ha constatato che la
veloce azione di dispersione della folla «si è risolta con un successo: non ci
sono stati incendi, non ci sono stati atti di criminalità, nè attacchi alla
proprietà personale». In seguito alle parole del colonnello Matt Langer, il
presidente ha sollecitato anche gli altri Stati a «trarre esempio nel bloccare
gli anarchici della sinistra radicale». E ha anche annunciato che il gruppo di
contestatori di sinistra Antifa, che lui giudica i principali colpevoli delle
violenze, sarà definito come «gruppo terrorista». Dal canto suo, il ministro
della Giustizia William Barr ha promesso una «robusta indagine federale»
sull'uccisione di Floyd. La famiglia della vittima chiede piuttosto che
l'indagine sia condotta da una commissione indipendente, e il fratello di Floyd,
Philonise, ha anche cercato di dirlo a Trump, quando il presidente ha telefonato
alla famiglia per presentare le sue condoglianze: «Non mi ha ascoltato si è però
lamentato Philonise -. Ha cercato di farmi star zitto». E comunque l'avvocato
della famiglia ha sostenuto che si è trattato di omicidio premeditato. Il
cammino fuori da questa crisi sembra comunque ancora lungo. Secondo un copione
oramai ben noto, le manifestazioni cominciano pacificamente, e la polizia le
lascia sfilare, fino a che non scatta l'ora del coprifuoco e allora in alcune
città le forze dell'ordine decidono di intervenire per mandare tutti a casa. In
certi luoghi questo porta a scontri e a violenze con gruppi di manifestanti
irriducibili. In altri, come ha dimostrato Minneapolis, le folle vengono
effettivamente disperse. E poi ci sono esempi di diverso tipo, come la città di
Flint nel Michigan o Camden nel New Jersey, dove la polizia ha compiuto una
decisione diversa: i poliziotti sfilano fianco a fianco con i manifestanti, in
un'atmosfera di fratellanza. Il panorama, in altre parole, non è unico e
identico. E se le immagini televisive restituiscono scene di auto in fiamme e
vetrine sfondate, talvolta si tratta di incidenti relegati a un unico incrocio
di una grande città, non una rivolta estesa come furono le riots di Los Angeles
nel 1992. Questo non vuol dire che la violenza non ci sia stata. Nella notte fra
sabato e domenica ci sono stati 340 arresti a New York (dove un suv della
polizia si è scagliato contro alcuni manifestanti), e casi di vandalismo a
Seattle, Filadelfia, Los Angeles e Washington, dove la folla è di nuovo arrivata
sotto la Casa Bianca, a lanciare sassi e pomodori contro la polizia e il
servizio di sicurezza intorno alla residenza presidenziale. La polizia dal canto
suo ha spesso tirato fuori i manganelli, o i lacrimogeni, o i proiettili di
gomma o quelli urticanti. Ma a essere presi di mira non sono stati solo i
manifestanti. In Florida, infatti, un agente è stato accoltellato al collo ed è
stato ricoverato in ospedale. Tanti i poliziotti costretti a farsi curare per
gli attacchi dei violenti. Anche i giornalisti sono stati spesso colpiti,
nonostante si fossero identificati come tali. Fra i colleghi feriti, la
fotogiornalista Linda Tirado è stata colpita al sopracciglio da una pallottola
di gomma e ha perso l'occhio. La nota inviata del Los Angeles Times, Molly
Hennessy-Fiske, che copriva le manifestazioni di Minneapolis con la collega
fotografa Carolyn Cole, è stata ferita in più punti da proiettili di gomma,
nonostante sia lei che altri giornalisti avessero chiesto alla polizia dove
dovevano ripararsi. La Hennessy-Fiske, giornalista pluripremiata che ha coperto
rivolte e guerre ha scritto: «Non mi era mai successo che la polizia mi sparasse
direttamente addosso». Contro i giornalisti si è sfogato anche Trump, che li ha
accusati di «fomentare l'odio e l'anarchia»,
A Miami polizia e manifestanti pregano insieme per Floyd.
Le immagini hanno fatto il giro di internet e hanno
una grande potenza simbolica in giorni caratterizzati da forti violenze che
coinvolgono forze dell'ordine e dimostranti. Agi l'1 giugno 2020. Gli agenti di
polizia della contea di Miami-Dade si sono uniti a Coral Gables ai manifestanti
pacifici in una preghiera per George Floyd, l'afroamericano di 46 anni che
è morto lunedi' dopo essere stato arrestato a Minneapolis. Le immagini degli
agenti di polizia in ginocchio mentre altri cittadini portavano cartelli con i
messaggi "Black Lives Matter" e "Stop Police Brutality" sono diventate virali
sui social media. "La polizia può mostrare il suo antirazzismo", ha scritto il
regista di documentari Maureen Gosling su Facebook, commentando una foto degli
uomini in uniforme in ginocchio e a capo chino. Durante la manifestazione
pacifica, gli amministratori della contea e gli organizzatori della
manifestazione si sono impegnati a tenere una discussione virtuale sulla
questione, per ascoltare le preoccupazioni della comunità afroamericana nel sud
della Florida, ha detto un portavoce della polizia al canale CBS 12.
DAGONEWS il 3 giugno 2020. Sono le immagini che hanno sorpreso e
commosso l’America: decine di poliziotti da New York a Los Angeles si sono
inginocchiati in segno di solidarietà con i manifestanti che sono scesi in
strada per protestare per la morte di George Floyd. «Mi sono tolto l'elmetto e
ho posato i manganelli. Ho chiesto ai manifestanti: “Dove volete andare?
Cammineremo tutta la notte”», ha dichiarato Chris Swanson, lo sceriffo di Flint,
nel Michigan. A Des Moines, nell’Iowa, il capo della polizia Dana Wingert si è
inginocchiato davanti a una folla di manifestanti insieme ad altri ufficiali:
«Noi ci uniamo a loro in modo simbolico, è il minimo che possiamo fare». I
manifestanti che si battono contro il razzismo in tutto il paese hanno preso in
prestito il gesto reso famoso dall'ex quarterback Colin Kaepernick che ha
iniziato a inginocchiarsi durante l'inno nazionale nel 2016 per protestare
contro la brutalità della polizia contro i neri e altre minoranze. Kaepernick è
stato ostracizzato dalla NFL per la sua protesta che gli è valsa la condanna di
altri atleti e gli insulti da parte dei conservatori tra cui Trump. Ma adesso
quel gesto di inginocchiarsi è stato preso in prestito dalla polizia che vuole
mostrare un segno di solidarietà ai manifestanti: se da un lato farsi vedere
solidali ha disinnescato la tensione dall’altra è una sorta di ricerca di
"assoluzione" davanti agli occhi del mondo. Lunedì a New York, il capo della
polizia della città Terence Monahan si è inginocchiato e ha stretto le mani ai
leader della protesta, alzando le braccia al cielo in sostegno ai manifestanti.
Un gesto che è stato accolto con un plauso anche dal sindaco Bill de Blasio:
«Questa è la strada che ci porterà a una soluzione». Scene simili si sono viste
in Florida, in Illinois, in Missouri, in Georgia, così come nella capitale
Washington. Lunedì sera, fuori dal Trump International Hotel di Washington, ad
esempio, una fila di poliziotti che si è ritrovata faccia a faccia con i
manifestanti si è inginocchiata davanti alla folla inferocita.
Morte Floyd, la solidarietà dello sceriffo di Flint che si
unisce ai manifestanti: "Qui per darvi voce".
Pubblicato lunedì, 01 giugno 2020 da La Repubblica.it. Dopo essersi liberato del
casco e del manganello, Christopher Swanson ha preso parte alla
protesta: "Andiamo là fuori per aiutare le persone, non per fare queste cose".
Durante il fine settimana diversi agenti in varie città si sono uniti ai
manifestanti marciando insieme a loro e, in diversi casi, inginocchiandosi. Non
solo violenza, ma anche segnali di solidarietà: durante il fine settimana in tre
grandi città degli Stati Uniti la polizia si è unita ai manifestanti che
protestavano in nome di George Floydmarciando insieme a loro e, in diversi casi,
inginocchiandosi. Il gesto degli agenti di Camden, in New Jersey, Ferguson, nel
Missouri e Flint, in Michigan, è diventato virale sui social suscitando elogi,
un po' di speranza, e diffondendo un esempio che inizia a ripetersi in altre
parti degli Stati Uniti. I manifestanti a Flint, in Michigan, radunati davanti
alla stazione di polizia, hanno ascoltato le parole dello sceriffo della Contea
di Genesee Christopher Swanson che ha parlato con loro prima di unirsi alla
protesta pacifica dopo essersi liberato del casco e del manganello in segno di
pace: "L'unico motivo per cui siamo qui è assicurarci che voi abbiate voce, solo
per questo!". Lo sceriffo ha sottolineato come gli agenti degli Stati Uniti non
siano tutti come l'ex poliziotto Derek Chauvin, accusato dell'omicidio di Floyd:
"Non pensate per un secondo che lui rappresenti i poliziotti di tutta questa
nazione", ha detto Swanson. "Andiamo là fuori per aiutare le persone, non per
fare queste cose" e in nome di questo ora "voglio fare un corteo, non una
protesta". "Questi poliziotti vi adorano!", ha continuato lo sceriffo. Morte
George Floyd, uno sceriffo si unisce alla protesta: "I poliziotti sono qui per
aiutarvi" in riproduzione....Fuori dalla stazione di polizia di Ferguson, in
segno di rispetto i manifestanti si sono inginocchiati per gli stessi nove
minuti che hanno causato la morte di Floyd per soffocamento. Tra la folla erano
presenti e in ginocchio, anche molti agenti. Le riprese video del momento
scattate da uno stagista di Heroic Imagination mostrano la folla che incoraggia
gli agenti per il loro spettacolo di solidarietà. Ma gli agenti si sono
inginocchiati anche in altre parti degli Stati Uniti, nella contea di Miami Dade
in Florida o Santa Cruz in California, a Washington e a New York. È una delle
città più grandi e violente del New Jersey, ma è stato a Camden che sabato
pomeriggio gli agenti hanno deciso di marciare a fianco dei manifestanti. Il
capo della polizia della contea, Joe Wysocki, si è unito in prima fila
sfoggiando la sua uniforme, una maschera protettiva e un segno di pace. "Ieri è
stato un altro esempio del nostro costante impegno e un dialogo con i residenti
di Camden", ha dichiarato Wysocki a The Associated Press. Da quando le forze di
polizia di Camden si sono sciolte e riformate nel 2013 come agenzia della
contea, gli ufficiali si sono concentrati molto sulla sorveglianza della
comunità.
(ANSA il 31 maggio 2020) Un agente a Jacksonville, in Florida, è
stato "pugnalato o ferito al collo ed è attualmente in ospedale". Lo ha
dichiarato lo sceriffo di Jacksonville Mike Williams, citato dalla Cnn. Williams
ha riferito che altri agenti sono stati attaccati dai rivoltosi e colpiti con
pietre e mattoni durante le proteste in città. Sono stati fatti molti arresti,
ha detto, senza fornire un numero preciso. Un giornalista dell'Huffington Post,
Chris Mathias, è stato preso in custodia dalla polizia e poi rilasciato mentre
seguiva per le proteste contro il razzismo a New York City. Lo riferisce la
stessa testata. Il cronista è stato rilasciato intorno all'una del mattino dopo
essere stato portato al distretto di polizia di Brooklyn. Almeno tre persone
sono state ferite da colpi d'arma da fuoco e una è morta nelle proteste nel
centro di Indianapolis sabato sera. Lo ha dichiarato il capo della polizia di
Indianapolis Randal Taylor in conferenza stampa, secondo quanto riferisce la
Cnn. La polizia sta ancora indagando e ha consigliato ai cittadini di evitare la
zona. Anche un agente di polizia ha anche riportato lievi ferite. La polizia ha
arrestato quasi 1.400 persone in 17 città Usa da quando sono iniziate le
proteste per la morte dell'afroamericano George Floyd, che continuano anche
stanotte. Lo riportano alcuni media americani, citando il calcolo fatto dall'Ap.
Flavio Pompetti per “il Messaggero” il 31 maggio 2020. La
protesta dei neri americani è di nuovo esplosiva, e Trump è pronto ad usarla a
fini elettorali. Il commentatore politico Ian Bremmer ci aiuta a decifrare i
tanti messaggi che arrivano dalle città statunitensi in fiamme.
Perché proprio ora, dopo anni di apparente silenzio del movimento
Black Lives Matter?
«I video che ritraggono la morte di George Floyd hanno una forza
innegabile. Ma la rabbia dei neri covava da mesi durante il regime di lockdown,
perché l'isolamento sociale e la perdita dell'occupazione hanno gravato in
misura maggiore sulle comunità più povere, e loro sono in prima linea anche sul
fronte dei decessi. L'omicidio a Minneapolis è stata la scintilla che l'ha fatta
scoppiare».
A cinque anni di distanza da Fergusson l'oppressione dei neri è
cresciuta o diminuita negli Usa?
«Negli ultimi cinque anni la condizione dei poveri e in
particolare dei neri poveri, è peggiorata negli Usa come nel resto del mondo. E'
questo un profondo problema strutturale che conoscete bene anche in Italia. Ha a
che vedere con la mancanza di investimenti nelle infrastrutture e
nell'istruzione, con l'incarcerazione su larga scala della comunità. Misurata su
questi parametri, la comunità degli afro americani è quella che soffre di più in
termini di mancanza di servizi sociali e qualità delle cure mediche».
La politica di Trump ha aggravato la tensione?
«Nulla è stato fatto per correggere l'oppressione di polizia nei
confronti dei neri, o per migliorare le loro condizioni di vita. Nel frattempo
la classe dei bianchi poveri ha sofferto un parallelo deterioramento economico e
sociale che ha favorito un clima di opposizione crescente tra i due gruppi. La
differenza è che i bianchi poveri si sentono maggiormente rappresentati dalla
retorica presidenziale, e la rabbia della popolazione di colore è cresciuta
anche per questo. Dal punto di vista delle dinamiche sociali il mandato di Trump
è stato caratterizzato da due fenomeni: il Me Too e il Black Lives Matter. Non è
un caso che il primo abbia prodotto cambiamenti sostanziali per le donne, mentre
il secondo è rimasto lettera morta».
I conservatori dicono che la divisione tra i due gruppi è
cresciuta anche negli anni di Obama. Lei è d'accordo?
«Certo, anche se mi sembra che sia cresciuta non per effetto
della sua gestione del potere, ma nonostante essa. Gli otto anni della sua
presidenza sono stati il periodo nel quale la divisione tra ricchezza e povertà
è cresciuta al ritmo più veloce della storia. Il libero scambio commerciale e la
tecnologia hanno giocato un ruolo maggiore di ogni politico in tutto il mondo
nell'esacerbare questa e altre linee di confine. Se Romney e Hillary Clinton si
fossero trovati al posto di Obama, il risultato non sarebbe stato diverso».
Trump sta gettando benzina sul fuoco delle proteste. Che
vantaggio può ricavarne?
«In una logica tutta elettorale, il voto degli elettori afro
americani è totalmente fuori dalla sua portata. Trump sa che se il livello della
violenza sale e durerà nel tempo, gli amministratori repubblicani degli stati ad
alta densità di popolazione di colore avranno l'estro per limitare il numero dei
seggi, e cercare di ridurre l'impatto del loro voto. E' un calcolo brutale, ma
tale è la considerazione che il presidente mostra per questa porzione di
elettori».
E' sorpreso dal quasi silenzio di Biden in questa vicenda?
«Biden non è il vero antagonista di Trump nel voto di novembre.
Le elezioni saranno un referendum sul presidente in carica, e il candidato
democratico resterà ai margini a registrare le variazioni della curva di
popolarità del suo opponente. Finora non gli è andata male a vedere i sondaggi».
Usa, 4 morti e suv polizia su manifestanti. Fratello Floyd:
“Trump non mi ha ascoltato”. Redazione de Il
Riformista il 31 Maggio 2020. Sale a 4 il bilancio delle vittime negli Stati
Uniti durante le proteste per l’omicidio di George Floyd, il 46enne
afroamericano soffocato da un poliziotto durante l’arresto a Minneapolis. Per il
quinto giorno di fila le proteste hanno interessato molti Stati del Paese e dopo
l’uccisione di un 19enne a Detroit e un poliziotto a Oakland, gli ultimi due
morti si sono registrati a Indianapolis dove la polizia ha riferito che una
seconda persona è morta a seguito delle sparatorie avvenute durante le proteste
per la morte di George Floyd. Una delle sparatorie mortali è avvenuta alla fine
di sabato e la seconda alle 2:30 di oggi, la polizia ha dichiarato che nessun
agente era coinvolto. Non è ancora chiaro il movente degli attacchi. “Non
abbiamo modo di collegarli, in questo momento, a nessun tipo di protesta o
altro”, ha spiegato un portavoce della polizia Patrolman Michael Hewitt, “Non
sappiamo di cosa si tratti e se si tratti di incidenti separati”. Le proteste si
sono registrate in almeno 25 città in 16 stati che hanno imposto il coprifuoco.
La Guardia Nazionale è stata attivata in circa una dozzina di Stati e nel
distretto di Columbia. Lo riporta la Cnn. Nella quinta notte di proteste, gli
scontri sono arrivati fin sotto alla Casa Bianca, dove i manifestati si sono
radunati per la seconda sera consecutiva. Intanto più di 340 persone sono state
arrestate in tutta New York durante le proteste iniziate sabato e durate fino a
domenica mattina per la morte di George Floyd. Lo ha riferito alla Cnn un alto
funzionario della polizia di New York. Almeno 33 agenti sono
rimasti feriti durante la protesta, alcuni dei quali gravemente. Circa 48
veicoli della polizia sono stati danneggiati o distrutti.
SUV POLIZIA SULLA FOLLA – La polizia di New York ha inoltre
aperto un’indagine dopo che sui social è stato pubblicato un video che mostra
un suv della polizia andare contro a una folla di manifestanti, rovesciando una
barricata. Non è ancora chiaro se ci siano stati feriti. Il sindaco della Grande
Mela Bill de Blasio ha confermato l’indagine, affermando che la polizia
“potrebbe non aver avuto scelta”.
ATTACCO CYBER A PC STATALI – Il governatore del Minnesota Tim
Walz ha riferito che i computer statali sono stati colpiti da un cyber attacco
prima che le forze dell’ordine entrassero in azione per sedare le proteste. Walz
ha descritto l’incidente come un “attacco molto sofisticato di blocco del
servizio” e ha affermato che è stato eseguito su “tutti i computer”. Non ha
fornito ulteriori dettagli ma ha indicato l’attacco come prova che i disordini
siano stati alimentati da gruppi esterni coordinati che cercano di seminare il
caos. Le autorità del Minnesota hanno dichiarato che il 20% delle persone
arrestate ha la residenza al di fuori dello Stato.
FRATELLO FLOYD: “TRUMP NON MI HA LASCIATO PARLARE” – La
conversazione con il presidente Donald Trum è stata “così veloce. Non mi ha dato
nemmeno l’opportunità di parlare”. Così il fratello di George Floyd, Philonise
Floyd, alla Msnbc sulla conversazione avuta con il presidente Trump. “E ‘stato
difficile. Stavo cercando di parlargli, ma lui continuava a spingermi via, come
(se dicesse) ‘Non voglio sentire di cosa stai parlando'”, ha raccontato l’uomo,
“gli ho detto che voglio giustizia. Ho detto che non potevo credere che abbiano
commesso un linciaggio ai giorni nostri e in pieno giorno”.
DANNI AI MONUMENTI – I manifestanti che stanno protestando da
giorni per la morte dell’afroamericano george Floyd per mano di un agente
bianco, hanno preso di mira i numerosi monumenti confederati che si trovano
ancora negli Usa, in particolare negli stati del Sud. Nel campus dell’Università
del Mississippi, le parole “genocidio spirituale”, insieme a impronte di mani
rosse, sono state dipinte sui lati di un monumento confederato. A Charleston,
nella Carolina del Sud, i manifestanti hanno deturpato una statua vicino a The
Battery, un’area storica a sud della città. La base della statua dei difensori
confederati, eretta nel 1932, è stata verniciata a spruzzo con le parole “Blm” e
“traditori”. Nella Carolina del Nord, la base di un monumento confederato al
Campidoglio è stata contrassegnata con una X nera e con una frase che esprimeva
disprezzo per la polizia, insieme alla parola “razzista”. La questione dei
monumenti confederati è stata particolarmente controversa nella Carolina del
Nord, dove tali monumenti sono generalmente protetti dalla legge. Una battaglia
di quasi due anni è stata condotta sul destino della statua di “Silent Sam” dopo
che è stata rovesciata dai manifestanti nel campus di Chapel Hill, l’ammiraglia
della University of North Carolina nel 2018. Un accordo legale raggiunto lo
scorso novembre ha consegnato la statua a un gruppo di discendenti confederati,
tenendola fuori dal campus. Anche una statua confederata fuori da un tribunale
di Durham è stata demolita dai manifestanti.
SOLIDARIETA’ DA LONDRA – Migliaia di persone si sono radunate a
Trafalgar Square a Londra per esprimere il loro sdegno per la morte di George
Floyd. I manifestanti hanno applaudito e sventolato cartelli in sostegno delle
proteste negli Usa. La folla si è radunata nonostante le regole del governo che
vietano assembramenti per la pandemia di Covid-19.
Uccisione Floyd a Minneapolis: la moglie del poliziotto
arrestato chiede il divorzio. Pubblicato sabato, 30
maggio 2020 da La Repubblica.it Kellie Chauvin, ex miss e sposata da 10 anni con
l'agente accusato di aver soffocato l'afroamericano, ha notificato la richiesta
di separazione: "È devastata". Licenziato, arrestato con l'accusa di omicidio e
ora lasciato anche dalla moglie, una ex reginetta di bellezza del
Minnesota. Derek Chauvin, l'ex agente incriminato per la morte a Minneapolis
di George Floyd, l'afroamericano che aveva immobilizzato a terra tenendo un
ginocchio sul suo collo per nove minuti, ha ricevuto una richiesta di divorzio
dalla moglie Kellie. "È devastata dalla morte di Floyd e desidera sciogliere il
suo matrimonio", ha fatto sapere il suo avvocato dello Studio legale Sekula. I
due sono sposati da 10 anni e non hanno figli. "Mio marito ha modi ruvidi, ma
sotto l'uniforme è un tenerone", aveva detto la signora Chauvin in una
intervista del 2018 durante il concorso di Miss Minnesota. La donna, nata nel
Laos e vissuta per anni in un campo di rifugiati, ha due figli da un precedente
marito di cui era rimasta vedova. La casa della coppia nel sobborgo di Oakdale,
fuori Minneapolis, è stata vandalizzata dalla folla arrabbiata. I manifestanti
si sono ritrovati davanti all'abitazione mostrando cartelli alle auto di
passaggio e gridando il nome di Floyd. Morte George Floyd, le proteste nelle
città Usa: fiamme e scontri in strada da New York a Los Angeles in
riproduzione.... Condividi Chauvin è stato arrestato venerdì con l'accusa di
omicidio preterintenzionale e omicidio di terzo grado: rischia una condanna
massima di 25 anni. Il procuratore della Contea di Hennen, Mike Freeman, l'ha
definita "l'incriminazione più veloce in un'indagine contro un agente di
polizia". L'ex agente, 44 anni, è stato ripreso in un video mentre preme il
ginocchio sul collo di Floyd, dichiarato morto poco dopo essere stato
trasportato in ospedale. Il video-denuncia e la morte hanno suscitato proteste a
Minneapolis e in tutti gli Stati Uniti.
Irene Soave per il “Corriere della Sera” il 31 maggio 2020. «Mio
marito ha modi ruvidi, ma sotto l' uniforme è un tenerone». Diceva così Kellie
Chauvin, reginetta di bellezza del Minnesota, in un' intervista del 2018 subito
dopo l' incoronazione. Allora era sposata da otto anni al suo secondo marito,
Derek Chauvin: il poliziotto che a Minneapolis, il 26 maggio, ha ucciso George
Floyd arrestandolo con una violenza inspiegabile, e che per questo è in carcere
da venerdì. Poche ore dopo l' arresto, ieri, è arrivato l' annuncio di lei,
tramite avvocati: Kellie Chauvin «è devastata dalla morte di George Floyd e
desidera sciogliere il suo matrimonio». Licenziato, in carcere- dove il processo
potrebbe lasciarlo anche per 35 anni, pena massima possibile per i reati che gli
sono contestati - Derek Chauvin è ora stato lasciato solo «nella cattiva sorte»
anche dalla moglie Kellie; che ora chiede soprattutto «sicurezza e massima
privacy per tutta la nostra famiglia», inclusi i due figli avuti con il
precedente marito. Una doppia esigenza che in queste ultime ore si è rivelata
non peregrina. Nei giorni scorsi, i manifestanti che senza tregua infiammano
Minneapolis avevano raggiunto nel sobborgo di Oakdale la villetta di Derek e
Kellie Chauvin (già scappati) per un picchetto, che era culminato in scritte
come «Qui vive un assassino» sul selciato e lanci di secchi di vernice rossa. E
sui tabloid, che hanno subito passato al setaccio la vita di Derek Chauvin, è
stato riesumato tutto della vita di Kellie, persino una piccola vicenda
giudiziaria: nel 2004 aveva tentato di pagare la spesa con un assegno a vuoto,
42 dollari che non aveva e grande imbarazzo, poi era intervenuto il primo marito
e le aveva pagato la cauzione. Forse per lei - pure nata in Laos e vissuta per
anni in un campo di rifugiati perché appartenente alla minoranza Hmong, e già
vedova di un primo matrimonio combinato quando aveva solo 17 anni - la pressione
è stata insopportabile. Sta di fatto che ieri ha chiesto il divorzio. Eppure la
vita di Kellie Chauvin, nata Xiong nel 1974 in un Laos in guerra e diventata nel
2018 «Mrs. Minnesota» - «Signora Minnesota», un titolo di bellezza per donne
sposate e adulte che mette le vincitrici sulla strada di «Mrs. America» e poi di
«Mrs. World» - era già stata non priva di difficoltà. La sua famiglia appartiene
alla minoranza Hmong, un popolo che vive tra la Cina meridionale, il Vietnam e
il Laos: nella guerra del Vietnam gli Hmong si erano schierati prima con i
francesi e poi con gli americani, e negli anni Settanta molti dovettero fuggire.
Nel 1977 Kellie aveva tre anni quando la sua famiglia scappò in Thailandia, in
un campo profughi, dove «vivevamo nell' indigenza più totale: a oggi non mangio
fiocchi d' avena perché era l' unico cibo che ci davano», raccontava lei in un'
intervista rilasciata a un giornale locale dopo l' elezione a Miss. Nel 1980 li
accolgono gli Stati Uniti: prima nel Wisconsin, poi, molti anni dopo, lei si
trasferirà a Minneapolis, dove vive la più grande comunità Hmong del Paese.
Educazione tradizionale, matrimonio combinato a 17 anni con un connazionale
quasi sconosciuto: «I miei pensavano che dopo i 18 non mi avrebbe voluta
nessuno. Mi sforzai di fare funzionare le cose». Il matrimonio, che lei racconta
violento, dura 10 anni; nascono due figli, il marito muore. Nel frattempo Kellie
studia e diventa tecnica radiologa dell' Hennepin County Medical Center a
Minneapolis: lo stesso ospedale dove molti anni dopo è stato portato George
Floyd, già in stato d' incoscienza e senza polso. Ed è qui che conosce Derek
Chauvin, nel 2009: il poliziotto aveva portato un arrestato al pronto soccorso
prima di incarcerarlo. Poi era tornato, il giorno stesso, per chiederle di
uscire. Le nozze l'anno seguente: è il 2010, e poco dopo Kellie Xiong, ora
Chauvin, lascia il lavoro all' ospedale e ne trova uno meno impegnativo, agente
immobiliare. Lei e Derek non avranno figli, ma un matrimonio sereno e non privo
di dolcezze. «Da allora mi tiene ancora aperta la porta, mi infila il cappotto,
è un gentleman», raccontava lei alla locale Pioneer Press nel 2018, da fresca e
sorridente Mrs. Minnesota, la prima di radici Hmong nella storia del concorso.
«Del resto dopo una vita come la mia ho le idee molto chiare su quello che
voglio in una relazione, e su quello che non posso accettare». Un' intervista di
due anni fa che letta oggi, a poche ore dall' annuncio del divorzio immediato
dal marito ex «tenerone» diventato assassino in mondovisione, sembra spiegare
tutto.
Flavio Pompetti per “il Messaggero” il 31 maggio 2020. Negli
ultimi sei giorni è stato licenziato in tronco dalla polizia di Minneapolis,
arrestato e incriminato per due capi d'accusa che in totale prevedono un massimo
di 35 anni di reclusione. L'omicidio del quale è accusato ha messo a ferro e
fuoco una dozzina di città negli Stati Uniti; la moglie, ex Miss Minnesota 2018
per la classe delle donne adulte sposate, lo ha lasciato e ha già depositato la
richiesta di divorzio dopo dieci anni di matrimonio. La donna ora chiede
soprattutto «sicurezza e massima privacy per tutta la nostra famiglia», inclusi
i due figli avuti nelle nozze con il precedente marito, di cui era rimasta
vedova. Ha trovato un legale disposto a difenderlo dalle accuse di cui deve
rispondere, ma non ha ancora i 500.000 dollari necessari per la cauzione e per
la libertà in attesa del processo. È stata una settimana terribile per Derek
Chauvin, il poliziotto 44enne che lunedì ha ucciso un suo quasi coetaneo di
colore, nel corso di un arresto per un reato minore. Ma a guardare bene il
curriculum, la caduta precipitosa è in realtà la fine di una percorso, che
l'agente ha compiuto nel corso di diversi anni. Nel corpo di polizia cittadina
era entrato nel 2001, dopo aver lavorato come buttafuori e guardia di sicurezza
nei locali privati. Cinque anni dopo è coinvolto in un primo episodio ai limiti
della legalità. Chauvin interviene con altri 5 colleghi sulla scena di un
accoltellamento. La persona sospetta tira fuori il coltello all'arrivo delle
pattuglie, e uno degli agenti lo fredda con un colpo di pistola. Tre anni dopo è
lui stesso a sparare durante un'incursione per un caso di violenza domestica.
Nel referto si legge che l'assalitore ha cercato di impossessarsi dell'arma di
ordinanza del secondo agente, e Chauvin lo ha fermato sparandogli alla schiena e
uccidendolo. Nel 2011 un altro episodio che si conclude con un esito mortale.
Sei poliziotti sulla scena di una sparatoria. Il giovane 23enne Leroy Martinez
cerca di scappare, ma è raggiunto e colpito mortalmente da un collega di
Chauvin. I sei dichiarano che Martinez brandiva una pistola. Un testimone
oculare contraddice la versione: la giovane vittima si era arresa e aveva le
mani alzate, ma la sua voce resta inascoltata. Nel totale sulla sua scheda
personale di Chauvin ci sono 18 denunce di cittadini che raccontano episodi di
abuso subiti da parte dell'agente. Il gruppo di vigilanza privato contro la
brutalità della polizia: Stolen Lives, vite rubate, lo aveva inserito nel suo
database, e indicato come un soggetto pericoloso. La moglie Kelly non ha
resistito alla pressione degli ultimi giorni. Picchetti di contestatori si erano
accampati fuori dalla porta della sua abitazione, e con la vernice rossa avevano
scritto sul selciato: «Qui vive un assassino». Anche lei appartiene ad una
minoranza etnica. E' nata in Laos, nel seno della comunità Hmong, che negli anni
della guerra in Vietnam si erano schierati dalla parte degli Stati Uniti, e
collaborarono con i marines nelle azioni contro i vietcong. Per questo alla fine
del conflitto sono stati premiati con il trasferimento in zone dall'economia
depressa negli Usa, e sono sopravvissuti tra gli stenti continuando a coltivare
la terra come facevano in patria. Kelly si è emancipata con lo studio, è
divenuta una tecnica radiologa e aveva avuto due figli in un precedete
matrimonio che si era concluso con la morte del primo marito. Era convinta fino
alla scorsa settimana che Derek fosse un uomo dalla scorza dura, ma in fondo
tenero di cuore.
Minneapolis, da George Floyd al procuratore: personaggi e
interpreti di una tragedia Usa Minneapolis, personaggi e interpreti di una
tragedia statunitense. Chi sono e che ruolo hanno avuto la vittima, l’agente
arrestato, il sindaco, il capo della polizia e il procuratore.
Alessandra Muglia il 30 maggio 2020 su Il Corriere della Sera.
Volti e storie. Chi sono e che ruolo hanno avuto la vittima, l’agente arrestato,
il sindaco, il capo della polizia e il procuratore.
La vittima «Non respiro»: così la morte di George diventa
bandiera. George Floyd si era trasferito a Minneapolis alcuni anni fa, uscito di
prigione per un furto. Voleva ripartire, vagheggiava un lavoro, una nuova vita,
ha trovato la morte. La sua agonia è durata 9 lunghi minuti, ripresi nel video
di un passante. «Non riesco a respirare» ha ripetuto più volte George Floyd con
il volto a terra e le ginocchia del poliziotto che premevano sul collo, prima di
esalare l’ultimo respiro. Era stato fermato per aver tentato di usare una
banconota falsa in un supermercato. Ma chi era l'afroamericano la cui brutale
morte ha incendiato l’America? Ribattezzato dagli amici «Big Floyd» per la sua
stazza —«il gigante gentile» scrive Oscar Smallwood su Facebook — era nato 46
anni fa in North Carolina, ma si era trasferito a Houston, in Texas, dove vive
sua figlia di sei anni, Gianna, con la madre, Roxie Washington. La donna ha
detto allo «Houston Chronicle» che George era un buon padre. Floyd lascia anche
una fidanzata, Courtney Ross, che si è detta «affranta».
L’agente arrestato. Molte denunce per Chauvin che non doveva più
lavorare. Non avrebbe dovuto essere lì a occuparsi ancora di ordine pubblico
Derek Chauvin, il poliziotto di 44 anni che a un controllo su una strada di
Minneapolis ha premuto le sue ginocchia sul collo di George Floyd fino a farlo
morire soffocato. Nei suoi 19 anni di servizio aveva infatti collezionato 18
denunce per il suo comportamento violento, senza mai ricevere alcun procedimento
disciplinare, a parte una lettera di richiamo. Già nel 2006 il suo nome
compariva tra quelli dei poliziotti che, dopo essere entrati in una casa di
Minneapolis, aprirono il fuoco contro l’uomo che aveva tentato la fuga.
Nonostante quella controversa vicenda, Chauvin è rimasto in servizio e due anni
dopo è tornato protagonista di un altro episodio: intervenuto in una casa per un
incidente domestico, ha ingaggiato una colluttazione con una ragazza di 21 anni,
poi colpita con due colpi all’addome. Nel 2011 Chauvin è stato posto in congedo
temporaneo per un’altra sparatoria.
La scelta di Frey: avvocato di Ong ebreo praticante difende i
neri. Il democratico Jacob Frey, nato 38 anni fa vicino a Washington, da due
anni è il sindaco di Minneapolis, dove vive dal 2009. Avvocato attivo nelle Ong,
ebreo praticante, si è imposto promettendo più case popolari e rapporti più
distesi tra polizia e afroamericani. Dopo l’omicidio di George Floyd, si è
schierato con la famiglia e i leader delle associazioni: ha subito chiesto
l’incriminazione del poliziotto che ha schiacciato il collo di Floyd, trovando
una sponda nel capo della polizia. Frey però non è riuscito a placare la rabbia,
degenerata in incendi e saccheggi per due notti consecutive. Trump lo ha
attaccato definendolo «un sindaco debole, della sinistra radicale». Frey ha
risposto a tono: «Essere deboli vuole dire puntare il dito sugli altri nei
momenti di crisi». Ieri ha dichiarato: «I rivoltosi violenti arrivano da fuori».
Il capo della polizia. Arradondo: «Poca speranza,colpa nostra».
Dopo trent’anni di servizio Medaria Arradondo nel 2017 è diventato il primo nero
della storia a guidare la polizia di Minneapolis. Il suo predecessore si era
dimesso dopo che una donna (bianca) era stata uccisa sotto casa da un agente
(afroamericano) che lei stessa aveva chiamato per via delle urla sentite in
strada. Arradondo sembra invece determinato a portare avanti la sua missione
nella città in cui è nato 55 anni fa. «Mi scuso nel modo più assoluto per la
pena, la devastazione e il trauma che la morte di Mr Floyd ha provocato ai suoi
cari», aveva detto dopo l’omicidio. «So che al momento c’è un deficit di
speranza nella nostra città, e so che il nostro dipartimento ha contribuito a
questo deficit nel suo insieme». Dopo le scuse, Arradondo ha subito licenziato i
quattro agenti implicati nell’omicidio. Ma non aveva la competenza giuridica per
procedere all’incriminazione. Anche lui ha attribuito gli incendi e le violenze
a «gruppi esterni» al movimento di protesta.
Il procuratore. Liberal, 72 anni e cinque figli Freeman agisce in
tempo record. È un liberal di 72 anni il procuratore che ha disposto l’arresto
del poliziotto per l’uccisione di George Floyd. In una conferenza stampa Mike
Freeman ha spiegato che gli inquirenti hanno raccolto sufficienti prove per
l’incrimina-zione, mettendo insieme clip, testimonianze e il referto medico. Due
i capi di imputazione: un reato simile al nostro «omicidio colposo»
e manslaughter, sorta di ’«omicidio preterintenzionale». Il procuratore ha
sottolineato che «il provvedimento restrittivo» è arrivato «in tempo record»,
mentre «proseguono le indagini» sugli altri tre agenti implicati nel crimine.
Suo padre era Orville Freeman, già governatore del Minnesota e ministro
dell’Agricoltura con i presidenti Kennedy e Johnson. Sposato con la giornalista
Kathleen McCarthy e padre di 5 figli, in passato ha parlato dei suoi problemi
con l’alcol: l’anno scorso ha preso un breve congedo per seguire un programma di
recupero.
La capo della polizia di Atlanta. È instancabile Erika Shields,
la capo della polizia di Atlanta non si dà pace per quello che sta succedendo e
passa il tempo in strada a parlare con i contestatori per dire loro che è
disgustata da quello che sta succedendo. Laureata alla Webster University in
International Studies Shield è a capo della polizia dal 2016. «Sta parlando con
tutti quelli che la vogliono ascoltare — ha scritto una donna su Twitter - e ha
mandato via un poliziotto bianco perché le avevamo detto che si stava
comportando male». Anche Shields è bianca ma sa cosa vuol dire far parte di una
minoranza essendo lesbica e avendo lottato per essere accettata.
George Floyd, Vittorio Feltri su violenza e polizia: "Perché
per una volta siamo superiori agli Stati Uniti".
Vittorio Feltri Libero Quotidiano l'1 giugno 2020. Anche in Italia la gente non
è molto tranquilla. Sabato i cosiddetti gilet arancioni sono scesi in piazza per
protestare. Avranno avuto i loro motivi, tra i quali la crisi a cui ha dato la
stura il Covid, inclusa l'accentuazione del calo dei posti di lavoro. Ma tutto
sommato si è trattato di manifestazioni al cloroformio. Neanche uno schiaffo,
nemmeno una carica della polizia. Per il momento siamo un popolo mite, poco
incline alla violenza. Probabilmente tutti noi o parecchi di noi siamo stati
vaccinati negli anni Settanta, quando la moda ideologica imponeva ai giovani
rivoluzionari del cavolo l'uso della P38. In quel periodo ci siamo sfogati
abbastanza senza ottenere altri risultati che non fossero cataste di morti
ammazzati. E ci siamo calmati. Per fortuna. Le nostre forze dell'Ordine sono
serene, difficilmente si fanno prendere dal nervosismo e raramente mettono mano
alla fondina per ristabilire la pace. I connazionali si sono rassegnati a essere
governati da Conte e personaggi simili, piuttosto scarsi, e sopportano di essere
sequestrati in casa, obbligati a stare a distanza gli uni dagli altri, a non
viaggiare da una regione all'altra, e non osano disobbedire benché la
Costituzione glielo consentirebbe. Il nostro sarà un Paese allo sbando ma ha
sfoderato la virtù della pazienza. Il massimo che si concede è la libertà di
brontolare. Ha fatto del mugugno la sua arma più in voga. Mentre gli Stati
Uniti, che per molti versi noi ammiriamo in quanto efficienti, quando si
incavolano danno fuori da matti e invece di limitarsi a borbottare estraggono la
pistola e sparano per far capire al volgo chi comanda: la massa, bianca o nera
che sia, non è rispettata. Viene trattata quale carne da macello. Il caso del
ragazzo di colore soffocato col ginocchio da un agente ha scoperchiato una
reazione giustificata nella moltitudine di cittadini. Ormai siamo di fronte a
battaglie quotidiane e uomini e donne di pelle scura sono talmente fuori di sé
da far temere alle istituzioni di essere pronti a una autentica rivolta. È
evidente che gli scontri non sono stati causati da Trump, bensì dal
comportamento irresponsabile di un poliziotto crudele e incosciente che si è
accanito contro un giovanotto, il quale implorava di poter respirare. È assurdo
soffocare un ragazzo mettendogli il ginocchio sul collo fino a togliergli la
vita. Certi fatti non si giustificano, ed è normale che scatenino reazioni
rabbiose nella popolazione più sfortunata. Il presidente americano deve rendersi
conto che la polizia va educata per non consentirle di compiere azioni tanto
spietate. Vero che l'assassino è stato arrestato, e pure abbandonato dalla
moglie, significa che tutto sommato la gravità dell'episodio è stata percepita.
Ma è altrettanto vero che sotto la presidenza di Obama, il democratico, i tutori
dell'ordine commisero più reati di ora che a menare il torrone è appunto Trump.
Segno che la spietatezza dei tutori della legge è una tradizione degli States.
Questo è il punto. Il grado di civiltà di un Paese si misura in varie maniere,
non ultima quella di avere riguardo per la vita anche di chi sgarra.
«Noi non abbiamo nome. Se volete, chiamateci George Floyd».
Una notte con i manifestanti di Flatbush, quartiere a
sud di Brooklyn. In una battaglia di sassi, bottiglie, pietre. Teaser, spray al
peperoncino, manganelli e auto della polizia incendiate. Davide Mamone l'1
giugno 2020 su L'Espresso. Sono le sette di sera di sabato 30 maggio. La seconda
notte di scontri a New York. La terza di proteste nella città che non dorme mai.
La quarta in tutto il Paese, dove si manifesta contro l’ennesima morte ingiusta
di un cittadino afro-americano qualunque, George Floyd. Quel video amatoriale ha
fatto il giro del mondo. Ed è pensando a quel corpo inerme che perde conoscenza,
supino, sotto il ginocchio bianco dell’agente di polizia a Minneapolis, che gli
scontri si fanno più forti. A Flatbush, quartiere a sud di Brooklyn, si marcia
da tre isolati lungo Bedford Avenue, in modo pacifico. Ci sono canti. Ci sono
slogan. A un tratto un’esplosione, in coda al corteo. Si corre indietro a
vedere. C’è una macchina della polizia di New York sventrata. Inizia il
finimondo. Altre vetture della NYPD prendono fuoco come fiammiferi, la prima tra
Church Avenue e Bedford, a dieci minuti dal borghese quartiere residenziale di
Park Slope. Agenti caricano manifestanti, senza troppo guardare. Da una parte si
lanciano sassi, bottiglie di vetro, pietre. Dall’altra si usano i teaser, lo
spray al peperoncino, i manganelli e gli arresti. Gli agenti hanno la divisa
sporca di sangue. Le persone sono a terra ovunque. A essere colpito (e a uscirne
quasi indenne) è un ragazzo afro-americano di Flatbush. Ha 23 anni. È vestito
con una felpa e pantaloni neri. Un poliziotto durante gli scontri lo ha colpito
all’avanbraccio, dove tre lividi ora si fanno spazio sulla sua pelle. Come ti
chiami?, gli chiedo. «Non te lo dico, perché potrei avere qualsiasi nome», la
risposta. Poi ancora, gli occhi spaventati, i lacrimogeni ovunque, il rumore
degli elicotteri nel cielo, il cordone della polizia a due passi. «Non riesco
nemmeno a guardarlo, quel video. Ma il prossimo potrei essere io. George sarebbe
potuto essere ognuno di noi, non abbiamo nome in queste proteste». La polizia
di New York ha aperto un'indagine dopo la condivisione sui social di diversi
video che mostrano un'automobile della polizia sfondare una transenna e
travolgere una folla di manifestanti che circondava il mezzo. Il sindaco Bill de
Blasio ha confermato l'inchiesta sul caso ma ha anticipato che "gli agenti
potrebbero non aver avuto scelta". Le proteste dopo la morte di George Floyd
continuano in molte città degli Stati Uniti. La polizia sgombera la via con la
forza. Il ragazzo senza nome inizia a scappare. Seguono esplosioni, scontri,
attacchi e vetri. Ci saranno ovunque, nella Brooklyn dove vivono quasi
novecentomila afro-americani. A Bedstuy. A Flatbush. A Crown Heights. Davanti al
Barclays Center. In fondo a East New York. Sono le 72 ore di Brooklyn, dove
ragazze e ragazzi senza nome manifestano contro la morte di uno come loro.
L’ennesimo.
Le teorie del complotto sull’omicidio di George Floyd.
Giovanni Giacalone il 2 giugno su Inside Over. Le rivolte
scoppiate in varie città statunitensi in seguito all’omicidio di George
Floyd diventano sempre più violente, con auto della polizia assalite e date alle
fiamme, scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, auto della polizia che
passano sopra i dimostranti, stazioni della polizia bersagliate da molotov,
vetrine di negozi spaccate e non potevano ovviamente mancare i saccheggi ai
negozi, il cosiddetto “looting“, oramai un classico di ogni protesta seguita da
un abuso della polizia, fin dai tempi del caso “Rodney King” del 1991.
La società americana appare in stato confusionale, con la polizia divisa tra chi
passa sopra i manifestanti con l’auto e usa le maniere forti e chi invece decide
di togliersi il casco e stringere la mano ai dimostranti. Nella Third Ward di
Houston, quartiere dove era cresciuto George Floyd, il capo della polizia della
città texana, Art Acevedo, ha prima tenuto un discorso per solidarizzare con i
manifestanti e li ha poi invitati a manifestare pacificamente, unendosi egli
stesso al loro corteo. Persino le minoranze etniche appaiono confuse, con
i latinos che se in alcuni casi scendono in strada per manifestare contro la
brutalità della polizia, in altri casi recriminano che nessuno scende in strada
a protestare quando tocca a loro essere vittime di soprusi. Eloquente il post di
un ispanico del Texas con una foto di bambini trattenuti all’interno di una
recinzione dell’Ice e la scritta “perché nessuno scende in strada per noi quando
ci chiudono in gabbia”? Un altro utente denuncia invece il fatto che si scende
in strada a devastare auto della polizia quando un agente uccide qualcuno, ma ci
si guarda bene dal manifestare quando degli spacciatori uccidono una bambina di
sette anni. Una divisione sociale accompagnata anche da tutta una serie di
fantasiose teorie complottiste che vanno dal coinvolgimento dei cartelli
messicani nei disordini fino ad arrivare ai soliti piani segreti dei russi per
dividere l’America e condizionare le elezioni presidenziali. C’è poi chi arriva
addirittura a ipotizzare che George Floyd non sia realmente morto.
Il complottismo dilaga. Il Presidente americano Donald Trump ha
reso noto che gli Antifa saranno inseriti nella “black list” delle
organizzazioni terroristiche e di fatto è anche una decisione condivisibile. Se
per indicare il “terrorismo” utilizziamo la definizione di Boaz Ganor dell’ICT
di Herzliya e cioè: “Violenza perpetrata nei confronti di civili per motivi
politici”, allora il provvedimento può essere considerato più che legittimo. Il
fatto che eventuali Antifa possano essersi infiltrati tra i manifestanti per
cavalcare le proteste non stupisce perché si tratta di un tipico modus operandi
più volte attuato. La faccenda diventa però un po’ più colorita nel momento in
cui subentrano affermazioni come quelle di alcuni attivisti della destra che
hanno tirato in ballo una foto del Procuratore generale del Minnesota, Keith
Ellison, con una copia dell’ “Anti-Fascist Handbook”, come se fosse una prova
incriminante di non si sa bene quale piano malefico partito dall’alto. I
sostenitori della sinistra Dem e di quella radicale hanno invece tirato in ballo
i soliti oscuri complotti russi che vengono “estratti dal cappello” ogni
qualvolta che la sinistra americana è in crisi o anche solo semplicemente per
attaccare Donald Trump. La docente di Giurisprudenza dell’Università del
Michigan, Barb McQuade, ha twittato un link all’articolo del New York Times con
il commento “rapporti dell’intel indicano che l Russia sta cercando di seminare
il caos in America prima delle elezioni. Missione compiuta”. Una tattica, quella
della “russofobia” che è deleteria per le stesse agenzie di sicurezza
statunitensi ed anche soltanto per una questione di immagine. Se infatti il
Cremlino avesse realmente tutta questa capacità di penetrazione strutturale in
Usa, allora ci sarebbe veramente da chiedersi cosa fanno tutto il giorno le
agenzie americane per la sicurezza. Il governatore del Minnesota Tim Walz e il
sindaco di Minneapolis Jacob Frey sono arrivati addirittura a puntare il dito
contro i suprematisti bianchi e contro i cartelli messicani della droga per le
violenze scatenatesi in città, come riportato dal New York Post. Nella serata di
sabato sui social sono persino comparsi post che accusavano la MS13-Mara
Salvatrucha, famigerata gang salvadoregna ampiamente presente anche in Usa, di
essere i “burattinai” delle manifestazioni svoltesi in California, al punto che
un membro della gang interpellato da Insideover ha riferito: “Ci tirano in mezzo
anche quando non abbiamo fatto niente”.
Morti strane e misteriosi personaggi. Vi sono poi alcuni che
arrivano persino a mettere in discussione la reale morte di George Floyd, come
un utente californiano che scrive:” Qualcuno ha visto il filmato di George Floyd
mentre veniva portato via? Lo hanno preso gli agenti? È arrivata un’ambulanza?
Lo hanno messo su una barella?….Mi chiedo se sia realmente morto”. Un altro
utente pubblica un filmato dove si vedono due individui con uniforme della
polizia che escono da un’ambulanza con una barella e caricano Floyd per portarlo
via e si chiede come mai non vi fosse personale medico, sottolineando anche la
strana maniera, poco professionale, con la quale l’arrestato viene messo sulla
barella. Immancabile poi l’uomo del mistero, un uomo bianco con cappuccio nero e
maschera anti-gas dai filtri fuxia (ottimo per passare inosservati) che
camminava con l’ombrello aperto e spaccava a martellate le vetrate di un negozio
di auto di Minneapolis. Alcuni manifestanti lo hanno redarguito, ma lo strano
personaggio ha evitato battibecchi ed è sparito. A quel punto è subito stato
ipotizzato che si potesse trattare di un agente provocatore, al punto che il
Dipartimento di Polizia di Minneapolis si è trovato costretto a smentire la
cosa. Intanto il medesimo personaggio veniva avvistato in altre città americane.
Come già detto lo scorso 31 maggio, le cause del pandemonio scatenatosi in Usa
vanno ricercate in tutta una serie di fattori che includono anche problematiche
inter-etniche (definirlo semplice razzismo sarebbe riduttivo) ma che si
coniugano con una società tendenzialmente violenta dove gli eccessi arrivano sia
da parte di chi porta il distintivo che da parte di chi infrange la legge. I
video dell’aggressione a una donna su sedia a rotelle (a sua volta armata di
coltello), piuttosto che la devastazione di auto della polizia a Philadelphia
parlano chiaro. Eppure c’è chi preferisce cercare misteriose mani nascoste e
strani complotti quando le ragioni di tutto ciò sono più che evidenti. Una
violenza che si rispecchia tra l’altro anche nella politica, dove oramai da
tempo si cerca di screditare i candidati presidenziali a colpi di scandali
e impeachment. Abraham Lincoln e John F. Kennedy non ebbero invece questo
privilegio.
I veri motivi delle proteste negli Stati Uniti.
Giovanni Giacalone il 31 maggio 2020 su Inside Over. Il caso del
46enne George Floyd, originario della “Third Ward” di Houston e ucciso il 25
maggio a Minneapolis durante l’arresto condotto dall’agente di polizia Derek
Chauvin, ha generato un’ondata di violente proteste in molte città statunitensi,
con tafferugli e roghi, uno dei quali appiccato contro la stazione di polizia
del Third Precint della città del Minnesota. L’eccessiva violenza della polizia
americana causa dunque un’altra vittima e per l’ennesima volta si scatenano i
cosiddetti “riots“, sommosse con tanto di devastazioni di proprietà pubbliche e
private, incendi, aggressioni e saccheggi di negozi. Le dinamiche sono oramai a
grandi linee sempre le stesse e fanno parte della turbolenta storia dell’ordine
pubblico statunitense che spesso degenera in disordine pubblico. Il caso
di Rodney King fa scuola, quando l’allora 26enne afro-americano venne massacrato
a colpi di manganello e taser da un gruppo di agenti della polizia di Los
Angeles che vennero poi assolti, causando così i cosiddetti “L.A. Riots”
dell’aprile 1992. Casi come quello di George Floyd e Rodney King ce ne sono
purtroppo parecchi e vengono spesso relazionati a un problema di razzismo da
parte della polizia statunitense, ma è realmente così? O forse la questione può
essere ricollegata all’eccessiva violenza utilizzata dagli agenti ma anche della
società stessa, a prescindere dal colore della pelle? Per rispondere a questa
domanda è utile prendere in esame alcuni dati.
Il rapporto tra “bianchi” e “neri” uccisi dalla polizia. Uno
studio effettuato dalla Statista Media Platform ha dimostrato come nel 2017 il
numero di “bianchi” uccisi dalla polizia risulta essere di 457, mentre i “neri”
223; nel 2018 il rapporto scende a 399 (B) e 209 (N); nel 2019 i numeri vanno a
370(B) e 235 (N). In poche parole, tra il 2017 e il 2019 la polizia ha ucciso
1226 “bianchi” e 667 “neri”. I dati della Statista MP confuterebbero dunque la
teoria secondo cui la polizia uccide più afro-americani. Un caso noto di
“bianco” ucciso dalla polizia è quello di Daniel Shaver, ammazzato dall’agente
di polizia Philip Brailsford durante il suo arresto mentre era disarmato.
L’agente venne successivamente assolto e riuscì anche ad andare in pensione con
tanto di “bonus” per il trauma che avrebbe sofferto in seguito all’aver ucciso
Shaver. Dinamiche a dir poco allucinanti che mettono però in primo piano tutta
una serie di problemi che riguardano la polizia americana e cioè la
militarizzazione, l’assenza di trasparenza, l’impunità anche nei casi più
evidenti di responsabilità, il ricorso alla violenza anche in situazioni che non
la richiedono. Per capirsi, Shaver venne ucciso con cinque colpi sparati con un
fucile da assalto AR-15 mentre strisciava disarmato a terra, su istruzione degli
agenti accorsi sul posto, nel corso dell’arresto. Secondo l’agente di polizia,
Shaver aveva avvicinato la mano al fianco mentre era steso a terra
(probabilmente per tirarsi su i pantaloni) e Brailsford gli aveva quindi
scaricato addosso cinque colpi nel timore che stesse per prendere un’arma.
Peccato che Shaver era stato trovato in possesso di un semplice fucile a pallini
che aveva tra l’altro già consegnato appena arrivati gli agenti. La violenza,
spesso gratuita, della polizia americana è però documentata anche in molte altre
situazioni dove cittadini vengono arrestati anche solo semplicemente per non
aver messo le mani sul volante durante un “pull-over” per eccesso di velocità o
per aver protestato nei confronti degli agenti. L’aggressività della polizia non
risparmia neanche i minori, come nel caso di Honestie Hodges, ragazzina
afro-americana di 11 anni “aggredita” da alcuni agenti vicino casa sua nel 2017
in Michigan.
Una società violenta. Più che un problema di razzismo, il
problema può essere ricollegato a una società tendenzialmente violenta in un
Paese dove si può essere uccisi a colpi di arma da fuoco per una “banale”
rapina, per un “drive-by shooting” tra gangs, per aver suonato alla porta
sbagliata nella sera di Halloween, ma si può anche essere ammazzati dalla
polizia per una “banale” infrazione. Le stesse reazioni ad aggressioni e omicidi
ingiustificati da parte della polizia sfociano spesso in proteste che a loro
volta degenerano in tumulti ai quali si uniscono teppisti e delinquenti di
strada che approfittano della situazione per saccheggiare negozi, facendo così
passare in secondo piano l’omicidio di turno e legittimando la conseguente linea
dura da parte delle forze dell’ordine. Chi ha vissuto i giorni degli “L.A.
Riots” del 1992 sa bene di cosa si parla. Un’ulteriore segnale di allarme è
l‘invasione del Capitol Hill del Michigan lo scorso aprile da parte di uomini
armati della “Michigan Liberty Militia” che protestavano contro il “lockdown”
imposto per l’emergenza Covid. La questione del razzismo è certamente presente
in alcuni contesti, ma ridurre tutto a ciò significa perdere di vista una serie
di aspetti che indicano come la questione sia ben più complessa e come le cause
vadano ricercate altrove.
Chi sono gli Antifa americani che Trump vuole mettere al
bando. Pubblicato lunedì, 01 giugno 2020 da La
Repubblica.it. Il collettivo radicale di estrema sinistra non ha un leader ed è
strutturato in cellule locali. Cresciuti dopo l'elezione del presidente nel
2016, ora il capo della Casa Bianca li vuole inserire nella lista delle
organizzazioni terroristiche. "Azione antifascista", meglio conosciuto come
Antifa, è un collettivo internazionale radicale presente in molti Paesi: dalla
Germania al Regno Unito, dalla Svezia all'Italia fino agli Stati Uniti. Un
movimento che si oppone ai neonazisti, al fascismo, ai suprematisti bianchi e al
razzismo. Antifa si è fatta conoscere in America in occasione degli scontri
contro i suprematisti bianchi al raduno "Unite the Right" a Charlottesville, in
Virginia, nel 2017. Senza un leader e organizzata in cellule locali autonome, è
nata in opposizione ai movimenti di estrema destra, scrive il New York Times, fa
campagna contro azioni che considerano autoritarie, omofobe, razziste o
xenofobe. Sebbene non sia affiliata con altri movimenti a sinistra, i loro
membri a volte lavorano con reti di attivisti locali come il movimento Occupy o
Black Lives Matter. Questa galassia di organizzazioni di estrema sinistra,
alcune delle quali teorizzano e praticano l'azione violenta come i black bloc, è
finita nel mirino del presidente Trump, che la vuole inserire nella lista delle
organizzazioni terroristiche. Negli Stati Uniti il gruppo ha iniziato a crescere
dopo l'elezione del presidente Trump nel 2016, per contrastare la minaccia
dell'alt-right, la destra alternativa. Uno dei primi gruppi negli Stati Uniti ad
usare il nome Antifa fu 'Rose City Antifa', fondata nel 2007 a Portland. Ha un
ampio seguito sui social media, dove condivide articoli di notizie e talvolta
cerca di rivelare le identità e le informazioni personali di figure della destra
americana. Il movimento è stato ampiamente criticato dalla sinistra e dalla
destra tradizionali. Dopo le proteste a Berkeley, in California, nell'agosto
2017, Nancy Pelosi ha denunciato "le azioni violente di persone che si
definiscono antifa" e ha affermato che dovrebbero essere arrestate.
Antifa, ecco chi sono gli estremisti violenti di sinistra che
stanno mettendo a ferro e fuoco gli Usa. Redazione su
Il Secolo D'Italia lunedì 1 giugno 2020. Sono polarizzati contro Trump e la
destra, sono gli Antifa, il gruppo estremo e violento che non accetta l’esito
democratico delle elezioni Usa. Nel puntare il dito contro i presunti
responsabili delle proteste che infiammano il paese, il presidente americano
Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti inseriranno gli attivisti Antifa
di estrema sinistra tra le organizzazioni terroristiche. C’è chi fa notare come
gli Stati Uniti non sono dotati di una legge sul terrorismo interno. E
sostengono che "antifa" non è un’organizzazione con un suo leader, una sua
struttura definita o dei ruoli e dei mandati al suo interno. A sottolinearlo è
oggi il New York Times. Che cerca di fare il punto su questi manifestanti di
Antifa ed i loro obiettivi. Piuttosto, scrive il giornale, Antifa è un movimento
di attivisti che condividono filosofia e tattiche. Si sono fatti notare con la
loro presenza in occasione di varie proteste negli anni recenti, tra cui "Unite
the Right" a Charlottesville nel 2017. E’ impossibile sapere quante persone si
considerino membri di Antifa, scrive il giornale. I suoi seguaci ammettono che
il movimento Antifa è circondato dal riserbo. Non ha leader ufficiali. Ed è
organizzato in cellule autonome. Inoltre si tratta di uno solo dei movimenti di
attivisti all’interno di un’ampia costellazione di gruppi. Che negli ultimi anni
si sono uniti per opporsi alla destra. Anche alla destra repubblicana
democraticamente eletta. I membri di antifa contestano le azioni che considerano
autoritarie, omofobiche, razziste o xenofobe. Il movimento non è affiliato ad
altri gruppi a sinistra. Ma i suoi attivisti a volte collaborano con altre reti
locali che protestano sulle stesse tematiche, ad esempio Occupy o Black Lives
Matter. Gli obiettivi sono genericamente quelli di contrastare l’azione messa in
atto da gruppi considerati fascisti, razzisti e di destra per dotarsi di una
piattaforma che consenta loro di promuovere il loro punto di vista. L’idea di
partenza è che l’espressione di tali ideologie provochi azioni dirette contro
gli emarginati, quali minoranze razziali, donne, membri della comunità
L.G.B.T.Q. “La loro tesi è che la militanza antifascista sia intrinsecamente
un’azione di autodifesa per via della violenza documentata rappresentata dai
fascisti, soprattutto per la gente marginalizzata”, spiega Mark Bray, del
Dartmouth College, interpellato dal quotidiano. Molti organizzatori aderenti ad
Antifa partecipano a molte forme pacifiche di organizzazione comunitaria. Ma
ritengono che l’uso della violenza sia giustificato dal fatto che se i gruppi
fascisti o razzisti sono autorizzati ad organizzarsi liberamente, “questo
porterà inevitabilmente a violenze contro gli emarginati”, aggiunge. Quanto alle
origini del movimento si ritiene che molti si siano uniti ad esso negli Stati
Uniti a seguito dell’elezione di Trump nel 2016. Per contrastare la minaccia
proveniente dall’alt-right, la destra alternativa. Il movimento ha acquistato
maggiore visibilità nel 2017. Dopo una serie di azioni. Tra cui gli scontri con
i nazionalisti bianchi a Charlottesville. Il movimento Antifa è stato ampiamento
criticato dalla politica mainstream, a destra come a sinistra. Dopo le proteste
a Berkeley, California, nel 2017 Nancy Pelosi aveva condannato “le azioni
violente di gente che si fa chiamare antifa” ed aveva detto che dovevano essere
arrestati. Quanto ai conservatori, hanno ripetutamente condannato le loro azioni
sostenendo che i militanti del movimento stanno cercando di impedire la libera
espressione del loro pensiero politico.
Chi sono gli “Antifa”. Emanuel
Pietrobon l'1 giugno 2020 su Inside Over. Gli Stati Uniti sono scossi dalla più
imponente e vasta rivolta sociale della loro storia recente, incendiata dalla
presenza di elementi razziali. La brutalità poliziesca contro le minoranze,
rappresentata iconicamente dalla morte di George Floyd, ha scatenato le proteste
che poi si sono trasformate in saccheggi e scontri con le forze dell’ordine,
palesando l’esistenza di un altro grave problema della società americana: la
violenza. Fra i movimenti che hanno contribuito ad elevare il carattere degli
scontri, rendendoli organizzati, consentendone la diffusione capillare
sull’intero territorio nazionale, ve n’è uno che ha attratto l’attenzione della
Casa Bianca per il suo marcato estremismo: il collettivo di sinistra radicale
noto come “Antifa“.
Le proteste per George Floyd. Le violenze sono scaturite
dalla morte di George Floyd, afroamericano 46enne che il 26 maggio è deceduto a
Minneapolis, in pieno giorno, dinanzi gli occhi della folla e delle fotocamere
dei loro cellulari, dopo che un agente di polizia gli ha premuto con forza il
ginocchio sul collo per più di cinque minuti. Quella morsa si è rivelata fatale:
Floyd ha smesso di respirare e le sue ultime parole “I can’t breathe” (let. Non
riesco a respirare) hanno suscitato uno sdegno tale da spingere decine di
migliaia di persone ad occupare le strade in ogni parte del paese, da
Minneapolis a Los Angeles, da Washington D.C. a New York. Violenti scontri e
saccheggi si sono registrati e si registrano nelle più grandi metropoli, la
sicurezza fisica della stessa Casa Bianca e dei suoi inquilini è stata
minacciata da scontri fra manifestanti e forze dell’ordine nella notte del 31
maggio, e l’imposizione di rigidi coprifuochi e l’entrata in scena della Guardia
Nazionale sono stati inevitabili. Il bilancio dei disordini, al 31 maggio, è un
vero e proprio bollettino di guerra: in 15 stati è stata richiamata la Guardia
Nazionale, per un totale di oltre 5mila truppe per le strade, più di 4mila
persone sono state arrestate, in 12 grandi città vige il coprifuoco.
La decisione di Trump: Antifa, un'organizzazione terroristica. Il
31 maggio, Donald Trump ha utilizzato il proprio profilo ufficiale su
Twitter per comunicare che il collettivo apolide Azione antifascista,
popolarmente noto come “Antifa”, sarà prossimamente qualificato
come organizzazione terroristica. La decisione fa seguito alla consapevolezza
che i manifestanti appartenenti ai movimenti autonomi dell’estrema sinistra,
riconoscibili dal vestiario e dai simboli utilizzati, stanno giocando un
ruolo-chiave nell’esportazione delle violenze da Minneapolis al resto del paese,
in collaborazione con Black Lives Matter. L’eventuale concretizzazione
dell’annuncio di Trump comporta al tempo stesso problematiche e gigantesche
opportunità. Le problematiche vertono sul fatto che Antifa non è
un’organizzazione dalla struttura centralizzata, opera in numerosi paesi
occidentali attraverso cellule che sono completamente autonome l’una dall’altra,
anche all’interno della stessa nazione, e che non possiedono né liste di membri
ufficiali né una dirigenza riconoscibile e riconosciuta. Antifa, in pratica ed
in sostanza, è un termine ombrello riferibile più ad una costellazione
transnazionale di movimenti fra loro poco o nulla comunicanti e collegati che ad
un’entità formale e perseguibile. Questo è il motivo per cui, fino ad oggi, è
stato difficile definire un’agenda nei confronti di Antifa, di cui Trump aveva
proposto la messa al bando già l’anno scorso. Ad ogni modo, la minaccia è reale
e non si tratta di una mossa elettorale: fra il 2010 e il 2016, i gruppi della
sinistra radicale hanno compiuto il 12% di tutti gli attentati avvenuti sul
suolo statunitense, in aumento rispetto agli anni precedenti. I movimenti
Antifa, similmente alle controparti della destra alternativa (alt right),
alternano militanza reale e virtuale. La prima è divenuta sempre più palese e
propensa alla violenza negli anni recenti, in particolare a partire dal 2016. La
seconda indica l’attivismo in rete, su internet, luogo in cui i movimenti Antifa
sono incredibilmente presenti, disponendo di propri organi di informazione, siti
web, blog, e di pagine sulle principali piattaforme sociali, come Facebook e
Twitter. Internet è il luogo in cui gli Antifa fanno proselitismo ed organizzano
le proteste, coordinano gli attacchi, stabiliscono i propri obiettivi. Queste
problematiche nascondono, come scritto, delle gigantesche opportunità. Il fatto
che i movimenti Antifa utilizzino la rete come sede centrale delle loro
attività, li rende facilmente monitorabili e consente agli investigatori di fare
una stima approssimativa, ma realistica, delle persone che vi fanno parte, dei
simpatizzanti ed anche delle sigle operanti sul territorio. Per quanto riguarda
queste ultime, fra le più importanti e violente si segnalano: By Any Means
Necessary, Redneck Revolt e Anti-Racist Action. Assenza di un corpo unitario, di
una dirigenza, di elenchi di iscritti e carattere de-territorializzato, non
rappresentano quindi un ostacolo insormontabile alla schedatura dei sospetti e
alle indagini. In effetti, le organizzazioni terroristiche internazionali
presentano le stesse caratteristiche, con l’unica differenza di possedere un
centro di comando definito, e le agenzie di sicurezza di tutto il mondo hanno
perfezionato le loro tattiche nel contrasto a simili entità negli anni della
guerra al terrore.
Obiettivi, ideologia, pericolosità. Il movimento Antifa è
un amalgama transnazionale, ricco e complesso, composto da movimenti autonomi il
cui unico trait d’union è l’ideologia, ossia la condivisione di valori,
l’aderenza ed il cieco supporto a scuole di pensiero, visioni del mondo e valori
appartenenti alla produzione culturale della sinistra radicale: anarchismo,
anticapitalismo, anti-conservatorismo, anti-identitarismo, comunismo, femminismo
di terza e quarta ondata, marxismo-leninismo, socialismo rivoluzionario, teoria
queer. Gli Antifa esaltano tutto ciò che viene ritenuto suscettibile di
accelerare il collasso del sistema capitalista e dell’America intesa come un
attore storico bianco-centrico, imperialista, razzista e suprematista nei
confronti di minoranze etniche e religiose. Coerentemente e conseguentemente,
negli anni recenti, i collettivi di estrema sinistra statunitensi hanno dato
vita a delle lotte di notevole virulenza per l’abbattimento delle statue
ritraenti personaggi degli Stati confederati, per la cancellazione di feste come
il Columbus Day, per la riscrittura dei curricula universitari in direzione
della de-bianchizzazione e, ovviamente, hanno mostrato una
crescente insofferenza verso la destra alternativa e nei confronti di tutti
coloro la cui libertà di pensiero viene reputata dannosa. Sono sempre i
collettivi Antifa, infatti, ad essere dietro le campagne contro la libertà di
parola nei campus delle più prestigiose università statunitensi, organizzate con
l’obiettivo di ridurre al minimo la visibilità e l’influenza di studenti,
attivisti e politici di destra. Quest’ultimo punto, che mina le fondamenta
stesse della democrazia nel nome della sua presunta difesa dalla minaccia
fascista, ha spinto Trump ad intervenire, il 21 marzo dell’anno scorso, con un
ordine esecutivo che punisce, tramite privazione di fondi pubblici, tutti quei
college e quelle università che non riescano a garantire la libertà di parola al
loro interno. L’insieme di queste azioni ha spinto la società civile a prendere
le distanze dagli Antifa e ha attratto l’attenzione degli enti impegnati nel
monitoraggio degli estremismi, come l’Anti-Defamation League (ADL), delle
autorità federali e dei servizi segreti, le cui prese di posizione non lasciano
spazio a dubbi circa la pericolosità del movimento. L’ADL ha denunciato le
azioni degli Antifa come anti-democratiche, pericolose e fonte di ulteriore
polarizzazione sociale; il New Jersey Office of Homeland Security and
Preparedness collega il movimento all’estremismo anarchista ed evidenzia come
sia composto da elementi radicali disposti ad esercitare violenza per
raggiungere i loro scopi; e dal 2017 il Dipartimento della Sicurezza Interna
(DHS) e la Federal Bureau Investigation (FBI) hanno aumentato la sorveglianza
sui circoli Antifa, anticipando Trump nel parlare del movimento come espressione
di “terrorismo domestico“.
Le azioni più eclatanti. Il movimento Antifa ha iniziato a
conquistare la visibilità mediatica, e la conseguente attenzione delle agenzie
di sicurezza, fra le presidenziali del 2016 e la prima parte del 2017,
continuando a rendersi protagonista di eventi eclatanti fino ad oggi, in
un circolo crescente di violenza. Nel corso del 2016, gli Antifa hanno
guidato il fronte popolare delle proteste anti-Trump, unendosi e mescolandosi ai
black bloc in azioni di disturbo dirette agli eventi repubblicani e
contraddistinguendosi per i pestaggi ai danni dei sostenitori dell’attuale
presidente. È stato il 2017, però, l’anno della svolta e della definitiva
emersione degli Antifa quali attori dal potenziale realmente destabilizzante,
come si può comprendere dagli eventi elencati di seguito. Da febbraio a
settembre, la città di Berkeley (California) è stata scossa da disordini e
violenze perpetrate dagli Antifa ai danni di simpatizzanti repubblicani e
persone ordinarie, colpevoli di prendere semplicemente parte a eventi e marce in
supporto di Trump, e di figure di spicco della destra alternativa, come
l’attivista Milo Yiannopoulos. Il fattore detonante è stato proprio un invito
dell’università cittadina a Yiannopoulos, che avrebbe dovuto tenere un
comizio il 1 febbraio, ma l’evento è stato bloccato dal raduno dinanzi il campus
dell’ateneo di centinaia di black bloc e Antifa, alcuni appartenenti al gruppo
“By Any Means Necessary”. L’assembramento ha poi assunto la forma di un’isterica
battaglia contro polizia e studenti di destra combattuta con pietre, bombe
molotov ed altri oggetti reperibili in strada, che si è poi estesa nel resto
della città, dove i radicali di sinistra hanno vandalizzato esercizi commerciali
e banche. L’arrivo di Yiannopoulos ha messo in allerta gli Antifa californiani,
che hanno rapidamente trasformato Berkeley in una città-santuario,
interrompendo marce pacifiche regolarmente permesse dalle autorità, non di
estremisti di destra ma di semplici simpatizzanti repubblicani, come la “March 4
Trump” del mese seguente. In agosto è stato il turno
di Charlottesville (Virginia), scelta da gruppi di destra alternativa e del
nazionalismo bianco come sede di una due-giorni di mobilitazione, dall’11 al 12,
per protestare contro l’arrivo in città della guerra contro i simboli
confederati. L’obiettivo della marcia, denominata “Unite the Right“, era di
persuadere l’amministrazione locale a non rimuovere la statua del generale
Robert Lee dal parco-simbolo della città, tra l’altro dedicato a suo nome. Come
è noto, l’evento si è concluso in scontri, per via della decisione degli Antifa
di giungere in città e dar vita ad una contro-manifestazione, e con una tentata
strage con macchina da parte di un attivista di destra, terminata con un morto e
19 feriti. Il 2018 ha sancito l’inizio di un cambio di paradigma: il focus degli
Antifa è stato spostato dalla lotta di strada contro gli attivisti dell’estrema
destra e gli elettori repubblicani alla caccia contro i rappresentanti delle
istituzioni e gli esponenti di spicco del mondo conservatore. I due eventi più
emblematici, a questo proposito, sono stati le minacce di morte al
giornalista Tucker Carlson da parte di un gruppo noto come “Smash Racism”, che
ha anche organizzato proteste dinanzi casa sua, e la pubblicazione in rete con
intento intimidatorio di nomi e fotografie di 1.595 agenti dello U.S.
Immigration and Customs Enforcement, l’agenzia federale per il controllo
dell’immigrazione e delle frontiere, da parte degli “Antifa del Nebraska”.
I legami internazionali. La Turchia sta seguendo con attenzione
l’evoluzione dei disordini negli Stati Uniti e ha accolto con interesse
l’annuncio di Trump circa la designazione del movimento Antifa quale
organizzazione terroristica. Il motivo, come spiega in maniera chiara un
recentissimo approfondimento di TRT World, il sito web della principale azienda
radiotelevisiva turca, è che la bandiera del movimento Antifa è stata vista
sventolare ed è stata fotograta nel Rojava, una regione siriana in cui si trova
un’importante sacca di resistenza curda. Secondo TRT, dal 2014 ad oggi,
centinaia di esponenti del movimento Antifa provenienti da Europa e Stati Uniti
si sarebbero arruolati come combattenti volontari nelle fila dell’Unità di
Protezione Popolare (YPG), un’organizzazione militare composta da curdi, arabi
ed occidentali che negli anni della guerra siriana ha combattuto sia contro lo
Stato Islamico che contro le forze irregolari filo-turche. Ed è proprio nel
Rojava che gli Antifa avrebbero fatto il salto di qualità, ricevendo
addestramento, apprendendo l’arte della guerra asimmetrica e, soprattutto,
facendo esperienza diretta sul campo con combattimenti quotidiani. Come riporta
TRT, le autorità turche avrebbero indagato sul flusso di combattenti stranieri
che ha ingrossato le unità dell’YPG, scoprendo che la maggior parte di loro era
di origine statunitense e rispondente alle seguenti caratteristiche: adesione
all’anarchismo, all’ecologismo radicale e/o al femminismo, tendenzialmente di
giovane età e con alcuni casi di ex tossicodipendenze.
I prodromi degli Antifa: la rivoluzione culturale degli anni '60.
La storia del movimento Antifa è relativamente recente e può essere ricondotta
ai turbolenti anni ’60, il decennio di insurrezione controculturale che
ha cambiato per sempre il volto delle società occidentali, segnando l’inizio di
un percorso lungo, tortuoso e non privo di tensioni sociali ed
intergenerazionali, che ha avuto come mete finali lo sdoganamento dei diritti
lgbt, l’avvento del post-cristianesimo e la messa in discussione dell’idea
stessa di “civiltà occidentale” e dei suoi cardini fondamentali: religione,
cultura, aspetti etno-razziali. Nel caso degli Stati Uniti, la rivoluzione
culturale degli anni ’60 ha portato alla fine della segregazione razziale,
all’inizio delle lotte di liberazione sessuale, alla nascita dei movimenti per
la legalizzazione delle droghe, all’emergere della Nuova Sinistra (New Left) e
all’espansione di nuovi movimenti religiosi e sociali, come le varie sette New
Age e gli hippie, caratterizzati da una forte vena antisistemica e in ribellione
contro i “valori tradizionali”. Ed è proprio nel seno di questa epoca
dall’impronta storica che possono essere trovati i prodromi del movimento
Antifa, che non sarebbe errato considerare la naturale evoluzione di esperimenti
anteriori, ugualmente radicali e propensi alla violenza, come i gruppi
del potere nero, l’Esercito di Liberazione Simbionese, Weather Undeground e
Students for a Democratic Society.
La polarizzazione durante l'era Obama. Il terrorismo della
sinistra radicale ha una lunga tradizione storica negli Stati Uniti, le cui
origini affondano nel sindacalismo rivoluzionario tardo-ottocentesco, ma è
sempre stato considerato una minaccia minoritaria alla sicurezza nazionale
rispetto al suprematismo bianco o al jihadismo. Ma negli ultimi anni, più
precisamente a partire dall’inizio dell’era Obama, qualcosa è cambiato: la
polarizzazione economica e sociale è aumentata in maniera dirompente, insieme
alla cristallizzazione delle tensioni inter-etniche, mentre la sinistra
moderata, i cosiddetti “liberal”, è stata interessata da
una radicalizzazione ideologica che ne ha spostato ambizioni, agenda e discorso
politico su posizioni sempre più oltranziste. Questa, almeno, è la tesi del Pew
Research Center, secondo cui il principale lascito delle due presidenze Obama è
stato l’aumento della polarizzazione politica, causata dall’estremizzazione
degli elettorati di sinistra e destra e da tutto ciò che questo comporta sul
piano delle relazioni sociali, di classe e fra etnie. In breve, negli anni
dell’era Obama si è assistito ad una profonda rottura sociale, simile per
gravità e dimensioni a quella degli anni ’60, le cui manifestazioni più
eloquenti sono state l’aumento delle divisioni inter-etniche, che hanno portato
alla nascita di Black Lives Matter e al ritorno in scena del nazionalismo nero,
le proteste sociali di movimenti come Occupy Wall Street, e la formazione di due
opposti estremismi in stile anni di piombo italiani: estrema destra,
rappresentata dalla rinascita del suprematismo bianco, ed estrema sinistra,
rappresentata dalla comparsa degli Antifa. Questi ultimi hanno rapidamente
trasformato la sinistra radicale da una forza irrilevante, sul piano della
violenza politica, ad una minaccia esistenziale per l’identità degli Stati
Uniti, fra guerre iconoclaste contro i simboli nazionali ed attacchi continui
alle libertà di parola e di assemblea fino al più recente ruolo-guida nella
regia dei disordini razziali più gravi della storia del paese, di gran lunga
peggiori della rivolta di Los Angeles del 1992, che hanno costretto gli
inquilini della Casa Bianca a rifugiarsi nel bunker dell’edificio, la notte di
venerdì 29 maggio: la prima volta di sempre per un presidente.
Gli Antifa, i black bloc a stelle e strisce.
Dietro i disordini ci sono i cuginetti violenti di italiani ed
europei. Gian Micalessin, Mercoledì 03/06/2020 su Il Giornale. Si fanno chiamare
«antifa» e al pari dei fratellini italiani ed europei di cui riprendono nome e
ideologia si arrogano non solo il diritto di decidere chi sia fascista e chi no,
ma anche di attaccarlo e colpirlo usando ogni forma di violenza. Proprio per
questo il Procuratore alla Giustizia William Barr li considera i fomentatori
occulti dei disordini che incendiano le città americane. Il direttore dell'Fbi
Chris Wray annuncia, invece, indagini a livello federale per individuare chi
stia commettendo violenze collegate alla loro specifica ideologia. Gli «antifa»
che Donald Trump promette d'incriminare per «terrorismo» e sbattere in galera
sono dunque i fratellini a stelle e strisce dei nostri centri sociali e di quei
«black bloc» anarco-insurrezionalisti responsabili di tante scorrerie nelle
città italiane ed europee. Definirli un prodotto d'importazione non è però
corretto. La prima apparizione di dimostranti vestiti di nero e con i volti
coperti da passamontagna risale al 1967 quando gli antesignani dei «black bloc»
sfilano a Wall Street. E anche la loro prima grande scorreria è in quella
Seattle che nel 1999 ospita la Conferenza del Wto (l'organizzazione mondiale del
commercio). Il nome e l'etichetta «antifa», apparsi per la prima volta a
Portland nel 2007, si diffondono, invece, solo con l'affermarsi di Donald Trump.
Per le frange anarchiche e di estrema sinistra «ciuffo biondo» diventa il volto
e l'immagine del loro immaginario nemico fascista. Per le autorità il marchio
«antifa» è invece sinonimo di vandalismo. Nel febbraio 2017 i disordini
scatenati all'università di Berkeley spingono anche la democratica Nancy Pelosi
a chiederne l'incriminazione. Pochi mesi dopo però gli «antifa» tornano in
azione a Charlottesville in Virginia, dove danno l'assalto ad una manifestazione
di suprematisti bianchi, neonazisti e incappucciati del Ku Klux Klan.
Considerarli i registi e gli unici artefici della violenze di questi giorni
potrebbe però rivelarsi eccessivo. Nonostante la proliferazione di sigle gli
«antifa» restano un movimento marginale, numericamente esiguo e senza una
leadership e di un coordinamento nazionale. L'aggressivo e capillare impiego
della rete, unito al sapiente utilizzo delle tecniche di guerriglia urbana,
potrebbe però aver consentito ai pochi, ma rodati militanti «antifa» di mettersi
alla testa delle frange più radicali della protesta. Incriminarli per
terrorismo, come promette di fare Donald Trump, non è però semplice. Non avendo
né dei capi, né una struttura nazionale gli «antifa» non possono essere
considerati una vera e propria organizzazione. E se anche lo fossero mancherebbe
una legge capace di trascinarli sul banco degli imputati. La classificazione
delle organizzazioni terroristiche come Al Qaida o lo Stato Islamico comprende
solo le organizzazioni straniere inserite nelle apposite liste del Dipartimento
di Stato. Manca invece un registro in grado di elencare i gruppi terroristi di
natura interna. Inoltre la legislazione statunitense, pur specificando gli atti
classificabili alla stregua di terrorismo, non ha mai definito la natura di
eventuali organizzazioni terroristiche operanti sul territorio federale. Quindi
per incriminare e sbattere in galera gli «antifa» Donald Trump deve prima far
approvare dal Congresso una legge che gli consenta di farlo.
Che cos’è Black Lives Matter.
Emanuel Pietrobon il 3 giugno 2020 su Inside Over. Gli Stati Uniti sono scossi
dalla più imponente e vasta rivolta sociale della loro storia recente,
incendiata dalla presenza di elementi razziali. La brutalità poliziesca contro
le minoranze, rappresentata iconicamente dalla morte di George Floyd, ha
scatenato le proteste che poi si sono trasformate in saccheggi e scontri con le
forze dell’ordine, palesando l’esistenza di un altro grave problema della
società americana: la violenza. Due sono le entità che hanno contribuito in
maniera fondamentale ad elevare il carattere degli scontri, rendendoli
organizzati in maniera scientifica e consentendone la
diffusione capillare sull’intero territorio nazionale: il movimento sociale
“Black Lives Matter” (Blm) e il collettivo di sinistra radicale noto come
“Antifa“.
Le proteste per George Floyd. Le violenze sono scaturite
dalla morte di George Floyd, afroamericano 46enne che il 26 maggio è deceduto a
Minneapolis, in pieno giorno, dinanzi gli occhi della folla e delle fotocamere
dei loro cellulari, dopo che un agente di polizia gli ha premuto con forza il
ginocchio sul collo per più di cinque minuti. Quella morsa si è rivelata fatale:
Floyd ha smesso di respirare e le sue ultime parole “I can’t breathe” (let. Non
riesco a respirare) hanno suscitato uno sdegno tale da spingere decine di
migliaia di persone ad occupare le strade in ogni parte del paese, da
Minneapolis a Los Angeles, da Washington D.C. a New York. Violenti scontri e
saccheggi si sono registrati e si registrano nelle più grandi metropoli, la
sicurezza fisica della stessa Casa Bianca e dei suoi inquilini è stata
minacciata da scontri fra manifestanti e forze dell’ordine nella notte del 31
maggio, e l’imposizione di rigidi coprifuochi e l’entrata in scena della Guardia
nazionale sono stati inevitabili. Il bilancio dei disordini, al primo giugno, è
un vero e proprio bollettino di guerra: in 15 Stati è stata richiamata la
Guardia Nazionale, per un totale di oltre 5mila truppe per le strade, più di
5mila persone sono state arrestate, in 12 grandi città vige il coprifuoco.
Il ruolo di BLM. Blm sta svolgendo un ruolo-chiave nel
coordinamento delle proteste sin dalla morte di Floyd e sta guidando la comunità
afroamericana alla rivolta in tutto il paese, essendo dietro l’organizzazione di
marce e mobilitazioni, spesso sfocianti nella violenza, ovunque siano presenti
comunità nere, come Chicago, Dallas, New York, Las Vegas, Los
Angeles e Minneapolis. Mentre l’entrata in scena del movimento Antifa ha
contribuito a trasformare le proteste in una vera e propria insurrezione su
scala nazionale, spingendo l’amministrazione Trump a valutare la qualificazione
dei collettivi di sinistra radicale come organizzazioni terroristiche, BLM sta
svolgendo una funzione parallela ma complementare: convincere gli afroamericani
ad unirsi al moto riottoso, ovunque essi vivano e spostandosi da una città
all’altra se necessario, per allargare l’anarchia sociale il più possibile, da
costa a costa. BLM ha anche giocato un ruolo unico nell’internazionalizzazione
delle proteste, sfruttando la propria rete di alleanze e collaborazioni con le
organizzazioni antifasciste e di sinistra radicale attive nel resto
dell’Occidente per organizzare mobilitazioni contro la brutalità poliziesca ed
il razzismo e di solidarietà verso gli afroamericani nelle principali città del
Vecchio Continente, di Australia e Nuova Zelanda. Il lobbismo di BLM ha prodotto
dei risultati straordinari poiché, rubando la scena alla pandemia, sta
convincendo le minoranze e gli attivisti antirazzisti a prendere il controllo
delle piazze occidentali: da Londra ad Auckland, da Berlino a Perth e Bruxelles,
ed anche in teatri sensibili come le banlieu francesi vi sono segnali di
prossime mobilitazioni. L’effetto complessivo potrebbe essere incendiario,
perché i Paesi finiti nell’agenda di Blm condividono con gli Stati Uniti storie
di difficile convivenza inter-etnica, cospicue minoranze e frequenti disordini.
Obiettivi, ideologia, dimensione. BLM nasce nel 2014 come
movimento apolitico e apartitico di denuncia sociale, a composizione
afroamericana, mirante a sensibilizzare l’opinione pubblica americana ed
internazionale, l’industria dell’intrattenimento e il mondo politico sulla
presunta brutalità poliziesca etno-centrica delle forze dell’ordine
statunitensi. Sebbene questa tesi sia confutata dai dati disponibili sulle
attività della polizia, liberamente visionabili dal pubblico, e sia criticata
anche da esponenti della comunità afroamericana, come Deroy Murdock, il
vincitore indiscusso della battaglia delle narrative è senza dubbio Blm.
L’evento spartiacque è stata la morte di Trayvon Martin, un 17enne afroamericano
morto il 26 febbraio 2012 in seguito ad una colluttazione con George Zimmermann,
un vigilante volontario di quartiere. L’estate dell’anno seguente, Zimmermann è
stato assolto dai capi d’accusa e su Twitter ha iniziato a circolare
l’hashtag #BlackLivesMatter, dal quale il movimento ha poi preso il nome. Ad
ogni modo, BLM nasce ufficialmente soltanto nel 2014 dopo le morti di altri due
afroamericani: Michael Brown ed Eric Garner. Ed è proprio la morte di Brown ad
aver consacrato il trasferimento di BLM dalla rete alle strade. La città di
Ferguson, luogo dell’assassinio, a seguito dell’evento è
sprofondata nell’anarchia sociale per un anno intero, registrando rivolte e
disordini intermittenti dall’agosto 2014 all’agosto 2015. L’insurrezione di
Ferguson ha mostrato quale fosse il potenziale intrinseco di Blm per via
dell’internazionalizzazione della protesta fino a Londra, ivi portata avanti da
“Stand Up To Racism” e dai radicali di sinistra “London Black Revolutionaries”,
e della solidarietà ai manifestanti espressa dal mondo dello spettacolo, dello
sport, da Amnesty International, e dalle Nazioni Unite. Ugualmente al movimento
Antifa, Blm non possiede una struttura gerarchica e territorializzata, non ha
una dirigenza riconosciuta e riconoscibile, sebbene vi siano attivisti che si
occupano di dare visibilità al movimento, ed agisce nel paese e all’estero
attraverso cellule autonome ma comunicanti fra loro, che utilizzano la rete come
principale piattaforma di dialogo e coordinamento. Il trait d’union dei gruppi
che si autodefiniscono parte della galassia di Blm è l’ideologia. I BLM, dagli
Stati Uniti all’Australia, hanno come obiettivo la lotta contro
il bianco-centrismo delle società occidentali, di cui brutalità poliziesca,
segregazione spaziale, disuguaglianze economiche fra etnie e razzismo
istituzionale sarebbero le principali e più palesi espressioni. Mentre a
Washington, BLM concentra gli sforzi sulla difesa dei diritti degli
afroamericani, a Canberra e Wellington i BLM protestano contro la
discriminazione anti-aborigena, così come a Londra il focus è sulle disparità di
trattamento fra inglesi bianchi e di origine afro-caraibica. Essendo le cellule
comunicanti tra loro, un episodio di razzismo accaduto a New York può fungere
da detonatore per l’esplosione di proteste di solidarietà a Sydney e Francoforte
da parte degli omologhi ivi presenti, pur in assenza di tensioni recenti in
questi luoghi, che è proprio quel che sta succedendo in questi giorni. Il potere
destabilizzante di BLM è, quindi, molto elevato in quanto suscettibile
di esportare le crisi oltre-confine, in tutti quei paesi afflitti da tensioni
inter-etniche e multiculturali. Il razzismo continua ad essere e rappresentare
il pilastro fondamentale dell’identità e delle attività dei BLM, ma negli anni
recenti si è assistito ad un ampliamento del loro raggio d’azione, sempre nel
nome della difesa degli oppressi, che ha portato a sposare la causa dei
movimenti omosessuali ed antisionisti, alle cui proteste i BLM sono ormai ospiti
fissi. In entrambi i casi, l’adesione alla lotta è giustificata dal ritenere la
discriminazione contro le minoranze sessuali e contro i palestinesi come
manifestazioni, rispettivamente, del suprematismo bianco e di apartheid. Un
altro campo in cui BLM è entrato in scena è l’ambientalismo radicale. Nel Regno
Unito, gli attivisti di BLM collaborano con “Wretched of the Earth“, un gruppo
ecologista che si batte per dare un’impronta etnica al dibattito sul
clima, criticando il più noto “Extinction Rebellion” per lo scarso focus
dedicato ai danni arrecati alle persone di colore dal surriscaldamento globale.
La pericolosità. Come già scritto, i Blm godono di un incredibile
potenziale destabilizzante di natura transnazionale, ma è negli Stati Uniti che
il grado di minaccia è più elevato che altrove, come palesato dall’insurrezione
duratura di Ferguson, dalle azioni di disturbo durante le presidenziali del 2016
(che in un caso hanno spinto Donald Trump ad annullare un comizio per
via dell’alto rischio di incidenti) e dal più recente coinvolgimento nei
disordini seguiti alla morte di George Floyd. Quello che è nato come un
movimento di protesta sociale ispirato ai valori della resistenza non-violenta e
mirante alla sensibilizzazione contro la brutalità poliziesca, si è presto
trasformato in un’entità composta da elementi estremisti, proprio come gli
Antifa, e questo ha spinto la Federal Bureau of Investigation (Fbi) ad
incrementare le attività di sorveglianza sui circoli fisici e virtuali legati
alla galassia Blm a partire dal 2017. L’attivismo di Blm ha avuto dei riflessi
sociali e culturali considerevoli, avendo contribuito alla rinascita del
nazionalismo e del suprematismo nero e alla diffusione capillare di sigle di
sinistra radicale che sfrutterebbero l’ombrello della lotta contro la brutalità
poliziesca per condurre crimini d’odio. È il caso, ad esempio, del Huey P Newton
Gun Club di Dallas, un “gruppo di autodifesa” fra le cui attività rientra il
pattugliamento dei quartieri neri, ed il Guerrilla Mainframe, noto per essere
diventato il primo gruppo ad essere inserito nella categoria dei Bie. BIE è la
sigla con cui si identificano i Black Identity Extremists (let. Estremisti
dell’identitarismo nero) ed appare per la prima volta in un rapporto
ufficiale della Fbi del 3 agosto 2017, successivamente inviato a migliaia di
dipartimenti di polizia a scopo informativo. Secondo il materiale raccolto dalla
polizia federale, le violenze di Ferguson hanno determinato l’inizio di una
nuova epoca per le relazioni interrazziali e, più nel dettaglio, per le
relazioni fra neri e forze dell’ordine. Blm ha avuto un effetto esiziale in
tutto questo, popolarizzando l’idea che queste ultime siano impegnate in una
lotta contro i primi, alimentando un’ondata di identitarismo nero
equiparabile al suprematismo bianco per minacciosità e capacità di commettere
atti eclatanti. Fra Bie e suprematisti bianchi, però, vi sarebbe una profonda
differenza di fondo: i primi non cercherebbero la “guerra razziale”, almeno non
come obiettivo primario, poiché maggiormente interessati a colpire i poliziotti.
Il supporto domestico ed internazionale. Blm ha costruito in
tempi brevissimi una gigantesca rete di supporto a livello nazionale e
internazionale, utile e funzionale alla promozione planetaria della sua agenda e
alla popolarizzazione della falsa tesi della brutalità poliziesca etno-centrica.
Un ruolo fondamentale nella vittoria della battaglia delle narrative, anche
dinanzi numeri inconfutabili, è stato giocato dal fatto che si tratta di un
tema estremamente sensibile, ricollegato e ricollegabile ai difficili trascorsi
degli afroamericani negli Stati Uniti, dalla schiavitù alla segregazione. Per
Blm non è stato difficile conquistare l’appoggio dei principali volti dello
sport, dalla National Basket Association (Nba) alla National Football League
(Nfl), che dal 2016 hanno iniziato a boicottare il canto dell’inno nazionale
come gesto di solidarietà contro razzismo e brutalità poliziesca, riportando la
memoria degli americani agli anni delle proteste simboliche dei seguaci del
potere nero. I consensi più importanti, però, Blm è riuscito ad ottenerli da una
parte del mondo politico, ossia dal Partito democratico. Sebbene i rapporti non
siano stati privi di incomprensioni e tensione, come l’interruzione di un
discorso di Bernie Sanders a Seattle l’8 agosto 2015 da parte di attivisti Blm,
i Dem hanno tentato di cavalcare l’onda del risentimento nero sin dall’inizio.
L’inizio del dialogo è stato rappresentato dall’approvazione di una
risoluzione del Comitato nazionale democratico (Democratic National Committee)
sanzionante il supporto ufficiale a Blm, firmata proprio nei giorni seguenti
all’incidente di Seattle. Come scritto, Blm non possiede una struttura
centralizzata ma questo non è un impedimento alla filantropia dei privati,
grandi e piccoli, interessati a sostenerne la causa e che, periodicamente,
aprono raccolte fondi ed effettuano donazioni. Nei giorni delle proteste per
George Floyd, ben 16 organizzazioni hanno aperto delle raccolte fondi in favore
dell’ultima battaglia di Blm: pagare la cauzione degli arrestati. Il Minnesota
Freedom Fund, da solo, ha collezionato 20 milioni di dollari dall’inizio dei
disordini, ricevendo denaro dai grandi volti di Hollywood, come gli attori Seth
Rogen, Steve Carell e Don Cheadle, e da personaggi della musica, come le
cantanti Janelle Kehlani e Noname. Negli stessi giorni in cui lo star system si
mobilita per aiutare Blm, la nota attivista politica afroamericana Candace
Owens, fra i più noti “Blacks for Trump” in circolazione, ha lanciato delle
accuse gravi all’indirizzo di George Soros, rispolverando delle vecchie teorie
circa il suo coinvolgimento nel finanziamento del movimento Antifa e Blm.
Secondo la Owens, BLM avrebbe ricevuto 33 milioni di dollari negli ultimi anni
dalla Open Society Foundation del magnate e speculatore ungherese. PolitiFact ha
provato a far luce sull’argomento, concludendo che non ci sono prove di un
finanziamento diretto a Blm ma che, al tempo stesso, non si può negare una
connessione perché la Open Society Foundation ha effettuato donazioni ad una
serie di enti che collaborano attivamente con il movimento, come la
britannica Release Leads, che soltanto nel 2018 ha ricevuto circa 280mila
dollari in dono e che ospita ed organizza periodicamente eventi di Blm Uk. Le
accuse della Owens, perciò, potrebbero non essere completamente infondate.
I prodromi di Blm: il potere nero. Le origini ideologiche di Blm
possono essere ricondotte ai turbolenti anni ’60, il decennio di insurrezione
controculturale che ha cambiato per sempre il volto delle società occidentali,
segnando l’inizio di un percorso lungo, tortuoso e non privo di tensioni sociali
ed intergenerazionali, che ha avuto come mete finali lo sdoganamento dei diritti
lgbt, l’avvento del post-cristianesimo e la messa in discussione dell’idea
stessa di “civiltà occidentale” e dei suoi cardini fondamentali: religione,
cultura, aspetti etno-razziali. Nel caso degli Stati Uniti, la rivoluzione
culturale degli anni ’60 ha portato alla fine della segregazione razziale,
all’inizio delle lotte di liberazione sessuale, alla nascita dei movimenti per
la legalizzazione delle droghe, all’emergere della Nuova Sinistra (New Left) e
all’espansione di nuovi movimenti religiosi e sociali, come le varie sette New
Age e gli hippie, caratterizzati da una forte vena antisistemica e in ribellione
contro i “valori tradizionali”. Ed è proprio nel seno di questa epoca
dall’impronta storica che possono essere trovati i prodromi di BLM, che non
sarebbe errato considerare la naturale evoluzione di esperimenti anteriori
appartenenti alla galassia del potere nero, come le Pantere Nere. Le tensioni
fra le due Americhe, quella dei wasp e dei neri, non sono diminuite negli anni
successivi alla fine della segregazione razziale e questo ha consentito alle
organizzazioni promuoventi l’ideologia del potere nero di non cadere nel
dimenticatoio ma, al contrario, di proliferare. I casi più emblematici sono
rappresentati dalle Nuove Pantere Nere e dalla Nazione dell’Islam. Blm è,
quindi, l’ultimo punto di approdo di un sessantennio di agitazione culturale che
non è mai realmente morta; ha semplicemente alternato fasi di attività e
passività.
La polarizzazione durante l'era Obama. Negli ultimi anni, più
precisamente a partire dall’inizio dell’era Obama, la società americana ha
affrontato dei cambiamenti molto profondi: la polarizzazione economica e sociale
è aumentata in maniera dirompente, insieme alla cristallizzazione delle tensioni
inter-etniche, mentre la sinistra moderata, i cosiddetti “liberal”, è stata
interessata da una radicalizzazione ideologica che ne ha spostato ambizioni,
agenda e discorso politico su posizioni sempre più oltranziste. Questa, almeno,
è la tesi del Pew Research Center, secondo cui il principale lascito delle due
presidenze Obama è stato l’aumento della polarizzazione politica, causata
dall’estremizzazione degli elettorati di sinistra e destra e da tutto ciò che
questo comporta sul piano delle relazioni sociali, di classe e fra etnie. In
breve, negli anni dell’era Obama si è assistito ad una significativa rottura
sociale, simile per gravità e dimensioni a quella degli anni ’60, le cui
manifestazioni più eloquenti sono state l’aumento delle divisioni inter-etniche,
che hanno portato alla nascita di BLM e al ritorno in scena del nazionalismo
nero, le proteste sociali di movimenti come Occupy Wall Street, e la formazione
di due opposti estremismi in stile anni di piombo italiani: estrema destra,
rappresentata dalla rinascita del suprematismo bianco, ed estrema sinistra,
rappresentata dalla comparsa degli Antifa.
Così la protesta dei Black Lives Matter è sfuggita di mano ai
Dem. Francesco Boezi il 2 giugno 2020 su Inside Over.
Il capitolo sul movimentismo americano, un capitolo sempre attuale, prosegue con
la saga dei membri di Black Lives Matter, che però sta evolvendo in qualcosa a
cui non eravamo ancora o del tutto abituati. La protesta portata avanti dopo il
caso della morte di George Floyd sta montando. Altre nazioni, oltre agli Stati
Uniti d’America, hanno assistito alla comparsa tra le strade di persone che si
richiamano a quella organizzazione o, più in generale, alla tutela dei diritti
dei neri. “Black Lives Matter”, però, è un nome che non basta a spiegare quello
che sta succedendo. “Riots”, rivolte è un termine che descrive molto meglio la
fotografia scattata in queste ore. Anzitutto la portata complessiva: bisognerà
vedere per quanto tempo i manifestanti continueranno ad occupare alcune tra le
principali città occidentali, Londra per esempio. La storicità di un fenomeno
dipende pure dalla partecipazione e dalla durata del moto, che può essere
idealistico o sfociare – come sta già accadendo – pure in altro. La natura
pacifica non è una costante di queste manifestazioni. Incendi, scontri,
devastazioni e saccheggi che interessano negozi: gli episodi stigmatizzabili,
almeno negli Usa, non si contano più. C’è anche chi si limita alla non violenza,
e non si può generalizzare. Distribuire le responsabilità per le fasi meno
pacifiche delle rivolte non è semplice. E non è neppure detto che i gesti
violenti siano riconducibili a gruppi specifici o a sigle. Anche lo spontaneismo
recita la sua parte – una parte che potrebbe essere molto rilevante – in questa
storia. Sia come sia, il politicamente corretto impone una consueta linea
tiepida: il doppiopesismo narrativo prevede che un certo tipo di violenza,
filtrato dall’interpretazione, possa passare in sordina o quasi essere
giustificato. Tre, a prescindere dal humus delle circostanze e dalla ciclicità
di questi eventi, sono i principali fattori in gioco che vale la pena annotare:
il contesto statale da cui è partito tutto, quello del Minnesota, gli effetti
socio-economici della pandemia da Sars-Cov2 e la time-line che scorre in
direzione di novembre, mese del voto per le presidenziali.
Il Minnesota. I Black Lives Matter, con la partecipazione di
altre frange, come quella dell’estrema destra dei Boogaloo Boys, non hanno
invaso le metropoli, partendo dall’Alabama o da qualche altro Stato del Sud.
Quelli in cui la questione della discriminazione razziale è, se non altro per
motivi storici, percepita come non più rimandabile. La base d’origine del moto è
Minneapolis, una città governata da un progressista in rampa di lancio, Jacob
Frey. Minneapolis è in Minnesota, dove governa un altro democratico: Tim Walz.
Il Minnesota è un’isola felice degli asinelli. Perché a licenziare il poliziotto
accusato di omicidio ed altri agenti presenti nel mentre si consumava la tragica
vicenda di George Floyd è stato Jacob Frey e non Donald Trump? La risposta a
questo quesito ci aiuta a chiarire meglio come stiano le cose. La polizia di
Minneapolis ha un capo: il primo cittadino. Una sottolineatura necessaria perché
contribuisce a chiudere il cerchio sul fatto che Trump non abbia alcuna
responsabilità diretta sul caso di Floyd. C’è chi parla di “clima creato”, ma
quella è una considerazione politologica che lascia il tempo che trova. Il
governatore Tim Walz ha preso una posizione netta: “Capisco la rabbia, ma la
situazione è incredibilmente pericolosa. Dovete andare a casa”. E ancora: “Tutto
questo non riguarda la morte di George Floyd, né le diseguaglianze, che sono
reali. Questo è il caos”. Il caos, appunto, che è un elemento spesso dimenticato
dalle analisi giustificazioniste, ma non dai vertici Democratici a quanto
pare. Joe Biden sta postando foto che lo immortalano mentre incontra ed ascolta
alcuni esponenti della protesta che – ripetiamolo – è anche pacifica, ma la
sensazione è che i Dem non possano vantare un controllo su quello che sta
accadendo e che, al contrario, all’establishment democratica, soprattutto in
Minnesota, sia del tutto sfuggita di mano la situazione.
La situazione sociale dovuta alla pandemia. Le persone che si
stanno fisicamente rivoltando hanno politicamente rivendicato qualcosa di
circoscritto? La risposta è no. Un conto sono le manifestazioni non violente, un
altro quelle che non violente non sono. Mentre scriviamo, il tasso di
disoccupazione negli Stati Uniti procede spedito verso il 20%. La comunità nera,
ma non solo, potrebbe aver subito il contraccolpo dell’implosione dell’economia
reale. Implosione che è una conseguenza già palese della pandemia. Con Donald
Trump, il tasso di disoccupazione dei neri che risiedono negli States è molto
diminuito, ma il “cigno nero” potrebbe aver cambiato le carte in tavola. Ora,
quella comunità, potrebbe sentirsi tradita dalle istituzioni in genere, dopo un
periodo in cui – lo raccontano i dati – qualcosa in termini di percentuali di
persone occupate era molto migliorato. Possibile che questo fattore faccia parte
delle motivazioni dei rivoltosi? Possibile. E, in caso, sarebbe forse un
collante, una radice, più profonda rispetto a molte altre.
La strada verso novembre. Donald Trump non è nella posizione di
poter attaccare chi fa parte dei Black Lives Matter. Il movimento ha ricevuto
critiche in passato ma, ad oggi, un attacco significherebbe condannarsi alla
sconfitta elettorale. Perché le minoranze crescono demograficamente. E perché
Biden sfrutterebbe la dichiarazione come non mai. Meglio, allora, individuare un
altro avversario: gli antifascisti. Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti si
apprestano ad omologare le organizzazioni antifasciste alle organizzazioni
terroristiche. La mossa è intelligente: non colpevolizza la comunità
afroamericana ed individua un responsabile politicizzato e forse al centro delle
rivolte scoppiate in queste ore. La strada verso novembre per Trump appare
comunque in salita. Ma associare le proteste di questi giorni ad una presunta
mala gestione trumpiana è un atteggiamento prettamente opportunista che poco ha
a che fare con la realtà dei fatti.
Paolo Mastrolilli per “la Stampa” l'1 giugno 2020. Il luogo dove
mi parla Hank Newsome deve restare segreto. Perché quando Trump ha denunciato
che le proteste di Minneapolis sono aizzate da agitatori radicali venuti da
altri Stati, e il segretario alla Giustizia Barr ha promesso di arrestarli,
parlavano di lui. Ma il presidente di Black Lives Matter a New York il suo
avvertimento vuole lanciarlo comunque, anche se adesso rischia la galera: «Noi
stiamo chiedendo una soluzione politica, a un evidente e antico problema di
abusi ed emarginazione. Se la politica non ci ascolterà, non si lamenti poi
delle violenze che continueranno. Ne sarà responsabile». La storia di Hank è
emblematica della crisi che sta incendiando l' America. Nato e cresciuto al
Bronx in una famiglia profondamente cristiana, era scappato dalla scuola perché
«avevo ceduto alle tentazioni del mio ambiente». Come il figliol prodigo, alla
fine aveva ritrovato la strada: laurea, dottorato in legge, assistente del
procuratore della sua contea, project manager nello studio legale Wilson Elser
Moskowitz Edelman & Dicker LLP. I suoi genitori però si erano conosciuti negli
anni Sessanta, durante una manifestazione del movimento per i diritti civili, e
il richiamo dell' impegno politico è rimasto sempre forte per lui. Così quando è
nato Black Lives Matter si è subito mobilitato, diventando il presidente a New
York.
Il segretario alla Giustizia Barr minaccia di arrestarla, proprio
perché è venuto a Minneapolis da un altro Stato.
«Con tutto il rispetto, sono bullshit, cazzate. Il Minnesota
aveva già avuto gravi problemi di violenza prima che arrivassimo noi, come l'
omicidio di Philando Castile da parte della polizia. Le persone con cui
protestiamo sono cittadini di questo Stato, e Black Lives Matter del Minnesota
ci ha invitati, per aiutarli ad organizzare le manifestazioni. Ormai poi la
protesta è un fenomeno nazionale, e quindi è ridicolo lamentarsi del fatto che
qualcuno venga da fuori per cavalcarla sul piano locale. L' amministrazione
Trump cerca solo capri espiatori, per i problemi che non vuole risolvere».
Perché state incendiando tutto il Paese?
«Se l' America ci avesse ascoltato, facendo un minimo sforzo per
aiutare i neri, tutto questo non sarebbe accaduto. Durante gli anni scorsi la
gente ha marciato, cantato, protestato, ha anche eletto diversi politici
importanti, ma nulla è cambiato. Ora stiamo parlando all' America con l' unico
linguaggio che capisce».
Condonate le violenze e i saccheggi?
«Realisticamente, se mi chiedi se mi sento male per Walmart,
Target, o qualunque altra impresa che ha fatto profitti sulla comunità nera,
senza mai portare vere opportunità, o manifestare alcuna simpatia per noi, la
risposta è no. Per nulla».
È vero che in strada ci sono anche i suprematisti bianchi?
«Non mi sento minacciato, perché abbiamo le armi per reagire, ma
è plausibile che si siano infiltrati, per due ragioni: primo, scontrarsi con
noi, approfittando di qualunque incidente per demolire il sistema creato dal
movimento dei diritti civili; secondo, provocare disordini per rovinare la
nostra immagine».
Quali saranno le prossime mosse?
«Faremo richieste, che saranno anche le condizioni per fermare le
proteste. La prima è l' approvazione del "I Can' t Breathe Act", ossia una legge
che impone di incriminare i poliziotti, se una persona dice loro che non può
respirare e viene ignorata. È un atto simbolico, ma anche pratico, per dare un
segnale che gli abusi non saranno più tollerati».
Chiedete qualcosa sul piano economico?
«Certo, il pagamento delle compensazioni alla comunità afro
americana per il danno della schiavitù».
E per l' integrazione sociale dei neri?
«Vogliamo che i nostri figli abbiano accesso all'istruzione di
qualità nei settori dell' impresa, la finanza, la programmazione, l'
intelligenza artificiale. La rivoluzione dell' automazione è iniziata: noi
chiediamo che le nuove generazioni siano addestrate sul piano tecnologico,
preparate per il futuro, e in grado di assumere posizioni di leadership».
Quale sarà il prossimo passo della protesta?
«Continuare a combattere, nelle strade e non solo, per la
libertà. È nostro dovere farci ascoltare da un Paese che ci ignora».
E se le vostre richieste non saranno ascoltate?
«Sarà sempre peggio, e la politica ne avrà la colpa».
Hank, sta minacciando più violenza?
«È difficile usare la parola violenza, quando parli del
Minnesota. Questa regione fu conquistata dai colonizzatori bianchi, sterminando
le popolazioni indigene che l' abitavano. È curioso che ora proprio i bianchi si
lamentino della violenza, quando con la violenza hanno rubato questo Paese».
Alcuni analisti avvertono che così aiutate la rielezione di
Trump, perché i moderati si stringeranno intorno a lui.
«Io non voglio salvare questo sistema e non appoggio alcun
candidato, però noi facciamo una proposta politica sensata per risolvere
problema. Se la politica continuerà a ignorarci, allora forse anche gli
elettori, in particolare quelli della comunità afro americana che non andarono a
votare nel 2016, a novembre saranno abbastanza motivati da tornare a farsi
sentire alle urne».
Da repubblica.it il 2 giugno 2020. L'ex stella del basket
statunitense Dennis Rodman ha lanciato dal suo profilo Instagram un appello
rivolto a tutti i ragazzi scesi in strada per manifestare dopo la morte di
George Floyd. Il cinque volte campione Nba, simbolo del secondo three-peat dei
Chicago Bulls di Michael Jordan e seguitissimo sui social nelle ultime settimane
grazie al successo della docu-serie "The Last Dance", ha dichiarato in un video:
"Non dovete andare in giro ad appiccare incendi, a rubare, a creare ulteriori
problemi. Siamo già in una situazione davvero brutta, se avete intenzione di
protestare, fatelo nel modo giusto". L'ex bad boy dell'Nba, oggi 59enne, ha poi
rincarato la dose affermando senza mezzi termini: "Dobbiamo superare insieme
questo momento, siamo degli esseri umani e non dei fottuti animali. Vi prego
datemi ascolto". Una dichiarazione in pieno stile Rodman, tanto idolatrato per
le sue doti di combattente sul parquet (miglior rimbalzista di sempre nell'Nba
nonchè ritenuto uno dei difensori più forti della storia della lega) quanto
discusso per il suo stile di vita eccentrico e gli eccessi fuori dal campo. Il
video dell'ex compagno di squadra di Michael Jordan ha ottenuto migliaia di
visualizzazioni.
Da repubblica.it il 2 giugno 2020. L'ira della chiesta episcopale
si abbatte su Donald Trump. La vescovo di Washington, Mariann Edgar Budde, si è
detta "indignata" dalla presenza del presidente americano che davanti la St.John
Episcopal Church, di fronte alla Casa Bianca, ha ostentato una Bibbia per
rafforzare il suo messaggio contro le proteste. "Il nostro messaggio è
antitetico a quello del presidente", ha detto la Budde parlando con CNN e
Washington Post, denunciando le cariche della polizia effettuate su manifestanti
pacifici per liberare lo spazio antistante la chiesa. Ieri, dopo aver parlato
alla Casa Bianca Trump, seguito da un corteo di guardie del corpo e di membri
della Casa Bianca e dell'Amministrazione, si è recato a piedi alla Saint John
Epyscopal Church, non lontano dalla Casa Bianca: qui, senza fermarsi a pregare,
si è fatto riprendere dalle telecamere alzando un braccio e mostrando una
Bibbia. "Il Paese sta tornando forte", ha detto. La chiesa era stata danneggiata
nei giorni scorsi dalle proteste per la morte di Floyd, arrivate a Washington
tutto intorno alla Casa Bianca. Nelle foto, si vede Trump camminare circondato
da decine di agenti in assetto anti-sommossa: gli stessi che pochi minuti prima
avevano sgomberato con la forza i manifestanti pacifici riuniti nella zona.
Budde, che ricopre la posizione dal 2011, dopo aver passato 18 anni a
Minneapolis, già nei mesi scorsi si era scagliata contro la "retorica
incendiaria" del presidente in un comunicato firmato insieme a altri leader
religiosi: ma ieri ha usato parole durissime. "Non appoggiamo in nessuna maniera
la risposta incendiaria del presidente a una nazione che è stata ferita ed è in
lutto - si legge nel suo comunicato - nel rispetto dei valori del nostro
Salvatore che ha vissuto una vita di non violenza e di amore per il prossimo ci
uniamo a quelli che chiedono giustizia per la morte di George Floyd.''
Trump contro i Cuomo: "New York fatta a pezzi dalla feccia". Li
accusa di essere responsabili dei saccheggi di New York, e arriva a dare al
fratello del governatore, un giornalista della Cnn, del mafioso italiano. "Ieri
è stata una giornata negativa per i fratelli Cuomo. New York ha perso di fronte
ai saccheggiatori, alla sinistra radicale e a tutte le altre forme di feccia".
Lo twitta Donald Trump riferendosi a Andrew Cuomo, governatore di New York, e a
suo fratello, il giornalista Cnn Chris Cuomo. "Il governatore ha rifiutato la
Guardia nazionale e la città di New York è stata fatta a pezzi. Allo stesso
tempo i rating" tv "di Fredo calano del 50%", aggiunge Trump, tornando a
chiamare Chris Cuomo Fredo e associandolo quindi a Fredo Corleone del Padrino.
Da gazzetta.it il 2 giugno 2020. L’ex pugile ha parlato al
telefono con la famiglia di Floyd, che ha accettato la sua offerta. Coprirà le
spese del servizio funebre di martedì 9 giugno a Houston, la città in cui Floyd
era nato e cresciuto. Mayweather ha inoltre chiesto e ottenuti di potersi
accollare le spese per le manifestazioni di commemorazione per Floyd previste
giovedì in Minnesota e sabato in North Carolina per l’uomo la cui morte ha
innescato le proteste che infiammano le strade d’America. “Probabilmente si
arrabbierà con me per averlo rivelato pubblicamente ma... sì, pagherà il
funerale” ha detto a Espn Leonard Ellerbe, amministratore delegato della
Mayweather Promotions. Anche la voce di Tiger Woods si è unita a quelle di
protesta per la morte di Floyd. La leggenda del golf, 44 anni, ha raccontato in
un comunicato come sta vivendo questo momento. “Il mio cuore è con George Floyd,
la sua famiglia e quelli di noi che stanno soffrendo ora - sono le parole di
Woods -. Ho sempre avuto il massimo rispetto per le forze dell’ordine, che si
allenano diligentemente per capire dove, come e quando usare la forza. Questa
scioccante tragedia ha chiaramente superato il limite. Ricordo la rivolta di Los
Angeles (quella del 1992 seguita al pestaggio di Rodney King, ndr) e ho imparato
che l’educazione è il miglior modo di andare avanti. Possiamo far sapere come la
pensiamo anche senza bruciare i quartieri in cui viviamo. Spero che attraverso
conversazioni costruttive e oneste riusciremo a costruire una società più sicura
e unita”.
La versione di Trump: “Ho fatto più io per i neri di Abraham
Lincoln”. Il Dubbio il 3 giugno 2020. La reazione del
presidente americano alle proteste che incendiano le città americane. E a New
York i democratici si dividono. “La mia amministrazione ha fatto per la comunità
nera di qualsiasi altro presidente dopo Abraham Lincoln”. Lo ha scritto in un
tweet, in piena rivolta dopo la morte di Floyd il presidente americano,
Donald Trump, che ha elencato alcuni dei successi raggiunti. “Le opportunity
zone (per tassazione agevolate, ndr) approvate con il senatore Tim Scott,
finanziamenti garantiti per Hbcu (college e università storicamente della
comunità nera), School Choice (programmi di studio alternativi, ndr), la riforma
della giustizia penale, il più basso tasso di disoccupazione tra i neri, più
bassa povertà e criminalità nella storia. E il meglio deve ancora venire”, ha
aggiunto Trump. Nel frattempo è polemica sulle proteste e le violenze di questi
giorni. Il sacco della città spacca i democratici. Il governatore Andrew Cuomo
attacca il sindaco Bill de Blasio, suo compagno di partito, per le razzie che
hanno sconvolto New York lunedì sera: “Guardate le immagini. E’ stata una
vergogna”. Cuomo mette sotto accusa duramente il New York Police Department e
chi ne ha la guida: “Il sindaco e le forze dell’ordine non hanno fatto il loro
lavoro”. – Le proteste e le violenze che stanno scuotendo gli Stati Uniti non
nascono solo dall’uccisione di George Floyd per mano della polizia ma dalla
diffusa ingiustizia e disuguaglianza. Parola di Spike Lee, convinto che “la
gente sia arrabbiata per un motivo, non si nasce arrabbiati, ci si arrabbia
perchè si vive ogni giorno in questo mondo dove il sistema non è fatto perchè tu
vinca”. “La gente è arrabbiata perchè i neri vengono uccisi a destra e manca e i
poliziotti lasciati liberi, per la disparità tra l’avere e il
non-avere…istruzione, acqua potabile, razzismo, aspettativa di vita, la lista
potrebbe essere infinita. E’ un’analogia stupida ma se lasci la pentola sul
fuoco, l’acqua bolle”, ha sottolineato il regista, ripreso dalla Bbc. Il
razzismo non è prerogativa degli Stati Uniti, ha continuato, “c’è in tutto il
mondo, era una pandemia prima del coronavirus”, ma negli Usa si ritrova nella
fondazione del Paese, segnata da “genocidio, furto di terra e schiavitù”. A
peggiorare la situazione c’è un presidente che è “un gangster, che sta cercando
di fare il dittatore”, ha proseguito Spike Lee, condannando duramente lo
sgombero di manifestanti pacifici ieri, con gas lacrimogeni, per permettere a
Donald Trump di recarsi in una chiesa vicino alla Casa Bianca e farsi riprendere
con la Bibbia in mano. Uno spettacolo “ridicolo”, ha commentato il regista, “con
la mia famiglia abbiamo urlato increduli vedendolo. Non ho mai visto in vita mia
qualcosa del genere, in particolare da parte di un leader mondiale”.
Si aggrava la posizione dell'agente. George Floyd, “omicidio
volontario”: cambia l’accusa per il poliziotto.
Redazione su Il Riformista il 3 Giugno 2020. Il procuratore generale del
Minnesota Keith Ellison rafforzerà le accuse contro Derek Chauvin, l’agente
arrestato per l’uccisione a Minneapolis di George Floyd: da omicidio colposo
a omicidio volontario, fino a 40 anni di detenzione, e incriminerà anche gli
altri tre agenti. Lo ha detto in un tweet, ripreso dalla Cnn, la senatrice
democratica Amy Klobuchar, sottolineando che si tratta di una “altro importante
passo per la giustizia”. Secondo alcune fonti anonime, altri tre agenti sulla
scena – Tou Thao, J. Alexander Kueng e Thomas Lane – saranno accusati di aver
aiutato e favorito l’omicidio volontario. Chauvin è stato arrestato venerdì
scorso.
George Floyd, il terrore dell’arresto: «Per favore non
spararmi, amico». Laura Zangarini il 4 agosto 2020 su Il Corriere della
Sera. «Non spararmi, per favore amico». È in queste parole il terrore di George
Floyd, quando gli agenti si avvicinano alla sua auto e gli puntano la pistola
sul viso. Il video dei drammatici momenti che, il 25 maggio scorso, a
Minneapolis, negli Stati Uniti, hanno portato alla morte del 46enne
afroamericano, ripreso direttamente dalle bodycam dei poliziotti che hanno
condotto il suo arresto, è stato pubblicato in esclusiva dal «Daily Mail» sul
suo sito internet. Il terrore sulla faccia di Floyd può essere visto per la
prima volta, mentre le videocamere degli agenti Thomas Lane e Alex Kueng, che
facevano parte della squadra guidata da Derek Chauvin, il poliziotto
materialmente accusato della morte dell’uomo per averlo tenuto immobilizzato per
8 minuti con il ginocchio sul collo, registrano la scena. La registrazione
comincia nel momento in cui l’agente Lane bussa con la torcia al finestrino
dell’auto di Floyd, accusato di aver spacciato un biglietto da 20 dollari falso.
Quando Floyd apre la porta, Lane gli punta la pistola. L’uomo lo implora di non
ucciderlo. «Per favore, non spararmi amico. Ho appena perso mia madre, amico»,
dice. Floyd piange mentre l’agente lo tira fuori dall’auto e lo ammanetta. Dopo
una breve colluttazione per far salire Floyd sull’auto della polizia, le
immagini lo riprendono sdraiato sul marciapiede, con il ginocchio di Chauvin sul
collo per immobilizzarlo. Floyd si lamenta più volte di non riuscire a respirare
e chiama «mamma», ma la sua voce di fa sempre più debole: «Probabilmente morirò
in questo modo», sussurra. Un tribunale del Minnesota, intanto, sta indagando su
come il tabloid britannico abbia ottenuto in esclusiva il filmato. Lo riporta il
«Toronto Star». Il mese scorso un giudice della contea di Hennepin aveva
permesso a giornalisti e membri del pubblico di visionare il filmato su
appuntamento, ma senza autorizzare la diffusione del video al pubblico.
L’articolo del giornale diceva che i video sono stati fatti trapelare sul suo
sito web. Le immagini ottenute mostra circa 10 minuti dal bodycam dell’ex
ufficiale Thomas Lane e circa 18 minuti dal bodycam dell’ex ufficiale Alex
Kueng. Ma le immagini ottenute dal «Mail» mostrano il terrore di Floyd quando
gli agenti bussano sulla portiera della sua auto, e gli puntano una pistola in
faccia. E lui comincia a implorare: «Non spararmi, agente. Per favore, amico».
Il portavoce del tribunale distrettuale della contea di Hennepin, in Minnesota,
ha detto a «Toronto Star» che è in corso un’indagine sulla diffusione del video,
ma ha rifiutato un ulteriore commento. Lane e Kuang facevano parte della squadra
guidata da Derek Chauvin, l’agente che ha soffocato l’afroamericano di 46 anni,
tenendogli per otto minuti il ginocchio sul collo, incurante dei ripetuti
appelli dell’uomo che faticava a respirare e dopo poco ha smesso di parlare e
muoversi.
"Non spararmi, agente, per favore". Le immagine mai viste del
fermo di Floyd prima dell'uccisione. Pubblicato
lunedì, 03 agosto 2020 da Anna Lombardi su La Repubblica.it. La drammatica
sequenza ripresa dalla webcam sulla divisa di due degli agenti intervenuti a
Minneapolis, negli Usa, contro l'afroamericano accusato di avere spacciato venti
dollari falsi. Il video è stato pubblicato dal Daily Mail. La tragedia di George
Floyd, fotogramma dopo fotogramma. Sono le drammatiche immagini registrate dalle
webcam portate sulla divisa da Thomas Lane e Alex Kueng, i due poliziotti che
facevano parte della squadra guidata da Derek Chauvin, l’agente che ha
soffocato l’afroamericano di 46 anni, tenendogli per otto il ginocchio sul
collo, incurante dei ripetuti appelli dell’uomo che faticava a respirare e dopo
poco ha smesso di parlare e muoversi. Le immagini della sua terribile agonia
erano state riprese da un cellulare da un passante: e una volta diffuse avevano
scatenato la rabbia di mezza America. Ma le immagini ottenute ora in esclusiva
dal Daily Mail sono ancora più agghiaccianti. Sì, perché mostrano il terrore
dell’uomo, accusato di avere spacciato un biglietto da 20 dollari falso, fin dal
primo istante: quando gli agenti bussano sulla portiera della sua auto, e gli
puntano una pistola in faccia. E lui comincia a implorare: «Non spararmi,
agente. Per favore, amico». Lo si vede provare a resistere all’arresto, mentre
dice che soffre di claustrofobia. Che gli è appena morta la mamma e soffre di
attacchi di ansia. Gli agenti non lo ascoltano. E lui piange. E implora mentre
lo tirano fuori dall’auto. Ancora, si vede la breve colluttazione per
trascinarlo alla volante. E poi l’uomo improvvisamente in ginocchio. La
situazione che tutti conosciamo. Floyd ripete diverse volte mamma. E presagendo
quel che sta per succedergli, sussurra: «probabilmente, morirò così».
Morte Floyd, arrestati tutti i poliziotti coinvolti. Mattis
contro Trump sull'uso dell'esercito. L'ex capo del
Pentagono critica il presidente: duro anche l'attuale segretario alla Difesa
Esper. L'autopsia: Floyd aveva il coronavirus ma era asintomatico. Scontri a
Brooklyn, tre agenti feriti. 90 arresti a New York. La Repubblica il 4 giugno
2020. Sono stati arrestati tutti gli agenti coinvolti nell'omicidio di George
Floyd, l'afroamericano morto a Minneapolis dopo che un poliziotto gli ha premuto
il ginocchio sul collo. Thomas Lane e Tou Thao sono stati portati nel
penitenziario della contea di Hennepin intorno alle ore 17 locali. J. Alexander
Kueng si era già consegnato nel pomeriggio. Dereck Chauvin, l'agente che teneva
il ginocchio sul collo di Floyd, è in prigione dalla scorsa settimana con
l'accusa di omicidio. Per tutti è stata fissata una cauzione da un milione di
dollari. Per Chauvin l'accusa è destinata a essere aggiornata da omicidio
colposo a omicidio volontario. Dall'autopsia è emerso che George Floyd aveva il
coronavirus ma era asintomatico.
Trump ci ripensa: "L'esercito forse non sarà necessario". "Forse"
non sarà necessario inviare l'esercito per fermare le proteste scatenate
dall'uccisione di George Floyd. Lo ha detto il presidente Donald Trump durante
un'intervista su Newsmax, condotta dal suo ex portavoce Sean Spicer. "Dipende.
Forse non servirà. Anche se abbiamo il forte potere di farlo. La Guardia
nazionale è una consuetudine e abbiamo una Guardia nazionale molto forte", ha
detto Trump dopo aver minacciato di ricorrere all'Insurrection Act per usare le
forze armate contro i manifestanti.
I militari contro Trump. Un'impostazione che il capo del
Pentagono Mark Esper ha dichiarato di non condividere: la legge del 1807 che
consente al presidente di usare l'esercito negli Usa dovrebbe essere usata "solo
nelle situazioni più urgenti e drammatiche e non siamo in una di quelle
situazioni ora" ha detto Esper. La scelta di Trump è stata criticata anche dal
suo ex segretario alla Difesa James Mattis, in una rara e durissima presa di
posizione pubblica: "Donald Trump è il primo presidente nella mia vita che non
tenta di unire il popolo americano, neppure finge di tentare. Invece tenta di
dividerci". ha detto l'ex capo del Pentagono in una nota a The Atlantic. "Siamo
testimoni - ha proseguito - delle conseguenze di tre anni di questo sforzo
deliberato, di tre anni senza una leadership matura. Possiamo unirci senza di
lui, attingendo alla forza interna alla nostra società civile". "Quando entrai
nell'esercito, circa 50 anni fa, feci un giuramento per sostenere e difendere la
Costituzione. Non avrei mai sognato che ai soldati che fanno lo stesso
giuramento sarebbe stato ordinato in qualsiasi circostanza di violare i diritti
costituzionali dei loro cittadini, ancor meno per una bizzarra foto
del commander in chief con a fianco la leadership militare", ha aggiunto Mattis,
riferendosi anche al suo successore Mark Esper. La risposta di Trump è arrivata
su Twitter: "Probabilmente l'unica cosa che io e Barack Obama abbiamo in comune
è che entrambi abbiamo avuto l'onore di licenziare Jim Mattis, il generale più
sovrastimato del mondo. Chiesi la sua lettera di dimissioni e mi sentii
benissimo. Il suo soprannome era caos, cosa che non mi piaceva, e l'ho cambiato
in cane pazzo".
Dopo Bush e Obama parla anche Carter: "Basta discriminazioni".
"Siamo costernati dalle tragiche ingiustizie razziali": dopo Obama e George W.
Bush scende in campo anche l'ex presidente democratico Jimmy Carter. "Siamo con
tutto il cuore con le famiglie delle vittime e con tutti coloro che si sentono
disperati di fronte all'onnipresente discriminazione razziale e alla crudeltà
pura e semplice", ha affermato in una nota.
Scontri a Brooklyn: tre poliziotti feriti. La notte è passata
tranquilla nella maggior parte delle città americane: in molte è in vigore il
coprifuoco. Scontri invece a Brooklyn dove un poliziotto è stato ferito da una
cltellata al collo e altri due in maniera lieve in scontri nelle ore del
coprifuoco: la dinamica degli eventi non è ancora chiara ma sembra che l'uomo
che ha attaccato i poliziotti sia stato a sua volta ferito. A New York nella
notte sono state arrestate 90 persone, in netto calo rispetto alle 280 di due
giorni fa.
Andrea Marinelli per il “Corriere della Sera” il 3 giugno 2020.
La retorica del presidente sui social network e le immagini da guerra civile in
tv hanno trasmesso insicurezza agli americani, facendo saltare persino le
barricate politiche dell' ultimo decennio. È una bomba a orologeria che la
stampa liberal ha cercato di disinnescare, sia per togliere un sostegno a Trump,
che vuole usare l' approccio «law and order» in chiave elettorale, sia per
abbassare i toni. Una strategia che è stata però colpita dal fuoco amico, al
punto che il New York Times , simbolo liberal , è stato criticato da sinistra
per la prima pagina di ieri. «Mentre si diffonde il caos, Trump promette di
porvi fine», titolava il quotidiano, accusato di aver tralasciato l' attacco ai
manifestanti che protestavano pacificamente davanti alla Casa Bianca. «Non amo
insultare il Times », ha twittato David Boardman, preside della scuola di
comunicazione della Temple University. «Il titolo però è sbagliato, si perde il
giorno più spaventoso della presidenza Trump». Altri commenti sono stati più
diretti. «Poteva essere un titolo di Fox News », ha scritto Andrew Bates, membro
dello staff di Biden. «Patetico. Un insulto ai lettori e a tutti gli altri», ha
rincarato Jon Lovett, ex speechwriter di Obama. Senza commentare, il Times ha
aggiustato il tiro, come successo ad agosto dopo le stragi di Dayton ed El Paso.
E così l' edizione online del mattino titolava: «Manifestanti dispersi con i gas
lacrimogeni per permettere a Trump di farsi fotografare in chiesa». A destra è
toccato a Tucker Carlson saltare il confine politico. Il conduttore di Fox News
, già critico sul coronavirus, ha attaccato Trump con un monologo di 30 minuti,
invitandolo a riprendere il controllo delle strade. «Puoi dire cose imbarazzanti
in tv, puoi assumere Omarosa alla Casa Bianca e sarà tutto perdonato se proteggi
la tua gente: altrimenti sei finito», ha affermato, riferendosi a una troupe di
Fox News assaltata sabato dai manifestanti davanti alla Casa Bianca. «Se non
puoi proteggere un corrispondente di Fox davanti a casa tua, come puoi
proteggere la mia famiglia, come puoi proteggere il Paese?». A prendere di mira
i giornalisti non sono però soltanto i manifestanti. Solo negli ultimi quattro
giorni, segnala il Nieman Lab di Harvard, sarebbero stati cento i casi di
violenza sui cronisti da parte delle forze dell' ordine: alcuni colpiti per
caso, sostiene il Nieman Lab, ma la maggior parte erano chiaramente
identificabili e sono stati attaccati deliberatamente.
Flavio Pompetti per “il Messaggero” il 4 giugno 2020. «Non sono
d'accordo sull'uso dell'esercito contro chi protesta, né sull'utilizzo della
legge per casi di insurrezione per motivarlo». Il ministro per la Difesa Mark
Esper ha annunciato una netta e inaspettata presa di distanza dalla posizione di
Donald Trump riguardo alle dimostrazioni in corso. Una critica dura, che mal si
concilia con la carica di massima fiducia che il presidente gli ha affidato meno
di un anno fa, e che ha immediatamente sollevato voci di una sua prossima
rimozione dall'incarico, o di sue dimissioni in arrivo. Si parla ora del
limitato potere che gli è stato affidato fin dall'inizio, con Mike Pompeo vero
arbitro delle decisioni del suo dicastero, e l'insoddisfazione strisciante che
lo stesso Trump nutrirebbe da tempo per il suo operato. La frattura fa seguito
al pasticcio consumato lunedì sera, con la passeggiata che ha portato Trump,
seguito dal suo stato maggiore avvertito di quello che stava per accadere, ad
uscire dalla Casa Bianca, attraversare il parco Lafayette, e sostare per una
foto di fronte alla chiesa episcopale di Saint John vandalizzata la notte prima
da alcuni dimostranti. La decisione è stata presa all'ultimo minuto, pare su
iniziativa dalla figlia del presidente Ivanka, per riscattare l'onta della
temporanea fuga domenica notte nel bunker alla quale Trump ha dovuto sottoporsi
in un momento di tensione. Il presidente ha negato che la visita sotterranea
fosse legata a motivi di sicurezza, e ha anche tenuto a precisare che l'arma
usata dalla polizia per aprirgli la strada verso la chiesa di St. John non era
gas lacrimogeno, ma cartucce fumogene e spray urticante. Ma l'attacco ai
dimostranti pacifici che non ha precedenti per un presidente degli Usa ha finito
per vanificare lo stesso pugno di ferro che Trump aveva voluto dimostrare nella
gestione della protesta. Anche l'ex capo del Pentagono, James Mattis, ha
condannato l'uso dell'esercito contro i manifestanti, definendo «abuso di potere
esecutivo» lo sgombero della folla davanti alla Casa Bianca per una «bizzarra
photo-op» del commander in chief. E ha invitato a «respingere e a richiamare
alle loro responsabilità chi ha cariche e deride la nostra costituzione». La
portavoce della Casa Bianca Kayleigh McEnany ha ripetuto che Trump farà uso
della legge anti insurrezionale del 1807 se necessario, ma l'ipotesi sembra
stemperarsi alla luce degli sviluppi più recenti. McEnany rivendica
all'intervento deciso del presidente l'improvviso calo della tensione e degli
scontri tra polizia e dimostranti che si è registrato la notte tra martedì e
mercoledì, quando i sindaci e i governatori di molti stati hanno anticipato
l'orario d'inizio del coprifuoco. A New York la polizia ha bloccato l'accesso
alle automobili nella parte alta di Manhattan, e la misura ha contribuito sia a
ridurre il flusso dei manifestanti, che la possibilità dei male intenzionati a
nascondersi tra di loro. Ieri da Minneapolis è poi arrivata la conferma che
potrebbe finalmente soddisfare la sete di giustizia della famiglia Floyd e di
chi è sceso in piazza a manifestare al suo fianco. Il procuratore generale dello
stato del Minnesota Keith Ellison, al quale il governatore Tim Walz aveva appena
assegnato il caso, ha elevato l'accusa contro il poliziotto che ha ucciso Floyd
bloccandogli la carotide con il ginocchio per quasi nove minuti: Derek Chauvin
dovrà ora rispondere di omicidio volontario non premeditato, e i tre agenti che
lo accompagnavano saranno arrestati come complici del delitto. La commemorazione
di George Floyd in programma oggi partirà con questo viatico.
Glauco Maggi per “Libero quotidiano” il 4 giugno 2020. C' è un'
offensiva omicida aperta contro i neri, e contro i poliziotti di tutti i colori,
che ha preso quota nella scia delle proteste per la morte di George Floyd,
l'afro-americano ucciso a freddo, senza causa, dal poliziotto bianco Derek
Chauvin che lo aveva già ammanettato. Tutto il mondo conosce il nome di Floyd
come vittima del razzista in divisa, su cui pendono accuse che gli potrebbero
costare 35 anni di galera per omicidio. I cortei pacifici di questi giorni in
tutta America hanno giustamente stigmatizzato il razzismo che cova ancora nella
società e a volte esplode negli individui disturbati come Chauvin (che infatti
aveva una lunga lista di rapporti negativi nella fedina professionale). Ma nelle
notti passate, le città di 28 Stati nei quali è stata mobilitata la Guardia
Nazionale hanno assistito allo scempio dei tumulti diretti dai radicali
organizzati con gli anarchici e gli ultra-sinistri che hanno rubato di tutto,
depredando negozi di alta moda e botteghe gestite da piccoli imprenditori,
moltissimi di famiglie di immigrati. È in questo caos che, all' ombra di una
stampa selettiva e concentrata solo sul messaggio anti Trump, sono successi
episodi gravissimi che hanno generato altre vittime, i cui nomi non sono finiti
in nessun alato editoriale di condanna, ma solo nelle cronache più asettiche e
nei necrologi delle famiglie. Del resto, come conciliare la mistica del razzismo
con la realtà della violenza cieca, che quando serve è protetta dalla
correttezza politica? David Dorn, 77 anni, afro-americano, ufficiale in
pensione, è una vittima scomoda di questa rivolta. Stava proteggendo un negozio
a St. Louis vandalizzato e derubato, ed è stato vittima della ferocia di
criminali-protestatari, insensibili al motto che «le vite nere contano». La
morte di Dorn è stata ripresa in diretta Facebook e le immagini del suo cadavere
sono state condivise via web e subito dopo rimosse. «Il nostro più alto rispetto
va alla famiglia di David Dorn, un grande capitano della Polizia di St. Louis,
che è stato barbaramente colpito da un colpo d' arma da fuoco e ucciso da
spregevoli saccheggiatori l' altra notte. Onoriamo i nostri agenti di polizia
più di prima», ha twittato il presidente. Sempre a St. Louis, la polizia ha
denunciato che quattro suoi agenti sono stati feriti da colpi d' arma da fuoco
durante le proteste per l' uccisione di George Floyd. «Sono stati tutti
trasportati in ospedale, sono coscienti, riteniamo che non siano in pericolo di
vita», ha reso noto il dipartimento metropolitano su Twitter, aggiungendo che la
situazione nel centro della città del Missouri è ancora tesa. Neri o bianchi?
Poliziotti, e tanto basta. Un altro nome destinato al dimenticatoio della storia
è Dave Patrick Underwood. Nero pure lui, era un agente del servizio di
protezione del Dipartimento della Sicurezza Nazionale ed è stato ammazzato da
killer che hanno sparato da lontano. Era di guardia davanti al palazzo federale
Ronald V. Dellums e al tribunale di Oakland, in California, assieme a un
collega, anche lui colpito ma non mortalmente. Per il capo della polizia locale
si è trattato di un attacco mirato a colpire agenti delle forze dell' ordine in
divisa. Il governatore Gavin Newsom, liberal, a proposito delle proteste di
piazza che hanno fatto seguito alla morte di Floyd, ha parlato «di gente
giustamente oltraggiata da come si continui a permettere che esista un sistemico
razzismo». Sull' omicidio di Underwood, ha invece promosso un distinguo peloso
figlio della cattiva fede liberal: «Nessuno dovrebbe affrettarsi a confondere
questo atto brutale con le proteste». Certo, il criminale in divisa di
Minneapolis che soffoca un poveretto nero è espressione del razzismo inguaribile
di tutti i bianchi, secondo la narrazione dei Democratici. Un militante armato
che nell' onda delle proteste spara a due poliziotti per la divisa che portano,
di cui uno di sicuro nero (dell' altro, almeno finora, non è apparsa l' identità
e la razza) risponde solo per sé. Non è significativo di nessuna ideologia o
appartenenza. Non è neppure un "compagno che sbaglia", come si diceva un tempo.
L'innocente per impaginato.it il 4 giugno 2020. La
logica liberal e progressista non fa una grinza. Soprattutto nei resoconti che
si leggono o ascoltano su quanto accade in America. Dove sembra esserci un solo
cattivo, Trump, e tantissimi buoni che lo combattono. Vedremo a novembre se è
davvero cosi o se, al contrario, i grandi e informati inviati hanno preso
l’ennesima, clamorosa cantonata. Nel frattempo alcune “perle” meritano di essere
classificate. Otto anni con Barack Obama alla Casa Bianca, otto anni colmi di
“hope” (speranza) e di colori della pace, 8 anni con decine di fatti simili a
quelli di Minneapolis, di neri ammazzati da poliziotti e di successive violenze,
ma ecco che la colpa dell’ennesimo episodio di razzismo e delle devastazioni
cittadine è di Donald Trump. Non tutti sanno (ma i giornalisti sì!), che la
polizia delle città americane dipende esclusivamente dai sindaci. Sono
i Mayor che pagano, nominano i vertici e, se del caso, allontanano gli agenti
inidonei. Tuttavia a leggere e sentire le cronache di questi giorni, sembrerebbe
che il caos sia stato generato dal Presidente Usa che ha osato scagliarsi contro
le devastazioni e i saccheggi. Minneapolis, per dire, è amministrata da almeno
tre lustri da sindaci democratici ultra-liberal che, ovviamente, hanno il totale
controllo sulla polizia locale. Ebbene, anche in quest’ultimo caso la colpa
dell’omicidio di George Floyd da parte di quel poliziotto (dopo 19 segnalazioni
di soprusi era ancora al suo posto!) sarebbe non tanto del primo cittadino ma
del “riporto biondo” che fa impazzire il mondo. Ancora. La figlia del sindaco
liberal di New York, Bill De Blasio viene arrestata dalla polizia perché intenta
a scagliare pietre contro alcuni negozi, ma suo padre - che è il responsabile
della NYPD - si dichiara “orgoglioso” di lei. Ne discerne che dopo il repulisti
di Rudolph Giuliani col suo “tolleranza zero”, nella Grande Mela devastazioni e
saccheggi, sono di nuovo cosa buona e giusta! Infine anche le bufale
smaccate. Rula Jebreal, pasdaran liberal, lautamente remunerata a Sanremo per
spiegarci come stare attenti ai soprusi e alle bugie in rete, posta una enorme,
grossolana fake news con un Hitler in posa con una Bibbia, accostata a quella
recente fatta da Trump. Peccato (per lei!) che proprio Twitter abbia segnalato
subito quel suo post come “manipolato”. Il sito Dagospia lo rileva subito. Ma
nessuna trombetta e nessun trombone del grande giornalismo nostrano fiata. La
logica liberal e progressista non fa una grinza!
"Mandate le truppe": un commento al caso Floyd sul New York
Times fa insorgere i giornalisti. Pubblicato giovedì,
04 giugno 2020 da La Repubblica.it. "Mandate le truppe". Il titolo non appare in
un tweet di Donald Trump, bensì nella pagina dei commenti del New York Times. Ma
non esprime la linea del principale quotidiano americano, progressista e critico
nei confronti del presidente. Il titolo presenta la column di un ospite a dir
poco contro corrente, il parere esterno di un noto senatore repubblicano, Tim
Cotton. Il senatore dell'Arkansas la pensa come il presidente degli Stati Uniti:
serve l'esercito per riportare ordine nelle strade d'America. Ma crea una
rivolta pubblica, all'interno della redazione del quotidiano. Diversi
giornalisti contestano la scelta della direzione e twittano il loro dissenso.
Molti dei tweet sono identici, ripetono questa denuncia: "Pubblicare questo
mette in pericolo i dipendenti neri del New York Times". Alla contestazione
pubblica reagisce il direttore delle pagine dei commenti, James Bennet. Anche
lui via Twitter, ricorda che il quotidiano "si batte da anni contro le crudeltà
sistematiche che hanno portato a queste proteste". Spiega però che la pagina
delle opinioni "ha il dovere verso i lettori di mostrare i contro-argomenti,
soprattutto se vengono da persone in grado di dettare la politica". Bennet dice
di capire che "molti lettori troveranno penosa e pericolosa la tesi del senatore
Cotton, ma è una buona ragione per sottoporla al dibattito e alla critica in
pubblico". Nella sua column, il senatore repubblicano rievoca i saccheggi
avvenuti nei giorni scorsi a New York, Los Angeles e altre città americane;
paragona la situazione odierna ai disordini violenti degli anni Sessanta;
sostiene che le polizie locali "hanno un disperato bisogno di rinforzi".
Conclude appoggiando la proposta di Trump e spiega che l'Insurrection Act
invocato dal presidente "non equivale a una legge marziale". L'opinione del
senatore Coton è apparsa mercoledì pomeriggio sull'edizione digitale, giovedì in
quella cartacea del quotidiano.
Roberto Fabbri per “il Giornale” il 2 giugno 2020. Città
americane a ferro e fuoco, morti e feriti, perfino la Casa Bianca sotto assedio.
E a Pechino si fregano le mani. Quale migliore occasione, infatti, per
restituire con gli interessi a Donald Trump la bordata anticinese sparata
prendendo le parti di quanti a Hong Kong chiedono libertà? Così, in questo nuovo
clima di guerra fredda tra l' Aquila e il Dragone, la macchina propagandistica
del partito comunista non ha perso tempo per dettare la linea ai media
nazionali: gli Stati Uniti stanno assaggiando la nostra stessa amara medicina e
farebbero bene a imparare la lezione, non si può fomentare la piazza in casa d'
altri e reprimerla in casa propria pretendendo di essere comunque dalla parte
giusta della barricata. «I politici statunitensi, che avevano definito le
proteste di Hong Kong uno spettacolo bellissimo da vedere, naturalmente non si
aspettavano che un simile spettacolo arrivasse così velocemente fin sotto le
loro finestre», scrive il Global Times. E il China Daily incalza intimando agli
americani di «mettere rapidamente da parte il sogno di interferire a Hong Kong
per minare la prosperità della Cina», per poi piazzare il messaggio di chiara
provenienza governativa: «I politici statunitensi dovrebbero fare il loro lavoro
e aiutare a risolvere i problemi negli Stati Uniti, invece di creare nuovi
problemi in altri Paesi». É evidente che la decisione di Trump di togliere lo
status speciale a Hong Kong, con le prevedibili gravi conseguenze economiche che
questo comporta non solo per l' ex colonia britannica ma per la stessa Cina,
rappresenta una sfida che Xi Jinping intende raccogliere. Il ministero degli
Esteri di Pechino annuncia dunque «ferme contromisure» anche ad altre azioni
ostili minacciate dalla Casa Bianca contro gli studenti cinesi negli States e le
aziende cinesi quotate nelle Borse americane. L'azione propagandistica della
Cina comunista continua inoltre a investire Washington anche per la decisione di
Trump di ritirarsi dall' Organizzazione Mondiale della Sanità. Una scelta
bollata come egoista e come prova di una politica «unilateralista e fondata
sulla forza». Ma Pechino sembra aver già imboccato anche la strada del conflitto
commerciale. Secondo Bloomberg, il governo cinese ha dato indicazione alle
principali aziende agricole statali (vengono citati colossi come Cofco e
Sinograin) di bloccare gli acquisti di prodotti americani come i semi di soia e
la carne di maiale, infliggendo così un colpo duro all' accordo commerciale a
suo tempo firmato con gli Stati Uniti. Tornando a questioni meno prosaiche, un
segnale preoccupante arriva da Hong Kong. La polizia ha respinto, per la prima
volta in trent' anni, la domanda da parte degli organizzatori dell' annuale
veglia per ricordare le vittime del massacro di piazza Tienanmen avvenuto il 4
giugno 1989. La giustificazione ufficiale per il diniego, esposta in una lettera
della polizia agli organizzatori, è di ordine sanitario: le regole di
distanziamento sociale contro il coronavirus vietano le riunioni di oltre otto
persone. É però evidente che le autorità temono il verificarsi di manifestazioni
ostili al governo di Pechino, e che intendono impedirle in coerenza con lo
spirito delle annunciate nuove leggi «per la sicurezza». Il rischio di
manifestazioni non autorizzate, e della loro inevitabile repressione, è più che
mai reale.
“Sono i suprematisti bianchi che istigano alla guerra
razziale”. Morte Floyd e la violenza contro i neri, la
sociologa: “Divario tra bianchi e afroamericani più ampio che negli anni ’60”.
Rossella Grasso su Il Riformista il 2 Giugno 2020. La drammatica morte di George
Floyd, soffocato a Minneapolis da un poliziotto che gli ha premuto per 9
interminabili minuti il ginocchio sul collo, ha riacceso le proteste negli Stati
Uniti. E ha acuito il risentimento tra la popolazione afroamericana che non si è
mai sentita rispettata, ma sempre privata di diritti e marginalizzata. Non è un
sentimento ma un dato di fatto testimoniato dai numeri. Quello che emerge
dai report pubblicati negli USA conferma una situazione di violenza che colpisce
soprattutto i neri. Una ricerca pubblicata qualche anno fa sulla rivista
scientifica Plos One evidenzia questo divario: negli USA un afroamericano
disarmato ha la probabilità di essere ucciso dalla polizia mediamente 3,5 volte
superiore rispetto a un bianco ugualmente disarmato. Un dato che in alcune
contee si spinge fino a 20 volte più su. Nello stesso dossier si legge che la
probabilità per un nero di essere sparato dalla polizia è più alta nelle città
più grandi, dove i salari medi sono più bassi e c’è un gran numero di residenti
neri. E infine “non c’è relazione tra l’influenza razziale negli spari della
polizia e il tasso di crimine”: in poche parole il report dimostra che non c’è
una correlazione tra la violenza eccessiva della polizia e un alto tasso di
criminalità. Secondo il sito mappingpoliceviolence.org, il 99% degli agenti che
vengono accusati o condannati per questi eventi non riporta accuse di tipo
penale. “Tutto ciò sta riportando a galla con forza il vecchio trauma storico
della popolazione afroamericana”, spiega Rita Sinorita Fierro, sociologa
italo-americana, nata a New York, con un dottorato di studi afro-americani tra
le università La Sapienza di Roma e la Temple University di Philadelphia. Vive e
lavora negli Stati Uniti ed è spesso in contatto con gruppi di attivisti
afroamericani. In 15 anni di esperienza sul campo tra quartieri dei bianchi e
dei neri, si è fatta un’idea ben precisa di quello che sta succedendo
in un’America che sembra essere tornata indietro nel tempo. Una nazione dalle
grandi ambizioni ma che negli ultimi giorni ha riportato al mondo l’immagine
stridente di una democrazia dal primo presidente afroamericano ma che continua
nei fatti a trattare diversamente una parte dei suoi concittadini. I
suprematisti bianchi che cavalcano l’odio – Rita ci accompagna in un breve giro
nella città di Philadelphia, tra i vetri rotti delle vetrine e i negozi
saccheggiati e spiega che c’è un criterio in quanto accaduto: “Si tratta di una
polemica contro le grandi catene – spiega la sociologa – che aprono negozi ma
portano altrove i soldi guadagnati. C’è una critica allo sfruttamento della
gente povera che alimenta catene enormi che poi non reinvestono negli stessi
spazi”. Rita racconta che a Minneapolis quando la rivolta è scoppiata è stata
subito cavalcata da suprematisti bianchi che hanno iniziato a spaccare tutto.
Poi la colpa è ricaduta sui neri. “A Minneapolis hanno scoperto che tutte le
persone arrestate dalla polizia durante la seconda notte non era locale e che
sono state trovate riserve di bombe a mano probabilmente preparare mesi fa. Poi
ci sono persone che vanno in giro con maschere a gas, loro erano già pronti a
una rivolta di questo tipo. Il nazionalismo bianco è gravemente cresciuto con
l’era di Trump. Ma in realtà sono cresciute già il giorno dopo l’elezione
di Obamba, perché videro l’elezione del primo presidente afroamericano come un
affronto. Un nero non sarebbe mai dovuto essere eletto presidente. Quello che
vogliono i suprematisti bianchi è istigare una guerra razziale. Ci sono tanti
video che testimoniano che sono i bianchi che mentre i neri protestano in strada
spaccano vetri e vanno via. Poi c’è chi trova il negozio aperto, entra e fa
razzia. Ma non sono tutti le stesse persone, c’è un miscuglio generale”. La
violenza della polizia contro i neri. Rita racconta che Obama ha avviato una
serie di indagini nei distretti di polizia perché i numeri degli afroamericani
morti per mano della polizia erano aumentati a dismisura. La sociologa ha fatto
parte del team di valutazione del programma di training per polizia e comunità
sull’istruzione ai trauma. Un training volto a migliorare il rapporto tra
comunità e polizia. Ha svolto questo lavoro in particolare a Newark, New Yersey,
una delle città in cui gli agenti erano risultati più colpevoli per abuso di
forza nelle comunità di colore. “Ciò significa che nelle zone dei bianchi questi
poliziotti si comportavano in maniera più tranquilla, in zone nere, invece,
usavano la mano pesante. Visto che molti di questi poliziotti erano colpevoli di
aver agito con eccessiva violenza, si è deciso di porre delle telecamere sulle
loro divise. Accorgimenti in più ce ne sono stati ma questo non basta”. Con le
nuove tecnologie la violenza è sotto gli occhi. La ricercatrice ha studiato per
anni l’afrocentricità e l’antirazzismo negli Stati Uniti: il frutto del suo
lavoro è racchiuso nel libro dal titolo “L’identità afroamericana. Nascita ed
evoluzione del movimento afrocentrico degli Stati Uniti” (ed. L’Harmattan).
Spiega che le uccisioni dei neri da parte della polizia ci sono sempre state, a
partire dagli anni della fine della schiavitù. Quello che c’è di differente oggi
e che sta accendendo maggiormente la voglia di riscatto sono i social media.
“Tra gli smartphone e Facebook è tutto davanti ai nostri occhi così come
accade”. La sensazione di ingiustizia e quella di non contare. La violenza di
per se è una ferita grave per gli afroamericani, ma per Rita Fierro la cosa per
loro più insopportabile è che spesso i poliziotti che sparano non vengono
imputati: non sono nemmeno sottoposti a processo. La sociologa frequenta varie
comunità afroamericane, vive in un quartiere prevalentemente afroamericano, e
conosce bene il senso di ingiustizia che affligge chi magari ha visto il proprio
fratello o figlio morire sotto il tiro della polizia. A questo si aggiunge la
sensazione di non contare affatto nella società. “Quando si sono resi conto che
a morire di Covid erano soprattutto gli afroamericani e di ceto basso hanno
detto ‘vabbè riapriamo comunque, muoia chi muoia’”. Una generazione delusa. “Non
sono solo le ultime uccisioni, ma tutte le morti accumulate che stanno
accendendo la rabbia specialmente nei più giovani”. Fierro parla soprattutto
della generazione tra i 20 e i 30 anni, quella che è vissuta con un presidente
nero per 8 anni e che per la prima volta ha avuto un senso di positività verso
il futuro: “Hanno vissuto la leadership nera nella quotidianità con l’elezione
di Obama e hanno fiducia”, dice la sociologa. Gli ultimi eventi di cronaca
stanno scalfendo il loro entusiasmo, che si sta trasformando in necessità di
protesta, per questo secondo Rita Fierro sta aumentando l’attivismo e la rabbia
in tutta la nazione. Questi ragazzi sentono ancora molto quello che è successo
ai loro genitori o ai loro nonni durante le lotte contro la segregazione
razziale degli anni ’60: “È la generazione subito prima di loro a essere stata
presa a morsi dai cani della polizia e pestati a calci dai loro cavalli. Non è
passato abbastanza tempo da poterlo dimenticare”. “Il divario tra bianchi e neri
più ampio che negli anni ’70”. “Oltre ai ricordi le nuove generazioni fanno i
conti con una frustrazione intensa: la discriminazione nella quotidianità”. Le
statistiche infatti dimostrano che i neri, anche se di estrazione borghese, sono
sempre più poveri rispetto ai bianchi o comunque vivono situazioni più precarie
sotto vari aspetti. Le difficoltà economiche rendono sempre più raro l’accesso
alle Università e a una formazione migliore. La conseguenza è che i neri
occupano le posizioni lavorative meno prestigiose e il guadagno è più
basso. “Molti afroamericani dicono che la schiavitù non è mai finita, ma è solo
cambiata. Ci sono afroamericani che hanno avuto successo ma sono solo casi
isolati. Molti sociologi hanno studiato che il divario tra bianchi e neri è più
ampio adesso che negli anni ’60 e ’70”. Secondo la sociologa quei sistemi creati
per tenere i neri separati dai bianchi fino al tempo delle lotte per i diritti
civili sono cambiati di nome ma non di fatto. Una considerazione frutto di sei
anni di studio per la sua tesi di dottorato alla Temple University di
Philadelphia. “Noi abbiamo reso illegale la discriminazione aperta ma in modo
implicito si è continuato a farlo”, dice la ricercatrice. Sostiene che negli
Stati Uniti ogni sistema agisce sulla popolazione bianca e nera di fatto in modo
diverso, anche se questo non si può mai dire esplicitamente. E fa alcuni esempi:
“Negli USA le scuole sono finanziate per lo più dalle tasse locali, e solo in
minima parte da fondi statali. Questo vuol dire che una scuola di una zona
povera riceve molti pochi soldi rispetto a quella di una zona ricca, tutto
questo a distanza di pochi chilometri. E chiaramente nelle zone povere vivono i
neri”. La sociologa parla anche della crisi dell’oppio, un’altra testimonianza
di come in USA ci siano sempre state due americhe. “Quando l’eroina che ha a
base l’oppio ha devastato le comunità afroamericane tra gli anni ’70 e ’80, la
politica era fare ‘guerra’alla droga. Quando i tossicodipendenti erano i bianchi
c’è stato invece tutto in giro di compassione nei loro confronti e un grande
investimento per essere di supporto a queste persone. Agli afroamericani per la
stessa dipendenza compassione zero, anzi guerra”. La dottoressa cita anche
il sistema dell’assistenza sociale che toglie i figli alle famiglie e colpisce
per lo più i neri, o i sussidi che privilegiano le madri vedove piuttosto che le
ragazze madri che sono in prevalenza nere. Rita Fierro conosce bene queste
tematiche su cui sta svolgendo ricerche da 15 anni e su cui ha incentrato il
libro “Ridammi mio figlio”, di prossima pubblicazione. Per la sociologa ogni
sistema in America ha fatto questo e quindi la discriminazione è avvenuta in
modo indiretto. “La situazione degli afroamericani rispetto agli anni ’60 è
peggiorata – continua la sociologa – Basti pensare che in carcere ci sono più
afroamericani oggi che quanti ne erano schiavizzati negli anni della schiavitù”.
Segregazione abitativa e il velo della cordialità. Una recente mappatura delle
maggiori città americane fatta dal New York Times, testimonia come la
segregazione continua a livello geografico. Gli immigrati e gli afroamericani si
accorpano per quartieri formando dei veri e propri ghetti: “la stessa situazione
che Martin Luther King stava cercando di abolire quando è stato ucciso” chiosa
la sociologa italoamericana. Qui nascono e proliferano i luoghi comuni, per cui
in una città come Philadelphia, che è per metà abitata da bianchi e per l’altra
metà da neri, è difficile trovare la sera seduti in un bar lo stesso numero di
bianchi e di neri. Rita Fierro racconta che a Philadelphia la diffidenza tra
bianchi e neri c’è, ma è sempre nascosta da un velo di cordialità: “È il modo in
cui gli Stati Uniti hanno messo sotto il tappeto la segregazione: i bianchi che
non si ritengono razzisti sono molto cordiali con i neri, ma spesso gli
afroamericani recepiscono questo atteggiamento come finto. La dinamica che si
crea è paradossale: un bianco, che non ha rapporti con gli afroamericani e non
ne capisce la storia, cerca di essere rassicurato dal nero sul fatto di essere
una brava persona. Ha bisogno di una "validazione esterna" sulla propria bontà.
Gli afroamericani questa cosa la detestano perché soffrono il trauma storico ma
purtroppo sanno che per vivere in questa società devono imparare ad esserlo”.
Usa paese razzista, compresi gli italoamericani. Molti degli americani lo
confermano: “Gli Stati Uniti sono un paese razzista, è ancora lunga la strada da
fare”. E anche gli italo-americano non sono stati da meno. La sociologa racconta
che in massa hanno votato Trump perché nemmeno loro potevano accettare l’idea
del presidente afroamericano. “Na novità di questa ondata di proteste è che sono
tantissimi i bianchi che stanno partecipando alle manifestazioni, molto più che
in passato. E questo mi dà una grande speranza che qualcosa sta cambiando”.
Le proteste in USA viste da un’afroamericana: “La morte di
Floyd ricorda l’epoca dei linciaggi per strada nel 1876”.
Rossella Grasso su Il Riformista il 3 Giugno 2020. “L’immagine
del poliziotto che spinge il ginocchio sul collo di George Floyd mi ha ricordato
l’epoca in cui vigevano le leggi Jim Crow, quando eravamo linciati solo per il
fatto di stare camminando in strada, così solo per gioco”. Con queste
parole Aliesh Pierce, afroamericana di Long Beach, ha commentato le violenze e
le rivolte che si stanno susseguendo negli ultimi giorni negli Stati Uniti in
risposta alla morte di George Floyd. Aliesh è una make up artist che gira il
mondo truccando le star di tutte le nazionalità. I suoi genitori hanno vissuto
l’epoca delle proteste per i diritti negli anni ’60 e oggi rivive quegli stessi
sentimenti con le proteste attuali. “Quello che sta succedendo è una reazione
all’essere stati marginalizzati per anni”, dice. Aliesh fa riferimento alle
Leggi Jim Crow che furono in vigore negli stati uniti dal 1876 e il 1964, da
quando fu abolita la schiavitù in America e perdurarono per quasi 100 anni,
norme che servirono a creare e mantenere la segregazione razziale in tutti i
servizi pubblici. “Separati ma uguali”, era il motto che cancellava
dall’ordinamento la parola “schiavo” e la sostituiva con “nero”, introducendo la
possibilità del linciaggio per futili motivi e iniziative arbitrarie come
il coprifuoco. Gli afroamericani non erano più schiavi e dunque non erano più
proprietà privata e per assurdo la loro situazione peggiorò drammaticamente: non
erano più tutelati e per questo venivano linciati dai bianchi anche per nessun
motivo e nessuno lo impediva. In quel periodo ne morirono circa 6.000 in tutti
gli Stati Uniti. E’ stato proprio il suono dell’allarme che rimbomba per le vie
di Philadelphia a far tornare alla memoria a Aliesh quelle leggi razziali. “Ero
insieme ad altre 4 persone perché stiamo organizzando l’apertura di un nuovo
centro estetico – racconta la make up artist – Mancava un quarto d’ora alle 18
quando è suonato l’allarme. Ci segnalavano che avevamo 15 minuti per tornare a
casa perché poi iniziava il coprifuoco. Il problema della differenza tra i
bianchi e i neri tocca concretamente la mia vita. Nella mia comunità siamo tutti
gente di pace”. Aliesh non sta fisicamente prendendo parte alle rivolte ma sta
partecipando emotivamente e con un contributo economico. “Tutti noi dobbiamo
protestare in qualche forma in questo momento”, dice. Aliesh è a Philadelphia da
soli tre mesi, prima abitava a long Beach. Ha visto le immagini
dei poliziotti che lì si sono inginocchiati e hanno solidarizzato con i
manifestanti. Ha visto migliaia di persone, bianche e nere camminare insieme.
“Vederli uniti finalmente mi ha molto commosso”. “La cosa che più mi fa paura in
questo momento sono i suprematisti bianchi che vanno in giro distruggendo tutto
– dice – fanno ricadere la colpa sui neri, dicendo che sono loro a rovinare
l’economia. E poi sono i suprematisti bianchi che inneggiano alla violenza e
questo mi spaventa moltissimo”. E cita il presidente J.F. Kennedy che subito
dopo la rivolta nell’università del Mississippi del 1962 disse: “Coloro che
rendono impossibile la rivoluzione pacifica renderanno inevitabile la
rivoluzione violenta”: “Credo si estremamente attuale questa frase”. Per la
make-up artist poco o nulla è cambiato rispetto alle lotte che hanno fatto i
suoi genitori negli anni ’60. “Il problema è lo stesso – dice – il modo non
cambia. L’unica cosa diversa è la televisione, i social network, le immagini che
riusciamo facilmente a vedere sotto i nostri occhi. Abbiamo visto la morte di
George Floyd con i nostri occhi”. Gli Stati Uniti sono la sua nazione, è lì che
è nata, ma dice che il divario tra bianchi e neri è ancora larghissimo. “Certo
magari adesso ci apprezzano di più, alla gente piace la nostra cultura, ma non
abbiamo guadagnato il loro rispetto. Piace come giochiamo a calcio, a basket,
come cantiamo o balliamo, ma non c’è rispetto umano per la persona”. Quindi gli
Stati Uniti d’America, nonostante il primo presidente afroamericano, resta un
paese razzista? “Assolutamente si, non potrebbe essere diversamente – dice
Aliesh – Quelli di oggi sono i nipoti dei razzisti di un tempo. Finchè non
troveremo un modo per unirci sarà sempre così. Però una speranza c’è: vedo più
gente di colore nella polizia e in posti governo. Dobbiamo cambiare le cose da
dentro, cercando di trovare pace con la vecchia mentalità”.
"La vostra rabbia è la mia rabbia".
L’America dimentica Bob Kennedy, il suo discorso del ’68 una lezione per Trump e
Biden. Vittorio Ferla su Il Riformista il 18 Giugno 2020. Robert Fitzgerald
Kennedy muore per un colpo di arma da fuoco nella notte tra il 5 e il 6 giugno
1968, mentre attraversa le cucine dell’Ambassador Hotel di Los Angeles. Ha
appena festeggiato con i suoi sostenitori la vittoria nelle primarie
della California. Sono passati 52 anni da allora, eppure, in questi giorni di
proteste razziali, la figura di Bob sembra più attuale che mai. Al momento della
sua morte, infatti, Rfk è l’uomo bianco più apprezzato e stimato nell’America
nera. Si è opposto ai leader razzisti su entrambi i versanti della Mason-Dixon,
la linea che segna il confine tra l’America schiavista del Sud e quella liberale
– ma pur sempre a suo modo bigotta – del Nordest. Si è impegnato contro la
disoccupazione e la fame diffuse tra gli afroamericani del tempo. Ha usato il
suo scranno da senatore per avviare i primi programmi anti-povertà dal Delta
del Mississippi al Bedford-Stuyvesant di Brooklyn, il più grande ghetto
degli Stati Uniti. In questi giorni in cui i neri americani si rivoltano contro
il “ginocchio” della discriminazione che ancora schiaccia il loro “collo” –
proprio come quello dell’agente Derek Chauvin che ha ucciso il povero George
Floyd – la testimonianza di Bob è più moderna che mai. Sempre nel 1968, il 4
aprile – esattamente due mesi prima della morte di Kennedy – Martin Luther
King viene ucciso a colpi di arma da fuoco fuori dalla sua stanza al Lorraine
Motel di Memphis. In quel momento, Bob si trova in Indiana per la prima tornata
delle primarie per la campagna presidenziale. Viene informato della morte di
King appena atterrato a Indianapolis. Di lì a poco avrebbe dovuto partecipare a
una manifestazione all’aperto proprio nel cuore del ghetto nero di Indianapolis.
Il capo della polizia, afroamericano, temendo per la sua sicurezza e per paura
di disordini in città, gli sconsiglia di partecipare. Ma Bobby non vuole nemmeno
sentirne parlare: «Vado lì e basta», dice, chiedendo alla sua scorta di
allontanarsi poco prima del suo arrivo. Il discorso di quella sera è rimasto
celebre e ancora oggi è possibile riascoltarne l’audio: «Ho alcune notizie molto
tristi per tutti voi. Martin Luther King è stato colpito e ucciso questa sera»,
annuncia dal piano del camion adibito a palco, il cappotto scuro stretto per
proteggersi dal freddo, ma forse anche per timore delle reazioni, mentre il
pubblico urla “No! No!” con una sola voce. Continua alzando la voce, ancora
tremante: «A quelli di voi che sono neri e oggi sono colmi di odio e di sfiducia
contro tutti i bianchi per l’ingiustizia subita, dico solo che anche io riesco a
sentire nel mio cuore lo stesso sentimento. Anche io ho un membro della mia
famiglia ucciso da un uomo bianco». Il ricordo del fratello John gli dà
autorevolezza. L’impegno per superare le diseguaglianze razziali fa il resto.
«Ciò di cui abbiamo bisogno negli Stati Uniti non è la divisione; ciò di cui
abbiamo bisogno negli Stati Uniti non è l’odio; ciò di cui abbiamo bisogno negli
Stati Uniti non è la violenza e l’illegalità, ma è l’amore, la saggezza e la
compassione reciproca e un sentimento di giustizia verso coloro che ancora
soffrono nel nostro Paese, siano bianchi o neri». E conclude: «Vi chiedo quindi
stasera di tornare a casa, di dire una preghiera per la famiglia di Martin
Luther King, ma soprattutto di dire una preghiera per il nostro Paese, che tutti
noi adoriamo». Come spiega Larry Tye, ex giornalista del Boston Globe e autore
di Bobby Kennedy: The Making of a Liberal Icon, le parole di quel discorso,
della durata di appena cinque minuti, erano perfette: «Nessun altro come Bobby
sarebbe stato altrettanto credibile nel parlare della riconciliazione razziale o
del dolore per l’uccisione di una persona cara. Era la prima volta che si apriva
in pubblico parlando di suo fratello Jack. I suoi ascoltatori avvertivano la sua
sincera emozione. Sembrava che desiderassero confortarlo proprio mentre cercava
di calmarli». John Lewis a quei tempi era uno dei giovani Freedom Riders che, a
cominciare dal 1961, percorsero in autobus le tratte interstatali nel Sud
degli Stati Uniti per far valere le sentenze della Corte Suprema che vietavano
la segregazione dei neri sui mezzi di trasporto. Oggi Lewis, eletto nel
frattempo alla Camera dei Rappresentanti per lo Stato della Georgia, ricorda:
«Fare quel discorso quella notte è stato un gesto incredibilmente potente,
capace di unire le persone ed emotivamente onesto». Per Lewis, la candidatura di
Bobby per la Casa Bianca prometteva davvero la costruzione di nuovi ponti tra le
etnie. «Quella notte ho detto ai miei amici che non avevamo più King, ma che
avevamo ancora Kennedy», ricorda Lewis. L’attualità della testimonianza di Bob,
insomma, risuona oggi più che mai nel clima di divisione di questi giorni.
Quella notte di aprile di 52 anni fa, Kennedy non solo bypassa il sindaco e il
capo della polizia, ma riesce a disperdere una folla incattivita e, in alcuni
casi, armata. Durante l’insurrezione afroamericana per l’omicidio di King – che
vede scoppiare rivolte in oltre 100 città degli Usa – Indianapolis rimane
un’isola di calma. «Il modo in cui Kennedy incantò il pubblico – ricorda Larry
Tye – sarebbe stato inimmaginabile per i suoi rivali politici più ingessati: il
presidente Lyndon Johnson, il vicepresidente Hubert Humphrey o il
senatore Eugene McCarthy». Il pensiero corre subito a Joe Biden, oggi in lizza
per la Casa Bianca. Il candidato ci prova, partecipando a eventi simbolici o
inginocchiandosi con tanto di mascherina – come hanno fatto i poliziotti
di Houston e Minneapolis – nel ricordo di George Floyd. Ma resta un personaggio
goffo e impacciato, facile alla gaffe: «Un nero che non sa scegliere tra me e
Trump non è un nero», ha detto, pensando di fare il simpatico, qualche giorno
fa. Nessuno pretende un nuovo Kennedy, certo. Ma tanti temono che un ex
vicepresidente a fine carriera sia un po’ poco per licenziare Trump dalla Casa
Bianca.
Da Kennedy a Trump il declino dell’America, intervista a Furio
Colombo. Umberto De Giovannangeli su Il Riformista il
2 Giugno 2020. «L’insurrezionalismo bianco c’è sempre stato nella storia
americana, ed è sempre stato antinero e antiebreo, ma non aveva mai avuto un
capo politico legittimo, in grado di apparire nelle comunicazioni nazionali. Da
quattro anni questo capo c’è. Siede alla Casa Bianca, e il suo nome è Donald
Trump». Se c’è un giornalista e scrittore che conosce ogni sfaccettatura del
“pianeta Usa”, questi è Furio Colombo. Negli Stati Uniti è stato corrispondente
de La Stampa e La Repubblica. Ha scritto per il New York Times e la New York
Review of Books. È stato presidente della Fiat Usa, professore di giornalismo
alla Columbia University, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura.
Il Riformista lo ha intervistato, in uno stimolante viaggio
politico-intellettuale che lega passato e presente. Sintetizzabile nel titolo di
uno dei suoi libri più recenti: Trump Power. Dalla Nuova Frontiera di JFK al
Muro di Donald. Cosa è successo all’America (Power First).
“A time for greatness”: così recitava lo slogan elettorale
della campagna presidenziale del 1960 di John Fitzgerald Kennedy, una delle
grandi campagne elettorali nella storia degli Stati Uniti d’America.
Sessant’anni dopo, cosa è rimasto di quel “time for greatness”?
«Ciò che è rimasto del passaggio
della “meteora Kennedy” è un senso di aspettativa di cose grandi, nuove,
intelligenti e davvero fortemente innovative. La parola innovazione nasce
allora, con JFK. È allora che l’America più giovane comincia a intravvedere che
il senso di sé non è la continua celebrazione dei fasti, veri o presunti, del
passato ma è l’invenzione del futuro. È un cambio di prospettiva, di visione, di
straordinario significato in un Paese nelle cui vene continua a pulsare la
celebrazione continuata di se stessa, e in questa vena che si colloca Trump.
Kennedy rappresentò una rottura radicale di questa narrazione autocelebrativa,
affermando l’idea di una ricelebrazione come costruzione e immaginazione del
futuro. Come dire a se stessi: abbiamo un dovere molto più grande verso il
mondo. E questo dovere sta nel dare l’esempio e segnare la strada, invece di
bloccarla e presidiarla. Una rottura tanto più significativa, perché a
determinarla non era “solo” il candidato Kennedy, ma anche lo scrittore Kennedy,
che nel 1957 ricevette il prestigioso premio Pulitzer per il libro, che scrisse
nel 1955 quando era un giovane senatore, Profiles in Courage (Ritratti del
coraggio). Il coraggio di prendere decisioni impopolari ma necessarie anche a
rischio della carriera politica e perfino della vita. Questo fu, per molti
versi, il lascito più importante di John Fitzgerald Kennedy, che oltre ad essere
più affascinante, elegante, comunicativo, era anche il più colto. Per realizzare
le cose in cui si crede si deve mettere in conto anche l’essere impopolari.
Davvero una grande lezione».
Una lezione che ci porta all’oggi. Un oggi infuocato per
l’America. La rivolta degli afroamericani scatenata dall’uccisione di George
Floyd a Minneapolis, si estende e si radicalizza. Si contano le prime vittime,
in oltre 40 città americane è stato dichiarato il coprifuoco. Cosa cova sotto la
cenere della rivolta?
«Cova qualcosa che attenti
intellettuali americani, purtroppo non molti e neanche i più mediatizzati, hanno
tenuto sottocchio, e cioè il suprematismo bianco. Il suprematismo bianco non è
un fenomeno del Terzo Millennio. In Racconti di rabbia, John Dyer parlava nel
1980 di settantamila suprematisti bianchi attivi che aspettavano un segnale per
cominciare la caccia ai negri. Bisogna ricordare che l’equilibrio americano,
sulla questione razziale, si è mantenuto perché il partito Repubblicano per
tutto il dopoguerra, dal dopo Nixon in avanti, si era associato all’impegno dei
Democratici nel difendere e radicare i diritti civili. Semmai, c’è da mettere in
evidenza un singolare rimescolamento trasversale ai due partiti, prima e dopo
Kennedy. Rimescolamento nel senso che molti repubblicani erano antirazzisti, al
contrario di molti democratici del Sud, che invece sposavano posizioni
marcatamente razziste. È il caso eclatante del governatore dell’Alabama, George
Wallace, democratico e bianco, che avrebbe voluto impedire l’accesso
all’università dell’Alabama del primo studente nero, James Meredith, il quale,
scortato dall’esercito inviato dal ministro della Giustizia, Robert Kennedy,
entrò all’università. «Io sono stato eletto per questo», motivò Wallace il suo
comportamento. «E io devo rispondere a tutti i cittadini americani», replicò
Robert Kennedy, aggiungendo che se l’Alabama avesse mantenuto il punto, sarebbe
uscita dalla Federazione, che da 50 Stati sarebbe passata a 49. Successivamente
Wallace fu colpito da una tragedia personale, vittima di un attentato di estrema
destra, e divenne uno dei grandi governatori liberal dell’Alabama, Già dagli
anni Settanta, questo filone del suprematismo bianco aveva tre nemici contro cui
combattere anche con azioni terroristiche».
Quali erano queste tre battaglie?
«La prima era contro l’aborto, al
punto da assassinare medici abortisti, almeno una decina e altri feriti
gravemente, e far saltare in aria una ventina di cliniche che praticavano
l’interruzione di gravidanza. E qui c’è l’affermazione, documentata, di Dyer,
secondo cui ci sono più morti americani per mano di americani, di quelli rimasti
vittime del terrorismo islamico, compresi i 3mila morti delle Torri Gemelle. Non
appena si è allontanata la memoria di John e Robert Kennedy, il suprematismo
bianco ha alzato la testa, marcato ancora di più il suo imprinting razzista,
antisemita e anche anticattolico, contro una Chiesa giudicata troppo indulgente.
Il suprematismo si fece ancor più pericoloso, come testimoniano due eventi che
segnano questo saltò di pericolosità: 28 febbraio 1993. Quel giorno degli agenti
della Polizia federale che si occupa di narcotraffico e di armi – U.S. Bureau of
Alcohol, Tobacco and Firearms (ATF) – si presentarono al ranch di Mount Carmel a
pochi km da Waco, in Texas con un mandato di perquisizione della magistratura.
Di fronte agli agenti muniti di regolare mandato di perquisizione, gli abitanti
del ranch reagirono con una sparatoria. Dopo 50 giorni l’Fbi che aveva preso la
direzione delle operazioni diede il via a un assalto. Nella sparatoria e
nell’incendio che seguirono morirono 76 persone incluso il capo della setta,
David Koresh. Da allora “il massacro di Waco” è diventato per l’estrema destra
un simbolo potente: un episodio di resistenza armata di liberi cittadini contro
uno Stato centrale totalitario e oppressivo. La seconda data è il 19 aprile
1995: un attentato terroristico rade al suolo l’Alfred P. Murrah Federal
Building, l’equivalente di una nostra prefettura, nel centro di Oklahoma City.
Il bilancio è di 168 morti, tra cui 19 bambini, e 672 feriti. A compiere questa
immane strage fu un veterano della guerra del Golfo, Timothy McVeigh,
(condannato a morte e giustiziato l’11 giugno 2001, ndr) diventato un eroe per i
suprematisti bianchi, non solo americani. Una lunga punteggiatura di sangue che
ci porta fino a Trump, che a quei tempi non esisteva ancora come leader
politico. Questi due attentati sono la prova più grande che qualcosa di grosso e
di estremamente pericoloso esisteva già prima dell’emergere come politico di
Donald Trump».
Cosa ha aggiunto The Donald a questo fenomeno inquietante?
«Trump ha dato una vampata di
incoraggiamento al razzismo antinero e anti-ispanico, proiettando questo
atteggiamento razzista anche oltre i confini americani. Vede, non ho nascosto
che la vittoria di Trump mi ha trovato sorpreso. Poi, però, ho capito che si è
trattata della risposta dell’America dei bianchi all’America nera.
L’insurrezionalismo bianco c’è sempre stato, ed è sempre stato antinero e
antiebraico, ma non aveva mai avuto un capo politico legittimo in grado di
apparire nelle comunicazioni nazionali. C’erano potenti capi banda e pericolosi
capi clan, ma nessuno era mai arrivato alla ribalta politica nazionale. Fino a
quando entra in scena Donald Trump, che fa suo fino all’ultimo punto la
predicazione dei suprematisti bianchi, spingendosi fino al punto di twittare,
nel vivo di una rivolta sempre più estesa, che “antifa” (antifascista) sarà
considerato un termine terrorista – termine da lui mai utilizzato per i crimini
dei suprematisti – e che gli “anarchici radicali” saranno sedati “dai cani più
feroci dei servizi segreti”. Attorno a Trump, peraltro, si creano due grandi
equivoci mai chiariti…»
Quali?
«Il rapporto con i cattolici. Steve
Bannon, ideatore della campagna presidenziale di Trump e ispiratore ideologica
del suo “America first”, si dichiara apertamente un estremista cattolico, e ha
portato per la prima volta, con brutalità e violenza, una parte dei cattolici,
dalla parte dell’estrema destra. L’altro equivoco riguarda i rapporti con
Israele e parte dell’ebraismo americano. Israele non ha mai avuto amici razzisti
né li ha mai accettati, basti pensare al sostegno di Martin Luther King,
dall’altra parte, però, c’è il fatto di avere in casa il marito della sua figlia
prediletta, Ivanka, quel Jared Kushner che viene da una famiglia ricca come
quella di Trump e che ha assunto un ruolo informale, e se si vuole illegale,
perché mai ufficializzato, di consigliere presidenziale per il Medio Oriente e,
in particolare, per i rapporti con Israele. Non è Israele che sta a cuore a
Trump, ma stabilire e rafforzare i rapporti con una destra dura, spregiudicata
e, se necessario, estrema. Noi non stiamo parlando del rapporto fra un grande
Paese democratico e ciò che rappresenta libertà e democrazia in Medio Oriente,
ma del rapporto fra due leader, Trump e Netanyahu, che appartengono allo stesso
tipo di destra. La commistione fatta da Trump, e dal suo consigliere-genero, ha
lacerato l’ebraismo americano, che almeno per la metà è anti-Trump».
A novembre l’America elegge il nuovo presidente. Joe Biden, il
candidato dei Democratici, è l’uomo giusto per contendere a Trump la Casa
Bianca?
«È come se ai tempi della resistenza
antifascista ci si fosse interrogati se Ferruccio Parri era l’uomo giusto.
Semplicemente, è quello che avevamo. Forte, onesto, coerentemente antifascista.
Biden è un sincero democratico, ed è stato grande sostenitore di Obama. Ci
auguravamo una personalità più forte, questo sì, ma se fossi un elettore
americano ne desidererei ardentemente la vittoria. Una persona perbene alla Casa
Bianca, è già una conquista».
DAGONOTA il 6 giugno 2020. Giovedì il vice-presidente Usa Mike
Pence ha invitato alla Casa Bianca un gruppo di attivisti e tra questi c'era
anche Candace Owens. Donna, di colore, ultra-trumpiana, Owens è una star dei
social e le sue opinioni sono spesso controverse (i.e., ha dato della strega a
Meghan Markle). Mercoledì Owens ha pubblicato un video molto discutibile in cui
ha accusato George Floyd di essere un “essere umano orribile” che non dovrebbe
essere chiamato martire. A molti è sembrato curioso, e anche abbastanza
inopportuno, che il giorno successivo fosse alla Casa Bianca per incontrare il
Vice di Trump.
Cristina Gauri per ilprimatonazionale.it il 6 giugno 2020. E’
giusto dipingere l’afroamericano George Floyd come un martire? E’ giusto mettere
a ferro e a fuoco una nazione per protestare contro la sua morte? Se lo stanno
chiedendo – ovviamente sottovoce – in molti; per chi, invece, mostra il coraggio
di porsi pubblicamente la questione, è bell’e pronta la graticola del
politicamente corretto, messa in piedi dal fronte oceanico – o baraccone – dei
bianchi soggiogati dal white guilt e delle minoranze etniche in preda agli
afflati rivoluzionari. Se poi chi esprime dubbi sulla santità dell’afroamericano
rimasto vittima delle forze dell’ordine di Minneapolis è una donna nera, per di
più di tendenze conservatrici, apriti cielo: il minimo che le può capitare è
quello di sentirsi chiamare house nigger, negro da cortile, condito da i soliti
insulti a sfondo sessista e alle minacce di morte e di stupro – che in questo
caso non offendono nessuno, perché il target non è di estrazione
liberal-progressista. E’ successo all’attivista conservatrice e afroamericana
Candace Owens, che ad essere etichettata come house nigger ormai ci ha fatto il
callo da anni, e la cosa, evidentemente, non la turba e non la smuove
minimamente dalle proprie convinzioni. Proprio la Owens, fondatrice della
Blexit, movimento che si propone di «liberare gli elettori neri dalle grinfie
del Partito Democratico» è infatti intervenuta contro la martirizzazione di
Floyd operata da media e istituzioni progressiste in tutto il mondo, postando un
video di 18 minuti in cui espone i propri dubbi in merito. «Non mi devo scusare
per nulla. George Floyd non è il mio martire. Può essere il vostro, forse»,
attacca nel filmato, nel quale condanna apertamente gli agenti coinvolti
nell’omicidio augurandosi che vengano adeguatamente puniti per il crimine
commesso. «Tutti fingono che quest’uomo conducesse uno stile di vita “eroico”»,
prosegue. «Siamo fonte di imbarazzo per noi stessi. Nessuno vuole dire la verità
a riguardo». La verità che tutti i media conoscono e che tutti, ostinatamente,
si rifiutano di portare alla luce è che Floyd era stato condannato per ben 5
volte a una pena detentiva e che nel 2007 aveva fatto irruzione nella casa di
una donna incinta e l’aveva minacciata puntandole la pistola sulla pancia. Il
giorno della sua morte Floyd era strafatto di fentanyl e metanfetamine. Non
proprio l’attitudine da angelo vendicatore dei torti subiti dagli afroamericani
che tutti gli hanno voluto affibbiare dopo la morte. Per tutte queste
dichiarazioni la Owens ha ricevuto il solito trattamento riservato ai neri
«traditori», quelli cioè che non si fanno monopolizzare dalla vulgata
progressista: accuse di essere il cagnolino da grembo dell’uomo bianco, minacce
di morte e di stupro, provenienti dal fuoco incrociato di afroamericani
infuriati e dei liberal dalla bianchissima pelle; i quali, in modo più arrogante
e suprematista del più suprematista dei bianchi, sono letteralmente impazziti
alla vista di una donna afroamericana che non la pensa come dicono loro.
"Vale così
poco la vita di un afroamericano?" Caso Floyd, il fratello al Congresso: “George
è morto per 20 dollari”.
Redazione su
Il Riformista il 10 Giugno 2020. “George è morto per una discussione su 20
dollari. E’ questo che vale un afroamericano nel 2020?“. E’ il duro atto di
accusa di Philonise Floyd, fratello del 46enne morto a Minneapolis per mano
della polizia. Davanti ai membri del Congresso, parlando alla commissione
giustizia della Camera, l’uomo a stento è riuscito a trattenere le lacrime.
“Sono qui per chiedervi basta dolore, la forza mortale dovrebbe essere usata
solo in casi di grande pericolo, e mio fratello è morto per 20 dollari”. “Venti
dollari? Non meritava di morire per 20 dollari”, ha insistito Philonise Floyd:
“Questo è il 2020. Siamo stanchi. Quando è troppo è troppo. Siate il leader di
cui questo Paese, di cui il mondo ha bisogno. Fate la cosa giusta”. “Sono qui
per mio fratello George, sono qui per ottenere giustizia”, ha esordito Philonise
Floyd davanti alla commissione giustizia della Camera, aprendo la serie di
audizioni programmate nel momento in cui il Congresso avvia i lavori per una
riforma delle forze dell’ordine. “Dipende da voi far sì che la morte di George
non sia stata vana”, ha affermato rivolgendosi ai membri del Congresso. “Il nome
di George significherà qualcosa solo se la sua morte finirà per cambiare in
meglio il mondo. E io penso che sarà cosi”, ha continuato. Poi Philonise Floyd
si è rivolto direttamente al fratello: “Guarda cosa hai fatto, grande George,
stai cambiando il mondo. Spero hai trovato nostra madre e possiate insieme
riposare in pace”, ha aggiunto, riferendosi a quella mamma Larcenia, deceduta
nel 2018, che George ha invocato più volte prima di morire. “Non vi posso dire
il dolore che si prova nel vedere il proprio fratello maggiore morire chiamando
la mamma” ed implorando per la vita, ha detto ancora Philonise Floyd nella
sua testimonianza al Congresso. “Sono stanco, stando di questo dolore, sono qui
per dirvi di fermare questo dolore, non fateci più essere stanchi” ha
dichiarato chiedendo al Congresso di fare in modo che suo fratello “sia
qualcosa di più di un altro volto su una t-shirt, un altro nome in una lista
che non smette di allungarsi”. “George ha chiesto aiuto ed è stato ignorato, per
favore ascoltate la mia richiesta, della mia famiglia e che arriva delle strade
di tutto il mondo – ha aggiunto visibilmente emozionato il fratello di Floyd –
onorate la sua memoria, onorate George”. “Lui si è rivolto ai poliziotti
chiamandoli "signore" – ha detto ancora Philonise Floyd – ha avuto un
atteggiamento mite, non ha reagito. All’uomo che gli ha tolto la vita, che lo ha
soffocato per otto minuti e 46 secondi lui ha continuato a rivolgersi
chiamandolo ‘signore’ e a supplicarlo”.
Il caso che
ha causato scontri negli Stati Uniti. Perché è stato arrestato George Floyd,
l’afroamericano ucciso a Minneapolis.
Redazione su
Il Riformista il 2 Giugno 2020. “Alta tensione negli Usa”. “Polveriera America”.
“Stati Uniti a ferro e fiamme”. Sono solo alcuni dei titoli che in questi giorni
si stanno leggendo dopo che proteste e scontri anche violenti si sono verificati
in tutto il Paese. A causarli la morte di George Floyd, afroamericano di 46
anni, a Minneapolis, nello Stato del Minneasota, verificatasi il 25 maggio
mentre era in custodia delle forze di polizia. Derek Chauvin, che per quasi 9
minuti ha bloccato a terra la vittima, premendo le ginocchia sul collo e sulla
schiena dell’uomo è stato arrestato con l’accusa di omicidio di terzo grado.
Licenziati con lui anche altri tre colleghi intervenuti sul posto. L’autopsia
indipendente chiesta dalla famiglia di Floyd ha decretato che la morte è
avvenuta per asfissia per compressione del collo e della schiena. Floyd era
stato fermato sulla 38esima strada da due pattuglie di agenti. La polizia era
stata chiamata in quanto secondo due commessi del negozio Cup Food l’uomo aveva
comprato delle sigarette con una banconota falsa da 20 dollari. Per i due
commessi, che avevano chiesto la restituzione dell’acquisto, l’uomo era
visibilmente “ubriaco” e “fuori controllo”. Floyd è stato trovato nella sua
auto, trascinato fuori e ammanettato. I filmati che testimoniano l’accaduto non
mostrano resistenze da parte sua prima di cadere, di essere ancora strattonato e
immobilizzato a terra. In un video che ha raccolto immagini girati dalle
telecamere e dagli smartphone dei passanti, grafici e telefonate
d’emergenza, il New York Times ha ricostruito tutta la sequenza dall’arresto
alla morte del 46enne.
Chi era
George Floyd, l’afroamericano ucciso dalla polizia a 46 anni.
Redazione su
Il Riformista il 9 Giugno 2020. Migliaia di persone hanno visitato la camera
ardente a Houston per l’ultimo saluto a George Floyd. L’uomo, ucciso il 25
maggio a seguito di un intervento violento della polizia, sarà seppellito a
Houston, con una cerimonia in forma privata. Floyd sarà sepolto vicino alla
madre a Pearland, un sobborgo della cittadina texana. Il caso di Floyd ha
scatenato violente proteste in tutto il Paese che hanno causato morti e feriti e
portato il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump a minacciare l’uso
dell’esercito. George Perry Floyd Jr. era nato a Fayetteville, in North
Carolina, nell’ottobre nel 1973. Ma era cresciuto a Houston, dove si era
trasferito con la madre quando era ancora bambino. I due avevano vissuto nelle
Cuney homes, case popolari del Third Ward, un quartiere abitato in prevalenza da
afroamericani. In un compito della seconda elementare, secondo quanto postato su
Facebook da una sua maestra, aveva scritto di voler diventare un giudice della
Corte Suprema. Floyd si iscrisse al liceo Jack Yates di Houston, dove era
diventato un buon giocatore di basket e baseball. Ormai aveva raggiunto i due
metri di altezza. Successivamente aveva frequentato il South Florida community
college, sperando di poter diventare un giocatore di basket, ma un anno dopo
aveva lasciato l’istituto per il Texas A&M University di Kingsville. Tornato a
Houston aveva cominciato a fare hip hop con il nome di Big Floyd. Aveva
registrato un pezzo, Sittin’ on top of the world, nello studio Robert Earl Davis
Jr. Ma si era anche cacciato in alcuni guai: venne arrestato per furto e
possesso di droga. Dichiaratosi colpevole di furto aggravato a mano armata,
passò i successivi quattro anni alla Diboll Unit, una prigione privata in Texas.
Nel 2013 aveva ottenuto la libertà condizionale e aveva cominciato a lavorare
nella chiesa Resurrection Houston impegnandosi a favore degli abitanti di alcuni
quartieri popolari. Un anno dopo si era trasferito a Minneapolis, nel Minnesota,
dove lavorava come guardia di sicurezza al club-ristorante Conga Latin Bistro.
Aveva perso il lavoro a causa della crisi scatenata dal coronavirus. Floyd aveva
una compagna, Courtney Ross, e cinque figli, tra cui due, Quincy Mason e Gianna,
di 22 e 6 anni che vivono a Houston, e un altro figlio più grande a Bryan,
sempre in Texas. L’uomo al momento del fermo della polizia era positivo al
coronavirus. Il pomeriggio del 25 maggio è stato fermato da due pattuglie e
immobilizzato a terra per 8 minuti e 46 secondi. Era disarmato. A causare la sua
morte l’intervento violento dell’agente Derek Chauvin, licenziato e accusato di
omicidio.
DAGONOTA il 5 giugno 2020. Chi era George Floyd? Benvoluto,
sorridente, ex atleta, era di sicuro un membro attivo della comunità. E – a
quanto pare – si dilettava con il porno. Su alcuni siti legati alla destra
americana sono apparsi nelle ultime ore thread che linkano alcuni video di una
tale Kimberly che si sollazza con un uomo che somiglia molto, moltissimo al
povero George. I filmati in questione sono almeno un paio, come fanno notare
alcuni utenti sul ‘board’ 4chan “Politically Incorrect”. Avete dubbi che il
George Floyd ucciso da Derek Chauvin e quello sorridente del video siano la
stessa persona? Guardate i tatuaggi!
Ida Artiaco per fanpage.it il 5 giugno 2020. Ha lavorato per la
polizia di Minneapolis per più di 18 anni ma il suo comportamento non è sempre
stato esemplare. Continuano ad emergere dettagli oscuri sul passato di
Derek Chauvin, l'ex agente 44enne accusato dell'omicidio di George Floyd, il
46enne afroamericano morto durante un fermo di polizia lo scorso 25
maggio. Chauvin, ripreso mentre con il suo ginocchio comprime per quasi nove
minuti il collo dell'uomo a terra, mentre quest'ultimo continua a ripetere: "Non
riesco a respirare", rischia ora fino a 40 anni di reclusione, dal momento che
l'ipotesi di reato a suo carico è di omicidio volontario non premeditato.
Attualmente si trova nel carcere di massima sicurezza di Oak Park Heights, con
una cauzione di quasi mezzo milione di dollari. Ma a quanto pare non è questa la
prima volta che il poliziotto ha usato la forza mentre è in servizio. Nel suo
passato ha infatti collezionato ben 17 denunce a vario titolo con lamentale per
la sua condotta, anche se il dipartimento non ha specificato quali fossero le
accuse a suo carico. In due casi ha ricevuto persino una lettera di richiamo
formale. Secondo Communities Against Police Brutality, un'organizzazione no
profit del Minnesota che ha realizzato un database di reclami contro i
funzionari dello stato, Chauvin ha ricevuto rimproveri orali per l'utilizzo di
un "tono umiliante" e di un "linguaggio dispregiativo". L'ex agente, licenziato
dopo il caso Floyd, è stato coinvolto a vario titolo anche in numerose
sparatorie a Minneapolis. Nel 2006 ha aperto il fuoco e ucciso un uomo che
presumibilmente aveva una pistola. Nel 2008 ha fatto lo stesso contro un
sospetto di violenza maschile. E nel 2011, ancora, ha sparato su un uomo in fuga
da un conflitto a fuoco. Nonostante ciò, il 44enne è stato elogiato e lodato dai
suoi superiori per quasi 20 anni, ricevendo nel 2008 persino la medaglia al
valore del dipartimento di polizia. L'impiego presso il Dipartimento di Polizia
di Minneapolis non era per altro l'unico che aveva Chauvin. Lavorava infatti
anche come uomo della sicurezza di alcuni night club tra cui El Nuevo Rodeo,
dove anche George Floyd lavorava come buttafuori, come ha confermato alla
Cnn l'ex proprietaria del locale Maya Santamaria. "Non credo che però si
conoscessero – ha aggiunto la donna -, ma di certo le loro strade si sono
incrociate, visto che spesso lavoravano durante gli stessi turni". Nel
frattempo, era sposato con Kelly: nata in Laos, 45 anni, è un'ex reginetta di
bellezza che prima di trasferirsi negli Stati Uniti ha vissuto in un campo
profughi in Thailandia per fuggire dalla guerra. Ha conosciuto Chauvin in
ospedale, dove lei lavorava e dopo che lui aveva accompagnato un criminale che
aveva fermato. Tuttavia, ha chiesto il divorzio dopo i fatti del Memorial Day,
dicendosi "devastata" per quanto era successo.
Da "adnkronos.com" il 5 giugno 2020. “«Probabilmente c'è sempre
un 10-15% che non è composto da brave persone, ma questo non è quello che siamo,
la grande maggioranza sono persone perbene ed è a loro che mi rivolgo». È quanto
ha detto Joe Biden in una town hall virtuale con i giovani americani, durante la
quale, rispondendo alle domande di diversi giovani afroamericani, si è
concentrato sulle questioni razziali e la violenza della polizia. Parlando
dell'omicidio di George Floyd, l'ex vice presidente ha detto che come uomo
bianco non può comprendere a fondo la sensazione di pericolo che un
afroamericano prova quando si trova a che fare con le forze dell'ordine. Ma ha
sottolineato come questa trageda debba essere come «un campanello d'allarme» per
affrontare finalmente «il razzismo sistematico». Il candidato democratico ha poi
fatto riferimento a Donald Trump, sottolineando che «l'odio non è nato con
Donald Trump e non finirà con lui». Ma, ha aggiunto, «le parole del presidente
contano, non importa quale presidente sia».
LA RIVOLTA DEI GENERALI CONTRO TRUMP.
Da agi.it il 5 giugno 2020. L'ex capo del Pentagono James Mattis 'guida' la
rivolta dei generali contro il presidente Donald Trump. Per i leader militari,
tradizionalmente non schierati e tendenzialmente repubblicani, il tycoon ha
superato la linea rossa minacciando di usare le forze armate contro i
manifestanti che protestano per la morte dell'afroamericano George Floyd, ucciso
dalla polizia a Minneapolis. Trump non si è limitato ad invocare l'Insurrection
Act, una legge firmata nel 1807 da Thomas Jefferson che attribuisce al
presidente degli Stati Uniti - in casi eccezionali - il potere di utilizzare
l'esercito per compiti di polizia. Mentre il comandante in capo nel giardino
delle Rose proclamava l'editto, la polizia sparava lacrimogeni e proiettili di
gomma contro chi protestava davanti alla Casa Bianca, per disperdere la folla e
consentire al presidente di sfilare indisturbato a piedi verso la vicina chiesa
episcopale di St. John e mettersi in posa con la Bibbia in mano.
La scomunica di Mattis: Trump vuole dividere l'America. Se il
ministro della Difesa Usa Mark Esper, ex ufficiale dell'esercito, ha
immediatamente preso le distanze, quella di Mattis è stata una scomunica. Trump
"vuole dividere gli Usa", ha tuonato in un editoriale sull'Atlantic, "siamo
testimoni delle conseguenze di questo sforzo deliberato, di tre anni senza una
leadership matura. Possiamo essere uniti senza di lui, attingendo alla forza
interna della nostra società civile". "Militarizzare la nostra risposta come
abbiamo visto a Dc - ha attaccato Mattis - crea un conflitto, un falso
conflitto, tra le forze armate e la società civile". Contro Trump anche l'ex
generale John Kelly, suo ex capo di gabinetto ed ex ministro per la Sicurezza
nazionale, e John Allen, ex comandante delle forze Usa in Afghanistan.
La polemica sulla Bibbia. "Non gli è bastato privare i
manifestanti pacifici dei loro diritti sanciti dal primo emendamento - ha
osservato Allen - con quella foto ha tentato di legittimare quel gesto con un
alone religioso". Tra gli altri, pure Mike Mullen, ex capo dello stato maggiore
congiunto, si è scagliato contro Trump, avvertendo che mina i valori
dell'America.
Come funziona l'Insurrection Act. Il provvedimento
invocato da Trump per portare l'esercito nelle strade contro i disordini fu
applicato l'ultima volta nel 1992 durante la rivolta di Los Angeles. Mattis,
Kelly e il generale Herbert Raymond McMaster, nominato consigliere alla
sicurezza nazionale dopo le dimissioni lampo di un altro generale, Michael Flynn
(travolto dal Russiagate) erano considerati "gli uomini forti" del presidente.
"Alleniamo i nostri uomini per diventare macchine da guerra", dichiarava Trump
via Twitter nell'ottobre del 2019. Sarebbe stata questa immagine del militare
versione 'Rambo', sostiene Peter Bergen nel suo libro "Trump e i suoi generali:
il prezzo del caos", a spingere il capo della Casa Bianca a circondarsi di
generali al suo insediamento. Non aveva messo in conto le loro resistenze sul
ricorso facile alla forza (tantomeno contro i manifestanti) o sul ritiro delle
truppe Usa dalle zone ancora calde, per non parlare del sostegno alla Nato. Alla
fine del 2018, McMaster, Kelly e Mattis erano già tutti casa. Quella che
traballa ora è la poltrona di Esper.
Massimo Gaggi per "corriere.it" il 5 giugno 2020. Ancora immagini
che infiammano l’America, ancora poliziotti sotto accusa per la loro brutalità,
ancora un episodio che divide l’America ormai polarizzata anche sull’uso della
forza da parte degli agenti. Stavolta il teatro della violenza è Buffalo,
nell’estremo nord dello Stato di New York, al confine col Canada. Gli agenti in
assetto antisommossa avanzano per sgombrare la piazza centrale in ore di
coprifuoco. Vanno verso un gruppo di giovani manifestanti (che poi verranno
arrestati) ma davanti a loro si pone un uomo anziano, bianco, che parla loro in
modo animato, gesticolando. Gli agenti si fermano per un attimo, poi riprendono
ad avanzare, uno lo spinge via. La spinta non è violenta, ma l’uomo, che ha 75
anni (la sua identità non è stata resa nota) perde l’equilibrio, cade e batte la
testa sul marciapiede. La sequenza immortalata da un video girato da una tv
locale nel corso di una manifestazione (per la morte di George Floyd). Se non
fosse per il rumore secco e il sangue che comincia a uscire da un orecchio,
sembrerebbe una scena calcistica: mentre il poliziotto che lo ha spinto avanza
incurante, quello al suo fianco si china sull’uomo con atteggiamento aggressivo,
non per aiutarlo. Un altro agente capisce e allontana il suo collega facendo
arrivare i soccorsi mentre gli altri agenti continuano ad avanzare e cominciano
a bloccare i giovani che stanno manifestando pacificamente, incuranti del
coprifuoco. L’anziano, ricoverato in ospedale, viene definito in condizioni
serie ma stabili. L’immagine di questo uomo esile solo davanti a un plotone di
poliziotti in assetto di guerra fa subito il giro del mondo. Ottima per la
propaganda dei Paesi abituati a ricorrere massicciamente alla repressione che,
come sta facendo la Cina in questi giorni, sostengono che la libera America non
ha nulla da insegnare a nessuno. La polizia è di nuovo nei guai non solo per il
fatto in sé e per la forza di quelle immagini, ma anche perché, prima della
pubblicazione del video, afferma che l’uomo è caduto da solo. La decisione di
sospendere due poliziotti arriva soltanto quando vengono pubblicate le immagini
dell’incidente: il sindaco di Buffalo definisce «scoraggiante» il comportamento
della sua polizia. Il governatore dello stato di New York Andrew Cuomo aggiunge
che la violenza degli agenti è «totalmente ingiustificata». Un fatto destinato a
dividere ulteriormente l’America. Per i più è un’altra dimostrazione della
brutalità o, almeno, della scarsa preparazione della polizia. Sulla Fox, la rete
conservatrice, la più seguita negli Stati Uniti, l’episodio viene mostrato al
pubblico e criticato, ma è solo un inciso in una carrellata di immagini e
racconti di poliziotti accoltellati, volutamente investiti in mezzo alla strada,
malmenati dai saccheggiatori in questi giorni di disordini e sommosse. Due
Americhe sempre più lontane.
Francesco Bechis per formiche.net il 5 giugno 2020. Sulla stampa
l’hanno ribattezzata “la rivolta dei generali”. Ma le rivolte sono spesso
organizzate, studiate, preparate in anticipo. Non lo è stata la denuncia unanime
di alcuni dei più celebri generali a quattro stelle degli Stati Uniti contro
l’amministrazione di Donald Trump e la sua gestione delle manifestazioni seguite
all’omicidio di George Floyd a Minneapolis. Ha fatto rumore la condanna senza
appello di James Mattis, già segretario alla Difesa di questa amministrazione.
Non ne ha fatto meno quella del generale John Allen. Presidente di Brookings,
già comandante della missione Nato Isaf in Afghanistan, poi inviato speciale
degli Stati Uniti alla guida della Coalizione globale contro l’Isis, Allen ha
firmato un editoriale su Foreign Policy destinato a rimanere impresso nei
prossimi mesi. Con Formiche.net, ripercorre quelli che chiama i “giorni
rivelatori” della democrazia americana. Quelli in cui centinaia di manifestanti
sono stati “respinti con la forza” dalla polizia, di fronte a una Casa Bianca in
cui, oggi, “non c’è nessuno”.
Generale Allen, la sua è una denuncia molto severa. Davvero
questa situazione è senza precedenti?
«Abbiamo vissuto altre sfide. Ci
sono stati periodi della storia americana in cui abbiamo visto attacchi su larga
scala contro manifestanti pacifici. Ricordo bene gli anni ’60, l’assassinio di
Martin Luther King e i disordini che sono seguiti nel Paese. I problemi di
allora, l’ingiustizia sociale, la discriminazione contro i neri e altre
minoranze, non sono stati risolti. George Floyd è il simbolo non di anni, non di
decenni ma di secoli di ingiustizia sociale contro i neri».
Qual è allora la vera novità?
«Oggi questa ingiustizia si
interseca con la frustrazione degli americani per una crisi senza precedenti.
Abbiamo 107.000 morti, 2 milioni di infetti, 40 milioni di persone senza lavoro,
l’intera popolazione in quarantena».
Fra alcuni dei manifestanti ci sono stati dei violenti.
«Smentiamo un luogo comune. La
grande maggioranza di chi è sceso in strada è composta di manifestanti pacifici.
Sono guardiani della Costituzione. Il primo emendamento dà agli americani il
diritto di dissentire e la libertà di parola. Non dà loro il diritto di
organizzare sommosse o bruciare edifici. Queste sono attività criminali che
richiedono l’intervento delle Forze dell’ordine».
L’intervento è avvenuto, questo lunedì.
«Il presidente, poco dopo aver
deriso i governatori per essere troppo deboli con i manifestanti, in piedi nel
suo giardino, ha promesso di “aggiustare le cose” inviando in strada migliaia di
truppe. L’America dovrebbe essere governata dallo Stato di diritto, da un senso
profondo dei diritti dei cittadini. Invece abbiamo un linguaggio infiammatorio e
provocatorio, e un presidente che si auto-proclama “alleato” dei manifestanti
pacifici. Mentre lo dice, si sentono sullo sfondo il rumore delle granate
stordenti per spaventare chi era in strada. Poi, un gesto di pura pubblicità».
La passeggiata dalla Casa Bianca alla chiesa di St. John.
«Da un momento all’altro, i
manifestanti si sono visti spinti fuori dalla strada da polizia in tenuta
antisommossa, che li ha respinti con scudi, manganelli, gas lacrimogeno, spray
al peperoncino. Tutto questo perché il loro presidente “alleato” voleva farsi
una passeggiata fino alla chiesa e urlare “Make america great again”. Questo non
è il popolo americano. Questa non è America».
Allen, con lei altri generali si sono espressi con giudizi
severi su questa amministrazione. Perfino James Mattis, che ne è stato un
pilastro. Vi siete coordinati?
«No, assolutamente. Nelle scorse ore
quattro generali a quattro stelle hanno condannato le azioni del presidente.
Nessuno di noi si è parlato prima. Non ho sentito Mattis. Potrei farlo, ma
sarebbe ancora più importante non farlo. Il nostro è un messaggio spontaneo,
uscito in contemporanea, e questo la dice lunga».
Cosa può fare il prossimo presidente per far fronte a un
problema che, come ha detto lei, esiste da secoli?
«Non voglio sbilanciarmi in
pronostici. Posso solo dire che i due candidati attuali non potrebbero avere
visioni più diverse. Se un presidente è davvero impegnato nel cambiamento
sociale, allora deve mettersi alla testa del processo legislativo».
Cioè?
«Deve seguire e spronare i lavori
del Congresso, chiedere di cambiare o di introdurre leggi che rendono l’America
uguale per tutti i cittadini. Questo è l’impegno che sentiamo da parte di un
solo candidato. Il sistema di diritto dovrebbe essere goduto da tutti i
cittadini. Oggi lo è solo da alcuni. Il presidente dovrebbe preoccuparsi di
questo, piuttosto che promettere di scatenare l’esercito contro i suoi cittadini».
Lei ha scritto che, oggi, alla Casa Bianca “non c’è nessuno”.
Vale anche per la politica estera?
«Il bilancio di questa presidenza è
evidente. Ci siamo ritrovati ai ferri corti con i nostri alleati più preziosi.
Abbiamo stretto amicizia con gli uomini forti e totalitari che vantano una
“relazione speciale” con il presidente degli Stati Uniti. Abbandonato il
multilateralismo e la leadership americana nel mondo. Quando lavoravamo fianco a
fianco ai nostri partner eravamo più forti. Dalla fine della Seconda Guerra
Mondiale il sistema di stato di diritto internazionale ha garantito un’alleanza
fra democrazie, non solo occidentali. Non c’era nulla che, insieme, non
potessimo affrontare. Oggi il detto “Maga” si traduce in “Rendi l’America più
sola”».
Un solo tema di politica estera è entrato nella campagna per
le presidenziali: i rapporti con la Cina. Ormai da entrambe le parti si sente
parlare di Guerra Fredda. Ci sono ancora spazi per collaborare?
«Ci dovrebbero essere. Difficile
riconoscerli se nella Cina vedi solo un avversario. La minaccia cinese serve a
questa amministrazione come perno attorno al quale consolidare il suo supporto
politico. Stiamo perdendo molte opportunità».
Ma ci sono anche molte divergenze. Il caso di Hong Kong è una
di queste.
«Chiarisco: ci sono dei fronti in
cui non dovremmo mai allinearci con la Cina. I diritti umani, anzitutto. Così
come dovremmo mettere la Cina di fronte alle sue responsabilità, come il furto
di proprietà intellettuale nell’alta tecnologia. Ma ci sono aree non secondarie
in cui possiamo trovare non valori ma interessi comuni. Il Covid-19, la tutela
dell’ambiente, la tecnologia e lo spazio digitale. Ci sono occasioni che gli
Stati Uniti stanno perdendo. L’Intelligenza artificiale, il deep learning, il
super-comuting sono tutti settori dove dobbiamo lavorare insieme ai cinesi. Non
dovremmo scontrarci con loro, ma competere, e superarli».
Il GOP nella bufera. L’omicidio di
George Floyd “una messinscena contro Trump”, la teoria complottista della
Repubblica Cynthia Brehm. Redazione de il Riformista il 5 Giugno 2020. Quando a
sposare le peggiori teorie del complotto non sono i classici "napalm51", la
caricatura di Maurizio Crozza degli hater del web, ma uno dei massimi
rappresentati dello Stato. È quanto accaduto negli Stati Uniti nella vicenda che
vede protagonista Cynthia Brehm, presidente dei repubblicani della contea di
Bexar, Stato del Texas. Per la Brehm infatti la morte di George Floyd, il 46enne
afroamericano ucciso dalla polizia a Minneapolis durante un fermo, non sarebbe
altro che una “messinscena”, un evento organizzato a tavolino per screditare
l’amministrazione repubblicana della Casa Bianca targata Donald Trump. In un
lungo post su Facebook, poi cancellato, la Brehm spiega la sua teoria: “Penso
che ci sia almeno la ‘possibilità’ che si sia trattato di un’esecuzione pubblica
filmata di un uomo nero da parte di un poliziotto bianco con lo scopo di creare
tensioni razziali e aumentare ulteriormente i sentimenti contro lo Stato da
parte della gente comune, già psicologicamente traumatizzata dalla paura del
Covid-19”, scrive nel post. Dichiarazioni talmente forti da costringere gli
stessi compagni Repubblicani a dissociarsi, mentre il governatore del Texas Greg
Abbot ha chiesto le sue dimissioni: “Le sue parole sono disgustose, non c’è
posto per lei nel partito repubblicano o sulla scena pubblica”. Per ora la Brehm
sembra però voler restare al suo posto.
"Il razzismo si batte con l'economia".
Uccisione Floyd, lo sciacallaggio di Trump: “George ci guarda e
pensa che oggi è un gran giorno”. Redazione de il Riformista il 5 Giugno 2020.
“Spero che George ci stia guardando e dica che questa è una grande cosa che sta
accadendo al nostro Paese. È un grande giorno per lui. È un grande giorno per
tutti. È un grandissimo giorno in termini di uguaglianza“. A dirlo è il
presidente Donald Trump che, durante la conferenza stampa nella quale ha
commentato i dati positivi della ripresa dell’occupazione negli Stati Uniti, ha
citato l’uomo ucciso la scorsa settimana da un agente durante un fermo. Durante
il suo discorso il presidente ha parlato anche delle proteste di questi giorni
che, secondo il presidente americano, sembrano assumere un carattere meno
violento. Il presidente ha messo insieme nel suo discorso ripresa economia
e lotta al razzismo. “Il mio piano per affrontare il razzismo – ha detto Trump
– è avere la più forte economia del mondo“.
Il quotidiano ritratta. I giornalisti del New York Times in
rivolta: “I nostri colleghi neri sono in pericolo”.
Emilia Missione de il Riformista il 5 Giugno 2020. “Probabilmente mi metterò nei
guai, ma non dire niente sarebbe immorale. Come donna nera, come giornalista,
come americana, mi vergogno profondamente di quello che abbiamo fatto”. Di tweet
così, scritti dai giornalisti del New York Times, ce ne sono decine e decine da
ieri in rete. La redazione del quotidiano statunitense, infatti, ha protestato
contro la decisione di pubblicare nella sezione “Opinioni” l’intervento
del senatore repubblicano dell’Arkansas Tom Cotton, che sostiene l’idea del
presidente Trump di impiegare l’esercito contro i manifestanti che in questi
giorni sono scesi in strada per protestare contro l’uccisione di George Floyd da
parte di un poliziotto. Una vicenda che ha riacceso la discussione sulle
discriminazioni razziali nel Paese. Per i giornalisti del Nyt, infatti, la
scelta di dare spazio alla proposta di impiegare l’esercito contro i
manifestanti, mettere a rischio gli stessi colleghi neri che lavorano in
redazione. A difendere la scelta del quotidiano era stato inizialmente James
Bennet, responsabile della sezione Op-ed, le opinioni esterne. In un articolo
aveva spiegato come fosse dovere del quotidiano dar conto di tutte le opinioni,
nonostante lui, per primo, fosse profondamente contrario all’idea di utilizzare
l’esercito. “Metteremmo a repentaglio l’integrità e l’indipendenza del New York
Times se pubblicassimo solo opinioni con le quali giornalisti come me sono
d’accordo, e tradiremmo quello che penso sia il nostro scopo fondamentale: non
dirti cosa pensare, ma aiutarti a pensare per te”. Qualche ora dopo,
però, Bennet ha ammesso di non aver letto l’articolo prima che fosse pubblicato.
In un articolo successivo pubblicato online, dal titolo “Il New York Times
afferma che l’editoriale di Cotton non rispetta gli standard“, viene riportato
che “James Bennet, l’editore incaricato della sezione opinioni, in una riunione
con i membri del personale ha dichiarato che non aveva letto l’articolo prima
che fosse pubblicato”. Poco dopo, si legge, il Times ha rilasciato
una dichiarazione in cui affermava che l’articolo non era all’altezza degli
standard del giornale.“Abbiamo esaminato il pezzo e il processo che ha portato
alla sua pubblicazione”, ha dichiarato Eileen Murphy, portavoce del Times in una
nota. “Questa revisione ha chiarito che un processo editoriale frettoloso ha
portato alla pubblicazione di un Op-Ed che non ha soddisfatto i nostri standard.
Di conseguenza, stiamo pianificando di esaminare le modifiche sia a breve che a
lungo termine, per allargare la nostra operazione di verifica dei fatti e
ridurre il numero di Op-Ed che pubblichiamo. ”
Dal Messico alla Casa Bianca, il muro di Trump si sposta a
Washington per difendersi dalle proteste. Redazione de
il Riformista il 5 Giugno 2020. Una delle grandi promesse della scorsa campagna
elettorale, che lo hanno portato a conquistare la presidenza degli Stati Uniti,
era quella di costruire un muro al confine col Messi a difesa dei suoi
concittadini. Alla fine però Donald Trump è dovuto scendere ad un compromesso
diverso e, per salvarsi dalle proteste di massa scoppiata dopo la morte per mano
della polizia dell’afroamericano George Floyd, il muro lo ha costruito a difesa
della Casa Bianca. Le foto della recinzione costruita in fretta e furia davanti
la residenza dei presidenti per contrastare i manifestanti ha fatto il giro del
web, con grande ironia per la retromarcia del tycoon. Intanto in un Paese
segnato da violenti scontri il presidente Donald Trump soffia sul fuoco delle
contestazioni attirandosi le critiche sia dei predecessori, Jimmy Carter e Barak
Obama che, da ultimo, dell’ex capo del Pentagono James Mattis che ha accusato il
tycoon di essere “divisivo” e di “deridere la Costituzione”. Subito è arrivata
la replica del presidente che nei giorni scorsi si è scontrato anche con
l’attuale segretario alla giustizia Mark Esper sullo schieramento dei militari
per sedare le proteste. “Probabilmente l’unica cosa che Barack Obama e io
abbiamo in comune è che entrambi abbiamo avuto l’onore di licenziare Jim Mattis,
il generale più sopravvalutato del mondo”, ha scritto Trump rigorosamente su
Twitter, “Ho chiesto la sua lettera di dimissioni e mi sono sentito benissimo”.
Sul tema il fronte dei repubblicani si è spaccato. Molti senatori hanno difeso
l’operato del tycoon dalle critiche di Mattis, mentre la senatrice Lisa
Murkovski si è schierata con l’ex capo del Pentagolo, giudicando le sue parole
“vere e oneste”.
George Floyd, in migliaia a Minneapolis per la commemorazione:
“Aveva famiglia, sogni, speranze”. Redazione de il
Riformista il 4 Giugno 2020. A Minneapolis migliaia di persone si sono radunate
per dare l’ultimo saluto a George Floyd. Familiari, amici, manifestanti e
autorità stanno rendendo omaggio all’afroamericano 46enne ucciso dalla polizia,
nel santuario della North Central University, mentre a tenere l’elogio funebre
il reverendo Al Sharpton. All’interno sono ammesse solo 500 persone per le
restrizioni dovute alla pandemia di Covid-19, mentre sulla fondo del santuario
c’è un enorme ritratto della vittima. “Ho visto molti americani di razze ed età
differenti marciare insieme e alzare la loro voce insieme, siamo ad un punto di
svolta“, ha detto il reverendo newyorchese, tra i più importanti leader nella
lotta per i diritti civili. “Era un essere umano. Aveva famiglia, sogni,
speranze. Il vero compito di ognuno è preservare il valore della vita umana
spazzata via”, ha aggiunto quindi il reverendo. Ad omaggiare la memoria di Floyd
anche il reverendo Jesse Jackson, mentre il sindaco di Minneapolis Jacob Freby è
scoppiato in lacrime mentre si è inginocchiato davanti al feretro del 46enne
ucciso dalla polizia. E’ la prima delle tre cerimonie funebri che si terranno
nel corso della settimana. Dopo la cerimonia in Minnesota, il corpo di Floyd
verrà portato a Raeford, nella Carolina del Nord, dove è nato, e successivamente
a Houston in Texas, dove è cresciuto e ha vissuto gran parte della sua vita.
L’uccisione di Floyd ha scatenato un’ondata di rabbia e di proteste che ha
infiammato gli Stati Uniti. Per giorni i manifestanti hanno sfilato nelle vie
delle principali città per chiedere giustizia per Floyd e per tutti gli
afroamericani uccisi dalla polizia. Più di 10mila persone sono state arrestate
dall’inizio delle manifestazioni, di cui oltre un quarto a Los Angeles. In molte
occasioni le manette sono scattate per reati di basso livello come violazione
del coprifuoco e mancata dispersione. Centinaia di persone sono state invece
arrestate per furto con scasso e saccheggio. A San Francisco un ragazzo di 22
anni è stato ucciso dagli agenti perchè sospettato di essere armato. Ma quella
che alla polizia sarebbe sembrata una pistola, era in realtà un martello. Nelle
ultime ore il procuratore generale del Minnesota ha aggravato l’accusa per
l’agente Derek Chauvin, riconoscendo l’omicidio come volontario anziché colposo,
e ha incriminato e arrestato anche gli altri tre agenti coinvolti nel pestaggio
dell’afroamericano. Un primo passo verso quella giustizia che la comunità
afroamericana chiede a gran voce e che troppo spesso gli è stata negata. Come a
Los Angeles nel 1992 quando vennero assolti i quattro poliziotti che
massacrarono il tassista Rodney King. I democratici sono ora al lavoro su un
pacchetto di riforme per la polizia, con misure per supervisionare il lavoro
delle forze dell’ordine e vietare la presa di soffocamento, la stessa usata da
Chauvin per immobilizzare Floyd. In un Paese segnato da violenti scontri il
presidente Donald Trump soffia sul fuoco delle contestazioni attirandosi le
critiche sia dei predecessori, Jimmy Carter e Barak Obama che, da ultimo,
dell’ex capo del Pentagono James Mattis che ha accusato il tycoon di essere
“divisivo” e di “deridere la Costituzione”. Subito è arrivata la replica del
presidente che nei giorni scorsi si è scontrato anche con l’attuale segretario
alla giustizia Mark Esper sullo schieramento dei militari per sedare le
proteste. “Probabilmente l’unica cosa che Barack Obama e io abbiamo in comune è
che entrambi abbiamo avuto l’onore di licenziare Jim Mattis, il generale più
sopravvalutato del mondo”, ha scritto Trump rigorosamente su Twitter, “Ho
chiesto la sua lettera di dimissioni e mi sono sentito benissimo”. Sul tema il
fronte dei repubblicani si è spaccato. Molti senatori hanno difeso l’operato del
tycoon dalle critiche di Mattis, mentre la senatrice Lisa Murkovski si è
schierata con l’ex capo del Pentagono, giudicando le sue parole “vere e oneste”.
33enne afroamericano ucciso dalla polizia: “Smettete di
colpirlo”. Antonino Paviglianiti il 06/06/2020 su
Notizie.it. Manuel Ellis aveva 33 anni ed è morto dopo l'arresto: il video che
inchioderebbe la polizia. Un altro afroamericano ucciso dalla polizia: dopo le
polemiche sulla morte di George Floyd, che hanno portato a proteste di piazza in
tutti gli Stati Uniti, il New York Times ha reso nota la storia di Manuel
Ellis. Un afroamericano, di 33 anni, che ha perso la vita dopo l’arresto subito
a Tacoma, nello stato di Washington, lo scorso 3 marzo. Anche in questo
caso, come per la morte di Floyd, a rendere nota la violenza degli agenti
federali sono i video di cittadini che si sono trovati casualmente sul luogo
dell’evento. Per la morte di Ellis nessun dubbio: “È morto a causa del
soffocamento” ha evidenziato l’autopsia sul corpo del 33enne. L’uomo, infatti, è
stato scaraventato con violenza a terra da parte degli agenti federali per poi
continuare a inferire su di lui. Il filmato è stato girato da una donna di
passaggio che si è messa a urlare: “Smettetela di colpirlo, o mio Dio
smettetela!”. Come nel caso di Floyd, anche Manuel Ellis ha chiesto di smetterla
di infierire poiché impossibilitato a respirare; nei giorni scorsi, dopo mesi di
silenzio, l’ufficio del medico legale della contea di Pierce ha dichiarato che
il 33enne è deceduto per arresto respiratorio e ipossia, classificando la morte
come omicidio. Dall’autopsia sul corpo di Manuel Ellis è emerso che aveva fatto
uso di metanfetamina e soffriva di malattie cardiache, che secondo il medico
possono aver contribuito al suo decesso. Inizialmente, i federali si erano
giustificati evidenziando come fosse stato il 33enne ad avere atteggiamenti
violenti. Ma la ricostruzione dei fatti, grazie alla testimonianza video,
inchioderebbe la polizia. L’indagine interna da parte del distretto di Tacoma ha
individuato quattro agenti di polizia coinvolti nell’arresto di Manuel Ellis. E
per la sindaca di Tacoma nessun dubbio: “Gli agenti che hanno commesso questo
crimine dovrebbero essere licenziati e condannati con la pena massima prevista
dalla legge”.
Usa, un altro afroamericano soffocato dagli agenti: Manuel
Ellis, 33 anni. Un nuovo video sconvolge l'America.
Pubblicato sabato, 06 giugno 2020 da Katia Riccardi su La Repubblica.it La notte
del 3 marzo una donna, Sara McDowell, alla guida della sua auto dietro la
volante della polizia riprende l'arresto violento di un giovane uomo. Cerca di
intervenire ma non riesce a fermarli. Scopre solo mesi dopo che è morto quella
stessa notte, il 3 marzo. Secondo il medico legale per "ipossia dovuta a
immobilizzazione fisica": omicidio. È la potenza delle immagini che diventano
virali in poche ore ad indebolire le forze dell'ordine statunitensi. Telefoni
puntati come taser, ed è un nuovo video a piombare sulla polizia degli Stati
Uniti scossi dalle proteste in nome di George Floyd. Le immagini sono state
girate da Sara McDowell, una testimone che ha assistito all'arresto di Manuel
Ellis, 33 anni, afroamericano, fermato e ucciso a Tacoma, nello Stato di
Washington, il 3 marzo. Era alla guida della sua auto verso casa, dietro la
macchina dei poliziotti. Ha assistito alla scena, l'ha ripresa, sconvolta, si è
anche fatta avanti. Ha urlato "smettete di picchiarlo!". Stati Uniti, un altro
afroamericano ucciso dalla polizia: spunta il video del brutale arresto in
riproduzione....McDowell ha riferito al New York Times di aver visto Ellis
avvicinarsi all'auto della polizia a tarda notte, verso le 23:30. Pensava si
trattasse di una conversazione. Poi, all'improvviso, un agente ha aperto la
portiera dell'auto e ha buttato a terra Ellis. Un secondo lo ha trattenuto,
immobilizzandolo. Ellis si lamentava di non riuscire a respirare. La polizia si
difende dietro un racconto diverso. È stato Ellis ad iniziare la lite, lui a
sollevare un agente buttandolo a terra. Ma le immagini di Sara McDowell mostrano
altro. Interrompeva la registrazione poi la riprendeva, armata solo di un tasto
rosso. Nei brevi video riprende quanto basta: si vedono gli agenti prendere a
pugni Ellis mentre è a terra. Si sente la sua voce: "Fermi. Oh mio Dio,
smettetela di colpirlo. Arrestatelo e basta". "Ero terrorizzata per la sua
vita", ha detto Sara McDowell al Times. "Il modo in cui l'hanno attaccato non
aveva senso per me. Sono tornata a casa e mi sono sentita male". Poi non ha
saputo più nulla del ragazzo. Non ha saputo che Ellis è morto poco dopo,
incappucciato perché non potesse mordere o sputare, soffocato anche lui come
Floyd, con le sue stesse ultime parole: "Non riesco a respirare". Quando sono
arrivati i medici, era già troppo tardi. Lo ha scoperto in questa settimana di
proteste. Non ha ancora parlato con il detective Ed Troyer del dipartimento
dello sceriffo della contea di Pierce che conduce le indagini e il caso sarà
presentato ai pubblici ministeri la prossima settimana. Secondo il medico legale
della contea, Thomas Clark, che ha scritto il rapporto consegnato alla famiglia
mercoledì, Ellis è morto "ipossia dovuta a immobilizzazione fisica", omicidio
quindi, per soffocamento. Con le attenuanti che non attenuano il dolore della
scomparsa di nessuno: la vittima, dice il rapporto, aveva un'intossicazione da
metanfetamine. Secondo il medico legale il fattore più importante della sua
morte è stata la privazione di ossigeno "come risultato della costrizione fisica
e del posizionamento di una maschera sopra la bocca". Adesso che la relazione
del medico legale è pubblicata, e il video virale urla forte, la famiglia di
Ellis chiede che i quattro ufficiali coinvolti vengano licenziati e arrestati.
Mercoledì centinaia di persone si sono unite alla veglia organizzata dalla
famiglia a Tacoma. La polizia ha identificato gli agenti coinvolti: Christopher
Burbank, 34 anni; Matthew Collins, 37 anni; Masyih Ford, 28 anni; e Timothy
Rankine, 31. Due ufficiali sono bianchi, uno è nero e uno è asiatico. Sono
attualmente sospesi. "Parlo in nome di mio fratello nella tomba", ha detto Monet
Carter-Mixon alla veglia. "Sta ancora urlando, vai a prenderli, sorella. Non
mollare sorella". Il capo della polizia di Tacoma, Don Ramsdell, ha offerto le
sue "più sincere condoglianze" alla famiglia e agli amici di Ellis in una
dichiarazione giovedì. "Siamo impegnati nel processo investigativo e
nell'integrità dei risultati, ha affermato, "abbiamo collaborato pienamente e
siamo stati trasparenti e continueremo a farlo per eventuali ulteriori indagini.
La nostra speranza è che l'indagine porti risposte per tutti i soggetti
coinvolti". Condividi Anche Victoria Woodards, il sindaco di Tacoma, ha
chiesto che quattro ufficiali siano processati. Woodards ha parlato giovedì dopo
la diffusione del video: "Le azioni degli agenti che abbiamo visto stasera in
questo video confermano solo che la morte di Manuel Ellis è stata un omicidio e
oggi sto chiedendo - no, ve lo sto dicendo - che chiederò diverse cose, e chi ha
commesso questo crimine sarà giudicato secondo la legge. Ci vuole un video
affinché così tante persone credano alla verità sul razzismo sistemico e sul suo
impatto violento. Nelle vite dei neri. Nella mia vita".
Anche a Tacoma la polizia uccise una afroamericano: il video che
indigna gli Usa. Il Dubbio il 6 giugno 2020. Anche nel caso di Manuel Ellis,
l’afroamericano di 33 anni ucciso nel marzo scorso a Tacoma durante l’arresto,
spunta un video che inchioda gli agenti del dipartimento di polizia della città
dello stato di Washington alle loro responsabilità. Anche nel caso di Manuel
Ellis, l’afroamericano di 33 anni ucciso nel marzo scorso a Tacoma durante
l’arresto, spunta un video che inchioda gli agenti del dipartimento di polizia
della città dello stato di Washington alle loro responsabilità.
Nel video, diffuso dal Tacoma Action Collective, infatti si
vedono gli agenti che picchiano Ellis dopo averlo schiacciato a terra e
ammanettato sul ciglio di una strada.
La sindaca chiede il licenziamento degli agenti. La sindaca di
Tacoma , Victoria Woodards, che ha chiesto il licenziamento dei quattro agenti
coinvolti sottolineando che il video diffuso conferma quello che i medici legali
della contea hanno reso noto nei giorni scorsi, stabilendo che la morte di
Ellis, avvenuta per asfissia, è stato un omicidio. “Questa sera la famiglia ha
chiesto perché ci vuole sempre un video per far convincere la gente che la vita
di una persona nera è stata tolta in modo ingiusto? come donna afroamericana non
ho bisogno di un video per credere”, ha detto Woodards chiedendo al procuratore
distrettuale di procedere velocemente nei confronti degli agenti coinvolti.
“Mentre guardavo il video diventavo sempre più arrabbiata e delusa”, ha aggiunto
la sindaca.
Per i medici legali è omicidio. I medici legali del Pierce County
Medical Examiner’s Office hanno reso noto che Ellis, che aveva gravi problemi di
tossicodipendenza, aveva delle sostanze stupefacenti nel suo sistema al momento
della morte, ma i hanno stabilito che non sono state queste a provocarla.
L’ufficio del medical examiner – che ha pubblicato il suo rapporto mentre anche
nelle strade di Tacoma si sta protestando – ha quindi definito la morte come
omicidio. All’epoca dei fatti, gli agenti avevano detto che Ellis era in preda
ad una sorta di delirio violento ed aveva attaccato i due poliziotti che erano
intervenuti che hanno quindi chiamato rinforzi cercando di calmarlo. I quattro
agenti coinvolti – due bianchi, un afroamericano ed un asiatico – erano stati
sospesi dal servizio subito dopo i fatti, ma prima della pubblicazione dei
risultati dell’autopsia erano rientrati in dipartimento.Il governatore Jay
Inslee ha annunciato che lo stato avvierà un’inchiesta indipendente sulla morte
di Ellis “La più triste realtà è che George Floyd è qui a Tacoma , ed il suo
nome è Manny”, ha detto il legale della famiglia di Ellis”, affermando che nel
video si sente Ellis gridare “non riesco a respirare”, I can’t breath, come fece
Floyd. Intanto, il sindacato della polizia di Tacoma ha diffuso una dura nota in
cui attacca la sindaca per aver parlato basandosi su “un breve, sfocato video di
Twitter” e sottolineato che “ora è il momento per i fatti e non i teatrini:
quello che è successo a George Floyd nelle mani della polizia è sbagliato, gli
agenti di Tacoma non hanno assassinato Mr Ellis”
Da "corriere.it" l'8 giugno 2020. Un video pubblicato sui social
e girato negli Stati Uniti documenta un nuovo arresto controverso da parte della
polizia americana. Un agente e un ragazzo (bianco nda) discutono animatamente.
Il poliziotto lo accusa di averlo “fissato minacciosamente”, poi di “toccarlo”.
Il giovane invece si difende negando e chiede il motivo delle “vessazioni” che
sta subendo. La discussione si accende quando il poliziotto insiste e il ragazzo
risponde: “Se non sai cosa vuol dire guardare in una direzione, allora devi
tornare a scuola, ritardato!”. A quel punto l’agente gli intima di girarsi e lo
ammanetta, ma senza dichiarare il motivo. Dopo le insistenze di un amico
dell’arrestato arriva una risposta: “Rimarrà ammanettato finché non lo
capiremo”.
La polizia uccide un afroamericano ad Atlanta, un altro morto
dopo George Floyd. Le Iene News il 13 giugno 2020. Si
chiamava Rayshard Brooks, il 27enne afroamericano, ucciso dalla polizia ad
Atlanta. Un video registrato da una passante testimonia gli ultimi secondi di
vita del ragazzo, ucciso con tre colpi di pistola. L’episodio ha tanti punti
comuni con l’omicidio di George Floyd, ucciso lo scorso 25 maggio. Un altro
afroamericano ucciso dalla polizia. Questa volta ad Atlanta a neanche tre
settimane dall’omicidio di George Floyd. Il video della morte di Rayshard
Brooks, 27 anni, è virale sui social. In quel filmato sono raccontati gli ultimi
30 secondi di vita del ragazzo. Secondo una prima ricostruzione, la pattuglia
sarebbe intervenuta in un parcheggio dove il ragazzo avrebbe dormito
sull’asfalto. Dal confronto con i due agenti, il 27enne sarebbe riuscito a
strappare il teaser prima di tentare di fuggire a piedi. Tutto questo è durato
pochi secondi come testimoniato dal video registrato da una passante che ha
assistito alla scena dalla sua auto. Brooks a questo punto è stato raggiunto da
tre colpi di pistola sparati alle sue spalle. La polizia di Atlanta ha aperto
un’inchiesta per verificare anche l’autenticità del filmato girato in Rete, ma
sull’epilogo di questa vicenda ci sarebbero due versioni. Secondo la prima, il
ragazzo sarebbe stato portato d’urgenza in ospedale, dove poi è morto. Invece
per la seconda versione sarebbe stato lasciato agonizzare sull’asfalto. Questa
morte ha tanti punti in comune con quella di George Floyd (qui il video). Anche
lui afroamericano brutalmente ucciso dalla polizia a Minneapolis lo scorso 25
maggio. Il video della sua morte, in cui chiedeva disperatamente pietà
all'agente che lo ha soffocato, è diventato virale e tantissime persone nelle
ore successive alla sua morte sono scese in strada per protestare. La sede della
polizia è stata data alle fiamme, e il presidente Trump ha minacciato l'invio
dell'esercito per ristabilire l'ordine.
Il video del caso ha fatto il giro del mondo.
Afroamericano ucciso dalla polizia ad Atlanta, licenziato
l’agente che ha sparato. Redazione su Il Riformista il 14 Giugno 2020. È stato
licenziato l’agente che ha sparato e ucciso l’afroamericano Rayshard Brooks ad
Atlanta, nello Stato della Georgia. Il suo nome, reso noti da fonti di polizia,
è David Brosnan. La notizia del licenziamento è stata resa nota dal portavoce
della polizia della città, Carlos Campos, alla Cnn. Il caso, emerso ieri, è
diventato subito noto in tutto il mondo, anche a causa delle recenti proteste
scatenate dalla morte, avvenuta sotto la custodia della polizia di George Floyd
a Minneapolis. Brooks, 27 anni, stava dormendo nella sua auto in un parcheggio
di un ristorante della catena Wendy’s. La polizia ha accertato il suo stato di
ebbrezza ma l’uomo si è ribellato all’arresto strappando il taser dalle mani di
uno dei poliziotti. Per fermare la fuga di Brooks l’agente ha così esploso tre
colpi di arma da fuoco che hanno raggiunto il 27enne alla schiena. Inutili i
soccorsi e l’intervento chirurgico in ospedale. Il video dei fatti ha fatto il
giro del web. Il secondo agente coinvolto nel caso si chiama Garrett Rolfe,
sospeso. Il capo della polizia della città, Erika Shields, ritenuta fino a
qualche giorno fa uno dei volti positivi delle forze dell’ordine per aver
cercato il dialogo con i manifestanti durante le proteste per la morte di George
Floyd, si è dimesso. Le indagini per chiarire l’accaduto sono in corso. In
strada, a protestare pacificamente, si sono radunate migliaia di persone
cantando “no justice, no peace”. A tre settimane dalla morte di George Floyd si
rischia una nuova ondata di manifestazioni.
Proteste anche in Europa sull'onda del caso Floyd.
Rabbia ad Atlanta: fiamme e arresti nelle manifestazioni per
l’uccisione di Rayshard Brooks. Redazione su Il Riformista il 14 Giugno 2020.
Almeno 36 persone sono state arrestate ad Atlanta, in Georgia, per le
manifestazioni scatenate dall’uccisione di Rayshard Brooks da parte della
polizia. Il caso è avvenuto lo scorso venerdì sera, a nemmeno un mese dalla
morte di George Floyd a Minneapolis, sempre sotto la custodia della polizia, che
aveva scatenato proteste e manifestazioni, anche violente, in tutto il Paese e
perfino in Europa. Anche nel Vecchio Continente si continua infatti a scendere
in piazza per manifestare contro il razzismo. Gli Stati Uniti sembrano
intrappolati nella spirale di violenza e nello shock che li ha colpiti dopo la
morte di Floyd lo scorso 25 maggio. Ad aumentare l’indignazione e la protesta i
video virali dei fatti, come in quest’ultimo caso. Brooks aveva 27 anni e cinque
figli. E’ stato raggiunto da tre colpi di arma da fuoco alle spalle dopo una
colluttazione con due agenti nel parcheggio di un fast-food. La vittima aveva
scippato dalle mani di uno dei due poliziotti intervenuti la pistola elettrica
taser. L’agente che ha sparato, Devin Brosnan, è stato licenziato. Il capo della
polizia di Atlanta ha dato le dimissioni. “No peace, no justice”, lo slogan con
il quale sono scesi in piazza i manifestanti nella città della Georgia. Alle
proteste pacifiche di ieri sono seguiti scontri più violenti. Il fast-food dove
si è verificato l’omicidio è stato dato in parte alle fiamme. Alcuni
manifestanti hanno infranto i vetri delle finestre e lanciato fuochi d’artificio
all’interno del locale. Le forze dell’ordine hanno risposto con lacrimogeni e
hanno chiuso l’interstatale che conduce al ristorante. Previste grandi proteste
anche oggi. L’onda lunga del caso George Floyd continua a portare in piazza
persone anche in Europa. A Hyde Park a Londra si è tenuta una manifestazione
anti-razzista. A causare tensioni è stato però il raduno di estrema destra che
nella capitale inglese aveva l’obiettivo di proteggere e preservare le statue
della città, come quella di Winston Churchill e i caduti del Cenotafio. Oltre
100 i fermati dalla polizia. I dimostranti hanno lanciato fumogeni e coni
stradali verso le forze dell’ordine che hanno risposto con i manganelli. Il
corteo ha provato a raggiungere la manifestazione di Hyde Park ma è stato
fermato dalla polizia. A Parigi ieri pomeriggio migliaia di manifestanti
in Place de la Republique si sono radunato per protestare contro le violenza
della polizia. Le forze dell’ordine hanno impedito la manifestazione e sono
partiti dei tafferugli. Il Consiglio di Stato ha revocato il divieto di raduni
di più di 10 persone e ristabilito il diritto a manifestare ma sempre
“nell’ambito delle regole”. A Milano è stata vandalizzata la statua di George
Floyd.
Afroamericano ucciso ad Atlanta, licenziato poliziotto che gli
sparò. Jacopo Bongini il 14/06/2020 su Notizie.it.
L'agente di polizia Devin Brosnan è stato licenziato dopo aver ucciso un
cittadino afroamericano ad Atlanta mentre questi stava fuggendo all'arresto. È
stato licenziato Devin Brosnan, l’agente di polizia che lo scorso 13 giugno ha
sparato tre colpi di pistola, uccidendolo, contro il cittadino
afroamericano Rayshard Brooks, reo di essere fuggito a un arresto strappando di
mano il taser all’altro poliziotto che lo stava immobilizzando. Quest’ultimo
agente, Garret Rolfe, è stato invece sollevato dal suo incarico venendo
assegnato a lavori d’ufficio, tutto questo mentre la sindaca di Atlanta ha
denunciato quello che a suo dire è stato un uso eccessivo della forza da parte
delle forze dell’ordine. L’annuncio del licenziamento di Devin Brosnan è stato
dato dal portavoce del dipartimento della capitale della Georgia, Carlos Campos,
mentre la sindaca Keisha Lance Bottoms – anch’essa afroamericana – ha annunciato
le dimissioni del capo della polizia della città, Erika Shields,
affermando: “Rimarrà con la città in un ruolo da determinare, ma si sta facendo
da parte come capo della polizia”. Stando alle ricostruzioni dell’accaduto,
effettuate anche grazie ai filmati disponibili in rete, i due agenti sarebbero
stati impegnati nell’immobilizzare e arrestare il 27enne Brooks, quando
quest’ultimo è riuscito a divincolarsi dalla presa strappando di mano da uno dei
poliziotti la pistola taser con cui lo stavano trattenendo a terra. Dopo essere
fuggito per qualche metro con il taser in mano, Brooks è stato fermato da tre
colpi di pistola alla schiena sparati dall’agente Brosnan, che lo hanno in
seguito ucciso. Nel frattempo Chris Stewart, legale della famiglia Brooks, ha
affermato: “Vogliamo giustizia. Siamo impegnati a trovare un vaccino per
il Coronavirus, ma non siamo impegnati a trovare un vaccino contro la polizia
che spara nel giro di pochi secondi contro un afroamericano”. La morte di Brooks
arriva nel pieno delle proteste per l’analoga dipartita di George Floyd, con
migliaia di manifestanti che nelle ore successive sono scesi per le strade di
Atlanta denunciando la violenza della polizia contro le minoranze etniche.
Atlanta, polizia uccide il 27enne afroamericano Rayshard
Brooks. Veronica Caliandro il 13/06/2020 su
Notizie.it. Un altro afroamericano, il 27enne Rayshard Brooks, è stato ucciso
dalla polizia negli Usa, con un nuovo video choc finito sul web. Dopo la morte
di George Floyd un altro afroamericano, il 27enne Rayshard Brooks, è stato
ucciso dalla polizia negli Usa, con un nuovo video choc finito sul web. La
polizia di Atlanta ha aperto un’inchiesta per accertare le dinamiche della
vicenda. Da questa mattina alcune decine di persone si sono radunate ad Atlanta,
Georgia, vicino ad un’area occupata da un parcheggio dove nella notte la polizia
ha sparato, uccidendo, un afroamericano di 27 anni di nome Rayshard Brooks. In
base ad una prima ricostruzione dei fatti da parte degli agenti, una pattuglia
era intervenuta in serata per arrestare il giovane che si trovava sdraiato per
terra mentre dormiva in mezzo ad un parcheggio. L’uomo, così some si evince dal
video fatto da una persona che si trovava in un’auto ferma nel parcheggio, ha
reagito, strappando un teaser all’agente, per poi cercare di scappare a piedi. A
quel punto gli agenti hanno sparto tre colpi di pistola in rapida successione
alla schiena per cercare di fermarlo. In merito a quanto accaduto in seguito,
però, vi sono versioni discordanti. Secondo gli agenti, infatti, il 27enne
sarebbe stato portato d’urgenza in ospedale dove poi sarebbe morto. In base a
quanto raccontato da un testimone, invece, Rayshard Brooks sarebbe stato
lasciato a terra, per poi essere portato in ospedale quando era già morto. La
polizia nel frattempo ha aperto un’inchiesta per accertare le reali dinamiche
dell’accaduto e anche l’autenticità del video pubblicato in rete.
Da repubblica.it il 13 giugno 2020. Dopo la morte di George
Floyd c'è un altro afroamericano ucciso dalla polizia negli Usa, e un nuovo
video shock finito sulla rete. Da stamani alcune decine persone si sono radunate
ad Atlanta, Georgia, vicino a un'area occupata da un parcheggio, dove nella
notte la polizia ha ucciso un afroamericano di 27 anni. Secondo la ricostruzione
degli agenti, una pattuglia era intervenuta ieri sera per arrestare il
giovane, Rayshard Brooks, sdraiato per terra a dormire in mezzo a un parcheggio.
L'uomo, come documentato dal video girato da una persona che si trovava in
un'auto ferma nel parcheggio, ha reagito, riuscendo a strappare un "teaser"
paralizzante dalle mani di un agente, per poi tentare di scappare a piedi. A
quel punto i poliziotti gli hanno sparato almeno tre colpi di pistola in rapida
successione alla schiena. Su quello che è successo dopo ci sono due versioni
discordanti: secondo la prima, fornita dagli agenti, Brooks sarebbe stato
portato d'urgenza in ospedale, dove poi è morto. Secondo un testimone, invece,
l'uomo sarebbe stato lasciato agonizzante a terra e portato via solo in un
secondo momento, quando non c'era più niente da fare. La polizia di Atlanta ha
confermato l'episodio e aperto un'inchiesta, nell'ambito della quale sta
verificando anche l'autenticità del video che gira in Rete.
Il 27enne di Atlanta. Caso Rayshard Brooks, l’autopsia conferma:
morto a causa dei colpi alla schiena.
Redazione de
il Riformista il
15 Giugno 2020. Rayshard Brooks è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco
alla schiena. E’ quanto rivela l’autopsia dell’afroamericano ucciso dalla
polizia ad Atlanta. Secondo quanto riporta la Cnn, che cita i risultati
dell’ufficio di medicina legale di Fulton County, in Georgia, il 27enne è morto
a causa di danni ad alcuni organi con conseguente emorragia. L’autopsia,
eseguita domenica, elenca come causa della morte le ferite da arma da fuoco alla
schiena. Nel documento, si parla del caso come di omicidio. Intanto l’agente che
ha sparato, Devin Brosnan, non appena scoppiato il caso è stato licenziato e il
capo della polizia di Atlanta ha dato le dimissioni.
IL CASO – L’afroamericano di 27 anni è morto negli Stati Uniti dopo essere stato
ferito a colpi d’arma da fuoco dalla polizia. Dopo la morte di George Floyd,
soffocato da un agente a Minneapolis durante un tentativo di arresto, un nuovo
caso scuote il popolo americano. La vittima si chiamava Rayshard Brooks ed è
morto ad Atlanta, Georgia. Secondo una prima ricostruzione della polizia, gli
agenti sarebbero intervenuti in un parcheggio poco dopo le 22.30 di venerdì 12
giugno in seguito alla segnalazione dei proprietari di un ristorante (Wendy
sull’University Avenue) che lamentavano la presenza di un uomo che dormiva
all’interno di un’auto in sosta nel parcheggio. Durante gli accertamenti della
polizia, Brooks ha reagito al tentativo di fermo. Ne è nata una colluttazione,
così come documentato da diversi video che girano in rete, al termine della
quale il 27enne è riuscito a liberarsi e a scappare, forse dopo essere entrato
in possesso di un “taser”. Durante l’inseguimento i due agenti hanno esploso
almeno tre colpi di pistola che hanno raggiunto l’uomo alla schiena. Versione
discordante sulle modalità di soccorso. Secondo gli agenti, Brooks sarebbe stato
portato subito in ospedale dopo è morto mentre i medici lo stavano operando. Un
testimoni riferisce invece che sarebbe stato lasciato a terra agonizzate e
portato via solo quando non c’era nulla da fare. La polizia di Atlanta, nel
frattempo, ha aperto una inchiesta per far luce su quanto accaduto. E nella
giornata di domenica è arrivato il responso dell’autopsia che confermerebbe la
morte del giovane 27enne a causa dei colpi di pistola.
LE PROTESTE – Dopo il caso George Floyd, il caso di Brooks ha gettato benzina
sul fuoco sul già incendiato clima americano. Almeno 36 persone che sono state
arrestate ad Atlanta, in Georgia, per le manifestazioni scatenate dall’uccisione
di Rayshard Brooks. Ad aumentare l’indignazione e la protesta i video virali dei
fatti, come in quest’ultimo caso. Brooks aveva 27 anni e cinque figli.
Da repubblica.it il 18 giugno 2020. Sono undici i capi d'accusa,
fra i quali omicidio, per l'ex agente di polizia Garrett Rolfe che ha sparato e
ucciso Rayshard Brooks ad Atlanta. Il poliziotto aveva sparato all'uomo di
origini afromericane dopo un controllo con l'etilometro. Brooks stava dormendo
in auto bloccando la strada d'ingresso di un ristorante, quando è stato
controllato dagli agenti. Ne è nata una colluttazione, l'uomo ha preso il taser
di uno dei poliziotti ed è scappato puntandoglielo contro. Rolfe gli ha sparato
alla schiena, colpendolo con due colpi. Secondo l'accusa l'uomo in fuga non
costituiva una minaccia di morte immediata e il poliziotto lo avrebbe anche
calciato mentre era per terra, senza chiedere l'intervento di un'ambulanza per
almeno due minuti. Il suo legale ribatte invece che Rolfe "ha reagito dopo aver
sentito un colpo di arma da fuoco e visto una luce davanti a sé. Temendo per la
sua sicurezza e per quelle dei civili nell'area ha lasciato il taser e sparato
verso l'unica porzione di Brooks davanti a lui, la schiena". I poliziotti di
Atlanta si sono schierati con l'ex collega (che nel frattempo è stato
licenziato). In base a quanto riporta la Cnn, si sono dichiarati malati o sono
al posto di lavoro ma non rispondono alle chiamate al 911, l'omologo del 113,
per protestare dopo le accuse avanzate contro Garrett Rolfe, che nel frattempo è
stato licenziato, e il suo compagno di turno di quella notte Devon Brosnan. I
media americani stanno scavando nel passato dell'ex agente che ha ucciso
Rayshard Brooks e hanno scoperto che cinque anni fa è stato accusato di aver
insabbiato una sparatoria in cui era uno dei protagonisti insieme ad altri suoi
colleghi. Nell'agosto 2015 Garrett Rolfe e altri due agenti avevano sparato
contro Jackie Jermaine Harris, un afroamericano che stavano inseguendo, perché
alla guida di una vettura rubata. La sparatoria non è mai stata riportata dagli
agenti.
Trump: "Non si può resistere alla polizia in quel modo". "La
polizia non è trattata in modo giusto in questo Paese". Lo dice Donald Trump in
un'intervista intervenendo sul caso di Rayshard Brooks. "Non si può resistere
alla polizia in quel modo", aggiunge il presidente degli Stati Uniti riferendosi
allo scontro fra gli agenti e Brooks.
L'ad di Netflix dona 120 milioni di dollari ai college
afroamericani. Mentre gli Stati Uniti sono ancora scossi per le morti di George
Floyd e di Rayshard Brooks, che hanno riacceso il dibattito sul razzismo e
sull'uso eccessivo della forza da parte della polizia, l'amministratore delegato
di Netflix, Reed Hastings, e sua moglie Patty Quillin hanno deciso di donare 120
milioni di dollari a università tradizionalmente frequentate da una maggioranza
di afroamericani. La donazione record arriva fra le proteste "Black lives
matter" avvenute in tutta l'America.
Il caso del 27enne in Georgia. Perché è stato arrestato Rayshard
Brooks, l’afroamericano ucciso dalla polizia ad Atlanta.
Redazione de il
Riformista il
14 Giugno 2020. Una nuova ondata di proteste potrebbe travolgere gli Stati
Uniti, sull’onda delle manifestazioni, talvolta violente, scatenate dal caso
George Floyd, l’afroamericano 46enne ucciso dalla polizia a Minneapolis, nel
Minnesota. Un episodio analogo si è infatti verificato ad Atlanta, in Georgia. E
anche in questo caso sono diversi i video che hanno fatto il giro del web e del
mondo. La vittima, in questo nuovo caso, si chiamava Rayshard Brooks e aveva 27
anni. E’ stato freddato da tre colpi di arma da fuoco alle spalle. L’uomo si era
addormentato nella sua auto lo scorso venerdì sera nel parcheggio di un
ristorante. Alle 10:30 circa una pattuglia con due agenti di polizia lo ha
raggiunto. Le forze dell’ordine erano state contattate perché Brooks stava
ostruendo con la sua auto il passaggio per raggiungere il punto di ritiro del
cibo del fast food della catena Wendy’s. Il 27enne era stato sottoposto a un
test alcolemico ed è risultato ubriaco. A quel punto ha reagito e si è
divincolato dagli agenti. E’ riuscito anche a scippare a uno dei due il taser,
la pistola a scarica elettrica, ed ha provato a scappare a piedi. In quel
momento uno degli agenti, Garret Rolfe, ha sparato. E’ stato licenziato, il
collega Devin Brosnan è stato sospeso. In un primo momento la polizia aveva
dicharato che i colpi erano stati esplosi nella colluttazione con gli agenti
proprio perché Brooks si era impossessato del taser. Ma i video hanno smentito
la versione. Discordanti anche le versioni sui soccorsi: per gli agenti il
27enne sarebbe stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove poi è morto;
secondo un testimone l’uomo sarebbe stato lasciato a terra agonizzante e portato
via in un secondo momento. Brooks era muratore, aveva cinque figlie, due
adottive, e la compagna era incinta. I video che riprendono il suo arresto – le
fonti sono diverse: telecamere di sicurezza, polizia e passanti – sono diventati
in poco tempo virali. Manifestanti hanno dato fuoco a parte del ristorante. Il
capo della polizia di Atlanta si è dimesso.
Minorenne trattato come George Floyd: bloccato a terra e
picchiato da un poliziotto. Redazione su Il Riformista
il 8 Giugno 2020. Prima lo ha bloccato a terra, tenendogli il collo fermo con la
mano. Poi lo ha colpito con una raffica di pugni al busto. Mentre negli Stati
Uniti, dopo la morte di George Floyd, è esplosa la protesta contro la
violenza della polizia ai danni degli afroamericani, torna a far discutere un
video in cui si vede un 14enne mentre cerca di pararsi dai colpi di un
poliziotto. L’episodio, del 28 aprile scorso, è avvenuto a Rancho Cordova, in
California. Il ragazzo era stato fermato perché sospettato di essere in possesso
di stupefacenti ma secondo la sorella, che per prima ha denunciato l’episodio,
si trattava di un Swisher Sweet, un tipo di sigaro aromatizzato. “Era armato
ed enorme. Il ragazzo era piccolo e stava chiaramente cercando di proteggersi il
viso. Non c’è niente che un quattordicenne disarmato possa fare per giustificare
le azioni intraprese da questo ufficiale”, ha commentato Tanya Faison,
fondatrice di Black Lives Matter. La polizia ha fatto sapere che il ragazzo si
era prima rifiutato di fornire le sue generalità e poi aveva opposto resistenza.
“L’ufficiale – hanno spiegato – ha cercato di tenere sotto controllo il
minore senza le manette e mentre era solo in attesa che arrivassero i suoi
colleghi”. La sorella ha poi denunciato su Twitter che il ragazzo soffre di
una grave condizione cardiaca che può essere scatenata facilmente da un colpo al
petto o alla schiena. “È un bambino – ha detto – e non ha mai avuto alcun tipo
di problema con la legge”. La senatrice dem Kamala Harris, ex candidata alle
presidenziali dem in California ha definito l’accaduto “un orribile abuso di
potere“.
Da "Ansa" il
25 giugno 2020. Un altro video shock sulla brutalità della polizia Usa dopo
quello sull'uccisione dell'afroamericano George Flyod. Questa volta la vittima è
un ispanico, Carlos Ingram Lopez, 27 anni, morto durante l'arresto a Tucson, in
Arizona. Nel video della body camera, diffuso dalla polizia ad oltre due mesi
dall'episodio, si vedono gli agenti inseguire l'uomo dentro una casa,
ammanettarlo e tenerlo con la faccia a terra per 12 minuti mentre chiede
dell'acqua e mormora "non posso respirare" (come Floyd), prima di morire.
Secondo l'autopsia la causa della morte è una combinazione del blocco a terra in
posizione prona con un cappuccio anti sputo e di un arresto cardiaco in presenza
di una intossicazione di cocaina. I tre agenti - due bianchi e uno afroamericano
- hanno tentato il massaggio cardiaco e gli hanno iniettato anche del Narcan,
una sostanza per rianimare persone in overdose, ma inutilmente. Erano
intervenuti per la segnalazione di una condotta scombinata dell'uomo, che era
senza vestiti e sembrava agire in modo irregolare, tentando di nascondersi
dietro un'auto in un garage. Ad un certo punto si sente uno dei poliziotti dire
a Lopez che sarebbe stato colpito con una pistola taser se non avesse cooperato
ma l'uomo non oppone resistenza e appare solo terrorizzato. Secondo il capo
della polizia di Tucson, Chris Magnus, gli agenti non hanno usato la stretta al
collo (chokehold) ma hanno violato le linee guida tenendo l'arrestato in
posizione prona per 12 minuti in quella che ha descritto come una crisi di
salute mentale con "delirio eccitato". I tre agenti coinvolti nella morte di
Lopez hanno presentato le loro dimissioni, mentre il capo della polizia Chris
Magnus ha offerto le sue dopo la diffusione del video. I poliziotti coinvolti
sono Samuel Routledge, Ryan Starbuck e Jonathan Jackson. La sindaca di Tucson,
Regina Romero, prima latina a guidare una città largamente ispanica, si è detta
"profondamente turbata e indignata" e ha offerto le condoglianze alla famiglia
della vittima.
Giuseppe
Sarcina per il ''Corriere della Sera'' il 26 giugno 2020. Ancora immagini
agghiaccianti della polizia in azione. E un uomo di 27 anni ammanettato,
bloccato con la faccia a terra per 12 minuti. Chiede, implora dell'acqua.
Sussurra: «Non respiro più». Così il 22 aprile scorso è morto Carlos Ingram
Lopez, 27 anni, ispanico di Tucson, Arizona. Il capo del Dipartimento di
Polizia, Chris Magnus, ha diffuso la clip con l'intera sequenza di 25 minuti
solo mercoledì scorso, 24 giugno, perché, ha spiegato, la famiglia doveva ancora
vederla. Magnus ha convocato una conferenza stampa e ha «offerto le dimissioni»
in diretta, senza avvisare le autorità politica. Gli stava accanto la sindaca
Regina Romero, visibilmente colta di sorpresa. Romero, prima donna di origine
latina a guidare Tucson, democratica, ha avuto parole durissime per la condotta
degli agenti, «da licenziare immediatamente». Ma ha elogiato «l'integrità» e la
«gestione» di Magnus. Il video è stato ripreso dalla «body camera» montata sulla
divisa degli agenti. L'azione comincia intorno all'una, nella notte tra il 21 e
il 22 aprile. Una pattuglia risponde alla chiamata di un'anziana signora, la
nonna di Carlos: «Venite, sta combinando un disastro in casa». Gli agenti
rintracciano l'uomo nel garage. È nudo, sdraiato per terra, chiaramente in stato
confusionale. I poliziotti si avvicinano con cautela. Uno di loro minaccia: «Se
non la smetti di agitarti ti becchi una bella scossa». Nessuno, però, usa il
taser, la pistola elettrica, o le armi da fuoco. Alla fine Carlos si ritrova con
la pancia sul pavimento. Comincia a lamentarsi, ma i tutori della legge non lo
spostano. Anzi lo coprono con una coperta gialla che sembra di materiale
sintetico. Il tempo scorre nella luce livida del garage, nel silenzio interrotto
dalle grida di una donna e dai lamenti sempre più flebili che arrivano da quel
fagotto immobile. Dodici minuti e un poliziotto si scuote, solleva un lembo
della coperta, urla: «Hey, hey». Un altro punta la torcia: «Non sembra molto
cosciente adesso». Carlos Ingram Lopez è già morto, come stabilirà l'autopsia.
Arresto cardiaco per asfissia. Nell'organismo viene trovata una quantità
rilevante di cocaina. Il capo della polizia Magnus ha chiesto all'Fbi di
indagare. I tre agenti si sono dimessi: Samuel Routledge, Ryan Starbuck e
Jonathan Jackson. Uno, non sappiamo ancora chi, è afroamericano. È un caso che
ricorda quanto è successo ad Atlanta, dopo l'uccisione del ventisettenne
Ryashard Brooks, colpito alle spalle da tre colpi di pistola sparati da un
poliziotto, il 12 giugno. Anche lì la responsabile del Dipartimento di Polizia,
Erika Shields, si è dimessa. Sia Magnus che Shields avevano avviato un processo
di cambiamento, incoraggiati dalle loro sindache. Romero a Tucson e Keisha Lance
Bottoms, anche lei democratica, ad Atlanta. Ancora poche settimane fa Magnus
aveva affermato di essere alla guida di uno dei Dipartimenti più moderni e
culturalmente più avanzati nel Paese. In particolare aveva bandito la tecnica
del «chokehold», la stretta alla testa. Il 25 maggio scorso a Minneapolis,
l'agente Derek Chauvin ne aveva utilizzato una variante, schiacciando con il
ginocchio il collo di George Floyd. Dopo un mese di proteste, sit-in, la riforma
della polizia è diventato un tema centrale negli Stati Uniti. Al Congresso di
Washington democratici e repubblicani stanno cercando, faticosamente, un accordo
per fissare almeno alcune regole standard di comportamento. Ma la scia di
violenza sembra non fermarsi. Ieri mattina un agente a New York, David Afanador,
è stato arrestato per aver cercato di strangolare «un sospetto».
Da ansa.it il 9 giugno 2020. Spunta un nuovo video che cattura
l'uccisione di un altro giovane afroamericano disarmato dopo essere stato
fermato in New Jersey da un poliziotto bianco per eccesso di velocità. Nella
clip si vede che l'agente chiede al giovane di sedersi nella propria "gazzella"
in attesa del carro attrezzi dopo che la sua auto è finita in panne.
L'afroamericano avrebbe tentato di sedersi sul posto di guida due volte: la
prima volta l'agente usa lo spray urticante, la seconda lo tira fuori dall'auto
e in una colluttazione gli spara 6 volte. Le immagini arrivano dalla videocamera
sul cruscotto dell'auto dell'agente e sono state diffuse dall'attorney general
del New Jersey, che sta indagando sull'episodio, accaduto il 23 maggio, due
giorni prima della morte di George Floyd. Nei circa 30 minuti di video, il fermo
sembra routine. L'agente Randall Wetzel ottiene le generalità di Maurice Gordon,
28 anni, di Poughkeepsie, New York, e chiama un carro attrezzi. Il poliziotto
gli offre una mascherina e un passaggio in una concessionaria d'auto. Dopo 20
minuti che era seduto nell'auto della polizia, Gordon si toglie la cintura di
sicurezza ed esce dalla vettura. Wetzel gli grida di stare dentro diverse volte
mentre sembrano azzuffarsi all'esterno. L'attorney general ha riferito che
Gordon ha tentato di entrare due volte sul posto di guida della pattuglia e che
l'agente ha reagito prima con lo spray e poi spingendolo fuori e sparandogli sei
volte durante una colluttazione. Il poliziotto è stato sospeso, in attesa
dell'esito dell'indagine. A due settimane dalla barbara uccisione di Floyd,
l'afroamericano soffocato con un ginocchio da un agente bianco a Minneapolis, il
movimento di protesta che ha percorso il Paese ottiene intanto le prime promesse
di cambiare la polizia e la giustizia, mentre Donald Trump affonda nei sondaggi
anche per la pessima gestione della crisi. L'intervento più importante arriva
dai democratici, che hanno annunciato alla Camera un pacchetto di riforme dopo
aver osservato inginocchiati nell'Emancipation hall 8 minuti e 46 secondi di
silenzio, il tempo dell'agonia di Floyd. Tra i punti principali della proposta,
la demilitarizzazione della polizia limitando il trasferimento di armi militari
ai suoi dipartimenti locali e statali; l'obbligo delle videocamere sul cruscotto
delle auto e sul corpo degli agenti; il divieto della stretta al collo (quella
che ha ucciso Floyd) e le perquisizioni senza mandato in casi di droga; fine
della profilatura razziale; un database nazionale sulla cattiva condotta degli
agenti. "Questo momento di angoscia nazionale si sta trasformando in un
movimento di azione nazionale mentre gli americani in tutto il Paese protestano
pacificamente per chiedere di far cessare l'ingiustizia", ha spiegato la speaker
della Camera Nancy Pelosi. Un'altra stretta sulla polizia - che secondo un
conteggio del Washington Post ha ucciso quasi mille persone all'anno dal 2015 -
arriva da 'De-fund the police', il movimento che chiede di togliere o ridurre i
fondi ai dipartimenti di polizia e di usarli per risolvere i problemi
socio-economici delle comunità locali. Una richiesta già fatta propria dal
consiglio comunale di Minneapolis, che ha deciso di smantellare la polizia di
casa. Una mossa senza precedenti replicata dal sindaco dem di New York Bill de
Blasio, che ha promesso di tagliare nel giro di tre settimane una parte dei
fondi destinati al New York Police Department (il suo bilancio è di 6 miliardi
di dollari) e di destinarli ai servizi per i giovani e ai servizi sociali. Sulla
stessa linea il sindaco di Los Angeles Eric Garcetti, anche lui democratico, che
ha fatto marcia indietro sulla promessa di nuovi fondi alla polizia locale,
reindirizzando 150 milioni di dollari a programmi per sanità, lavoro e centri
per la pace. Musica per le orecchie di Donald Trump, che cavalca il tema su
Twitter: "Ora la sinistra radicale dei democratici vuole togliere i fondi e
abbandonare la nostra polizia. Scusate, io voglio legge e ordine", cinquetta
rilanciando lo slogan di Richard Nixon. Ma Joe Biden non gli lascia strada su
questo terreno: tramite un portavoce, precisato di non condividere la riduzione
dei finanziamenti alla polizia. E incontra i famigliari di Floyd nella sua città
natale di Houston, nel giorno dell'ultima commemorazione pubblica prima dei
funerali di domani, ai quali non parteciperà ma invierà un videomessaggio. Il
tycoon intanto perde terreno nei sondaggi. Nell'ultima rilevazione della Cnn
sulla corsa presidenziale, l'ex vicepresidente stacca Trump di ben 14 punti, un
margine che non aveva mai avuto: 55% a 41%, rispettivamente il livello più alto
e più basso nelle rilevazioni della tv. Non solo. Il 38% approva l'operato
presidenziale mentre il 57% lo boccia: è il peggior rating dal gennaio 2019,
analogo a quello di Jimmy Carter e George H.W.Bush nello stesso momento negli
anni in cui non riuscirono ad essere rieletti. "I sondaggi della Cnn sono falsi
come le loro notizie", ha commentato il presidente, ma anche i sondaggi interni
del suo staff rivelano un crollo, soprattutto fra gli indipendenti e le donne in
seguito all'uccisione di Floyd e al coronavirus. La sua campagna è preoccupata e
sta cercando di correggere il tiro. E il senatore repubblicano Mitt Romney, ex
candidato alla Casa Bianca, ieri era tra le persone che hanno marciato a
Washington verso la Casa Bianca. "Bisogna trovare un modo per porre fine
all'ingiustizia e alla brutalità e per rassicurare una volta per tutte la gente
che la vita dei neri conta, come la vita di tutti", ha dichiarato Romney. Il
senatore, notoriamente un forte critico di Trump, avrebbe fatto sapere - secondo
quanto riportato dal New York Times - che a novembre non voterà per il tycoon.
Un appello a combattere chi fomenta divisioni e diffonde falsità e
disinformazione in un periodo in cui gli Usa sono colpiti dalla pandemia e
attraversati da proteste e disordini sociali: a lanciarlo è Barack Obama,
rivolgendosi ai giovani americani che nel 2020 si sono diplomati e laureati nel
corso di una cerimonia virtuale su YouTube a cui hanno partecipato 70
personalità della politica, della cultura e dello spettacolo tra cui Beyoncè,
Lady Gaga e Michelle Obama. Quello dell'ex presidente suona come l'ennesimo
affondo contro Donald Trump.
Susanna Picone per fanpage.it il 7 luglio 2020. La polizia di
Phoenix, in Arizona, ha ucciso un uomo ispanico che si trovava barricato nella
sua auto con almeno otto colpi a bruciapelo. L’episodio, che arriva dopo le
proteste scatenate dall’uccisione di George Floyd a Minneapolis e da altre
simili vicende controverse, ha innescato nuove polemiche anche per le due
diverse e opposte versioni sull'accaduto, in parte documentato dal video. Quello
che si vede nel video è che James Garcia, questo il nome della vittima, è stato
ucciso mentre si trovava in auto. La raffica di proiettili che ha investito
l’uomo non poteva lasciargli scampo. Cosa è successo prima però non è ancora
chiaro.
La versione della polizia di Phoenix. La polizia sostiene di aver
ricevuto, sabato 4 luglio, la richiesta d'aiuto da parte un cittadino di un
sobborgo a nord-est di Phoenix che segnalava il ritorno di una persona armata
che lo aveva precedentemente aggredito. Gli agenti avrebbero quindi individuato
il sospetto nella vettura parcheggiata sotto un condominio, gli avrebbero
chiesto di uscire dall'auto, ma lui avrebbe messo mano a una pistola. A questo
punto i poliziotti, che come si vede nel video avevano circondato l'auto, hanno
sparato diversi colpi contro l’uomo, poi dichiarato morto in ospedale. Nel
filmato si vede la scena ma non se il sospetto stava brandendo un'arma. Si
sentono invece le grida e anche insulti della gente per strada.
L'altra versione: "Hanno fatto il possibile per ammazzarlo".
L’altra versione dell’accaduto sarebbe quella della persona che ha girato il
video e che dice di essere un amico della vittima. “Hanno fatto il possibile per
ammazzarlo”, avrebbe dichiarato lui, aggiungendo che Garcia si era solo
appisolato nella sua auto. Non sembra credere alla versione della polizia
neppure il consigliere comunale Carlos Garcia, che ha chiesto – come tanti altri
– siano diffuse al più presto le immagini registrate dalla bodycam degli agenti
intervenuti. Le proteste per l'episodio sono scoppiate a Phoenix domenica notte,
con dozzine di manifestanti che hanno marciato verso il distretto di polizia.
Morte Floyd, via le statue degli eroi confederati e razzisti:
rimossi il monumento al generale Lee e al sindaco di Philadelphia Rizzo.
Pubblicato venerdì, 05 giugno 2020 da Gabriella Colarusso su
La Repubblica.it. L'ondata anti-razzista che attraversa gli Stati Uniti
riaccende le contraddizioni della storia americana: che fare con le statue dei
generali sudisti o dei sindaci sceriffi responsabili di abusi contro le
minoranze? A Philadelphia, in Pennsylvania, nel giro di una notte, mercoledì, è
andata giù la statua di Frank Rizzo, che nei giorni scorsi era stata ricoperta
di scritte durante le proteste per la morte di George Floyd. "Questo è l'inizio
del processo di guarigione della nostra città", ha proclamato fiero il sindaco
della città, il democratico Jim Kenney, che ha preso la decisione di rimuovere
l'icona dopo un dibattito durato in realtà anni. Rizzo è una figura molto
controversa nella storia della città: figlio di immigrati italiani, fu
commissario di polizia negli anni del movimento per i diritti civili (dal 1967
al 1971) e poi sindaco per due mandati - con i Democratici - fino al 1978.
Difeso dai bianchi per i suoi metodi risoluti, "legge e ordine", ma detestato
dai neri, dagli omosessuali e dalle minoranze per gli abusi commessi dalla
polizia sotto il suo comando, registrati anche nell'archivio del Dipartimento di
Giustizia. Una foto emblematica pubblicata dal Philadelphia Inquirer lo ritrae a
una festa vestito in smoking con un manganello nascosto sotto la giacca. Da
sindaco impedì che fossero costruiti appartamenti di edilizia popolare per i
neri nei quartieri della middle class bianca. La statua in suo onore era stata
fatta costruire otto anni dopo la sua morte, nel 1999, proprio nella piazza
della città dedicata a Thomas Pane, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti
d'America e uno dei primi a esprimersi a favore dell'abolizione della
schiavitù. La rabbia dei manifestanti in questi giorni si è diretta contro la
statua Rizzo e contro decine di altre icone che raccontano la segregazione
razziale negli Stati Uniti, le violazioni e gli abusi ai danni dei neri. Il
governatore della Virginia, il democratico Ralph Northam, ha annunciato che farà
rimuovere da Richmond la statua di Robert Lee, il generale comandante degli
Stati Confederati durante la guerra di secessione, simbolo del Sud bianco e
razzista contrario all'abolizione della schiavitù. Nel giorni scorsi i
manifestanti avevano ricoperto il monumento di scritte fatte con lo spray e
avevano tentato di rimuoverlo, senza riuscirci, così come avevano fatto con le
statue di altri generali degli Stati confederati su Monument Avenue. Dal primo
luglio, secondo una nuova legge statale voluta proprio da Northam, saranno i
governi locali a poter decidere se rimuovere o meno i monumenti confederati. Il
sindaco di Indianapolis, in Indiana, Joe Hogsett si è unito alla battaglia e ha
annunciato che rimuoverà dal parco della città un monumento dedicato ai soldati
confederati morti in un campo di prigionia. "Le nostre strade sono piene di voci
di rabbia e angoscia, testimonianza di secoli di razzismo contro i neri
americani", ha detto. "Qualunque fosse lo scopo originale che questo simbolo
aveva non è servito come promemoria del terribile abbraccio del nostro Stato con
il Ku Klux Klan un secolo fa". Esteri Usa, non solo le statue sudiste: "Via il
monumento a Italo Balbo". Ma gli italo-americani: "Fa parte della nostra
storia".
Il dibattito. Il dibattito sulle statue era già esploso nel 2017
quando a Charlottesville una donna nera morì investita da un'auto durante un
raduno di neonazisti e suprematisti bianchi. E ancora prima nel 2015, dopo
che Dylan Roof, un giovane nostalgico della Confederazione, uccise nove
afroamericani in una chiesa di Charleston. Secondo il Southern Powerty Law
Center in tutti gli Stati Uniti ci sono 1.503 simboli degli Stati Confederati
nei luoghi pubblici. Dal 2015, dicono le stime del gruppo riportate dal New York
Times, almeno 138 sono stati rimossi, conservati o spostati altrove. Ora il
movimento di protesta nato dopo l'omicidio di Minneapolis promette di riscrivere
l'iconografia di piazze e strade. Ad Alexandria, una statua confederata che
doveva essere rimossa il mese prossimo è stata demolita martedì. A Norfolk, a
Birmingham, Huntsville, statue e monumenti simbolo della segregazione vengono
ricoperti di nuove parole: "Black lives matter" e "No more white supremacy".
Simonetta Sciandivasci per “la Verità” il 5 giugno 2020.
Italiani, popolo di eroici contenutisti. Non c'è mobilitazione social che ci
perdiamo, non manchiamo mai un #jesuis, un #metoo, uno sciopero di foto profilo
(qualche anno fa, usava l' Aventino delle donne, e se eri femmina venivi
raggiunta da decine di messaggi di sconosciute molto accese che ti dicevano che
per far capire ai maschi quanto contasse il tuo contributo, dovevi sparire per
un giorno da Facebook - e non vi dico cosa ci si sentiva rispondere, noi
krumire). Copiosa e compatta è stata anche l' adesione all'oscuramento della
profile pic e/o pubblicazione di foto nera su sfondo nero, insomma tutta nera,
in ottemperanza all'agitazione internazionale del #blacklivesmatter, dopo che il
25 maggio George Floyd è stato ammazzato dalla polizia. In America scendono in
strada, protestano, noialtri compattamente partecipiamo con uno statino, e lo
facciamo non perché sia utile alla causa dell' antirazzismo (non lo è) ma perché
sappiamo che corre obbligo d' esporsi, chi non s' espone è complice (i poveri
Ferragnez sono stati massacrati per non essersi espressi sul caso e Meghan
Markle, che è in caduta di consensi ma quando vuole il suo lavoro di attrice
influencer lo sa fare, s'è affrettata a filmarsi mentre spiegava che la cosa
peggiore da fare è non dire niente). Myrta Merlino, conduttrice de L' Aria che
tira, s' è inginocchiata in trasmissione, mentre lo schermo alle sue spalle s'
oscurava e lasciava leggere soltanto #blacklivesmatters, con un' aria solenne da
sacerdotessa della gravità. Notevole, anche se non quanto la recita dell'Eterno
riposo di Barbara D' Urso - certe vette restano imbattibili, ed è giusto così,
trattandosi di sacro. La reazione della bolla degli intelligenti è stata di gran
chiacchiericcio e celia, la stessa che segue ogni impresa di Barbara, anche se
più contenuta, ché siamo pur sempre su La 7, rispettabile in sé, o così era
alcuni anni fa, quando si vantava d' essere la casa delle libertà di tutti gli
orfani di servizio pubblico qualificato, sobrio, variegato, altamente formativo,
e una serie di altre ambiziose qualità che il pubblico apprezzerebbe, se solo
chi gli si presenta davanti avesse la pazienza di studiare, per impossessarsene.
Voi a casa non fatelo, per cortesia, non inginocchiatevi per un hashtag (non
inginocchiatevi per niente).
Morte Floyd, i dieci cortei pacifici di Washington: "George
non è morto invano". Pubblicato domenica, 07 giugno
2020 da Federico Rampini su La Repubblica.it “George Floyd non sarà morto
invano, appuntamento di nuovo qui oggi e domani, poi tante volte ancora, fino al
28 agosto”. Per dare continuità al movimento contro il razzismo, contro le
violenze della polizia, un raduno nazionale tornerà nella capitale
nell’anniversario della grande marcia del 1963 per i diritti civili, guidata da
Martin Luther King. E’ nel segno della continuità e della durata, per cambiare
l’America davvero, per onorare la memoria di George Floyd, che molti
manifestanti di Washington prendono questo impegno solenne mentre si conclude la
grande protesta pacifica di questo sabato. Le manifestazioni continueranno prima
di allora, ma la scadenza già fissata del 28 agosto vuole indicare che la
battaglia sarà lunga, perché si volti pagina nei comportamenti della polizia e
nel sistema penale. Altra data-chiave, che aleggia al termine di questa grande
giornata di mobilitazione: il 3 novembre, l’elezione presidenziale. L’ondata di
proteste è un verdetto fatale per Donald Trump? Il presidente ha voluto uscire
dall’assedio twittando “contro” la grande folla pacifica e perfino gioiosa che
ha circondato la Casa Bianca. “Una folla molto più piccola del previsto”, ha
twittato in serata. Ha ringraziato la Guardia Nazionale, il Secret Service e la
polizia di Washington, poi ha accusato la Cnn e Msnb di aver cercato di
“infiammare” la piazza. Ha più volte ritwittato anche il suo slogan favorito:
"Law & Order". Ma al nono giorno di proteste per l’uccisione dell’afroamericano
George Floyd, l’invasione pacifica di Washington ha prevalso sui propositi
bellicosi di Trump che voleva l’esercito a domare la folla. “I can’t breathe”
(non posso respirare, le ultime parole di Floyd soffocato dal poliziotto), “Stop
Killing Us”, “Black Lives Matter”, “Alzo le mani, non sparare”, “Non c’è pace
senza giustizia”, sono gli slogan più cantati, si fondono con tante bandiere a
stelle e strisce, nei dieci cortei che hanno attraversato Washington “per
riprendersi l’America”. Il gesto più forte, ripetuto centinaia di volte: un
corteo s’immobilizza, cala il silenzio, e tutti si mettono in ginocchio. E’ il
nuovo linguaggio della denuncia pacifica, contro le troppe violenze subite dai
neri. Il clima per tutta la giornata di sabato si è disteso, è stato cancellato
il ricordo degli scontri e dei saccheggi nei negozi; le pattuglie di polizia
hanno distribuito bottigliette d’acqua per ristorare i manifestanti in una
giornata di afa opprimente. Molti hanno scelto un punto di partenza simbolico:
il Memoriale di Abraham Lincoln, il presidente che guidò la guerra al Sud
schiavista. E’ sulla celebre spianata che va dalla collina del Campidoglio
(Congresso) alla Casa Bianca. La serata si è conclusa ancora una volta a
Lafayette Park: il giardino pubblico davanti al palazzo presidenziale, quello
che Trump fece sgombrare con la forza per la sua foto “con Bibbia in mano”
lunedì scorso. La Casa Bianca rimane un fortino assediato, cinta da alte
griglie, tiratori scelti del Secret Service sui tetti e ai cancelli: viene
paragonata alla Green Zone, l’area fortificata che proteggeva il quartier
generale americano a Bagdad durante la guerra in Iraq. Ma la sfida con Trump
questo sabato l’ha vinta la sindaca, l’afroamericana Muriel Bowser. “La Casa
Bianca dovrebbe essere la casa del popolo americano, è un triste spettacolo
vedere i suoi abitanti murati vivi”, ha detto la sindaca. Lei ha permesso a una
squadra di volontari di dipingere in giallo un gigantesco “Black Lives Matter”,
visibile anche dagli elicotteri, sulla 16esima Strada che porta al palazzo
presidenziale. La sindaca ha tolto il coprifuoco, per consentire libertà di
manifestazione anche la sera. “Incapace, incompetente” le ha tuonato addosso
Trump. Lui vuole “sindaci e governatori in grado di dominare la piazza”; aveva
minacciato di schierare l’esercito professionale. Ma in aiuto alla sindaca è
arrivato un alleato insperato: il Pentagono. I vertici militari hanno fatto il
contrario di quel che minacciava Trump, hanno ritirato i reparti dell’esercito
professionale dalle vie di Washington; anche tolto armi da fuoco e munizioni ai
cinquemila riservisti della Guardia Nazionale. Rimangono tante forze federali a
presidiare la capitale, dal Secret Service che protegge il presidente ai reparti
anti-terrorismo della Homeland Security. Invece i generali hanno fatto una
scelta distensiva, che ha contribuito a trasformare questo sabato in una grande
festa di massa, con pochissimi scontri. Ora la sindaca vuole di più: “Se ne vada
anche la Guardia Nazionale”. Muriel Bowser è la nuova star del momento, nei
cortei della capitale echeggia spesso il grido “Muriel for Vice”, sono i fan che
la vorrebbero designata da Joe Biden come vice nella corsa alla Casa Bianca. A
Lafayette Park un potente impianto da concerti amplifica fino alle finestre di
Trump un discorso di Martin Luther King, il leader delle battaglie per i diritti
civili negli anni Sessanta: “Il nostro movimento non violento è maestro nel
disarmare la polizia”. Un augurio, non una certezza. In contemporanea con le
manifestazioni a Washington e in centinaia di altre città, un memoriale per
George Floyd si teneva a Raeford in North Carolina, il suo Stato natale. In
quella cerimonia lo sceriffo Hubert Peterkin ha detto: “La polizia è parte del
problema. Se quattro neri gettassero un poliziotto a terra e uno lo uccidesse,
ci sarebbe una caccia all’uomo”. Nei cortei è apparso un nuovo slogan, “De-fund
the police”, togliere finanziamenti alle forze dell’ordine. La marea umana di
Washington si è vista anche a New York e Philadelphia, a Los Angeles e San
Francisco, e in simultanea in centinaia di città. Di fatto l'America intera è
uscita di prepotenza dal lockdown, con una "movida" politica che ignora permessi
e calendari. Questo sabato di maree umane pacifiche coincide con uno spostamento
nell’opinione pubblica. Un sondaggio della Monmouth University rileva che il 76%
degli americani, e fra questi il 71% dei bianchi, considera il razzismo e la
discriminazione “un grosso problema” negli Stati Uniti; è in aumento del 26%
rispetto al 2015 (quando pure vi furono proteste per l’omicidio
dell’afroamericano Freddie Gray da parte della polizia di Baltimora). Lo
spostamento è ancora più marcato fra i giovani, che dominano nei cortei. Nella
fascia di età dei Millennial e della Generazione Z si trova anche il più forte
consenso alla campagna sulle “riparazioni”, lanciata da diversi esponenti di
Black Lives Matter e da leader della sinistra radicale come Alexandria
Ocasio-Cortez: risarcimenti per chi discende da vittime dello schiavismo. Il
dibattito sulle indennità per lo schiavismo ha spesso diviso il partito
democratico perché può spostare a destra i bianchi poveri. La dimensione
socio-economica della condizione afroamericana è tornata di colpo alla ribalta
quando Trump venerdì ha salutato il calo della disoccupazione dicendo: “George
Floyd sarebbe felice, questa è un ottima giornata per gli afroamericani”. Ma
perfino in un periodo prospero come il quindicennio dal 1985 al 2000, due terzi
dei bambini neri abitavano in aree povere e segnate dalla segregazione di fatto
(cioè quasi esclusivamente afroamericane), un dato peggiore rispetto agli anni
Sessanta. Un altro dato inquietante: perfino nel ceto medioalto, i figli degli
afro-americani hanno una mobilità sociale in discesa, stanno peggio dei
genitori.
Morte Floyd, in migliaia in corteo dall'Australia al Giappone:
uniti per "Black Lives Matter". Pubblicato sabato, 06
giugno 2020 da La Repubblica.it. Manifestazioni a Tokyo: "Anche qui c'è il
razzismo". Gli attivisti della Corea del Sud bloccati dalle restrizioni per il
coronavirus e in Thailandia l'appuntamento è online, domenica su Zoom. In Nuova
Zelanda due ministri della coalizione di governo di Jacinda Ardern contro Trump:
"Razzista". Tensioni in Francia e a Londra. IL governo aveva provato a impedirle
per paura di un picco di contagi da coronavirus, ma le proteste in nome
di George Floyd e del movimento Black Lives Matter sono arrivate anche in
Australia dove sono stati in migliaia a sfilare pacificamente, per sostenere le
manifestatzioni negli Stati Uniti contro la brutalità della polizia. La stessa
cosa è accaduta in Giappone, mentre erano attese manifestazioni in Corea del Sud
e una, virtuale, in Thailandia.
Morte Floyd, la solidarietà del mondo: migliaia in corteo
dall'Australia al Giappone. A Sydney una decisione del tribunale dell'ultimo
minuto ha annullato il divieto di manifestazione mentre già diverse migliaia di
persone erano riunite. In mezzo alla polizia, schierata massicciamente, migliaia
di persone con cartelli e slogan: "Di chi è importante la vita? Le vite nere
contano". A Brisbane la polizia ha stimato una presenza di oltre 10 mila
persone, molti con le mascherine o avvolti in bandiere indigene, per chiedere
la fine del maltrattamento della polizia contro gli indigeni australiani. Raduni
si sono tenuti anche a Melbourne, Adelaide e in altre città australiane.
Francia, cortei a Parigi. A Metz ferito leggermente il
procuratore A Parigi, i manifestanti sono stati bloccati a poche decine di metri
dall'Ambasciata degli USA, a place de la Concorde, da uno schieramento massiccio
di polizia. Secondo i dati diffusi dal ministero dell'Interno alle
manifestazioni hanno partecipato 23.300 persone di cui 5.500 a Parigi
rispondendo all'appello della famiglia di Adama Traoré, l'uomo ucciso nel 2016
dopo essere stato fermato dai gendarmi in Val-d'Oise. A Metz, nell'est della
Francia, i manifestanti hanno tentato di sfondare il portone del palazzo di
giustizia e nei tafferugli è rimasto leggermente ferito anche il Procuratore
della Repubblica, Christian Mercuri.
Tensioni a Londra. Alta tensione tra polizia antisommossa e
manifestanti a Londra durante le manifestazioni "Black Lives Matter" per la
morte dell'afroamericano di Minneapolis, George Floyd dove gli agenti a cavallo
hanno caricato i dimostranti davanti all'abitazione del Primo ministro inglese.
Gli scontri, riportano vari media britannici, sono scoppiati dopo che molti
attivisti si erano radunati fuori da Downing Street, al culmine della
manifestazione nella Piazza del Parlamento e di una marcia nel centro di Londra.
"È ora di bruciare il razzismo istituzionale", è risuonato da un megafono tra la
folla davanti al palazzo del parlamento inglese.
Nuova Zelanda, due ministri contro Trump: è razzista. Due
importanti ministri in Nuova Zelanda, membri senior della coalizione di governo
di Jacinda Ardern hanno definito Donald Trump "razzista" per la sua risposta
tramite Twitter alle proteste per l'omicidio di George Floyd. James
Shaw e Marama Davidson, co-leader del Partito Verde, hanno espresso la propria
opionione sui commenti del presidente degli Stati Uniti mentre entravano al
Parlamento di Wellington. I loro commenti sono stati confermati dal segretario
stampa del Partito Verde.
Le proteste in Giappone. A Tokyo alcuni manifestanti hanno
denunciato il maltrattamento della polizia nei confronti di un uomo curdo
fermato mentre guidava e spinto a terra da dagli agenti. Gli organizzatori hanno
detto che stavano però anche protestando a sostegno del movimento Black Lives
Matter. "Voglio dimostrare che esiste il razzismo anche in Giappone adesso", ha
detto alla Reuters una studentessa di 17 anni, Wakaba, in corteo con la sua
amica Moe, entrambe in uniformi scolastiche e un cartello con scritto: "Se non
sei arrabbiato, non stai prestando attenzione". La folla scandiva lo slogan
"Niente giustizia, niente pace, niente polizia razzista".
La solidarietà della Corea del Sud. Gli attivisti sudcoreani
avevano pianificato un corteo che sarebbe dovuto partire dall'ambasciata
americana di Seul nella serata di sabato ma sono stati bloccati per le
disposizioni governative emanate in questa fase del coronavirus.A Washington
l'enorme scritta "Black Lives Matter" sulla strada che porta alla Casa Bianca in
riproduzione....
La Thailandia protesta online. Con le restrizioni a causa della
pandemia, a Bangkok gli attivisti hanno deciso di organizzare una manifestazione
virtuale. Chiedendo video e foto di persone vestite di nero, i pugni alzati e un
messaggio per spiegare perché "si uniscono a Black Lives Matter". L'appuntamento
è previsto su Zoom domenica, saranno osservati 8 minuti e 46 secondi di
silenzio, il tempo esatto in cui George Floyd è stato filmato mentre era
bloccato dal ginocchio dell'agente senza riuscire a respirare.
DAGONEWS l'8 giugno 2020. Le proteste del movimento Black Lives
Matter sono arrivate anche a Londra e come già accaduto negli Usa i manifestanti
con la scusa della morte di George Floyd ne hanno approfittato per fare casino.
Tra poliziotti feriti, scontri e arresti, le persone scese in piazza hanno
dimostrato anche di avere un problemino con la storia: hanno infatti imbrattato
una statua di Winston Churchill scrivendo “razzista”. A Bristol invece è stata
buttata già la statua di Edward Colston, trafficante di schiavi del 17esimo
secolo.
(ANSA il 7 giugno 2020) Durante le proteste di “Black Lives
Matter” a Londra è stato imbrattato il memoriale di Winston Churchill a
Westminster. Lo riporta l'Evening Standard. Nel pomeriggio, mentre migliaia di
persone sono tornate a protestare per le vie di Londra contro il razzismo ed in
memoria di George Floyd, vittima della brutalità di un poliziotto americano,
alcuni manifestanti hanno scarabocchiato "era un razzista" sulla statua di
Churchill, Primo Ministro britannico durante la seconda guerra mondiale. A nulla
sono valsi i tentativi di coloro che hanno cercato di proteggere la statua che
peraltro era stata già deturpata con graffiti verdi durante l'imponente
manifestazione contro il razzismo, svoltasi nel 76/mo anniversario del D-Day.
Sui social media è anche comparso un post intitolato "un assaggio del vero
Churchill" con un elenco di citazioni attaccate al memoriale.
Boris Johnson minaccia i «teppisti» tra i manifestanti. Robert
Krcmar per tio.ch l'8 giugno 2020. Il Governo Tory britannico punta il dito
contro alcune frange «minoritarie» delle decine di migliaia di manifestanti
scesi in piazza negli ultimi giorni a Londra e in altre città contro il razzismo
sulla scia di quanto accaduto negli Usa a George Floyd. In un tweet diffuso ieri
il premier britannico Boris Johnson ha difeso il diritto di protestare, ma non
di «attaccare la polizia» e di «infiltrare la protesta con il teppismo». Johnson
fa riferimento agli episodi violenti di attacchi alla polizia e contro statue di
personaggi storici. «È ovvio che piccoli gruppi hanno puntato deliberatamente
alla violenza, sullo sfondo di una folla largamente pacifica, e che la polizia
ha risposto in modo proporzionato», gli ha fatto eco oggi alla Bbc il
viceministro dell'Interno, Kit Malthouse, precisando che ieri sono stati
arrestati altri 12 dimostranti e sono rimasti contusi 8 agenti (31 in totale da
venerdì). Malthouse ha aggiunto che i video di chi ha lanciato Molotov o petardi
contro poliziotti a cavallo - in seguito ai quali diversi animali si sono
imbizzarriti e un'agente donna è finita in ospedale con lesioni serie - saranno
esaminati, e altri fermi potranno seguire. Mentre ha definito «illegali» pure
«gli atti di vandalismo» contro varie statue: da quella dedicata a Edward
Colston, riverito uomo d'affari dell'epoca imperiale, ma trafficante di schiavi,
buttata giù a Bristol; a quella di Winston Churchill, imbrattata da un gruppetto
a Londra con la scritta «è stato un razzista» di fronte al Parlamento di
Westminster. Il viceministro non ha comunque voluto ipotizzare divieti contro
nuovi cortei, pur denunciando i rischi per la salute pubblica che le evidenti
violazioni al distanziamento e alle restrizioni dell'emergenza coronavirus
stanno comportando.
Regno Unito: opposizione critica governo per le posizioni sulle
proteste antirazziste. (Agenzia Nova l'8 giugno 2020) - Politici e attivisti
britannici hanno criticato il governo per aver suggerito che il Regno Unito non
è un paese razzista. Lo riporta il quotidiano britannico "The Guardian". Il
governo è stato attaccato anche perché ha affermato che le proteste antirazziste
svoltesi durante il fine settimana sono semplicemente basate sulla frustrazione
causata dagli eventi avvenuti negli Stati Uniti. Il ministro "ombra" della
Giustizia David Lammy ha affermato che è "veramente da ignoranti" pensare che i
dimostranti abbiano deciso di protestare unicamente per la violenza della
polizia negli Stati Uniti e non per la discriminazione razziale presente nel
Regno Unito. L'ex ministro del Partito laburista Dawn Butler ha detto che dare
per scontato che le proteste riguardino unicamente gli eventi negli Stati Uniti
è un segno che il governo "ancora non ascolta e non dimostra di voler risolvere
i problemi di razzismo nel nostro paese". Decine di migliaia di persone hanno
protestato nel paese durante il fine settimana. Tuttavia il ministro della
Sanità, Matt Hancock, ha tentato di minimizzare il ruolo del Regno Unito nelle
proteste. "Ritengo, per fortuna, che tutto si basi sulla risposta agli eventi in
America piuttosto che qui, ma comunque dobbiamo continuare a lottare per la
tolleranza e per pari opportunità per tutti", ha detto Hancock. Il ministro ha
poi affermato che il Regno Unito non è razzista, ammettendo però che ci sono
"ingiustizie che devono essere affrontate". Il premier Boris Johnson ha invece
criticato i dimostranti in un tweet. Secondo il primo ministro, le proteste del
movimento Black Lives Matter sono state "rovinate dai delinquenti – e tradiscono
la stessa causa che affermano di servire".
Regno Unito, follia della sinistra: stila la lista delle
statue da abbattere. Roberto Vivaldelli il 10 giugno
2020 su Inside Over. Forse gli attivisti cosiddetti “antirazzisti” e liberal che
in queste ore stanno sfogando la propria frustrazione contro statue e monumenti
in tutto l’Occidente non conoscono il significato della locuzione
latina damnatio memoriae, ossia la “condanna della memoria”. Come riporta
l’Enciclopedia Treccani, parliamo della condanna, che si decretava in Roma
antica in casi gravissimi, per effetto della quale veniva cancellato ogni
ricordo (ritratti, iscrizioni) dei personaggi colpiti da un tale decreto.
In 1984 di George Orwell quando un sovversivo viene fatto sparire dal partito,
si applica la damnatio memoriae: viene cioè eliminato, da tutti i libri, i
giornali, i film e così via, tutto ciò che si riferisca direttamente o
indirettamente alla persona in oggetto. Citiamo un passaggio chiave del
capolavoro di Orwell: “Ogni disco è stato distrutto o falsificato, ogni libro è
stato riscritto, ogni immagine è stata ridipinta, ogni statua e ogni edificio è
stato rinominato, ogni data è stata modificata. E il processo continua giorno
per giorno e minuto per minuto. La storia si è fermata. Nulla esiste tranne il
presente senza fine in cui il Partito ha sempre ragione “. La follia nichilista
e politicamente corretta degli attivisti di Black Lives Matter, così come di
altre organizzazioni della galassia left-wing (anarchici, centri sociali,
Antifa) applica degli standard morali contemporanei, progressisti, fortemente
ideologici – e dunque di parte – a personaggi storici del passato: una furia
iconoclasta che spinge questi ultimi a scagliarsi con violenza e intolleranza
contro i simboli del passato. Ma la cosa grave è tali estinti non vengono
condannati dalla politica ma, anzi, tollerati, in modo particolare dai sindaci
più progressisti delle grandi metropoli, se non addirittura incoraggiati. Come
riporta l’agenzia di stampa Agi, gli attivisti antirazzisti sono determinati a
rimuovere dallo spazio pubblico i simboli del passato coloniale del Regno Unito.
E nelle scorse ore, in concomitanza con il funerale di George Floyd, in Gran
Bretagna migliaia di attivisti hanno manifestato a Oxford contro una statua di
Cecil Rhodes, magnate minerario e politico colonizzatore, attivo soprattutto in
Sudafrica nel XIX secolo.
L’elenco delle statue da abbattere. Non troppo diversamente dai
miliziani dallo Stato Islamico, gli attivisti della sinistra radicale sono
arrivati a compilare un elenco di 60 statue che vogliono abbattere perché
“celebrano schiavitù e razzismo”. La mappa interattiva, Topple the racists,
ricorda l’Agi, è stata istituita dalla Stop Trump Coalition ed elenca placche e
monumenti in oltre 30 città del Regno Unito: nella lista, la statua di Robert
Milligan, il fondatore del mercato degli schiavi, West India Docks, al Museum of
London; quella a Edimburgo dell’ex segretario Henry Dundas, che ritardò
l’abolizione della schiavitù; quella di Sir Francis Drake sul Plymouth Hoe. Nel
frattempo, il consiglio comunale di Manchester ha annunciato la “revisione” di
tutte le statue della città. A Plymouth, le autorità hanno deciso di
ribattezzare una piazza intitolata al mercante di schiavi Sir John Hawkins,
anche se hanno fatto sapere che non intendono rimuovere la statua di Sir Francis
Drake. Come se non bastasse, il Museum of London, ha deciso di rimuovere la
gigantesca figura bronzea di un proprietario di piantagioni e schiavi, Robert
Milligan. E l’immancabile sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha annunciato che una
nuova commissione rivedrà le statue, i monumenti e i nomi delle strade per
assicurarsi che “riflettono la diversità della città”.
Il sindaco di Londra appoggia la furia dei manifestanti. Ciò che
è davvero scioccante e grave, nota lo Spectator, è che invece di condannare
questi atti criminali, il sindaco di Londra li ha istituzionalizzati. La
commissione annunciata da Khan lascia infatti spazio a parecchi quesiti.
Innanzitutto, davvero una commissione – non eletta da nessuno – può avere la
facoltà di decidere cosa cancellare e cosa no? E quali sono le possibilità ,
riflette lo Spectator, che tale Commissione rappresenti democraticamente una
realtà sufficientemente ampia di opinioni? “Nel corso della storia britannica –
sottolinea lo Spectator – Londra non ha avuto la diversità culturale che ha
oggi, ed è profondamente sbagliato scrivere la storia delle persone che ci hanno
preceduto, indipendentemente dal fatto che attualmente troviamo aspetti di quel
passato moralmente discutibili. È una semplice cancellazione culturale.
Attraverso l’occupazione romana, il periodo anglosassone, l’epoca vittoriana,
fino ad oggi, queste cose hanno lasciato un segno indelebile e prezioso nel
nostro paesaggio e nella nostra storia. Il sindaco di Londra non dovrebbe dare
credito all’impulso autoritario di privarci della prospettiva storica nello
spazio pubblico”. Eppure, è esattamente quello che sta facendo Khan, nonostante
soltanto una netta minoranza dei londinesi abbia supportato, per esempio, la
rimozione della statua di Colston, perlomeno con questi metodi. Ma questo agli
attivisti e alla sinistra liberal sembra importare gran poco.
(ANSA l'11
giugno 2020) - Una statua di Cristoforo Colombo è stata demolita e gettata in un
lago a Richmond, in Virginia, la scorsa notte nel corso di una manifestazione di
protesta per la morte di George Floyd. lo riporta il Mail online. La scultura è
stata demolita meno di due ore dopo che i manifestanti si erano radunati nel
Byrd Park della città chiedendo a gran voce la sua rimozione come simbolo di
oppressione razziale. Dopo aver legato il monumento con alcune corde, i
manifestanti lo hanno buttato giù, lo hanno dato alle fiamme e lo hanno fatto
rotolare in un lago nel parco tra gli applausi della folla. Il piedistallo vuoto
è stato dipinto a spruzzo e coperto da un cartello che dice "Colombo rappresenta
il genocidio". Una statua di Cristoforo Colombo è stata decapitata a Boston nel
corso della notte e verrà rimossa dalla sua attuale collocazione nel North End,
il quartiere italo-americano della città del Massachusetts. Il sindaco Marty
Walsh ha annunciato che il monumento sarà messo in magazzino mentre verranno
avviate "conversazioni" sul "significato storico" dell'incidente e se la statua
dell'esploratore italiano sarà mai riportata al suo posto. La statua è la
seconda di Colombo vandalizzata in questi giorni. A Richmond in Virginia una
statua del genovese è stata abbattuta e gettata in un lago nel corso di una
manifestazione di protesta per la morte dell'afro-americano George Floyd per
mano della polizia. Dopo aver legato il monumento con alcune corde, i
manifestanti lo hanno portato a terra e dato alle fiamme mentre il piedistallo
vuoto veniva dipinto a spruzzo e coperto da un cartello su cui e' scritto
"Colombo rappresenta il genocidio". La statua di Boston è stata oggetto in
passato di atti di vandalismo: fu decapitata anche nel 2006 mentre quattro anni
fa venne imbrattata di vernice rossa con le parole "Black Lives Matter"
spruzzate sulla base.
Ugo Barbara
per agi.it l'11 giugno 2020. L'ultima a cadere è stata quella di Cristoforo
Colombo a Minneapolis. Ma prima di lui è toccato a Edward Colston e, in misura
minore anche se non meno impressionante, a Winston Churchill. La protesta
antirazzista che divampa un po' dappertutto nel mondo diventa iconoclasta e le
prima a farne le spese sono le statue di personaggi fino a ieri considerati -
quantomeno - fari di civiltà, quando non di libertà e democrazia. Sui social
media sono rimbalzate le foto della statua di Colombo abbattuta davanti al
campidoglio di Minneapolis. dopo che nella notte precedente ignoti vandali
avevano decapitato una statua dell'esploratore italiano a Boston, in
Massachusetts. La polizia, che ha aperto una indagine, ha trovato a terra la
testa decapitata e "vari pezzi". Nelle proteste seguite alla morte di George
Floyd, l'afroamericano 46enne soffocato durante l'arresto a fine mese a
Minneapolis, ci sono stati vari tentativi di rimuovere o abbattere statue o
monumenti considerati simboli della schiavitù o dei regimi coloniali, non solo
in Usa ma anche in Gran Bretagna. Martedì notte, un'altra statua di Colombo
era stata divelta e gettata in un lago a Richmond, in Virginia: i manifestanti
hanno utilizzato varie funi per rimuovere la statua, con una scritta che
recitava "Colombo rappresenta il genocidio" piantata sul basamento che sosteneva
la statua. A Oxford migliaia di manifestanti si sono accaniti contro una statua
di Cecil Rhodes, magnate minerario e politico colonizzatore, attivo soprattutto
in Sudafrica nel XIX secolo.
La lista degli
obiettivi. Nel Regno Unito la furia antirazzista se l'è presa con il mercante di
schiavi e filantropo Edward Colston, ma anche con Churchill. E in un Paese che
fino a ieri è stato un impero, molti sono gli obiettivi possibili sparsi in
parchi e giardini. Del resto sono stati gli stessi sostenitori di
Black Lives Matter a compilare un elenco di 60 statue che vogliono abbattere
perché "celebrano schiavitù e razzismo". La mappa interattiva,
'Topple the racists', è stata realizzata dalla Stop Trump Coalition ed elenca
placche e monumenti in oltre 30 città del Regno Unito: nella lista, la statua
di Robert Milligan, il fondatore del mercato degli schiavi, West India Docks,
al Museum of London; quella a Edimburgo dell'ex segretario Henry Dundas, che
ritardò l'abolizione della schiavitù; quella di Sir Francis Drake sul Plymouth
Hoe. Da parte sua il consiglio comunale di Manchester ha decviso di anticipare i
vandali e ha annunciato la 'revisione' di tutte le statue della città.
A Plymouth, le autorità hanno deciso di ribattezzare una piazza intitolata al
mercante di schiavi Sir John Hawkins, anche se hanno fatto sapere che non
intendono rimuovere la statua di Sir Francis Drake. Tra le crescenti proteste,
il Museum of London, ha deciso di rimuovere la gigantesca figura bronzea di un
proprietario di piantagioni e schiavi, Robert Milligan.
Come è
iniziato l'incendio. A innescare l'incendio in Gran Bretagna era stato, domenica
7 giugno, l'abbattimento della statua di Colston eretta a Bristol nel 1895, poi
trascinata per le strade e gettata nel fiume Avon, seguito dallo sfregio, nello
stesso giorno, a Londra, della statua di Winston Churchill, il primo ministro
conservatore britannico, eroe della Seconda Guerra Mondiale. "Era un razzista",
la scritta comparsa sulla base della statua, dinanzi al Parlamento di Londra.
Colston era stato un benefattore della città: con i soldi ricavati dal denaro
del commercio e dello sfruttamento degli schiavi aveva finanziato opere
filantropiche in case di cura, scuole, chiese; ma a causa della sua attività di
negriero, la statua era già stata contestata in passato e anche oggetto di una
petizione cittadina perché venisse fatta sparire. Una volta abbattuta, un
manifestante si è scattato una foto in ginocchio sulla figura bronzea, mimando
il gesto del poliziotto bianco che ha soffocato George Floyd, a Minneapolis.
Sempre a Londra un manifestante è salito sul piedistallo di The Cenotaph, il
monumento ai caduti di guerra a Whitehall, è ha appiccato il fuoco alla bandiera
con la Union Jack. E così il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha annunciato che
una nuova commissione rivedrà le statue, i monumenti e i nomi delle strade per
assicurarsi che "riflettono la diversità della città".
Da "it.sputniknews.com" il 15 giugno 2020. I manifestanti di Black Lives Matter
hanno scritto "razzista" sulla statua di Churchill a Londra, accusando il primo
ministro di essere un suprematista bianco. Una campagna sta prendendo slancio
nel Regno Unito per rimuovere altre statue legate al razzismo e alla schiavitù,
ma il governo le difende come strumento necessario per educare le persone sugli
errori del passato piuttosto che pensare alla loro demolizione. Gli utenti dei
social network nel Regno Unito e in molti altri Paesi hanno notato che la foto
non viene più visualizzata nell'elenco nella parte superiore della pagina quando
si cercano i primi ministri o leader della Seconda Guerra Mondiale. Invece è
stato sostituito con un immagine predefinita senza volto. Le immagini dei leader
nazisti e fascisti, Adolf Hitler e Benito Mussolini, sono rimaste intatte,
secondo gli screenshot dei risultati della ricerca. Gli utenti ora non possono
caricare direttamente le immagini nei risultati di ricerca e potrebbero esserci
due motivi per cui l'immagine di Churchill è scomparsa: o è stata Google a
rimuoverla o è stata rivista a seguito di un gran numero di richieste per la
rimozione.
Il dibattito sulle figure storiche "razziste". La figura di Churchill è
diventata oggetto di un acceso dibattito nel Regno Unito la scorsa settimana
alla luce delle diffuse proteste contro il razzismo, innescate dall'uccisione di
George Floyd negli Stati Uniti. I manifestanti chiedono la rimozione di statue
di figure legate alla schiavitù e al razzismo, richiesta sostenuta da alcuni
legislatori. L'attivista di Black Lives Matter Imarn Ayton ha suggerito che tali
statue sono "estremamente offensive" e dovrebbero essere trasferite nei musei.
"Penso che sia una vittoria per tutti, quindi non offendiamo più la nazione nera
e possiamo anche mantenere la nostra storia", ha detto alla BBC sabato. La
statua del commerciante e schiavo Edward Colston a Bristol è stata distrutta dai
manifestanti la scorsa settimana, e una statua del XVIII secolo di un uomo nero
in ginocchio (che in realtà raffigura un moro, non uno schiavo) è stata rimossa
dal terreno di un National Trust casa signorile di proprietà ad Altrincham,
Greater Manchester. Alcune altre statue sono state rimosse in tutto il paese,
tra cui uno di Robert Baden-Powell, il fondatore del movimento scout, nella
Grande Manchester, e due monumenti di Thomas Guy e Sir Robert Clayton a Londra.
Winston Churchill, considerato uno dei più grandi inglesi di tutti i tempi, ha
una storia di dichiarazioni controverse sulla razza. Una volta ha affermato che
gli indiani sono "le persone più bestiali del mondo accanto ai tedeschi" e ha
detto che "non pensava davvero che i neri fossero capaci o efficienti quanto i
bianchi".
Chi è Patrick Hutchinson, il manifestante antirazzista che ha
salvato l’estremista di destra.
Redazione de
il Riformista il
15 Giugno 2020. E’ diventata subito un simbolo la foto che ritrae un
manifestante del movimento Black Lives Matter portare in spalla un estremista di
destra ferito. L’episodio che ha visto protagonista Patrick Hutchinson è
accaduto a Londra dove il personal trainer di origini africane ha portato in
spalla un uomo ferito che, secondo quanto riporta la stampa britannica, sarebbe
un militante dell’estrema destra. Le proteste infatti non si arrestano non
soltanto negli Stati Uniti ma anche nel Regno Unito. Tra scontri, sangue e
statue imbrattante il clima in questi ultimi giorni si fa sempre più
incandescente e polemico. L’immagine ha subito fatto il giro del web gettando
luce sull’umanità delle manifestazioni dilagate dalla morte
dell’afroamericano George Floyd per contestare le discriminazioni razziali. Come
ha raccontato lo stesso Hutchinson alla CNN, il motivo principale per cui i
manifestanti a Londra e in tutto il mondo sono scesi in strada è per chiedere la
riforma della polizia dopo che non solo George Floyd ma molti altri neri hanno
perso la vita per mano delle forze dell’ordine. Dunque l’aria di violenza che si
respira in queste settimane non fa altro che alimentare un clima di odio che, al
contrario, si vuole stemperare: “Il mio vero obiettivo era quello di evitare una
catastrofe, all’improvviso la narrazione cambia da Black Lives
Matters a Youngsters Kill Protesters“.
IL CASO – Tra tutte le immagini che ritraggono scene di violenza e numerosi
feriti, lo scatto inedito di Hutchinson ha fatto subito il giro del mondo
rappresentando un simbolo di solidarietà. L’atto disinteressato compiuto da
Patrick è diventato in realtà l’emblema di un ritorno all’essenza delle proteste
e della lotta contro ogni forma di odio e discriminazione. Come ha spiegato lui
stesso, il gesto spontaneo è avvenuto per “evitare una catastrofe”. Infatti
l’uomo ha dichiarato che è stata la prima protesta di Black Lives Matter a cui
ha partecipato e ha aiutato l’estremista di destra ferito perché non voleva che
il motivo principale per cui le proteste fossero perse in un momento di
violenza. Dopo aver formato un cordone protettivo accanto all’uomo in difficoltà
insieme ad un amico, Hutchinson lo ha caricato sulle sue spalle e lo ha
consegnato nelle mani della polizia. Infatti Hutchinson ha raccontato che
inizialmente aveva visto l’uomo disteso sulle scale in posizione fetale
circondato da manifestanti. In quel momento, non ha pensato se fosse o meno
dall’altro lato della barricata e ha pensato solo a salvarlo. Hutchinson ha
voluto raccontare l’episodio per far capire alle persone che “siamo tutti una
razza”. “Voglio vedere l’uguaglianza per tutti. Sono un padre, un nonno e mi
piacerebbe vedere che i miei figli piccoli, i miei nipoti abbiano un mondo
migliore di quello in cui ho vissuto”, ha detto il personal trainer. “Il mondo
in cui vivo è stato migliore dei miei nonni e dei miei genitori e speriamo di
poter continuare fino a quando non avremo l’uguaglianza totale per tutti”.
GLI SCONTRI – Continuano i momenti di tensione a Londra dove i nazionalisti
britannici si sono riuniti nella piazza del Parlamento in risposta alle
manifestazioni del movimento antirazzista Black Lives Matter che è invece andata
in scena, in modo pacifico, tra Hyde Park e Trafalgar Square. Scontri la polizia
tra gli estremisti di destra scesi in piazza per “difendere i monumenti storici”
alcuni dei quali, nell’ultima settimana, sono stati presi di mira e vandalizzati
dai manifestanti antirazzisti per via del loro legame con la storia coloniale
del Paese. Più di cento persone sono state arrestate nelle proteste.
Antonello Guerrera per repubblica.it il 15 giugno 2020. È l’immagine che
potrebbe riconciliare Londra e il Regno Unito spaccati dalle proteste e dalle
polemiche degli ultimi giorni, travolgenti anche qui dopo l’uccisione di George
Floyd in America. È un’immagine di pietas, di compassione, che da ieri sera sta
facendo il giro del Paese e della Rete. È un’immagine che infonde speranza e
fiducia nonostante le lacerazioni razziali e le ferite sociali di questi ultimi
giorni, riapertesi oltremanica dopo le manifestazioni antirazziste di Black
Lives Matter due weekend fa, gli scontri che ne sono scaturiti, lo sfregio alla
statua di Churchill, vergata da un giovane manifestante nero con “era un
razzista” fino alla contromanifestazione di hooligan ed estrema destra di ieri:
scontri con la polizia, giornalisti picchiati (tra cui l’italiano Corrado
Amitrano) e l’oltraggio della targa a Keith Palmer, il poliziotto inglese ucciso
dall’Isis nel 2017 a Westminster, che un dimostrante (poi arrestato) ha
scambiato per orinatoio. Ora però, l’immagine che potrebbe cambiare molte cose.
Un uomo nero, muscoloso, con jeans e maglietta, che si carica sulle spalle un
manifestante opposto e contrario, bianco, di destra. Non per scontrarsi
fisicamente con lui, visto che intorno, all’esterno della stazione londinese di
Waterloo, infuria la battaglia tra gli attivisti di Blm e hooligan e destra
radicale. Anzi: lo porta in braccio proprio per salvarlo dalla violenza, dato
che è ferito. Dell’uomo bianco soccorso ancora non si conosce il nome. Di chi lo
ha aiutato sì: si chiama Patrick Hutchinson, londinese, padre di due figli ed
esperto di arti marziali. Questa sua passione e il fisico roccioso lo hanno
facilitato nell’impresa. “Ma non sono un eroe, mi hanno aiutato anche altre
persone”, ha raccontato alla tv britannica Channel 4. “Stavano pestando
quell'uomo. Era in pericolo di vita. Così ho deciso di agire”. “È stato un
attimo, non ti rendi davvero conto di quanto sia pericoloso”, continua
Hutchinson. “Ho visto una persona in grossa difficoltà allora mi sono buttato a
terra anch’io e, sotto calci e pugni, ho provato a tirarla fuori da lì,
proteggendola con il mio corpo. Ho ricevuto moltissimi colpi anch’io ma per
fortuna altri mi hanno fatto scudo. Non sono un eroe. È stato un lavoro di
squadra”. Hutchinson fa un parallelo toccante: “Se allo stesso modo i tre
poliziotti che erano inerti intorno a George Floyd in America avessero agito,
mentre stava per essere ucciso, sarebbe ancora vivo. Invece non lo hanno fatto”.
Il gesto eroico di Hutchinson dovrebbe essere la normalità: la fratellanza e la
solidarietà tra esseri umani. Invece ce ne stupiamo, segno di tempi non
confortanti. Eppure la sua generosità è anche il segno che si può restare umani,
persino nella violenza. E che un mondo migliore è sempre possibile.
Fr. Pier. per “il Messaggero” il 15 giugno 2020. No a una «odiosa, falsa
riscrittura del passato: la Repubblica non cancellerà alcuna traccia o nome
dalla sua storia. Non dimenticherà nessuna delle sue opere. Non ribalterà alcuna
statua», ha detto il presidente francese Emmanuel Macron in un discorso
televisivo intervenendo a proposito delle proteste per il caso di George Floyd
in America. La Francia deve guardare «lucidamente, insieme, tutta la nostra
storia, tutta la nostra memoria», per costruire «un possibile presente e futuro
su entrambe le sponde del Mediterraneo». Un processo che richiede «la volontà di
stabilire la verità, ma in nessun caso rivisitando o negando ciò che siamo».
Sulle polemiche riguardo il razzismo nella polizia, Macron ha detto: «Saremo
inflessibili di fronte al razzismo e all'antisemitismo». Macron ha inoltre
annunciato ai francesi che anche Parigi, da domani, può «voltare la pagina del
primo atto della crisi» provocata dall'epidemia di coronavirus. «Tutto il
territorio, ad eccezione di Mayotte e della Guyana, diventa zona verde. Questo
significa una ripresa forte del lavoro e la riapertura di ristoranti e bar». È
dunque arrivato dall'Eliseo l'annuncio che i francesi aspettavano con più ansia
dal 17 marzo, quando fu decretato il lockdown. Un risultato raggiunto con lo
sforzo di tutti, e di cui «andare fieri», dice il presidente: «L'estate 2020 non
sarà un'estate come le altre e bisognerà seguire l'evoluzione dell'epidemia per
prepararci. La lotta non è ancora finita. Ma sono felice con voi di questa prima
vittoria contro il virus». Riaprono tutti i ristoranti e i bar a Parigi,
riaprono completamente asili, scuole elementari e medie, che dal 22 luglio
ritroveranno ritmi e obblighi dei tempi della normalità. Nel momento della
riapertura totale, Macron ha fatto anche il bilancio di quanto avvenuto:
rivendicando «la scelta di mettere la salute davanti all'economia», ammettendo
«errori» ma rivendicando i successi. Il presidente ha «escluso» «qualsiasi
aumento di imposta per finanziare spese legate al coronavirus», ed ha assicurato
che farà «di tutto per evitare ogni licenziamento». Il capo dello stato ha
quindi sottolineato che la ripresa economica passerà dall'Europa che in questo
caso «è stata all'altezza della situazione» nonostante «un inizio difficile»
Infine, un accenno all'attualità, alle proteste che imperversano anche in
Francia sulle violenze della polizia: «La Repubblica non smonterà nessuna statua
- ha detto il presidente - non cancellerà alcuna traccia né alcun nome della
propria storia», aggiungendo poi che la Francia saprà essere «inflessibile di
fronte al razzismo e all'antisemitismo».
La questione
Leopoldo. In Belgio si dibatte sulla figura dell'ex re, Leopoldo II, controversa
per il passato coloniale. Una statua a lui dedicata è stata rimossa da una
piazza di Anversa e sarà conservata nei depositi di un museo locale. Una
petizione lanciata da un 14enne belga per chiedere la rimozione da Bruxelles, ma
non solo, di tutte le statue del monarca, ispiratore del sanguinoso regime
coloniale in Congo, è stata sottoscritta in pochi giorni da più di 44 mila
persone ed è stata accolta anche dai partiti di maggioranza in Parlamento. Al
governo hanno chiesto di istituire un gruppo di lavoro per "decolonizzare" gli
spazi pubblici della regione: rivedere ed eliminare i nomi di strade e
piazze che contengono riferimenti alla storia coloniale del Paese, in
particolare al re Leopoldo II (1835-1909). Secondo lo
storico Adam Hochschild, Leopoldo II fu responsabile di una strage, la morte tra
i 10 e i 15 milioni di persone: iniziò la sua spedizione in Congo nell'1879 e
nel 1885 lo Stato fu riconosciuto come territorio appartenente al monarca
durante la Conferenza di Berlino, in cui fu anche risolta la divisione
dell'Africa tra le potenze coloniali europee. Grazie alla colonizzazione di
questo territorio africano, Leopoldo II trasformò il Belgio in una potenza
imperialista e sfruttò le risorse offerte dal Paese, ricco ad esempio di gomma,
materiale-chiave dopo l'invenzione di pneumatici moderni in un ambiente
di estrema violenza dove le punizioni come l'amputazione delle mani erano
comuni. La disumanizzazione degli indigeni fu tale che all'Esposizione
Universale tenutasi a Bruxelles nel 1958, fu organizzato uno "zoo umano" di
uomini, donne e bambini congolesi per il divertimento dei visitatori.
I Sentinelli
contro Montanelli. In Italia si è fatto sentire il movimento dei Sentinelli di
Milano, gruppo che si batte contro le discriminazioni razziste e omofobiche, che
ha inviato un appello al sindaco Giuseppe Sala e al Consiglio comunale
perché sia valutata la rimozione della statua di Indro Montanelli posta nei
Giardini a lui intitolati. Montanelli - affermano i Sentinelli, fino alla fine
dei suoi giorni ha rivendicato con orgoglio il fatto di aver comprato e sposato
una bambina eritrea di dodici anni perché gli facesse da schiava sessuale,
durante l'aggressione del regime fascista all'Etiopia.
Simone Sabbatini per "corrriere.it" il 5 luglio 2020. L’analogia
è già stata segnalata ovunque, in altre occasioni, ma questa volta l’immagine
sembra davvero la stessa: cambiano solo lo sfondo e la forma della statua. Anche
le persone, poche e festanti, sono in numero simile. Il Saddam Hussein di 17
anni fa a Bagdad, il Cristoforo Colombo di oggi a Baltimora. L’abbattimento del
simulacro del navigatore italiano, questa volta poi buttato nel porto della
città del Maryland, è solo l’ultimo di una serie: nelle scorse settimane ne sono
avvenuti a Minneapolis e Richmond, in Virginia, mentre altrove, come a Boston,
le sculture sono state decapitate o vandalizzate. La foto e i video di Baltimora
arrivano all’indomani della contestata celebrazione orchestrata da Donald Trump
al Mount Rushmore, e nel Giorno dell’Indipendenza più complicato della storia
americana recente. Com’è noto, Colombo è finito nel calderone dei personaggi di
cui si chiede la rimozione, non solo fisica, dalla memoria collettiva americana,
in ragione delle violenze perpetrate ai danni delle popolazioni indigene (un
genocidio, secondo alcuni storici) incontrate durante le esplorazioni negli
ultimi anni del 1400, in particolare quella dei Taìno a Hispaniola, l’isola dove
oggi ci sono Haiti e la Repubblica Dominicana. Ma a ennesima testimonianza di
come i cambiamenti di scenario storico ribaltino il significato di alcune figure
anche di 180 gradi, a fine Ottocento il mito di Colombo era celebrato come
elemento identitario di chi all’epoca si sentiva oggetto — come oggi, e da
decenni, la popolazione afroamericana — di discriminazioni razziste: gli
immigrati italiani. Quarant’anni dopo, l’esploratore diventò l’oggetto di una
festa nazionale, il Columbus Day, che negli anni Trenta divenne anche
un’occasione per celebrare l’orgoglio italiano incarnato in quel momento, per
molti italo-americani, da Benito Mussolini, un dittatore come lo era Saddam.
Altro giro della Storia. Da giorni il fenomeno di assalto alle statue contestate
perché razziste si è allargato ad altri Paesi, come la Francia e la Gran
Bretagna (qui lo speciale del Corriere), allungandosi blandamente persino in
Italia (il caso Montanelli, a Milano). Ma è in America – dove il presidente ha
scelto proprio in occasione del 4 luglio di contro-combattere la battaglia della
Storia, invece che minimizzarla o ignorarla – che viene da chiedersi fino a dove
si spingerà e quanto segnerà il futuro prossimo del Paese, in primis quello
elettorale. La distruzione delle statue e la paura di un attacco ai simboli
della Nazione (o solo della sua parte bianca, secondo chi protesta) compatta
molti conservatori e spaventa alcuni moderati. Può essere un elemento di
riscossa trumpiana, come i suoi strateghi sembrano credere? Metterà in
difficoltà Joe Biden, una volta che la campagna entrerà nel vivo, come successe
a Obama con le parole del suo pastore e amico Jeremiah Wright nel marzo nel
2008 («Dio maledica l’America che uccide persone innocenti»)? E l’attacco a
Colombo avrà qualche presa sugli italo-americani? La distruzione nelle strade
scaturite dalle rivolte in seguito all’uccisione di George Floyd approderà anche
a una parte costruttiva di recupero di una cultura, quella nera (o nativa o
latina o asiatica), ampiamente rimossa o tenuta nascosta. Accanto alle vecchie
statue, o a quelle che rimarranno in piedi, ne sorgeranno di nuove? Nel
frattempo le parole e le immagini prendono peso man mano che si fissano nella
memoria, in questo caso quella recentissima, come le pietre acquistano forza
d’urto mentre rotolano. E l’immagine di Colombo trattato come Saddam incarna
(anche) i rischi dei paragoni storici che scattano in automatico, appiattendo
sulla superficie fotografica di uno schermo distanze lunghe secoli: con effetti
imprevedibili. È difficile figurarsi cosa possa pensarne un 19enne neo-maturato,
che ha studiato qualche anno fa l’uno (Colombo) e, forse, qualche settimana fa
l’altro (Saddam). Bisognerebbe chiederglielo. Cosa vince, tra una faticosa
prospettiva e una sovrapposizione fulminante?
Usa, statue
di Colombo abbattute e vandalizzate.
Pubblicato
mercoledì, 10 giugno 2020 da La Repubblica.it. Incendiata, imbrattata, divelta,
decapitata: la furia iconoclasta, scatenata in America e nel resto del mondo
dopo la morte di George Floyd, si è abbattuta sulla statua di Cristoforo
Colombo. Dopo aver preso di mira gli storici generali della Confederazione,
simboli del potere schiavista del Sud, i dimostranti degli Stati Uniti se la
sono presa con il navigatore genovese considerato un colonizzatore e uno
sterminatore di nativi americani e dunque indegno di troneggiare in un parco.
Mercoledì notte, a Richmond in Virginia, la figura alta due metri e mezzo di
Colombo è stata abbattuta dal suo piedistallo in un parco cittadino, bruciata e
trascinata con delle corde al vicino laghetto di Byrd Park dove è stata gettata.
Sul piedistallo sono stati dipinti graffiti e le scritte "questa terra è dei
Powhatan", il nome della popolazione nativa che abitava la Virginia, e "Colombo
rappresenta il genocidio". L'azione è avvenuta dopo una nuova manifestazione di
protesta contro il monumento di Robert Lee, il capo dell'esercito sudista
durante la guerra di secessione, che è stato sconfessato anche da un suo
discendente diventato pastore, Robert Lee, che ha spiegato come quel monumento
impedisca un cambio di mentalità nel Paese. Anche Colombo è accusato di frenare
il cambiamento. La sua figura storica è da tempo molto controversa negli Stati
Uniti perché con la sua "scoperta" ha avviato l'esplorazione e la colonizzazione
delle Americhe da parte degli europei con il conseguente sterminio di chi ci
abitava. "Questo continente è costruito sul sangue e le ossa dei nostri antenati
- ha detto Vanessa Bolin, membro della Richmond Indigenous Society, durante la
manifestazione di ieri - ma anche con il sudore, le lacrime, il sangue e le ossa
degli africani. Noi non siamo qui per dirottare il vostro movimento - ha
aggiunto rivolgendosi agli afroamericani, siamo qui per essere solidali". Non è
la prima volta che una statua del navigatore italiano è oggetto di vandalismi
negli Stati Uniti: nel 2019 è stata gettata vernice rossa sulle statue di
Colombo a San Francisco e Providence, in Rhode Island. E molti Stati negli
ultimi anni hanno scelto di trasformare la festa nazionale, il famoso Columbus
Day, in cui il 12 ottobre si ricorda l'arrivo nelle Americhe del navigatore
italiano, nell'Indigenous Peoples Day, il giorno delle popolazioni indigene
d'America. Anche a Boston l'ira popolare si è scagliata su una statua di Colombo
che adesso troneggia nel parco a lui dedicato senza la testa che è stata
decapitata nella notte.
Alice Mattei
per it.businessinsider.com il 10 giugno 2020. Tempi duri per i cinefili di tutto
il mondo che, pur non essendo per niente razzisti, hanno amato e amano uno dei
film più importanti e popolari (e belli, ci sentiamo di aggiungere) della storia
del Cinema: Via col Vento di Victor Flaming. Il film, ambientato negli stati
schiavisti del sud (per i quali smaccatamente parteggia) durante la guerra di
secessione è accusato (da tempo, in realtà, ma soprattutto negli ultimi giorni
di proteste) di essere razzista, filo schiavista e di promuovere stereotipi
orrendi sui neri d’America dipinti come spesso pigri, stupidi e fondamentalmente
a loro agio nella loro condizione di schiavi. Per questo, il canale via cavo
HBO, in questi giorni di polemiche e scontri, ha cancellato il film dai suoi
cataloghi on line. La rimozione del film, hanno fatto sapere da HBO, non è
definitiva, ma se e quando la pellicola tornerà disponibile dovrà essere
preceduta da una “discussione sul suo contesto storico e una denuncia di quelle
stesse rappresentazioni dei neri e della schiavitù”.
Enzo Verrengia per la Verità l'11 giugno 2020. Chi l'ha detto che
«coniglio» è sinonimo di vigliaccheria? Bugs Bunny lo smentisce a 80 anni
suonati. Li compirà il 27 luglio prossimo, nella ricorrenza della sua prima
uscita da protagonista del cortometraggio a cartoni animati Caccia al coniglio,
di Tex Avery. Ma stava già sulla piazza dal 30 aprile 1938, quando lo si vide
sgattaiolare in Un coniglio imprendibile, codiretto da Cal Dalton e Ben
Hardaway. Più che le date, comunque, per Bugs Bunny contano la definizione della
sua personalità e la svolta che diede agli animali antropomorfi così come li
aveva imposti nell'immaginario di tutti Walt Disney. Quest' ultimo costruì una
tipologia di moralità parlanti, più umane degli umani in carne e ossa. Pochi si
accorgono che Paperino è un'anatra, Pippo un cane, Orazio un cavallo, eccetera.
Bugs Bunny, invece, viola ogni norma edificante, anche a spese della sua stessa
specie. Del coniglio serba la velocità che lo rende imprendibile. Il resto è
riscrittura completa del modello zoologico originale. Bugs Bunny scatena la sua
verve a danno di quanti, fuori dai cartoons, sarebbero i suoi persecutori e
impallinatori. Li rappresenta Taddeo, il cacciatore, che il coniglio irride
sbucando dalla tana con la fatidica frase: «Che succede, amico?», in originale:
«Ehm What' s up, doc?». A partire da qui, Bunny imperversa con trovate
ultraviolente dalla comicità garantita. Si veda la parodia dell'Anello dei
Nibelunghi, di Richard Wagner, annoverato quale opera «di importanza culturale»
dalla Biblioteca del Congresso. «Bugs» in americano gergale sta per «folle»,
«testa matta», «picchiatello». E Bunny può sembrarlo all'apparenza delle sue
prodezze, che oltrepassano ogni limite di plausibilità. Be', certo: questa è la
dimensione parallela dei cartoni animati, dove si precipita da uno strapiombo e
non ci si sfracella, al massimo ci si appiattisce al suolo assumendo la forma di
una pizza, oppure si salta su una bomba e si resta solamente anneriti. La morte
non è contemplata. Quella di Bunny è l'irruzione della volontà di annichilire il
bigottismo che dagli Stati Uniti si spalma su tutto l'Occidente, da prima della
vittoria nella Seconda guerra mondiale. Con lui cessa l'intento didascalico che
risale alla Batracomiomachia, la battaglia delle rane e dei topi, attribuita a
Omero. Bugs Bunny vuole scombinare le cose e imporre un disordine creativo. È il
campione del politicamente scorretto. Altro che coniglietto decorativo, da
compagnia, cui ci si affeziona al punto di non avere più il cuore di cuocerlo
alla cacciatora. Non a caso, l'apice del successo lo ebbe proprio quando gli
americani entrarono in guerra. La crociata contro la Germania acquisiva sovente
i tratti di un'avventura da boy scout. L'ideale per rifarsi alle gag più
stralunate di Bugs Bunny, che peraltro Tex Avery faceva simulare dal vivo ai
suoi collaboratori quando le ideava con loro per i cortometraggi. All'infernale
coniglio oggi andrebbe strettissima la sensibilità ormai imposta per legge verso
le «minoranze etniche», le «diversità», le sfaccettature paradossali di quella
che Robert Hughes ha definito nel titolo del volume canonico, «la società del
piagnisteo», che mette al bando i duri e puri. Taddeo è un vero babbeo, non fa
soltanto rima. E Bunny non gli concede il bonus della comprensione. Lo tormenta
con un darwinismo che irride ogni «percorso di recupero». E, in effetti, come
già successo con i Simpson e i Griffin, anche i Looney Tunes non si salveranno
dalla censura benpensante americana: Yosemite Sam e Taddeo non avranno più le
solite pistole e fucili. Peter Browngardt, produttore esecutivo di Hbo, ha
rivelato al New York Times che la decisione di spogliarli delle armi è arrivata
dopo l'omicidio di George Floyd. Tuttavia, i personaggi potranno ancora dare la
caccia a Bugs Bunny con dinamite e coltelli. Negli anni Ottanta, vi fu un
tentativo di imitazione di Bugs, Roger Rabbit, che non resse oltre quell'unico
film. Mentre Bugs Bunny è immortalato con una stella nella Walk of fame di
Hollywood, unico essere autentico fra molti divi che a volte sembrano loro
cartoni animati.
Da globalist.it l'11 giugno 2020. È razzista chiamare moretto un
dolce al cioccolato che peraltro nasconde il candore di un’anima di panna? Sì,
per i supermercati della Migros, nota catena del Canton Ticino, che hanno
stabilito, dopo anni di polemiche e petizioni, di ritirare dagli scaffali la
golosità prodotta dal 1946 dalla Dubler, azienda del Cantone dell’Argovia, nel
nord del Paese, dove sono conosciuti come Mohrenkopf, "teste di moro". Come
racconta sull'Agi.it Manuela D'Alessandro: la decisione ha un impatto anche
sulle rimembranze proustiane di tanti ex bambini italiani di confine che alla
domenica andavano in Svizzera con mamma e papà a fare il pieno, quando ancora i
prezzi erano più convenienti di quelli nostrani, e coglievano l’occasione per
farsi regalare una scatola di moretti. Avvolti in una carta dorata, che merita
più attenzione della frenesia con cui viene scartata, nascondono sotto una
sottile scorza di cioccolato un tripudio di crema appoggiato alla base di wafer.
L'eliminazione del moretto è arrivata nelle scorse ore con un tweet in risposta
all’ennesima protesta di un utente che definiva “estremamente razzista” il nome
della delizia. “Abbiamo deciso di rimuovere il prodotto dalla gamma - ha
twittato Migros - L’attuale dibattito qui ci ha spinto a rivalutare la
situazione. Siamo consapevoli che questa decisione porterà anche a discussioni”.
Questo non significa che la squisitezza sparirà perché, ha precisato la catena,
la decisione riguarda solo la Dobler, l’unica azienda che si ostina a chiamare i
dolci col suo nome originale, mentre gli altri li hanno ribattezzati da tempo
con un più universale kiss. In effetti, gli animi su Twitter si sono scaldati,
come previsto, e in perfetto multilinguismo elevetico. C’è chi parla di “nuova,
dilagante e subdola dittatura del politicamente corretto”, chi, volando più
basso, sente spegnersi l’aroma dell’infanzia (“sono un ricordo legato alla mia
amata zia che non c’è più e abitava a Ginevra, andare con lei alla Migros a
mangiarli era una festa”, dice Chiara). Si è indignato anche un uomo di fede, o
almeno così si presenta: ”Oggi Migros non chiama più così i moretti per
rispetto, ma di cosa? E io che sono un sacerdote potrò esigere che Migros dia un
nome nuovo agli strozzapreti?”. Esultano invece i promotori di una petizione
affiliati al Comitato contro i dolci razzisti che nel 2017 chiedevano di abolire
il nome “palesemente razzista”. A sostenere la loro tesi c’era anche una
ricercatrice dell'Università di Basilea che sulle pagine della NZZ Franziska
Schutz si espresse per “decolonizzare la nostra lingua per evitare un futuro di
nuovi drammi legati alla migrazione”. Al momento, per i nostalgici dell'ultima
ora, sul sito della Migros è ancora presente la sezione dedicata all'acquisto
dei moretti, li chiamano ancora così, poi saranno solo kiss.
Marco Belpoliti per “la Repubblica” l'11 giugno 2020. Il 21
febbraio 1948, pochi giorni prima del colpo di Stato che trasformerà la
Repubblica ceca in uno Stato satellite di Mosca, il primo ministro Klement
Gottwald s' affaccia da un balcone per parlare alla folla. Nevica e accanto a
lui Vladimír Clementis si toglie il berretto e glielo mette sulla testa. Due
anni dopo, Clementis cade in disgrazia ed è cancellato dalla foto, rimane invece
il suo cappello su Gottwald. Questo episodio, raccontato da Milan Kundera in Il
libro del riso e dell'oblio, è solo uno dei tanti esempi di damnatio memoriae,
per cui ogni cambiamento politico porta alla cancellazione del nome e
soprattutto dell'immagine di chi è stato sconfitto, così come è avvenuto a
Bagdad dopo la caduta di Saddam Hussein o negli stati dell'Est Europa in seguito
alla fine del Muro di Berlino. Alla periferia di Budapest c'è il Parco delle
statue, dove sono stati portati i monumenti dopo la caduta del regime comunista.
La damnatio memoriae, che va distinta dall'iconoclastia, la condanna teologica
delle immagini che nel cristianesimo trova la più decisa espressione nella
Bisanzio dell'VIII-IX secolo, ha origini antichissime. Le più note nel passato
sono quelle che riguardano gli imperatori romani, i cui nomi, una volta morti,
come accadde a Commodo e a Nerone, furono scalpellati da steli e iscrizioni
votive. Un abbattimento più recente è quello della Colonna Vendôme a Parigi, su
cui si trovava la statua di Napoleone, distrutta durante la Comune il 16 maggio
1871 su iniziativa di Gustave Courbet, dal momento che, come scrisse il pittore,
si trattava di un «monumento di barbarie, un simbolo di forza bruta e falsa
gloria». Nei giorni scorsi a Bristol è stata abbattuta e scaraventata in mare la
statua di Edward Colston, noto benefattore della città, la cui ricchezza fu
accumulata attraverso la tratta degli schiavi; così davanti al Museum of London
è stata rimosso il monumento di Robert Milligan, mercante di schiavi. Due anni
fa negli Stati Uniti è esploso il dibattito sui monumenti alla Guerra civile, in
particolare quelli dedicati ai generali confederati, Robert E. Lee e Stonewall
Jackson, che guidarono quel conflitto per sostenere la legittimità della
schiavitù dei neri. Non si tratta di statue erette negli anni compresi tra il
1890 e il 1930, ma costruite in periodi successivi, fino agli anni Settanta del
Novecento. Nell'agosto del 2017 è stata rimossa la statua di Lee a
Charlottesville nell'Emancipation Park e le manifestazioni che opposero coloro
che volevano la rimozione a chi invece era contrario hanno provocato un morto.
Questo monumento fu realizzato nel 1924 dallo scultore bolognese Leo Lentelli e
raffigura il generale sudista a cavallo come Marco Aurelio in Campidoglio,
sovrano saggio e insieme condottiero nelle spietate guerre contro i Germani.
Anche a New York le vicende dei busti da rimuovere o abbattere hanno provocato
varie reazioni. Il sindaco Bill de Blasio ha parlato di "simboli dell'odio" e ha
fatto mappare tutte le statue della città. Neppure Cristoforo Colombo è stato
sottratto, dal momento che ieri a Richmond in Virginia la sua effigie è stata
abbattuta e a Boston decapitata. La furia iconoclasta si unisce alla damnatio
memoriae. Il dibattito è aperto almeno negli Stati Uniti. A uno studioso di
visual studies come Nicholas Mirzoeff, che incita ad abbattere tutti i
monumenti, si contrappongono le voci di chi non crede sia giusto dimenticare
quanto è accaduto nel passato e ritiene che non sia con questi gesti che si
risolvano problemi come il razzismo e la diseguaglianza. Sono parecchi gli studi
pubblicati negli ultimi vent' anni che sostengono sia necessario capire perché
questi monumenti siano stati creati e che cosa rappresentino per noi oggi. Come
ha notato lo studioso americano di antropologia Lawrence A. Kuznar, si tratta
del tentativo di esorcizzare il potere che hanno per noi le immagini, mentre
resta il problema del senso che noi diamo oggi a queste statue: le possiamo
venerare o detestare, onorarle o ridicolizzarle. Dipende da noi. L'opera di
cancellazione della storia è sempre un pericolo, dal momento che proprio la
memoria del passato diventa la base su cui costruire il presente e un futuro
diverso. C'è anche chi ha scritto che il problema non è tanto se le statue
vengono o meno giù, ma il dibattito che tutto questo suscita nelle coscienze del
presente. Rinunceremmo alla Colonna Traiana, capolavoro dell'arte romana, per
via delle stragi dei Daci, gli antenati dei romeni, per le scene di guerra e di
distruzione, per i villaggi dati alle fiamme, per l'accumulo di armi e morti?
Certo, da quei massacri ci separano oltre duemila anni, e tuttavia il problema
etico resta. La verità è che la diseguaglianza razziale è ancora oggi un
problema rilevante, per questo le reazioni sono così forti. Proviamo a
immaginare se, per un improvviso cambiamento politico, la figura di Giuseppe
Garibaldi diventasse il simbolo negativo della conquista nordista del Sud, e non
quella dell'eroe dell'Unità d'Italia. Si dovrebbero cancellare le dediche di
migliaia e migliaia di vie e togliere dalle piazze italiane duecento statue. La
storia del passato si studia e s' insegna, mentre nel presente è solo la lotta
politica che serve a cambiare lo stato delle cose. In quel giorno del 1871 la
folla festante della Comune abbatté l'odiata immagine di Napoleone, ma poi fu
Courbet a essere chiamato a pagare i danni. Per sua fortuna morì prima di pagare
la prima rata.
L’omicidio
Floyd ha creato la valanga: censurati Via col vento e Tom e Jerry.
Alessandro Fioroni su Il Dubbio il 10 giugno 2020. Dopo le proteste seguite alla
morte dell’uomo fermato dalla polizia, la macchina del politically correct va a
pieno regime e le accuse di razzismo fioccano. What’s the next? Tradotto
letteralmente: Cosa succederà ora? E’ l’interrogativo che si pone il Guardian
nella sua edizione on line di ieri riflettendo sul vasto movimento negli Stati
Uniti suscitato dall’uccisione di George Floyd. Una domanda riferita a possibili
sviluppi delle proteste, che dopo 15 giorni non sembrano aver perso ancora lo
slancio iniziale, e alle conseguenze politiche che arrivano fino alla Casa
Bianca. Iniziative come quella di Minneapolis di smantellare il dipartimento di
Polizia, la campagna “Defunding the Police”, la riforma della sicurezza pubblica
proposta al Congresso dai Democratici e la questione del razzismo declinata in
tutti i suoi aspetti. Tutte questioni che sono entrate nel dibattito pubblico
americano ma che faranno parte di una discussione si lunga durata.Nell’immediato
però qualcosa è successo, la portata del movimento e delle sue parole d’ordine
infatti ha toccato il mondo dello show biz, che è come dire il sentire comune,
la produzione di senso e significati. A cominciare dalla televisione. Il canale
in streaming HBO Max ha infatti annunciato ieri di aver rimosso dalla sua
programmazione in celeberrimo film del 1939 “Via con vento”. Ambientato durante
e dopo la guerra civile americana, “Gone with the Wind” è stato molte volte
attaccato per la sua rappresentazione della schiavitù. Basato sul romanzo di
Margaret Mitchell, presenta schiavi che sembrano contenti della loro sorte e che
rimangono fedeli ai loro ex proprietari anche quando potrebbero essere liberi.
All’epoca il film vinse 10 Oscar e fece registrare incassi da capogiro. Attori
come Clarck Gable e Olivia de Havilland furono resi famosissimi dalle loro
interpretazioni, ma per la prima volta un attrice afroamericana, Hattie McDaniel
(la domestica Mammy) ottenne la nomination per vincere la statuetta di
Hollywood. Un evento per quei tempi. La HBO Max ha motivato la sua decisione
affermando che sarebbe «irresponsabile» mantenere il film sulla sua piattaforma
senza «una spiegazione e una denuncia delle sue rappresentazioni razziste».
Parallelamente la Marina degli Stati Uniti martedì ha vietato le bandiere
confederate su navi e aerei, così come sembra tramontata l’dea di intitolare 10
basi a personaggi sudisti della guerra civile. Un movimento di pensiero con
conseguenze politiche visto che anche alcuni deputati del Missisipi avrebbe in
animo di togliere la bandiera dei confederati dalle proprie insegne anche se ciò
ha già incontrato la resistenza del governatore Repubblicano. I poliziotti
potrebbero avere ancora meno spazio in tv, ed è sempre l’intrattenimento che si
adegua alla situazione. Dopo essere andato in onda per ben 33 stagioni termina
di colpo la serie di documentari sulla Polizia, “Cops”, trasmesso dal canale via
cavo Paramount. Un portavoce della rete è stato tranchant comunicando la
decisione: «Cops non fa parte della rete Paramount e non abbiamo piani attuali o
futuri per il suo ritorno». E sulla lista nera sono finiti anche altre icone
come quelle della Disney, a partire da Dumbo oppure i cartoni di Tom e Gerry.
Per loro si parla di «rappresentazioni culturali obsolete».
Davide
Zamberlan per il Giornale il 10 giugno 2020. Domenica è toccato alla statua di
Edward Colston nel centro di Bristol, tirata giù dal piedistallo dai
manifestanti di Black Lives Matter e fatta rotolare dentro un canale cittadino.
Uomo politico e ricco commerciante vissuto tra il XVII e il XVIII secolo, anche
grazie al traffico di schiavi fece una fortuna che alla sua morte donò alla
città portuale inglese. Nella stessa giornata è stato imbrattato il piedistallo
di Winston Churchill a Parliament Square, a Londra: era un razzista, il pensiero
dell'ignoto autore. Ieri la maggioranza dei consiglieri comunali di Oxford ha
appoggiato la campagna per rimuovere l'effige di Cecil Rhodes che campeggia
sulla facciata dell'edificio a lui dedicato nel campus universitario di Oxford.
Politico e uomo d'affari vissuto nella seconda metà del 19esimo secolo, Rhodes
fa la sua fortuna nell'Africa del sud dove sfrutta le immense ricchezze
minerarie, fonda De Beers e amministra la colonia imperiale per conto della
regina Vittoria. E dona un sacco di soldi al prestigioso ateneo. Il sindaco di
Londra Sadiq Khan ha annunciato che istituirà una commissione per valutare quali
statue rimuovere dalla capitale inglese perché offensive. Le proteste innescate
dalla morte di George Floyd a Minneapolis stanno avendo un'eco molto forte nel
Regno Unito dove è numerosa la componente afrocaraibica della società.
L'abbattimento della statua di Colston ha dato vigore nuovo a un processo di
revisione dei simboli storici disseminati nel Paese già in corso da tempo. Sia a
Bristol che a Oxford movimenti di attivisti locali e di studenti chiedono da
anni la rimozione delle due statue controverse: le persone hanno sentito il
bisogno di tirarla giù, ha dichiarato il sindaco di colore di Bristol, non posso
e non farò finta che la presenza di una statua di un commerciante di schiavi
nella città in cui sono nato e cresciuto non sia un affronto a me e a persone
come me. La presa di posizione del sindaco fa da contraltare alle dichiarazioni
della ministra dell'Interno Patel, dura con i manifestanti i cui atti vandalici
non saranno condonati, ha dichiarato in Parlamento. Di origine indiane, Patel ha
fermamente respinto le accuse di insensibilità alle proteste, ricordando le sue
stesse esperienze di abusi e preconcetti razzisti. Il tono verso i manifestanti
lo aveva definito lo stesso Boris Johnson quando lunedì in un video messaggio ha
riconosciuto che anche nel Regno Unito c'è molto da fare per eliminare il
problema del razzismo. Ma «non supporterò né sarò indulgente verso coloro che
non rispettano la legge, attaccano la polizia o dissacrano monumenti pubblici».
La risposta alle manifestazioni si gioca sulla classica divisione culturale tra
la destra dell'ordine e la sinistra di protesta. Una contrapposizione stantia
cui si oppone il nuovo leader del Partito laburista, Keir Starmer: la statua
avrebbe dovuto essere rimossa molto tempo fa ma averla abbattuta è totalmente
sbagliato. Una risposta che demarca ancora più nettamente la differenza tra il
nuovo e il vecchio partito di Corbyn (intervenuto a favore dei manifestanti),
una presa di posizione in sintonia con le comunità laburiste del nord del Paese.
Come salvare le statue dal demone iconoclasta della folla? Bansky suggerisce di
ripescare Colston aggiungendovi le statue di alcuni manifestanti intenti a
tirarlo giù. Altri propongono di raccoglierle in un nuovo museo che racconti
storia e misfatti dell'impero. Auspichiamo senza la cieca pretesa di leggere il
passato con gli occhi del presente.
Adesso i neri si ribellano alla rivolta nera: "Non siamo degli
oppressi, i razzisti siete voi". Sale la
contro-protesta. Inghilterra, fermato l'assalto alla statua di Baden-Powell.
Roberto Fabbri, Venerdì 12/06/2020 su Il Giornale. La giovane signora americana
dalla pelle nera è molto arrabbiata. Ce l'ha con una ragazzotta dalla pelle
bianca che sta manifestando per quella che dovrebbe essere la sua causa: Black
lives matter. Le vite dei neri contano? Solo quelle che si possono
strumentalizzare, grida la donna inviperita. E non si ferma qui. «Dovete
piantarla di fare gli ipocriti, piantarla di dipingerci come vittime oppresse
aggiunge come un fiume in piena -. Noi qui siamo liberi, possiamo dire e fare
quello che vogliamo. Dove siete voi quando qui a Chicago dei neri ammazzano
altri neri nei nostri quartieri, come succede ogni giorno? Non ci siete mai,
perché non vi interessa delle vite dei neri, in fondo pensate che sia marmaglia
che uccide altra marmaglia. A voi interessa occuparvi di quello che fanno i
poliziotti bianchi, non delle nostre vite. Siete voi i razzisti. Il problema non
riguarda i neri, riguarda tutti: è un problema di violenza, e deve valere
sempre». Il filmato è finito su Twitter, ed è solo un esempio di quanta
irritazione possa suscitare, anche presso gli stessi neri, un certo modo di
approcciare il problema della violenza ai loro danni. Lo testimonia, fra gli
altri, un commento postato in Francia da un'altra donna nera. «Finalmente una
che la pensa come me scrive Lorie -. Quelle come lei sono i neri intelligenti,
persone che non sono disposte a servire da alibi né a questa sinistra nociva e
razzista né a certi bianchi psicopatici che ci assegnano il ruolo di vittime
solo per poi attribuirsi quello dei salvatori. No a Black Lives Matter!». Ma le
reazioni ideologizzate non sono le sole oggetto di critica. I saccheggi ai danni
di attività commerciali che hanno accompagnato in tante città americane le notti
di violenza seguite all'omicidio di George Floyd non hanno risparmiato quelle
gestite da afroamericani. «Questi non sono manifestanti per la giustizia
razziale ha detto una donna che si è vista devastare e ripulire il negozio -,
questi sono teppisti. E certi ipocriti attribuiscono loro il diritto di
infrangere la legge». Anche contro i neri, evidentemente. Come abbiamo visto in
questi giorni anche in Italia, si fa poi in fretta a passare dalla difesa delle
vite dei neri all'attacco ideologico ai cosiddetti simboli del razzismo: statue,
monumenti, magari dedicati a persone vissute 500 anni fa, come il genocida
Cristoforo Colombo. In Inghilterra questo andazzo politicamente corretto
comincia a suscitare reazioni. Ieri mattina nella città di Poole i soliti
benpensanti che pretendono di pensare per tutti avevano deciso di abbattere la
statua di Robert Baden Powell, il fondatore del movimento scout al quale
attribuiscono simpatie per i nazisti e antipatie per gli omosessuali. Ma
sorpresa! un picchetto di residenti ha impedito la rimozione del monumento. «Ma
cosa vogliono? diceva un anziano in tono di sfida Abbattere le piramidi, il
Colosseo? Io li combatterò!».
Parla
Donald Sassoon: “Il razzismo non è un problema solo degli Stati Uniti”.
Umberto De Giovannangeli su Il Riformista il 10 Giugno 2020. «L’Europa, inclusa
l’Italia, non ha il diritto di considerare il problema del razzismo come una
peculiarità transatlantica». A sostenerlo è uno dei più autorevoli storici
inglesi e della sinistra europea: il professor Donald Sassoon, allievo di Eric
Hobsbawm, ordinario di Storia europea comparata presso il Queen Mary College di
Londra, autore di numerosi libri di successo, tra i quali ricordiamo Quo Vadis
Europa? (Ibs), La Cultura degli Europei dal 1800 ad oggi (Rizzoli); Intervista
immaginaria con Karl Marx (Feltrinelli). Il suo ultimo saggio, da poco nelle
librerie, ha un titolo intrigante, e uno sviluppo che ci riporta all’Europa e
alle difficoltà della sinistra nell’essere all’altezza delle sfide del Terzo
Millennio: Sintomi morbosi Nella nostra storia di ieri i segnali della crisi di
oggi (Garzanti).
La rivolta
antirazzista scuote l’America. Professor Sassoon, qual è la sua valutazione in
proposito?
«La
cosiddetta rivolta non è la prima, ce ne sono state altre negli ultimi
trent’anni, per non andare ancora più indietro nel tempo. La grande novità è che
stavolta abbiamo un filmato che si è diffuso immediatamente per tutto il mondo;
un filmato particolarmente scioccante, orribile, perché scioccante e orribile è
stata la morte di George Floyd. La morte del cittadino afroamericano non è
avvenuta perché un poliziotto assalito gli ha sparato addosso o gli ha inflitto
un colpo letale con il manganello, come è successo anche in Europa, ma quel
poliziotto lo ha deliberatamente ucciso in modo raccapricciante mentre tre
poliziotti lo guardavano senza intervenire. Questo è quello che ha innescato una
serie di proteste, alle quali, ed è un dato politicamente di grande rilevanza,
hanno partecipato molti, forse anche in maggioranza, bianchi. E dunque non deve
stupire che quanto di raccapricciante è avvenuto a Minneapolis ha suscitato
anche in Europa, soprattutto in Gran Bretagna, dove c’è una percentuale non
piccola di gente di colore, figli di migranti che sono venuti dalle Indie
occidentali – Giamaica, Trinidad – dove erano stati trasferiti nel ‘600 e nel
‘700 da trafficanti inglesi, come schiavi per lavorare nelle piantagioni, e che
dunque hanno molto in comune con gli afroamericani. In questi avvenimenti che
segnano il nostro presente, c’è sempre un fatto particolarmente simbolico, che
dà il segno dei tempi».
Qual è, per
restare al Regno Unito, questo fatto simbolico?
«Ciò
che è accaduto domenica scorsa a Bristol, un fatto che ha avuto grande scalpore,
non solo in Gran Bretagna. Durante una manifestazione in solidarietà con quanti
protestavano in America, la statua di Edward Colston è stata abbattuta e gettata
in mare. La statua era in una piazza che aveva il suo nome, come molti edifici,
vie e scuole di Bristol. Colston era un trafficante di schiavi poi diventato
membro del Parlamento inglese. Colston marchiava a fuoco gli schiavi con le sue
iniziali, e li metteva nelle sue navi per mandarli in America e nelle Indie
occidentali. Molti di loro morivano durante il viaggio e con i profitti enormi
di questo traffico di esseri umani, Colston diviene il più grande filantropo di
Bristol. Morì nel 1721, ma più di un secolo dopo la città di Bristol,
riconoscente, gli edificò una statua in una delle piazze centrali della città.
Bisogna aggiungere che il sindaco di Bristol è oggi un uomo di colore, i suoi
genitori sono venuti dalle Indie occidentali, e i cui avi forse erano stati
schiavizzati da Colston. Da un certo punto di vista, questo simboleggia la
corresponsabilità dell’Europa e soprattutto della Gran Bretagna nella storia
deprimente, angosciante, degli schiavi negli Stati Uniti d’America. E dunque, è
vero che la situazione americana è di gran lunga peggiore di quella dei migranti
in Europa, malgrado l’indubbia crescita della xenofobia nel vecchio continente,
inclusa l’Italia, ma gli europei non hanno il diritto di considerare il problema
del razzismo come una peculiarità transatlantica».
Tra cinque
mesi l’America va al voto per eleggere il suo Presidente. Donald Trump è a
rischio?
«Non
ho altro a mia disposizione che i sondaggi. E i sondaggi sono tutti concordi nel
dire che Trump dovrebbe perdere le elezioni, il che non dovrebbe sorprendere se
si pensa alla sua totale incapacità di gestire l’emergenza pandemica, e il fatto
che l’economia americana sta andando molto male, e che la sua immagine si è
rafforzata unicamente tra le minoranze più estreme dei suoi sostenitori, del suo
elettorato. Vorrei ricordare che in realtà Trump aveva perso le elezioni del
2016 per quasi tre milioni di voti, lo scarto più grande nella storia americana,
e che ha vinto le elezioni per via di 77mila elettori distribuiti in 3 Stati.
Dunque si potrebbe dire che Donald Trump ha vinto con una enorme fortuna, che
sarebbe stata comunque difficile ripetere, anche se si fosse dimostrato un
presidente più abile di quanto si sia dimostrato».
Professor
Sassoon, il suo sfidante democratico, Joe Biden, l’entusiasma?
«Direi
proprio di no. Ma vorrei aggiungere che il ceto politico dei nostri giorni è nel
suo insieme, salvo rarissime eccezioni, drammaticamente carente. In Italia, se
si pensa agli Andreotti, Berlinguer, Moro, per non andare a De Gasperi e
Togliatti, e si fa un raffronto con l’oggi, non resta che piangere. In Gran
Bretagna, poi, Boris Johnson è senza dubbio un pagliaccio incompetente, ma i
suoi immediati predecessori a Downing Street, Theresa May e David Cameron, non
erano dei leader capaci o lungimiranti. In Francia, Emmanuel Macron finora non è
riuscito a risolvere alcuno dei problemi su cui aveva centrato la sua campagna
elettorale e si è dimostrato un vero dilettante in politica. L’unica che si
salva in Europa occidentale è la signora Merkel, che però ha annunciato il suo
ritiro dalla vita politica. E il deficit di leadership investe appieno la
vecchia sinistra europea, in ogni sua declinazione significativa. L’amara realtà
è che sia i conservatori tradizionali, sia la sinistra tradizionale, sono in
crisi e incapaci di portare avanti un discorso politico all’altezza della nuova
situazione. Per questo ho titolato il mio nuovo libro Sintomi morbosi,
riferendomi ad una famosa frase, del 1930, di Antonio Gramsci, in cui dice che
il vecchio mondo è sparito e non si scorge quello nuovo. E in questo interregno
si trovano dei fenomeni morbosi. E guardandoci intorno, possiamo dare a questi
fenomeni dei nomi».
Quali?
«Per
citarne solo alcuni: Donald Trump, Viktor Orban, Jair Bolsonaro, Jaroslaw
Kaczynski, Recep Tayyp Erdogan e via elencando».
Vede oggi
qualche efficace anticorpo capace di combattere e debellare questi sintomi
morbosi?
«In
questo momento, sinceramente no. Ma fa parte dell’essere in crisi il non sapere
come uscirne. È come essere in mezzo a un guado, cercando di attraversare un
fiume in piena: non scorgiamo più la vecchia riva ma non riusciamo neppure
ancora a intravvedere la nuova sponda».
In Italia
c’è chi a sinistra guarda al post Coronavirus, pensando che l’ancoraggio è il
ritorno al pensiero socialista e socialdemocratico che ha caratterizzato la
stagione del Welfare.
«È
una illusione. Oggi più che mai la sinistra non può pensare di ritrovare una sua
centralità, di azione e di pensiero, cercando di difendere quello che i ceti
popolari hanno ottenuto negli anni di crescita del Welfare state. È una nobile
battaglia. Ma è una battaglia difensiva. E lo è tanto più in una epoca in cui lo
Stato-nazione è sempre meno forte, e l’orizzonte da praticare non può essere
quello di un neo keynesismo. Si discute molto in Europa sulla necessità di
superare l’iper austerità e i vincoli di bilancio. Una necessità che l’emergenza
sanitaria e la crisi economica che porta con sé, rendono ancor più impellente.
Ma non è riproponendo un vecchio statalismo che la sinistra si farà portatrice
di una visione in grado di attrarre soprattutto le giovani generazioni. Il
futuro non potrà mai essere costruito rifugiandosi nel passato. E questo vale
sia per i progressisti che per i conservatori».
Il termine
“populista” viene spesso utilizzato per definire, in negativo, leader di destra
e non solo. Non ritiene che sia un termine troppo semplificatorio?
«Governare
significa scegliere e indirizzare una politica verso segmenti sociali di
riferimento e dunque contro altri (questo ad esempio è stato il thatcherismo).
Il punto è un altro. Il punto che non oggi, ma da trenta-quarant’anni, la
resistenza alla globalizzazione è stata condotta in nome della nazione. Mentre
il capitalismo si è sempre più internazionalizzato, globalizzato, la resistenza
ha sempre più assunto la dimensione, politica e culturale, nazionale,
rimodulando in questa chiave anche parole d’ordine e suggestioni proprie di un
vecchio internazionalismo proletario. Ecco allora che a «proletari di tutto il
mondo unitevi» si sostituisce «proletari (operai) americani, o inglesi, o
italiani… unitevi». Unitevi contro chi vi manaccia dall’esterno (i migranti e
quant’altro). Se è vero che dopo il Coronavirus niente sarà più come prima, la
sinistra cominci da se stessa».
Morte
Floyd, lo sciopero della scienza contro il razzismo.
Pubblicato
mercoledì, 10 giugno 2020 da La Repubblica.it. Dopo la morte di George Floyd
negli Usa, la scienza si ferma contro il razzismo. Sono migliaia di ricercatori
in tutto il mondo che si sono impegnati a interrompere le operazioni di lavoro
nella giornata di oggi per sostenere il movimento Black Lives Matter. Tra gli
hashtag e i motti a sostegno degli sforzi contro il razzismo Strike For Black
Lives, #ShutDownSTEM e #ShutDownAcademia, presenti non solo tra le proteste in
piazza e le manifestazioni in strada, ma anche nei laboratori universitari,
nelle società scientifiche e nelle riviste tecniche, che hanno aderito alle
iniziative STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) contro il
razzismo. "Come membri delle comunità accademiche globali e STEM, abbiamo un
enorme obbligo etico di interrompere i nostri soliti incarichi.
Indipendentemente da dove viviamo fisicamente, le nostre azioni dipendono da e
influenzano questo particolare momento storico", si legge sul sito ufficiale di
#ShutDownSTEM. Anche la rivista Nature ha notificato un ritardo nelle
pubblicazioni, dichiarando che "Nature si unisce a #ShutdownSTEM #
Strike4BlackLives per sradicare il razzismo dalle comunità di ricerca, il 10
giugno pubblicheremo solo contenuti che sono direttamente rilevanti per
sostenere le persone di colore in ambito accademico e STEM e contenuti relativi
alla pandemia globale Covid-19", come si legge sulla newsletter di ieri della
rivista. "Scopo dello sciopero, una ricerca alternativa: speriamo di riemergere
dopo questa giornata con nuove idee per combattere comportamenti e atteggiamenti
razzisti, allo scopo di attuare un vero cambiamento nelle istituzioni coinvolte
nella scienza", dichiara Brian Nord, astrofisico presso il Fermilab. Lo sciopero
ha raggiunto un sostegno internazionale e ha dato vita a una terza linea,
#VanguardSTEM, una piattaforma online che promuove le donne di colore che
lavorano in STEM. "L'idea è nata quando ci siamo chiesti cosa sarebbe stato
possibile fare durante il lockdown, come avremmo potuto agire in quanto comunità
scientifica per attirare l'attenzione", dichiara Brittany Kamai, fisico presso
l'Università della California Santa Cruz che ha dato origine a #ShutDownSTEM.
"Molti scienziati si sono impegnati a interrompere riunioni e meeting. E' il
nostro modo di manifestare in piazza", afferma la ricercatrice, sottolineando
che anche il suo gruppo di ricerca, il Laser Interferometer Gravitational-Wave
Observatory, aderisce all'iniziativa. Il server di prestampa arXiv, AAAS, che
pubblica Science, la Physical Society Letters della American Physical Society,
sono solo alcune delle prestigiose riviste che si impegnano a non pubblicare
nella giornata di oggi per sostenere il movimento. "Nel nostro dipartimento si
terrà un evento educativo virtuale con moderatori per sensibilizzare gli utenti
riguardo le esperienze delle perone di colore nella comunità scientifica",
dichiara Timothy Tait, presidente del Dipartimento di Fisica presso l'Università
della California Irvine. Altre iniziative prevedono marce e manifestazioni
all'interno dei campus. "Abbiamo bisogno di un mondo in cui vi sia accettazione,
tolleranza e rappresentanza di tutti, e non parlo solo di uomini di colore, ma
di una realtà in cui nessuno sia discriminato per il colore della pelle,
l'orientamento sessuale, il genere o la religione. Immagino un futuro in cui
tutti noi potremo lavorare anche a livelli di leadership", sostiene Chanda
Prescod-Weinstein, fisico presso l'Università del New Hampshire, dichiarando di
aver trascorso gran parte del suo insegnamento nella battaglia contro il
razzismo.
Matteo Cruccu per "corriere.it" il 9 giugno 2020. Tra le tante
voci che si sono alzate contro il terribile omicidio di George Floyd, risuona
anche la sua, più forte che mai: quella di Paul McCartney. Il Beatle ha infatti
pubblicato una nota sui suoi social in cui ha espresso tutto il suo dolore e la
sua indignazione per quanto accaduto all’afroamericano: «Dobbiamo lavorare
insieme per superare il razzismo in ogni sua forma, dobbiamo imparare di più,
ascoltare di più, parlare di più e soprattutto impegnarci in prima persona».
Il rifiuto del 1964. E Sir Paul ha ricordato che i Beatles in
campo scesero davvero nel lontano 1964, quando negli Usa la segregazione, in
molti stati del Sud, era una realtà fattuale, con autobus, scuole, quartieri
separati. E sale concerto: la band seppe che avrebbe dovuto esibirsi a
Jacksonville, in Florida, in un teatro diviso, da una parte i bianchi e
dall’altra i neri. E si rifiutò di esibirsi in un contesto simile: «Pensammo
fosse sbagliato» ricorda semplicemente McCartney « e imponemmo nel contratto che
non sarebbe dovuto avvenire». Così i Beatles vinsero la loro battaglia,
riuscendo a suonare lo stesso, ma senza alcuna divisione: «Fu il primo concerto
di sempre davanti a un pubblico non segregato». Un piccolo passo, ma decisivo
lungo la battaglia per i diritti civili.
Appello finale. Che però non deve essere servita a molto, ammette
«arrabbiato e addolorato». Paul «se quasi sessant’anni dopo dobbiamo assistere a
scene orrende come quella di Floyd e ad atti razzisti della polizia». E conclude
con un accorato appello: «Voglio giustizia per la famiglia di George Floyd.
Voglio giustizia per tutti quelli che sono morti e hanno sofferto. Non dire
nulla non è un’opzione». E dire quel dissero nel lontano 1964 fu un atto di
coraggio non da poco, in un mondo spesso piegato alle logiche del «business is
business», un’altra delle tante rivoluzioni della band più importante di sempre.
Da "huffingtonpost.it" il 9 giugno 2020. La campagna “Defund the
police” prende piede negli Usa. La maggioranza del consiglio comunale di
Minneapolis, città in cui l’afroamericano George Floyd è morto per mano di un
agente, ha votato per avviare un processo che dovrà portare a un taglio dei
fondi alle forze dell’ordine e allo smantellamento del dipartimento di polizia.
“L’obiettivo è quello di riformarlo e di ricostruire insieme a tutta la nostra
comunità un nuovo modello di sicurezza pubblica che davvero garantisca la
sicurezza di tutti” ha dichiarato la portavoce del Consiglio comunale, Lisa
Bender. La decisione è stata presa con una maggioranza tale da evitare il
veto. Le manifestazioni sono continuate in Usa durante tutta la giornata di
ieri, ma senza violenze e i manifestanti hanno cominciato a concentrare la loro
rabbia per la morte di Floyd su richieste di riforma della polizia e di
giustizia sociale.
Sulla scia delle proteste contro la polizia violenta e della
campagna "Defund the Police", il sindaco di New York Bill de Blasio ha promesso
di tagliare una parte dei fondi destinati al New York Police Department e di
destinarli ai servizi per i giovani e ai servizi sociali. Una mossa senza
precedenti nella Grande Mela che - ha assicurato de Blasio - sarà attuata nel
giro di tre settimane. Il dipartimento di polizia newyorchese ha un budget
annuale di 6 miliardi di dollari. Mosse che erano in qualche modo state
anticipate da un tweet di Donald Trump contro il suo rivale alla Casa Bianca Joe
Biden, in cui scriveva che “Sleepy Joe” e la sinistra radicale vogliono togliere
fondi alla polizia, mentre lui vuole legge e ordine.
Dagonews il 9 giugno 2020. Non ci sono solo le rivolte contro la
polizia per George Floyd. In America sta crescendo un sentimento di odio e
rivalsa contro le “Karen”, nome con cui si indicano in genere le donne bianche
di mezza età, tendenzialmente arroganti e ignoranti, che sono diventate
protagoniste loro malgrado dell’ironia dei social durante la pandemia. Qualcuna
di queste “Karen” però sta facendo a proprie spese la conoscenza di questo
stereotipo. Come la signora che è stata presa a schiaffi in un distributore di
benzina a Phoenix, in Arizona dopo aver fatto alcuni commenti razzisti a
un’altra donna. Nel filmato che è circolato online si vede una signora ispanica
che entra per chiedere aiuto, e poi in breve parte la lite e la rissa. L’uomo
che ha registrato il video sostiene di aver sentito la ‘vittima’ dire all’altra
di “tornare al suo paese” prima di chiedere con insistenza al cassiere di non
servirla. A quel punto l’altra si è incazzata e gli ha mollato un cinquino in
faccia…
Proteste Usa, Trump voleva schierare 10mila militari in tutto
il paese. Jacopo Bongini il 07/06/2020 su Notizie.it.
Secondo un'indiscrezione il presidente Usa Donald Trump avrebbe chiesto di
schierare 10mila militari in tutto il paese per sedare le proteste in atto.
Continuano le proteste negli Usa a seguito della morte dell’afroamericano George
Floyd, avvenuta lo scorso 25 maggio a Minneapolis, anche se rispetto ai primi
giorni ora i cortei di manifestanti sembrano aver assunto una connotazione
decisamente meno violenta. Per le strade di San Francisco, New York e Washington
Dc infatti, migliaia di persone si sono riunite in cortei pacifici al grido
di Black Lives Matter, mentre secondo il presidente Donald Trump, nella capitale
statunitense sarebbero presenti molte meno persone a differenza delle giornate
precedenti. Secondo un’indiscrezione trapelata nelle ultime ore inoltre, emerge
che Trump avrebbe chiesto il dispiegamento di oltre 10mila militari per sedare
le proteste in tutto il paese. Una richiesta che però sarebbe stata rifiutata
dallo stesso segretario di Stato alla Difesa, Mark Esper, e dal capo di Stato
maggiore delle Forze armate americane, Mark Milley. Nei giorni precedenti lo
stesso Esper aveva già ribadito il suo no all’utilizzo dell’esercito, concedendo
unicamente lo schieramento di 1.600 militari al fine di proteggere l’area nei
pressi della Casa Bianca. Militari che sono stati successivamente
richiamati lasciando sul posto solamente i 5mila uomini della Guardia
Nazionale e indisponendo visibilmente il presidente. Proprio a Washington
intanto, una recinzione alta tre metri e lunga tre chilometri è stata installata
per proteggere l’area attorno alla Casa Bianca, ciò malgrado Trump stesso abbia
affermato nelle ultime ore come le proteste nella capitale Usa si siano
notevolmente ridimensionate rispetto agli scorsi giorni. Su Twitter il thycoon
ha infatti scritto: “Molta meno folla a Washington di quanto previsto. Grazie
alla Guardia Nazionale e alla polizia di Washington Dc per l’ottimo lavoro
svolto”. Il Pentagono ha in seguito spiegato che l’area rimarrà recintata almeno
fino al 10 giugno, senza però specificare se e quando le barriere verranno
rimosse. Nel frattempo proseguono le manifestazioni pacifiche in molte città
degli Stati Uniti, tra cui a New York dove un partecipante al corteo ha
dichiarato: “La gente ha una voce ora e ci stanno ascoltando. Ci stanno
ascoltando perché siamo uniti”. A Los Angeles invece, la giornalista della
Cnn Lucy Kafanov ha così descritto l’atmosfera delle ultime ore: “Ci sono molte
persone che vanno in giro a distribuire snack, mascherine, disinfettante per le
mani, cibo per i dimostranti. Una delle cose belle a livello umano che abbiamo
visto è che mentre passano davanti a vari condomini, la gente esce ai loro
balconi, inizia a battere le mani, scuotere pentole e padelle in solidarietà
della protesta”.
“Gli afroamericani vanno educati”: Hulk Hogan ed ex moglie
banditi dal wrestling. Il commento di Linda su Twitter
riguardo i disordini avvenuti a Minneapolis, in seguito alla morte di George
Floyd, non sono piaciuti. Valentina Dardari, Sabato 06/06/2020 su Il Giornale.
Hulk Hogan, la leggenda del wrestling, e la sua ex moglie Linda, non potranno
più prendere parte agli eventi organizzati dalla All-Elite wrestling. La donna
infatti, attraverso Twitter, aveva postato commenti critici riguardo agli ultimi
disordini di ordine pubblico avvenuti a Minneapolis in seguito alla morte
di George Floyd. L’uomo, un afroamericano, era morto lunedì 25 maggio, dopo che
l’agente di polizia Derek Chauvin, si era inginocchiato sul suo collo per almeno
sette minuti, mentre era ammanettato e sdraiato a testa in giù sulla strada.
Nemmeno le parole pronunciate da George “non posso respirare” avevano indotto il
poliziotto ad alzarsi. Da quella tragedia sono poi nati tafferugli in giro per
gli Stati Uniti.
Il post incriminato. “Guardo le foto dei saccheggi e sono tutti
afroamericani: non sono certa che il furto e il saccheggio siano il modo
migliore per ottenere giustizia, se vogliono essere ascoltati devono
essere educati”, questo il commento postato su Twitter da Linda, incriminato
dalla maggior parte degli utenti e poi cancellato dalla donna. Proprio queste
parole hanno portato Tony Khan, capo della All-Elite Wrestling e comproprietario
della squadra di calcio inglese Fulham, a bandire Linda ed ex marito da tutte le
manifestazioni e gli eventi futuri. Sul perché anche la leggenda del wrestling,
Hulk Hogan, suo ex consorte, sia stato bandito a sua volta, non è stato
spiegato. Anche se un’idea, guardando il passato della star, ce la possiamo
anche fare.
I precedenti di Hulk Hogan. Nel 2015 infatti era già stato
allontanato dalla Wwe, e poi riammesso tre anni dopo, per insulti
razzisti saltati fuori durante una registrazione. In quel caso aveva espresso
opinioni non proprio lusinghiere nei confronti degli uomini di colore. La figlia
Brooke aveva una relazione con uno di loro. Non si era risparmiato neanche lo
scorso aprile quando aveva commentato il coronavirus, visto da lui come una
punizione di Dio verso l’uomo che adora falsi idoli. Sui social aveva infatti
dichiarato: “Dio ha detto: se vuoi adorare gli atleti, io chiuderò gli stadi. Se
vuoi adorare i musicisti, io chiuderò le sale da concerto. Se vuoi adorare gli
attori, io chiuderò i teatri. Se vuoi adorare il denaro, chiuderò l’economia e
farò crollare il mercato azionario. Se non vuoi andare in chiesa e adorarmi,
farò in modo che tu non possa andare in chiesa”. Questa volta è difficile che
tra qualche anno venga riammesso.
Da lastampa.it l'8 giugno 2020. E' bufera su Fox News, costretta
a scusarsi per la messa in onda di un grafico che spiega la reazione di Wall
Street ogni qual volta nella storia si sono verificati casi eclatanti di
uccisioni di persone afroamericane, da Martin Luther King a George Floyd. Una
scelta a dir poco di cattivo gusto nel pieno dell'ondata di proteste contro il
razzismo che sta attraversando l'America. Dal diagramma, mostrato venerdì scorso
durante il programma politico Special Report condotto dal popolare anchorman
Bret Baier', emerge come l'andamento dei mercati azionari in concomitanza con
questi tragici episodi è stato sempre in rialzo. E' successo nel 1968 dopo
l'assassinio a Memphis del leader storico dei diritti civili, dopo l'assoluzione
dei poliziotti che nel 1991 a Los Angeles pestarono quasi a morte il tassista
Rodney King e dopo l'uccisione da parte di un poliziotto bianco del 18enne
Michael Brown nel 2014 a Ferguson, in Missouri. Stessa storia dopo la morte di
George Floyd il 25 maggio a Minneapolis, con un vero e proprio balzo dei
principali indici della Borsa di New York nei giorni successivi. Sui social, e
non solo, si è subito scatenata l'indignazione di molti, tanto che i vertici
dell'emittente più amata da Donald Trump sono dovuti correre ai ripari: «Ci
scusiamo, l'infografica usata per illustrare la reazione dei mercati a periodi
storici di disordini civili non avrebbe mai dovuto essere trasmessa senza essere
inserita in un pieno contesto», ha ammesso Fox News in un comunicato ritwittato
da Baier senza alcun commento. Ma la frittata oramai era fatta. «Questo grafico
mette in chiaro come Fox News non si preoccupa delle vite di persone
afroamericane», ha commentato su Twitter Bobby Rush, uno dei leader
afroamericani al Congresso. «È così che a Fox piangono la perdita di persone
afroamericane, illustrando quanto sale la Borsa», gli ha fatto eco sempre su
Twitter l'ex presidente del Comitato Nazionale Repubblicano, l'afroamericano
Michael Steele.
Bufera e dimissioni al NY Times dopo l’editoriale
anti-manifestanti. Il Dubbio l'8 giugno 2020. Il
responsabile degli editoriali aveva pubblicato un articolo pro-Trump e il
giornale gli chiede un passo indietro: “Non ha rispettato gli standard del
giornale”. Il New York Times annuncia le dimissioni del responsabile della
pagina degli editoriali, James Bennet, e Trump s’infuria. Bennet ha lasciato
dopo le polemiche per la pubblicazione del commento del senatore repubblicano
Tom Cotton che chiedeva l’intervento dei militari per sedare i disordini. Il
presidente Donald Trump su Twitter difende il giornalista: “Se n’è appena andato
un Opinion Editor del New York Times. Esatto, ha lasciato per l’eccellente
commento scritto dal nostro grande senatore @TomCottonAR. Trasparenza! Lo Stato
dell’Arkansas e’ molto orgoglioso di Tom. Il New York Times è una fake news!!!”
Dimissioni anche del vice di Bennet, Jim Dao, Jim Dao. La responsabilità della
pagina degli editoriali passa per il momento ad un altro vice, Katie Kingsbury,
che dovrebbe svolgere le funzioni fino alle elezioni presidenziali di novembre.
“Abbiamo concordato che serve un nuovo team nel momento in cui stiamo
affrontando un periodo di considerevoli cambiamenti”, afferma in una nota
l’editore del quotidiano A.G. Sulzberger. Il Nyt, dopo una vera e propria
sollevazione della redazione, aveva fatto mea culpa per l’op-ed del senatore
repubblicano Cotton e, in un incontro con lo staff, Bennet aveva ammesso di non
avere letto il testo del senatore prima della pubblicazione. Poco dopo il Times
aveva pubblicato una dichiarazione in cui si afferma che l’articolo del senatore
“non è all’altezza degli standard del giornale”. La portavoce del Nyt, Eileen
Murphy. aveva quindi preannunciato “cambiamenti sia nel breve che nel lungo
periodo per un rafforzamento delle nostre operazioni di controllo dei fatti e
per ridurre il numero degli op-ed che pubblichiamo”.
Minneapolis scioglie la sua polizia, New York le taglia i
fondi. In tutta l'America avanza "De-fund the police".
Federico Rampini l'8 giugno 2020 su La Repubblica. Minneapolis smantella la
polizia. Altre città si preparano a tagliarle i fondi seguendo l'esempio di New
York. Al decimo giorno di proteste per l'uccisione dell'afroamericano George
Floyd da parte di un agente bianco, il primo risultato concreto di questo
movimento è un'offensiva senza precedenti per ridimensionare e disciplinare i
poteri considerati eccessivi delle forze dell'ordine. Accusati di razzismo
sistematico, molti corpi di polizia ora subiscono conseguenze immediate e
pesanti. Oltre agli agenti di Minneapolis già arrestati e incriminati per
l'omicidio di Floyd, anche due agenti di Buffalo (New York) sono agli arresti
per brutalità contro un dimostrante. Sanzioni disciplinari, sospensioni,
indagini si allargano in varie città d'America per abusi commessi proprio
durante la repressione dei cortei di protesta. Il gesto più clamoroso viene
dalla città dov'è stato ucciso Floyd. Il consiglio comunale di Minneapolis, con
una maggioranza qualificata a prova di veto, annuncia lo scioglimento puro e
semplice del suo Dipartimento di polizia. Il provvedimento significa che gli
agenti verranno ricollocati in una nuova forza di ordine pubblico, le cui
regole, procedure e gerarchie vanno ridisegnate in toto. Non è solo un gesto
simbolico, perché l'obiettivo è quello di arrivare ad una
maggiore accountability, un sistema di regole in cui gli agenti debbano
rispondere del loro operato ai cittadini. L'azione drastica di Minneapolis
risponde con i fatti ad uno degli slogan più gridati nei cortei di protesta:
"De-fund the police", togliete i fondi alla polizia. Il più celebre e il più
potente dei corpi di polizia americani, il New York Police Department, subirà
proprio questo: il sindaco Bill de Blasio ha annunciato tagli al bilancio delle
forze dell'ordine, per dirottare una parte del loro budget (un totale di 6
miliardi di dollari annui) verso servizi sociali e aiuti ai giovani. Molte altre
città americane stanno annunciando in queste ore che vogliono muoversi nella
stessa direzione. "De-fund the police" sembrava uno slogan radicale, un'utopia
fatta su misura per i tanti giovani che invadono le piazze. A gran velocità è
diventato un programma di governo, a livello locale. Le forze di polizia infatti
sono ovunque sotto la giurisdizione delle autorità locali, generalmente i
sindaci; in alcuni casi gli stessi sceriffi sono cariche elettive (fanno
eccezione le agenzie federali come Fbi, la polizia di frontiera o
l'anti-terrorismo della Homeland Security, che tuttavia non hanno compiti di
ordine pubblico né entrano in contatto quotidiano con le comunità dei
cittadini). Il movimento per "depotenziare" le polizie tagliando i fondi dovrà
vedersela con le Union: gli agenti sono uno dei pochi settori ad altissima
sindacalizzazione. Il ruolo dei loro sindacati è finito sotto i riflettori anche
in questi giorni. Le Union difendono strenuamente i loro iscritti, anche quando
incriminati per reati gravi. I sindacati di polizia - e in generale del pubblico
impiego - sono lobby elettorali potenti, con cui i sindaci dovranno fare i
conti.
Il kente,
la sciarpa che indossavano i democratici al Congresso in omaggio a Floyd.
Pubblicato mercoledì, 10 giugno 2020 da La Repubblica.it. Quando si sono
inginocchiati al Congresso in solidarietà con i manifestanti che protestavano
contro la morte dell'afroamericano George Floyd per mano di un agente di polizia
bianco, i democratici americani indossavano una sciarpa chiamata kente. Le
sciarpe erano state distribuite dai membri del Black Caucus, i rappresentanti
afroamericani. "Il significato del tessuto kente è la nostra eredità africana e
per quelli di voi senza quell'eredità signifca essere solidali con noi", ha
detto ai giornalisti secondo quanto scrive la Bbc Karen Bass, presidente del
Congressional Black Caucus.
La storia del
kente. Il kente è originario del Ghana. Dice la mitologia che due Akan (membri
della popolazione locale) andarono nella foresta per la caccia e si imbatterono
in un ragno che stava tessendo. Si fermarono due giorni rapiti dal movimento del
ragno, tornati a casa cominciarono a creare il primo kente. In gran parte
dell'Africa occidentale, la sciarpa, o il vestito, veniva tessuto con le strisce
di stoffa messe insieme.
La polemica.
Il vestito, però, in alcune occasioni parla e, spesso, il linguaggio non
coincide con quel che si vuole dire. Cosi il kente che, col favore delle
telecamere, adornava il collo tra le altre di Nancy Pelosi e Kamala Harris ha
creato molte polemiche. Le stole di kente per gli afroamericani sono un simbolo
di riscossa, indosso ai democratici hanno fatto un altro effetto, facendo
tornare in mente echi di colonialismo: anche Trevor Noah, sudafricano, nero, e
comico famoso in America ha protestato: "Ancora una volta l'identità nera non ha
bisogno di lezione dai bianchi", ha detto. Morte George Floyd, i democratici si
inginocchiano al Congresso in riproduzione.... Condividi Una tradizione
radicata
In Ghana molti
afroamericani sono tornati a partire dagli anni Novanta, per scoprire le radici
e gli antenati di chi giungeva in America schiavo, e scoprire gli Akan, gruppo
etnico di cui fanno parte anche gli Ashanti. Gli Akan-Ashanti hanno una ben
precisa cosmologia con proverbi, canti, favole, frasi che si costruiscono con la
geometria dei disegni kente, probabilmente derivato dal ritmo di "ke" e "te" -
il movimento di aprire e premere, associato dal tessuto - o da "kenten", cesto.
Tuttora ai diplomatici e presidenti in Ghana viene donata una sciarpa con colori
brillanti, tra i quali il nero, il giallo, il rosso, il bianco, il verde, il
marrone, l'oro, il grigio, la porpora e il rosa hanno un significato prezioso e
preciso. In America, il giorno della laurea, o in determinate ricorrenze, i neri
indossano una sciarpa nello stile ghanese. Tanti, però, sia in Ghana che in
America, non amano più questo tessuto perché lo ritengono inflazionato.
Paolo Mastrolilli per ''La Stampa'' il 7 giugno 2020. «Questo è
un momento storico, cruciale, in preparazione da cent' anni. Non ho mai visto
nulla del genere in vita mia. È come quando pensavamo che Barack Obama non
sarebbe mai diventato presidente, finché è accaduto». La sfida è tutta qui, come
l' ha descritta Lesley Edmond, marciando ieri con i figli su Lafayette Square a
Washington, l' ex mercato degli schiavi a due passi dalla Casa Bianca, dove ieri
hanno manifestato decine di migliaia di persone. La morte di George Floyd, che
ha spinto milioni di persone a protestare in tutto il mondo, da New York a
Tokyo, dall' Australia e l' Africa all' Europa, riuscirà a trasformarsi in un
movimento politico, capace di cambiare alla radice le cause del malessere
globale a cui ha dato voce? Verrà dirottata dai violenti, dando a Trump la scusa
per ottenere la conferma a novembre come presidente della legge e dell' ordine?
Oppure sparirà nel nulla, come in fondo era accaduto con la rabbia seguita agli
abusi di Ferguson, Baltimora, New York, e tutta la stagione che aveva fatto
nascere Black Lives Matter? Ieri, forse, è stato il giorno della svolta. Subito
dopo l' omicidio di Floyd, le reazioni emotive e gli interessi in malafede di
estremisti, antifa, surprematisti boogaloo e criminali comuni, avevano preso il
sopravvento. Il commissariato 3rd Pricint di Minneapolis dato alle fiamme faceva
più notizia dei manifestanti pacifici, che si inginocchiavano in strada per
chiedere sinceramente un cambiamento. Il caos aveva dato a Trump la scusa per
minacciare l' invio dei militari nelle strade, e scattare la foto con la Bibbia
in mano, usata come messaggio in codice per la sua base. Ieri, con un ritardo di
quasi due settimane, la scena è cambiata. La stessa prima cittadina di
Washington, Muriel Bowser, ha rinominato l' incrocio della 16th Street davanti
alla Casa Bianca «Black Lives Matter Plaza», lasciando che questa scritta fosse
dipinta sulla strada a caratteri cubitali gialli. La Guardia Nazionale c' era,
anche se Bowser aveva inviato una lettera al presidente chiedendo di ritirare
tutti i militari dalla città, ma non si vedeva. Ad Atlanta i soldati hanno
persino ballato la «Macarena» con i manifestanti, prima di accompagnarli in
corteo. A Buffalo invece sono stati incriminati Robort McCabe e Aaron Torgalski,
per l' assalto contro il settantacinquenne Martin Gugino, finito all' ospedale
con la testa rotta per i loro spintoni. Però 57 colleghi dei due poliziotti si
sono dimessi in solidarietà con loro, a dimostrazione di quanta strada resti
ancora da fare, per cambiare la mentalità con cui si mantiene l' ordine in
America. Così si capisce anche il senso del movimento «Defund the Police», che
magari darà a Trump argomenti per accusare i democratici di favorire il crimine,
ma in realtà punta a usare l' arma dei soldi per riformare la galassia delle
forze dell' ordine comunali, statali e federali, ormai evidentemente fuori
controllo. In North Carolina, invece, si è svolto l' ultimo saluto a George
Floyd nel luogo dove era nato, in attesa del funerale di martedì a Houston.
Trump ha osservato dalla Casa Bianca assediata, trasformata in bunker dalle
barriere metalliche alzate per proteggerla. E come al solito ha attaccato,
stavolta la prima cittadina della capitale: «La sindaco Bowser è esageratamente
incompetente, in alcun modo qualificata a guidare una città importante come
Washington. Se non fosse stato per la Guardia Nazionale, avrebbe fatto la stessa
figura del suo collega di Minneapolis». Donald è diventato presidente cavalcando
la spaccatura ideologica e culturale dell' America, e punta a ripetere questa
strategia a novembre. I violenti fanno il suo gioco, perché gli consentono di
presentarsi come il protettore della legge e dell' ordine, convincendo a votarlo
non solo la sua incrollabile base, ma magari anche i moderati della maggioranza
silenziosa impauriti dai saccheggi. Ha esaltato il calo della disoccupazione,
anche se secondo lo stesso dipartimento al Lavoro le statistiche pubblicate
venerdì erano sbagliate al ribasso almeno del 3%, perché così spera di far
dimenticare i ritardi nella gestione coronavirus e convincere gli elettori a
confermarlo. Anche i neri, che per lui sono beneficiati dalla crescita come
tutti. Le manifestazioni di ieri però hanno dimostrato che la protesta sta
diventando un movimento globale, che va ben oltre le violenze della polizia
contro Floyd e gli altri. Esprime un malessere dalle radici profonde, nelle
tensioni razziali, ma anche nelle disuguaglianze sociali. E ormai si riassume
nelle dure critiche del generale Mattis, non esattamente un estremista
scalmanato, che ha accusato Trump di essere «il primo presidente nella mia vita
che non cerca di unificare il Paese, e nemmeno fa finta di provarci. Quello che
vediamo in questi giorni è il risultato di tre anni senza una leadership
matura». La leadership però è un problema anche per la protesta, perché finora
non si è manifestata. Le stesse marce di ieri sono state pacifiche, almeno fino
al tramonto, ma scoordinate. L' incognita è se il candidato presidenziale
democratico Biden, magari aiutato da una vice nera, abbia la capacità di
impersonarla, unificarla, e indirizzarla al voto il 3 novembre.
Gli assembramenti sono belli ma solo se a farli è la sinistra.
Oggi non sentiremo nessuna reprimenda contro chi è
sceso in piazza per commemorare la morte dell'afroamericano George Floyd,
infischiandosene delle norme sul distanziamento sociale. Francesco Curridori,
Domenica 07/06/2020 su Il Giornale. La sinistra non poteva perdere l'occasione
di scendere in piazza e così, oggi, sono arrivate anche in Italia le
manifestazioni in memoria di in memoria di George Floyd, l’afroamericano ucciso
da un agente di polizia. Le piazze di Torino e Bologna, oggi, sono invase dai
centri sociali. Ormai, si sa, quando la piazza è sinistra, allora tutto è lecito
e assolutamente democratico. La piazza di centrodestra, invece, non piace mai e
viene sistematicamente insultata o descritta come “un manipolo di gente sudata”,
come ha fatto lo scrittore ed ex parlamentare del Pd, Gianrico Carofiglio. Poco
importa, come ha fatto notare il vicedirettore del Giornale, Francesco Maria Del
Vigo che si siano stati “assembramenti anche a Codogno per aspettare
Mattarella” così come in tutte le altre manifestazioni d'Italia “da una parte e
dall'altra”. Premesso che ieri nel centro di Roma si è consumato uno spettacolo
indecoroso, c’è da chiedersi se oggi arriveranno parole di condanna da parte del
Pd per le piazze dell’estrema sinistra torinese e bolognese. A pochi giorni
dall’inizio della fase 3, il gruppo torinese "No Justice No Peace" ha ben
pensato di manifestare in piazza Castello “contro gli inaccettabili fatti che si
stanno verificando negli Stati Uniti in questi giorni e in solidarietà agli
afroamericani uccisi dalla polizia". No, statene certi, contro
questi antagonisti non arriverà nessuna paternale o reprimenda da parte degli
stessi esponenti di una certa sinistra radical chic che, in questi giorni, hanno
redarguito i leader del centrodestra per non aver saputo dare il buon esempio.
Inutile ricordare, poi, i ristoratori falcidiati dalla crisi che sono stati
multati quando hanno manifestato davanti all’Arco della Pace di Milano,
nonostante tutti stessero rispettando le regole sul distanziamento sociale. Nel
Paese che ha avuto il maggior numero di decessi dopo Stati Uniti, Regno Unito e
Brasile, sulle norme anti-Covid si è inflessibili solo quando si tratta di
colpire chi osa manifestare contro questo governo. Quando, invece, si tratta di
partecipare ai flash mob in memoria di George Floyd, tutto è lecito. D’altronde
le norme anti-Covid sono state infrante proprio anche da chi le ha imposte agli
italiani. Non possiamo certo dimenticare la "calda accoglienza" che il
premier Giuseppe Conte ha riservato alla volontaria Silvia Romano oppure
l’assembramento creato dai giornalisti che hanno seguito l’inaugurazione del
Ponte Morandi. Arriveranno mai parole di condanna da parte del premier Conte o
del taciturno ministro della Salute Speranza? Sinceramente, abbiamo seri dubbi
e, anzi, è assai probabile che manifestazioni anti-Trump come quelle odierne
avranno la benedizione di tutta la maggioranza giallorossa. L'alternativa sarà
il silenzio assordante, proprio come accaduto per il 25 aprile quando gli
antifascisti e l'Anpi hanno invaso impunemente le strade della Capitale. Il
tutto, come sempre, alla faccia del distanziamento sociale.
L’Anpi multata per aver violato il lockdown del 25 aprile: non
vuol pagare. Leo Malaspina domenica 7 giugno 2020 su
Il Secolo d'Italia. L’Anpi non ci sta a pagare la multa di 400 euro. Perché
loro, i partigiani, in piazza ci possono scendere in barba alle regole del
lockdown, non come quelli di destra, criticati per i presunti “assembramenti”
del 2 giugno a Roma. L’ultima paradossale vicenda di “doppiopesismo” si registra
a Cosenza, dove una donna, una “partigiana”, presidente dell’Anpi locale, si
rifiuta di pagare la multa inflittale dalla polizia per aver violato il lockdown
del 25 aprile. Aveva portato i fiori per un sit-in su un luogo simbolo della
Resistenza.
La partigiana non rispetta le regole? Maria Pina Iannuzzi era
stata così multata per aver violato le prescrizioni atte al contenimento del
rischio epidemiologico Covid-19. Ma dopo aver incassato la solidarietà e
l’indignazione del Pd locale, la donna si è decisa a fare ricorso al prefetto
contro la multa. Sostiene che avesse preso le giuste precauzioni e che
l’obiettivo della sua uscita di casa era molto importante, quello di portare i
fiori su un luogo simbolico, il Largo dei Partigiani, nella città vecchia.
L’Anpi sottolinea inoltre che le associazioni partigiane e combattentistiche
erano autorizzate a partecipare alle celebrazioni per il 75º anniversario della
Liberazione. La conferma di quello che tutti sapevamo: alla sinistra era stato
concesso di violare il lockdown per la Liberazione, alla destra non di
manifestare liberamente in piazza, a lockdown, peraltro, ampiamente allentato.
(ANSA l'11 giugno 2020) - Thomas Lane, uno dei 4 ex poliziotti
coinvolti nella morte di George Floyd, è stato rilasciato su cauzione, ma con
condizioni, dal carcere della contea di Hennepin, nel Minnesota. Lo riporta
l'emittente CBSN. Lane ha pagato una cauzione di 750.000 dollari. Lo riportano i
media locali. Floyd è stato ucciso da Derek Chauvin, che per immobilizzarlo
quando era già a terra ha premuto un ginocchio sul suo collo per quasi nove
minuti soffocandolo. Chauvin rimane in carcere con le accuse di omicidio di
secondo e terzo grado e omicidio colposo di terzo grado. Gli altri ex poliziotti
- Tou Thao, J. Alexander Kueng e lo stesso 37enne Lane - dovranno rispondere
delle accuse di aver aiutato e favorito sia l'omicidio involontario di secondo
grado sia l'omicidio colposo di secondo grado. Per loro è stata fissata una
cauzione di un milione di dollari ciascuno senza condizioni e di 750.000 dollari
con condizioni. Per Chauvin la cauzione è di 1,25 milioni di dollari senza
condizioni ed un milione di dollari con condizioni. La prossima udienza è
prevista per il 29 giugno.
Giuseppe
Sarcina per il “Corriere della Sera” l'8 ottobre 2020. Non si sa chi abbia
garantito la cauzione di un milione di dollari. Ma l'ex poliziotto Derek Chauvin
è di nuovo libero. Il 25 maggio scorso, a Minneapolis, fermò per un controllo,
con altri tre colleghi, l'afroamericano George Floyd, 46 anni. Lo fece sdraiare
sull'asfalto e con il ginocchio gli montò sul collo per otto minuti e 46
secondi, restando immobile anche se l'uomo sotto di lui si lamentava sempre più
flebilmente: «non respiro». Floyd morì soffocato. Le proteste dilagarono a
Minneapolis, poi in tutto il Paese e nel mondo, innescando una mobilitazione con
pochi precedenti. Ora il movimento, frenato negli ultimi giorni dall'inerzia e
anche dal Covid, potrebbe riaccendersi proprio da Minneapolis, dove, in quei
giorni di fine maggio, ci furono anche distruzioni, incendi e scontri con la
polizia. Chauvin, 44 anni, fu immediatamente espulso dal Dipartimento di polizia
e subito dopo la Procura lo incriminò in un primo momento per omicidio colposo.
Poi corresse il capo di accusa con il più grave «omicidio intenzionale». Vennero
accusati per concorso in omicidio anche gli altri tre agenti di pattuglia:
Alexander Kueng, Thomas Lane e Tou Thao, già rimessi in libertà a fronte di una
cauzione di 750 mila dollari. Ma da dove saltano fuori tutti questi soldi? Il
Dipartimento di polizia di Minneapolis ha fatto sapere di non aver raccolto il
denaro. Sul web era stata promossa una raccolta fondi a favore della
scarcerazione di Chauvin. Ma a quanto risulta sono stati recuperati solo 4.500
dollari. L'avvocato di Chauvin, Eric Nelson, si è limitato a confermare
all'agenzia Ap che il suo cliente è stato rilasciato ieri mattina dalla prigione
di massima sicurezza, Oak Park Heights, in Minnesota. Ma non ha aggiunto altro.
Nei mesi scorsi la famiglia di Chauvin ha venduto la casa di proprietà a
Minneapolis, ma è improbabile che il ricavato sia stato sufficiente per la
cauzione. Dalle carte giudiziarie diffuse dalla Contea di Hennepin risulta che
sia stato presentato «un bond», una specie di fidejussione che garantisce per
l'imputato. È un particolare che sta già suscitando polemiche tra gli attivisti:
chi vuole aiutare i presunti assassini di Floyd? Chauvin si dovrà presentare
davanti alla Corte nel marzo del 2021. Il suo avvocato sosterrà che la morte di
Floyd in realtà sia avvenuta per overdose di Fentanyl, un oppioide generalmente
usato per la terapia del dolore, ma ora largamente diffuso come sostanza
stupefacente. Verrà riesaminato il referto dell'autopsia, pubblicato il 29
maggio scorso dall'Hennepin County Medical Examiner. Ecco il passaggio chiave:
«L'effetto combinato tra l'immobilizzazione subita dal signor Floyd da parte
della polizia e le sue condizioni di salute precedenti e ogni potenziale
intossicazione nel suo sistema hanno probabilmente contribuito alla sua morte».
Ma la linea difensiva è aspramente contestata dalla famiglia Floyd, dalle decine
di associazioni che la stanno assistendo e, soprattutto, dal video che ha
scandalizzato l'America. Quel pomeriggio di maggio, George non oppose alcuna
resistenza. Impossibile dimenticare il ghigno di quel poliziotto, una mano in
tasca e il ginocchio premuto sul collo di un uomo inerme.
(ANSA l'11 giugno 2020) - Amazon ha annunciato che vieterà per
un anno l'uso delle sue tecnologie per il riconoscimento facciale alla polizia.
La decisione dopo le pressioni su tutte le aziende hi-tech perchè diano anche
loro una risposta agli episodi di violenza e razzismo come la morte di George
Floyd. "Esortiamo i governi a varare leggi più severe sull'uso di queste
tecnologie", spiega l'azienda.
Federico Rampini per ''la Repubblica'' l'11 giugno 2020. «Stop
the pain», fermate la sofferenza: è l'appello lanciato da Philonise Floyd,
fratello di George, nel suo intervento alla Camera dei deputati di Washington.
«Io vi chiedo - ha detto ai parlamentari - cosa vale la vita di un nero? Venti
dollari?». Il riferimento era alla banconota contraffatta che fece scattare
l'arresto di George Floyd, poi ucciso per soffocamento in un video che il
fratello ha ricordato: «Ho continuato a rivedere quelle immagini, otto minuti
che mi sono sembrati lunghi otto ore. Non si tratta così neanche un animale.
Questo è il 2020. È ora di dire basta. Tutti quelli che protestano nelle strade
ve lo dicono: basta». E ha chiesto una legge contro le violenze della polizia.
Una rivoluzione culturale, sotto il segno dell'antirazzismo, sembra soffiare
impetuosa negli Stati Uniti. Investe anche il mondo dei media vecchi e nuovi.
Fra i segnali c'è la cancellazione della 33esima stagione di una serie
televisiva accusata di apologia dei poliziotti violenti, Cops. Ci sono le
dimissioni di capiredattori di testate importanti, dal direttore delle pagine
dei commenti del New York Times ad altri nel Wall Street Journal e Philadelphia
Inquirer, in seguito a contestazioni delle loro redazioni sul taglio scelto per
le cronache o i commenti sulla questione razziale e sulle manifestazioni di
protesta. Dopo le statue di personaggi controversi abbattute, c'è la decisione
della US Navy di abolire da ogni base della marina militare le residue bandiere
confederate, cioè quelle del Sud schiavista sconfitto nella guerra civile. La
rivoluzione culturale però suscita la resistenza di Donald Trump. Il presidente
si è schierato contro un'altra iniziativa, volta a ribattezzare le basi militari
intitolate ai generali dell'esercito sudista, come Fort Bragg in North Carolina,
Fort Hodd in Texas, Fort Benning in Georgia. «Queste potenti e monumentali basi
- ha twittato Trump - sono diventate parte dell'eredità della nostra grande
storia, una storia di vincitori, di vittorie e di libertà. Abbiamo addestrato e
schierato i nostri eroi in territori sacri, e hanno vinto due guerre mondiali.
Perciò la mia amministrazione non prenderà mai in considerazione di rinominare
queste magnifiche e mitiche installazioni». La rivoluzione culturale investe da
tempo anche i social media, con il precedente di Twitter che da due settimane ha
cominciato ad ammonire gli utenti quando le affermazioni di Trump risultano fake
news o possono incitare la violenza. Ieri Trump ha attaccato Snapchat, social
media diffuso tra i più giovani, per aver rimosso dalla bacheca Discover il
profilo della sua campagna per la rielezione. Si tratta dell'iniziativa più
radicale intrapresa finora da una piattaforma digitale nei confronti di Trump e
alza ulteriormente lo scontro tra il presidente e la Silicon Valley dopo la
decisione di Twitter. Continua invece la politica di neutralità di Mark
Zuckerberg, ma all'interno di Facebook la decisione del fondatore di non
censurare Trump è oggetto di crescenti contestazioni. Un veterano delle
battaglie per i diritti civili e contro il razzismo, il reverendo Al Sharpton
che ha celebrato il funerale di Floyd, teme che la rivoluzione culturale in
corso sia una fiammata di politically correct destinata ad esaurirsi presto.
Sharpton ha lanciato l'appello per una manifestazione nazionale a Washington il
28 agosto (57esimo anniversario della marcia di Martin Luther King e del
discorso "I Have a Dream") anche per dare al movimento contro le violenze della
polizia un orizzonte temporale più lungo.
Barbara Costa per Dagospia il 12 giugno 2020. Tony Rios sta
incazzato a bestia. Lui è l’amministratore delegato di AVN Media Network, la
voce ufficiale del porno, è il megafono autorizzato, megafono dal quale si è
levata forte la condanna per l’omicidio di George Floyd. Urla Tony Rios: con che
faccia da culo noi piangiamo Floyd, quando nel porno siamo i primi ad essere
razzisti? Tony Rios non solo ha scomunicato quanto di solidale espresso dalla
sua AVN, ma dice pure che i comunicati e le belle parole servono a un cazzo,
perché se vuoi cambiare la situazione devi agire, e lui agirà: che la categoria
"interracial" e la sigla IR siano tolte dal porno, mai più devono apparire
accanto a un video e, poiché l’AVN presiede e organizza gli Oscar del Porno,
anche la statuetta quale miglior scena interracial non esisterà più. Sembra
poco, sembra niente, e invece no, se si muove l’AVN c’è da stare attenti, perché
l’AVN è un potere. La presa di posizione di un boss come Rios conta, e il suo
sputtanamento di quello che nel porno accade ma che non si può dire, non si deve
dire, è senza precedenti. È la prima volta che il porno si auto-denuncia. Il
razzismo nel porno è il vero tabù del settore, nessuno ne vuole parlare, se ne
chiedi ti rispondono che non è vero, che è vero ma insomma, comunque è meglio
starsi zitti. E invece io li voglio far parlare, i pornostar neri, vediamo che
dicono sulla loro pelle nel porno. Facciamo parlare chi è nero ed è potente,
come Lexington Steele, leggenda porno vivente, più di 1000 film, oggi a capo di
una delle case di produzione che più macinano soldi. Steele è nel porno dal 1998
e l’ha sempre detto: il razzismo nel porno esiste, perché il porno è specchio
della società e ne riflette le distorsioni. La società americana è razzista, il
porno è razzista, un razzismo che per Steele equivale a menti bigotte che ancora
campano sullo stereotipo “grande mandingo nero che corrompe la principessina
bianca”, nonché sugli stereotipi della potenza sessuale del nero che ingolosisce
le bianche, e fa invidia e rabbia ai bianchi. Miti superati, scaduti, però
ancora riprodotti nei video porno, con la compiacenza di bianchi e neri. Lo
stesso Steele è diventato una star milionaria per le sue serie porno "ebony",
volte a coprire il mercato del "black porn": “Ho girato tantissimi interracial,
anche perché mi pagavano di più. Non posso negarlo: un porno tra me e una bianca
ha più mercato di uno con una nera”. Steele dice però che solo grazie al web si
è sconfitto il razzismo che vigeva nella distribuzione, quando i porno con
attori neri non erano venduti negli stati dell’America retrograda, e quando
persino mettere in copertina un attore nero in primo piano era vietato, mentre
era d’obbligo la foto della donna bianca in posa da vittima “sporcata, deflorata
da un nero”. Steele è spietato: “Nel porno l’unico colore che conta è il verde,
quello dei dollari”, ma è proprio quello dei soldi il tasto da non pigiare mai.
Te lo dicono in coro, “attori e attrici neri sono pagati di meno rispetto ai
bianchi a parità di numero e genere di scene”, e però mai ti fanno i nomi dei
boss che adottano questa politica! Ma tale disparità retributiva deve esserci,
se l’assassinio di George Floyd ha svegliato pure l’APAC, il sindacato dei
pornoattori (guidato da bianchi), il quale ripete che non si può più stare in
silenzio, bisogna far riforme radicali, quali non si sa. Lexington Steele dice
che lui è diventato famoso “non per quello che ho tra le gambe (28 cm) ma per
quello che ho tra le orecchie”, però l’archetipo dell’uomo nero dal pene enorme
che scopa la donna bianca, è tra le scene più girate – e cliccate – nel porno.
Angela White svela che lei prima di girare un anal con Dredd (30 cm) usa un
dilatatore anale speciale, che la "apre" e la prepara apposta per lui: l’avrebbe
detto lo stesso se il pene di Dredd fosse stato enorme ma bianco? E
gliel’avrebbero chiesto? È razzista chiedere – come chiedono – a Lexington
Steele qual è la sua pornostar bianca preferita, e la sua asiatica? Perché anche
le pornostar asian hanno da dire la loro, capeggiate da Asa Akira che, prima di
diventare la regina di Pornhub, ha passato anni a girare porno fissi sulla sua
"razza", e su tutti i massage, basati sulla pretesa passività asiatica. E quando
Rocco Siffredi aveva 20 anni e iniziava nel porno, girava in Francia e lo
chiamavano “l’italianò”, lo facevano non certo per fargli un
complimento…Mandingo si è ritirato dal porno un anno fa, dopo 20 anni di porno
intensi e brillanti. La sua posizione politica è nel nome d’arte che si è
scelto: quella è la sua origine, e lui ne va fiero, e afferma: “Il razzismo nel
porno c’è, ma non siamo ai livelli di 40 anni fa! Il muro l’hanno buttato giù
pornostar neri come Sean Michaels”. Lexington Steele ha votato Barack Obama e
oggi via social posta video di Obama contro Trump, ma Obama è stato votato pure
da un repubblicano come Mandingo, secondo cui Trump non è cattivo come lo
descrivono, tantomeno è un razzista (Trump è abbastanza apprezzato nel mondo del
porno perché ha abbassato le tasse). Le nuove generazioni sono diverse, si fanno
domande diverse, certo non la mettono in chiave razziale: Sarah Banks ha 23
anni, è nel porno da 4, ha stuoli di fan devoti sui social che non guardano al
colore della sua pelle ma “a quel tuo c*lo che è speciale”. Sarah vuole
sconfiggere altri stereotipi, come la falsa idea della degradazione della donna
nel porno: lei per scelta sul set si fa spermare molto (nel sesso, in faccia,
sul corpo), e gira porno anale violento, e meglio se ad alternarsi dentro e
fuori di lei sono peni bianchi e neri. Ha già lavorato con i più bravi, tra cui
il suo mito, James Deen, che è bianco. Conta? Dice Sarah Banks: “Sono nera, e a
16 anni ero già diplomata: i neri possono essere intelligenti o cretini come
ogni altra persona. Il porno non è un ghetto, e non sono trattata male in quanto
donna, né in quanto nera”. Scegliere di vedere una scena con Sarah Banks scopata
da bianchi, sarà mica gesto razzista da parte di noi spettatori? C’è chi si
spinge a dare la colpa a noi utenti per i porno che scegliamo di vedere, perché
dovremmo essere noi, il pubblico, ad educarci e ad educare, non cliccando più
sui video interrazziali. Ma il porno è scelta la più personale e libera
possibile, e noi possiamo scegliere di vedere una gang-bang con una bianca e più
neri, come il suo contrario, come pure possiamo vedere un bianco annegato da
squirting di vagine nere. Vedere porno e quale tipo, solletica la parte di noi
la più oscura, e se c’è qualche spettatore che davvero è convinto che quella
donna nera in video "soffra" nell’essere scopata da bianchi (o il suo opposto) è
scemo lui, non chi quel porno lo fa! Perché il porno è recitato, e sono recitate
le sevizie, le donne straziate, gli uomini malmenati. Di ogni colore siano. Il
porno ha girato "12 pollici" (=30 cm), la sua parodia del film "12 anni
schiavo". È peccato guardarla? No, è porno-satira, e la satira è tale quando non
si ferma davanti a niente. Non sono d’accordo con me Jet Setting Jasmine e il
suo partner di vita e di set King Noire: loro fanno sesso BDSM, e ne insegnano
metodi e segreti. Per loro fare porno è una missione, entrambi ce l’hanno con la
società americana “che deforma i neri, inscatolandoli in ruoli che non li
rappresentano”. Per loro il sesso nero esibito a porno è una forma d’arte, è
educazione, è riscatto di una specifica identità razziale. King Noire si ispira
a Malcolm X, accusa alcuni studios porno di essere razzisti, e ha rifiutato di
girarci scene ad alimento del cliché donnina bianca/maschione nero. Ma al tempo
stesso, il porno (e il rap) gli ha permesso di dire no a un futuro da teppista a
cui il suo ambiente, e il suo censo, lo spingevano. Mi scrive un fan del porno:
“Sono un nero, guardo solo porno nero, non sopporto le pornostar bianche, mi
ammosciano”. Lui, e quello che dice e fa, è sbagliato? È razzista? Cos’è?
Dagospia il 12 giugno 2020. La BBC ha pubblicato l'estratto di
un'intervista leggendaria di Michael Parkinson a Mohammed Ali (1971). Un
passaggio divertente e con un messaggio positivo, in cui raccontava come ci si
sentiva a essere bambini di colore nell'America dell'immediato dopoguerra. Ma
l'intervista non si fermava lì, e in un'altro spezzone (da Youtube) il campione
difendeva la segregazione razziale. Ecco una dago-trascrizione e traduzione di
questa seconda e ben più controversa parte, con le frasi di Ali definite da
Parkinson ''la filosofia della disperazione'':
MA: Quando dici integrazione, questo avviene con un matrimonio,
giusto? Sono sicuro che nessuna persona bianca intelligente che guarda questo
spettacolo voglia che uomini e donne neri sposino i loro figli e le loro figlie
bianchi e avere nipoti per metà bianchi.
MP: Vorrei obiettare a questo.
MA: Beh, tu non lo faresti magari. Ma sono sicuro che molti di
loro lo farebbero. Quello che sto cercando di dire è - beh, lo dici ma sei in
uno spettacolo devi dirlo.
MP: No, non è vero.
MA: Perché vorresti farlo?
MP: Perché non penso di essere diverso da te, capisci.
MA: Oh, siamo molto diversi. Sai che siamo diversi.
MP: La società ci ha resi diversi.
MA: No, non la società. Dio ci ha resi diversi.
MP: No no. Siamo solo esseri umani. Ci ha fatti uguali.
MA: Ascolta, gli uccelli blu volano con gli uccelli blu. Gli
uccelli rossi volano vogliono stare con gli uccelli rossi. Dimmi quando sbaglio.
I piccioni volano con i piccioni.
MP: Ma abbiamo l’intelligenza.
MA: Loro non hanno intelligenza, eppure stanno insieme. Dovremmo
avere più intelligenza di loro, giusto? Tutti hanno culture diverse. Alle aquile
piace passare il tempo in montagna. Alla poiana piace volare nel deserto.
MP: Ma ci sarebbero sicuramente problemi che una poiana si
accoppiasse con un passero, no?
MA: Giusto. Ma abbiamo anche noi dei problemi. Non vedo coppie
miste in Inghilterra o in America che camminano orgogliosamente portando i loro
figli a passeggio.
MP: Questo perché la colpa è della società. Dobbiamo educare le
persone.
MA: Ma la vita è troppo breve per me per farlo. Preferisco
pensare al mio: ho una figlia bellissima, una moglie bellissima. Mi
assomigliano, siamo tutti felici e non ho problemi. E non sono così innamorato
di nessuna donna per attraversare quell'inferno. Capisci?
MP: Capisco. Ma penso che sia triste che ...
MA: E’ triste che io voglia che mio figlio assomigli a me? Ogni
persona intelligente vuole che il proprio figlio assomigli a lui. I cinesi amano
i cinesi. Amano i loro piccoli occhi a mandorla, i bambini dalla pelle marrone
chiaro. I pakistani adorano la loro cultura. Gli ebrei amano la loro cultura.
Molti cattolici vogliono sposare i cattolici perché vogliono che la loro
religione rimanga la stessa. Chi vorrebbe pensato solo a se stesso e uccidere la
propria razza? Odieresti gli altri per rimanere quello che sei. Stai dicendo che
Dio ti ha creato. Dio non ha fatto un errore facendoci come siamo.
MP: Penso che sia frutto di una filosofia della disperazione. Lo
dico davvero.
MA: Disperazione? Non è disperazione. Voglio dirti una cosa.
Ascolta. Nessuna donna su questa terra può farsi piacere cucinare per me,
socializzare e parlarmi come lo fa una donna nera americana. Nessuna donna può
davvero identificarsi con me, il modo in cui agisco e il modo in cui parlo.
E non puoi prendere nessun cinese e dargli una donna portoricana
e parlare di loro come se fossero innamorati, emotivamente innamorati e
fisicamente. Quando in realtà non sono felici perché non basta un po' di musica
portoricana, un po' di musica cinese. Si scontrerebbero continuamente.
Così Benedetto XVI ha previsto il suicidio dell’Occidente.
Francesco Boezi l'11 giugno 2020 su Inside Over.
Oswald Spengler, Martin Heidegger, Emanuele Severino, Michel Houllebecq e Joseph
Ratzinger: punti di partenza diversi, per conclusioni simili. L’Occidente,
nell’analisi di questi pensatori, è destinato al tramonto, al nichilismo
assoluto, alla sottomissione, alla scomparsa nel primato della tecnica o al
suicidio relativista. Strade teoretiche ed argomentazioni che differiscono, per
un avvenire comunque nefasto. La profezia di Benedetto XVI è nota: insistendo
sull’imminente crisi della Chiesa cattolica, Ratzinger racconta in modo
indiretto l’implosione dell’Europa. L’Ecclesia, stando alla previsione di
Benedetto XVI, è destinata a divenire minoritaria, con una riduzione
significativa del potere e del numero dei fedeli cristiano-cattolici. La
disamina del teologo tedesco è ancora oggi al centro di molte interpretazioni.
Ratzinger aveva parlato per la prima volta di crisi ecclesiastica in tempi non
sospetti, ossia nel 1969, con un’intervista rilasciata ad un’emittente
radiofonica tedesca. Ma gli scritti ratzingeriani sono densi di analisi che
riguardano il collasso della civiltà occidentale e non si concentrano solo sulla
crisi che vive Santa Romana Chiesa. Proprio i moti sessantottini, nella visione
del Papa emerito, assumono un ruolo centrale: con la promozione dei “nuovi
diritti” si è entrati in un’altra fase che mira comunque a scardinare la basi
bioetico-antropologiche del giudaismo e del cristianesimo. Quei moti trovano
oggi il loro compimento definitivo, con lo sdoganamento di leggi volte ad
attaccare la famiglia naturale. Questo, almeno, non può non essere il punto di
vista di un tipo credente che per semplificazione le cronache chiamano
“conservatore”. Anche la pandemia da Sars-Cov2 ha svelato come l’Occidente possa
doversi confrontare con sfide inaspettate, finendo col porsi domande insolite:
la querelle sul raggiungimento dell’immunità di gregge, con le polemiche che ne
sono conseguite, è forse il simbolo più evidente della battaglia che si sta
combattendo tra due visioni del mondo diametralmente opposte. Quella che vuole
salvaguardare ad ogni costo il sistema economico-sociale e quella che ritiene
gerarchicamente prioritaria la salvezza delle vite umane. Nell’ultima opera del
giornalista Giulio Meotti, un’opera centrata su Ratzinger che si intitola
“L’ultimo Papa d’Occidente?“, questi afflati sulla catastrofe culturale del
Vecchio continente sono spiegati con dovizia di particolari. Nel libro viene
posto l’accento su questa capacità previsionale di Benedetto XVI, che non si è
limitato ad una fotografia del momento ma che ha anche preso posizioni
prospettiche non ritenute ammissibili dal politicamente corretto. Alcuni
passaggi centrali della fatica di Giulio Meotti sono stati citati sul blog di
Marco Tosatti. Molto prima di essere eletto sul soglio di Pietro Ratzinger
annotava quanto segue: “Si è trovato di continuo qualche sotterfugio per potersi
ritirare. Ma è quasi impossibile sottrarsi al timore di essere a poco a poco
sospinti nel vuoto e che arriverà il momento in cui non avremo più nulla da
difendere e nulla dietro cui trincerarci”. L’imputata, ancora una volta, è la
civiltà occidentale, che ha deciso di suicidarsi sposando la dittatura del
relativismo. Oggi le tesi di Ratzinger riemergono quasi in maniera esasperata:
chi pensa che l‘Europa abbia ancora qualche chance di salvezza, si ancora
al “diritto a non emigrare”, al valore che Ratzinger attribuiva alle
mura, quindi ai confini, alla persistenza della negazione di un diritto
all’aborto, di un diritto all’eutanasia e di un diritto all’eugenetica, sino
alle parole che ogni tanto l’emerito sceglie di pronunciare in pubblico
nonostante abbia rinunciato al papato. La parabola ecclesiastica di Benedetto
XVI diviene così una sorta di metafora di un tramonto che non riguarda la sua
figura, ma quello che siamo stati e che abbiamo rappresentato, in quanto
europei, sino al matrimonio col nichilismo. Anzi, la figura di Ratzinger è una
delle poche, in ottica conservatrice, a potersi dire in grado di ergersi tra le
rovine. Il dramma nel dramma è relativo agli avvertimenti di Benedetto XVI: non
solo non sono stati ascoltati, ma sono stati direttamente rifiutati da chi
gestisce i processi del mondo contemporaneo.
Quella gran
parte d’Italia che non si commuove e non si mobilita per George Floyd.
Giampiero Casoni l'08/06/2020 su Notizie.it. C'è un'Italia che scende in piazza
per George Floyd e un'altra che alla rabbia dei manifestanti risponde con
pragmatico benaltrismo. La partecipazione emotiva è sempre stata il nostro
forte. Di pancia, diretta, disorganizzata, caciarona ma accoratissima. Un po’
croce, un po’ delizia degli italiani, che non a caso hanno inventato il
melodramma e sono melodrammatici anche quando la situazione non lo richiede.
Questo per dire che a noi un po’ ci tocca per cliché, il ruolo di quelli che
compatti o in parte maggioritaria sposano le grandi cause planetarie. Amiamo le
piazze ed il suono della nostra voce che scandisce slogan dal megafono molto più
di quanto non amiamo la polpa di quegli slogan, è un fatto. Ma nel caso
dell’omicidio di George Floyd le vernice del costume popolare che scatta in
automatico per meccanismi rodati si scrosta da sé. Perché quella è vicenda vera,
sanguinolenta e chiama in causa due cose parallele, ma non eguali, e sono due
cose immense: la legge e la giustizia. Eppure c’è una grossa, grassa fetta di
italiani che non ha saputo cogliere l’usta di uno sconcio su cui forse c’era
bisogno di puntare di più i piedi. Magari di marcare un po’ più lo sdegno, come
si fa per le cose che devono arrivare a quella parte del mondo con le orecchie
piene del cerume dell’indifferenza. È vero, da noi ci sono state manifestazioni,
e poi gli immancabili lavacri teatraleggianti sotto l’italico cielo dei flash
mob. Insomma, ci siamo messi in pari con quella parte di mondo che più o meno ha
fatto le stesse cose, ma in minimo sindacale. Tuttavia qualcosa è mancato, lo si
percepisce sottotraccia come quando ti tocca raggiungere una cima "facile" e
alla fine la conquisti ma il fiatone ti arriva prima del previsto. È un gap che
cogli dal dialogo, dalle immancabili uscite social, dal clima delle letture al
bar mentre si ciuccia il cappuccio con la mascherina sotto il mento a fare da
bavetta. Sembra quasi che gli anni di full immersion, coatta o accolta,
nel sovranismo d’accatto abbiano reso una parte di noi preconcettualmente ostile
ad ogni forma di condanna del razzismo, del sopruso gratuito, della brutalità in
divisa. E si percepisce che questo è un sentire figlio di un certo modo
di dividere la società italiana in blocchi. Sono blocchi in cui l’Ordine è un
concetto sacrosanto, che si oppone al Caos e che quindi contiene già in sé tutti
i germi della sua auto assoluzione. Va da sé dunque che chiunque incarni e
materialmente vesta i panni di quell’ordine sia membro di una nuova casta,
intoccabile o scalfibile solo superficialmente, anche quando le sue singole
aberrazioni scrivono le pagine buie della storia. Ci stanno cambiano l’anima,
non ce ne stiamo accorgendo ma, anche a ricusare le tesi politiche di chi di
certe idee fa totem, noi italiani siamo di fronte ad uno dei grandi bivi del
nostro genio nazionale. Eravamo faciloni ma empatici e stiamo diventando tignosi
e anaffettivi. Eravamo idealisti urlanti ed ora siamo pragmatici benaltristi,
che contrappongono al caso Floyd i reati commessi dai neri qui da noi. E che
all’idea somma di una giustizia giusta schiaffano in contrappunto le frange più
compromesse della magistratura italiana. Come se certe bilance ci togliessero il
segnale dalle antenne puntate sulle brutture del mondo. Come se funzionassero da
livella per quella fame di giustizia che ormai, da qualche anno, ci vede in
buona parte anoressici.
Gli
ipocriti in ginocchio.
Pietrangelo Buttafuoco su Il Quotidiano del Sud il 6 giugno. Atterrisce il
potere della correttezza ideologica. Domina perfino i riflessi mentali. In tutto
il mondo si registra, giustamente, partecipazione verso l’inerme George Floyd,
soffocato da un poliziotto che gli schiaccia il collo togliendogli il respiro.
L’americanismo, si sa, ha le sue controindicazioni ma l’ipocrisia dei
benpensanti nostrani simbolicamente inginocchiati per solidarietà, porta a un
cattivo pensiero, giusto una domanda: come mai non si sono inginocchiati quando
sono stati uccisi altri afro, forse perché alla Casa Bianca c’era Barack Obama e
non, come adesso, il marito di Melania?
Pugni chiusi e genuflessi. Marcello
Veneziani, La Verità 12 giugno 2020. Se i simboli e i riti vogliono dire
qualcosa e raccontano la realtà più dei fatti e delle parole, quei pugni chiusi,
quelle città messe a ferro e fuoco dagli antifa, quella parodia di religione con
la genuflessione e la stola arcobaleno al collo e i minuti di penitenza in
ginocchio, vogliono dire che una nuova religione fanatica e un nuovo comunismo
stanno sorgendo in Occidente. Una religione preterintenzionale, al di là delle
intenzioni di chi l’abbraccia: per tanti che si sono inginocchiati in favore di
telecamera e hanno simulato un rito religioso, c’era un obbiettivo più basso:
schiacciare sotto un ginocchio, il Nemico, la Bestia, Donald Trump. Tutta una
messinscena mondiale perché si avvicinano le elezioni. Si rovescia su Trump un
brutale assassinio di cui non ha alcuna colpa, un assassinio come tanti della
polizia americana, sotto amministrazioni democratiche e repubblicane.
Altrettanti, va pure detto, ne subisce la polizia americana, ad opera della
delinquenza. Perché l’America resta una società violenta, a tratti selvaggia,
sotto la crosta di progresso, tecnologia, ciccia e lattine. Inginocchiarsi per
una vittima, quando ogni giorno la delinquenza comune, la persecuzione religiosa
e le dittature ne uccidono migliaia, è solo malafede. Ma una religione si va
formando nelle società occidentali intorno al catechismo politically correct.
Quella religione è il supporto morale di qualcosa di colossale che sta avvenendo
nei nostri giorni, sopra le nostre teste e sotto i nostri occhi. Quel che per
anni è stato definito Pensiero Unico sta diventando Potere unico. Come ogni
sistema totalitario si fonda su un assoluto: nel nostro caso è l’assoluto
sanitario, l’imperativo di salvarci la pelle a ogni costo. Proteggerci dal male,
amen; il male è il contagio. Ma la pandemia si presenta in due forme: il covid e
il fascio, cioè il virus e l’insubordinazione in forma di assembramento,
protesta sociale, obiezione di coscienza al vaccino, alle restrizioni più
assurde, al tentativo di renderle permanenti e alle profilassi più fanatiche e
insensate. I dogmi imposti dalla scienza e dai virologi sono usati dal potere
per allargarsi e durare il più possibile. Il modello implicito è la fonte stessa
del virus, di cui ogni giorno si scoprono le gravi responsabilità: la Repubblica
totalitaria cinese. Contagio e omertà, restrizioni conseguenti e durature,
popolazioni militarizzate, controllo totalitario e molecolare, divieto di
manifestazione, repressione del dissenso, uso totalitario della scienza e della
tecnologia, dominio commerciale globale; e sullo sfondo il comunismo come
orizzonte. Il modello cinese diventa il paradigma in Italia e in alcuni settori
progressisti occidentali. Dopo decenni di collusioni tra capitalismo e
radical-progressismo, ora si delinea, a viso aperto, quel connubio: il ponte tra
capitalismo e comunismo è l’uso imperativo della scienza e l’applicazione
totalitaria del controllo. Il fine, come nel comunismo, è sempre il bene
dell’umanità, il mondo migliore, l’uomo nuovo, magari transumano per essere più
nuovo. Di dittatura sanitaria ne parlai agli inizi di marzo, quando si stava
appena profilando. L’Italia stava candidandosi a diventare il paese pilota, la
cavia di laboratorio per l’esperimento. Oggi, dopo tre mesi di pratica, le
analisi e le denunce in questo senso sono tante. Vorrei citare due filosofi
diversi tra loro e ambedue lontani dal pensiero reazionario,
cattolico-tradizionalista o addirittura fascista. Mi riferisco a Giorgio
Agamben che denuncia l’inquietante connubio tra religione medica e capitalismo,
alla base di un nuovo sistema totalitario, incline a sospendere la libertà e la
democrazia; la religione cristiana e in particolare la Chiesa di Francesco
soccombe ai loro diktat sanitari e ritiene la salute prioritaria rispetto alla
salvezza. Da altri versanti, un giovane filosofo, Michel Onfray, che teorizzò
l’ateismo e criticò la religione, denuncia ora, sulla scia di Orwell, l’avvento
di una dittatura globale fondata su sette comandamenti: distruggere la libertà e
ridurre a fascisti tutti i dissidenti e gli insubordinati; impoverire la lingua
per manipolare le menti; abolire la verità tramite il bipensiero; sopprimere la
storia e riscriverla per gli usi del presente; negare la natura, a partire dalla
natura umana; propagare l’odio e fondare l’Impero, progressista e nichilista.
Non resta, per Onfray, che darci all’ateismo sociale per non “inginocchiarsi”
davanti ai nuovi dei arcobaleno. Usa proprio il verbo inginocchiarsi, non
sapendo dell’uso mistico-elettorale di questi giorni, scimmiottando la religione
(il diavolo, per la Bibbia, è simia dei, scimmia di dio). Entrambi, Agamben e
Onfray, denunciano la matrice teologica del nuovo totalitarismo, il tentativo di
sostituire dio con una nuova divinità. I nuovi fanatici si chiamano antifa,
contrazione global di antifascisti; e il fatto che l’elemento di odio – anti –
sopravviva al sostantivo, la dice lunga. Il nemico globale è Trump, il nemico
complementare è Putin, il nemico ideologico è tutto ciò che viene definito
sovranismo. Il piano prevede tre sostituzioni: la fede medico-progressista al
posto della fede in Dio, sacra e trascendente; la popolazione mobile dei
migranti al posto di popoli o nazioni restanti; il postumano secondo scienza e
volontà al posto dell’uomo secondo natura e procreazione. Non c’è un piano
globale prestabilito e non ci sono pianificatori; alcuni vi concorrono
consapevolmente, molti inconsapevolmente. L’Italia per la sua fragilità, la sua
teatralità, il trasformismo e il servilismo, l’impreparazione del governo, il
residuo ideologico depositato dal comunismo e dall’antifascismo, è il tampone
esemplare. Da noi la cialtroneria, come già scrivevamo, tempera il totalitarismo
nell’inefficienza e nella comicità. Ma il pugno chiuso è nemico della mente
aperta. MV, La Verità 12 giugno 2020
Con gli inchini l’Occidente muore di nichilismo.
Andrea Amata, 12 giugno 2020 su Nicola Porro.it. Si sta operando un’impropria
sanificazione identitaria per rendere asettica la nostra memoria, sottoponendola
alla depurazione del politicamente corretto. Una furia iconoclasta vorrebbe
smantellare tutto ciò che non è allineabile alla narrazione antirazzista che
occulta una becera natura discriminatoria. L’assassinio di George Floyd ha
scatenato proteste che si sono declinate nei saccheggi delle città americane e
nella devastazione delle icone marmorizzate in statue come quella di Cristoforo
Colombo a Richmond (Virginia) e di Winston Churchill a Londra. Strumentalizzare
la morte dell’afroamericano Floyd per demolire i simboli della civiltà
occidentale è espressione di analfabetismo e oscurantismo storico, che non onora
la vittima del poliziotto di Minneapolis Dereck Chauvin, semmai se ne serve per
conferire legittimazione morale ad azioni vandaliche che contraddicono la
presunta matrice antirazzista dell’organizzazione Black lives matter.
L’assassino di Floyd è stato giustamente arrestato, ma far discendere dalla
responsabilità individuale dell’episodio criminale una generalizzazione, che
implica la correità universale dell’uomo “bianco”, significa applicare
un’aberrazione logica. Per giunta, le statistiche ci informano che le “vittime”
della polizia statunitense sono in maggioranza maschi bianchi da cui non si
evince un accanimento razzista sugli afroamericani. Quando Pamela
Mastropietro fu barbaramente stuprata e il suo corpo vilipeso e smembrato dal
nigeriano Oshegale, non venne tramutato il reato personale in una responsabilità
collegiale degli africani. In base alle deduzioni arbitrarie di Blm la
responsabilità personale dell’omicida è stata convertita nella imputabilità
generica dei “bianchi” con un eccesso di semplificazione che esonda nel
pregiudizio. L’inginocchiatoio mediatico, allestito nella teatralità ipocrita
della solidarietà verso i presunti discriminati, ha reclutato nell’omologante
trending topic i soliti radical chic in versione salottiera. Non è stato il
genere umano a pigiare il ginocchio sul collo di Floyd, ma l’agente di
polizia Chauvin è stato l’autore del delitto che la legge americana ha
incriminato per la sanzione che merita. Le sceneggiate dell’inchino collettivo
confessano una subalternità culturale al nichilismo che come un rullo
compressore vuole nullificare la storia. Il movimento Antifà Black lives matter
con la demolizione dei monumenti innalzati a Churchill e Lincoln, simboli della
lotta al nazismo e alla schiavitù, dimostra di frodare la storia a cui non
riconosce il contributo dell’uomo “bianco” nel processo di affermazione della
libertà e di emancipazione di quelle che erano considerate minoranze. Chi si
rifiuta di inginocchiarsi alla narrazione mistificante rischia di essere
accusato di negazionismo o di collateralismo al Ku Klux Klan, equiparando il
dissenso all’apologia suprematista. Sta dilagando una propaganda anti-americana
nel tentativo di identificare Donald Trump come emanazione dei bassi istinti
razzisti. Il radicalismo politico si è impossessato del corpo esanime di Floyd,
elevandolo a simbolo asservito alle allucinazioni dell’ideologia antifascista
che infierisce sulle icone del passato, come sir Winston Churchill, che hanno
salvato l’occidente dalla repressione nazista. Nel clima suggestionato dal
pericolo illusorio del razzismo giungono notizie plasmate dal politicamente
corretto con il servizio streaming di Hbo che ha ritirato dal catalogo on-line
il film Via col vento per le “raffigurazioni razziste” e con la catena svizzera
di supermercati Migros che ha deciso di rimuovere dagli scaffali il prodotto
dolciario denominato “Moretto”. Tale ubriacatura dettata dal pensiero unico
rischia di far sbandare la civiltà occidentale che deve reagire alla
somministrazione di plateali idiozie. Dimostriamo di essere astemi e di non
berci il distillato dell’omologazione culturale che provoca sbornie suicide
destinate a spegnere la nostra identità. Andrea Amata, 12 giugno 2020
Giuseppe Fantasia per huffingtonpost.it il 12 giugno 2020.
Vengono distrutte le statue di coloro che si sono macchiati di razzismo o
imperialismo. Anche Cristoforo Colombo è ormai nella lista dei cattivi. Per
Achille Bonito Oliva, celebre critico d’arte, accademico e saggista, 81 anni il
prossimo novembre, ”è un atteggiamento che potremmo definire ‘politicamente
corretto’, ma che in realtà è solo scorretto, perché all’uccisione fisica
succede l’uccisione dell’arte e della cultura. C’è questa imitazione alla
violenza che non pareggia nulla, perché vince sempre la morte”. Conversando con
l’Huffpost, Bonito Oliva spiega che “facendo ciò pensano che sia un modo di
smascherare il razzismo anche storico dello scopritore dell’America come degli
altri colonizzatori. Pensano di punire la Storia, ma è patetico, perché quelle
sculture hanno una perennità per la loro qualità artistica. Nell’arte non
esistono solo i contenuti, non esiste solo la narrazione, ma anche l’apparizione
e la forma che è poi quella che dà durata all’opera. Questa uccisione postuma di
Cristoforo Colombo attraverso la statua, la ritengo patetica e infantile”. Da
Minneapolis - dove il Black Lives Matter è ripartito dopo la brutale uccisione
di George Floyd per mano della polizia – a Boston, da Saint Paul a Richmond, in
Virginia, dove la statua di Colombo, colui che “rappresenta il genocidio”, come
è stato scritto su un cartello, è stata buttata giù dal suo piedistallo nel Byrd
Park dai i manifestanti, incendiata e poi gettata nel lago del parco. Atti di
vandalismo ci sono stati anche in Regno Unito e in Belgio, mentre in Italia è
finita nel mirino l’effige di Indro Montanelli. “Era un uomo politicamente
prudente e moderato”, spiega Bonito Oliva. “Sembrava che tifasse per la destra,
ma questo non c’entra, perché in ogni caso atti come questi sono tutte vendette
postume e frutto di ignoranza e di un atteggiamento pericoloso di populismo
culturale”. Anche Roma, Sabaudia e molte altre città italiane con elementi di
architettura fascista potrebbero rischiare di vederli danneggiati, gli
chiediamo. “Esiste un’architettura razional-fascista di altissima qualità”,
risponde lui. “Quando vedo il Foro Italico non penso a Mussolini, perché quella
è un’architettura compiuta e volta a coniugare il lato progettuale – quindi la
razionalità – con l’enfasi legata alla celebrazione dei miti di Roma. Ritengo
assurdo giudicare, censurare e mettere a morte l’arte, anche questa - aggiunge -
perché è arte. Imitare per ricompensare il delitto di Minneapolis è
ingiustificato. Andrebbe stigmatizzato tutto il corpo della Polizia americana
che ha assunto una violenza indicibile. Oramai il suo stile è quello”. Nell’arte
– precisa - non dovrebbe esserci questo. L’arte è un massaggio del muscolo
atrofizzato della sensibilità collettiva. L’arte ci tiene svegli e ci
sensibilizza. Se invece, usiamo per l’arte lo stesso sistema del quotidiano, la
violenza, l’omicidio, lo spossessamento eccetera, si arriva al massacro, alla
fine dell’umanità. Tutto questo lo ritengo molto pericoloso, ma quello che è più
grave è che attraverso i social c’è una diffusione, un’imitazione del
comportamento, un’incoscienza inammissibile”. “Se non fermiamo questo trend, il
principio dell’imitazione – quello di imitare attraverso gesti simbolici la
negatività della vita, della storia, di eventi del passato – arriveremo alla
distruzione di tutto. È un modo triste di progettare il passato, di utilizzare
le forma simboliche del passato per punire peccati storici. Si si pensa che
facendo questo ci potrà essere l’emancipazione e un futuro garantito – conclude
– si sbaglia, perché ci sarà solo uno sbarramento”.
Nicola Porro sulla manifestazione a Bologna: "In ginocchio per
George Floyd ma scordano i nostri cassintegrati".
Libero Quotidiano il 07 giugno 2020. La rabbia di Nicola Porro si riversa contro
la manifestazione avvenuta a Bologna sabato 6 giugno, organizzata da Arci Ritmo
Lento, Amici di Piazza Grande, Link, Coalizione Civica e a cui hanno partecipato
anche le Sardine. Un flash-mob per George Floyd, l'afroamericano brutalmente
ucciso da un agente di polizia a Minneapolis e per cui si manifesta un po' a
tutte le latitudini del globo. E nella sua Zuppa di Porro di domenica 7 giugno,
Nicola Porro punta il dito: "Per capire questo Paese basta vedere la prima
pagina del Corriere di Bologna e la retorica della piazza con tutti gli
assembrati in ginocchio per George Floyd ma non in ginocchio davanti alle 800
mila persone che non hanno ancora ricevuto la Cassa Integrazione", picchia duro.
Già, tutti - e giustamente - in ginocchio per George Floyd. Ma nessuno, in
quella piazza, pensa al dramma dei nostri connazionali, dei cassintegrati a cui
il coronavirus ha rovinato la vita e il futuro.
(ANSA il 7 giugno 2020) - La protesta che sta infiammando gli
States sbarca a Roma: a migliaia, soprattutto ragazzi e famiglie, stanno
manifestando a Piazza del Popolo contro ogni razzismo. In tantissimi hanno
accolto l'appello sui social, lanciato da un vasto cartelli di organizzazioni
tra cui i Giovani Europeisti Verdi, Fridaysforfuture-Roma, NIBI : Neri italiani
- Black italians, 6000 sardine, Extinction Rebellion Rome International,
American Expats for Positive Change e Women's March Rome. Distanziati e tutti
con la mascherina, i manifestanti, tantissimi i ragazzi di colore con la
maglietta nera, hanno portato ognuno dei cartelli fatti in casa, sul modello
americano, con su scritte le parole d'ordine della campagna esplosa dopo
l'omicidio di George Floyd. Tante le scritte soprattutto in inglese come, "No
justice, no peace", "I can't breath", "Defund the police", "fuck racism". Ma
anche alcuni cartelli che chiedono "ius soli" e diritti per i migranti. Su uno
di loro, "Muoiono a casa nostra e non sappiamo nemmeno i loro nomi: black lives
matter". Non c'è un palco, ma solo un microfono dal quale si alternano gli
interventi degli organizzatori, alcuni di loro in inglese.
La storia
di Adnan, il "George Floyd italiano" ucciso a coltellate in silenzio.
Giulio Cavalli su Il Riformista il 9 Giugno 2020. Adnan Siddique è stato ucciso
la sera del 3 giugno nel suo appartamento, in via San Cataldo a Caltanissetta.
Viveva in Pakistan, a Lahore, una cittadina di 11mila abitanti con suo padre,
sua madre e i suoi 9 fratelli. Adnan era la punta di diamante su cui la sua
famiglia aveva investito tutto, tutto quel poco che ha, perché trovasse fortuna.
Aveva 32 anni e in Italia lavorava come manutentore di macchine tessili. Era
molto conosciuto in città, tutte le mattine passava al bar Lumiere per un caffè
e i gestori del locale lo raccontano come un ragazzo pieno di sogni e di
preoccupazioni. Quali preoccupazioni? Avere cercato giustizia per un gruppo di
connazionali che lavoravano nelle campagne da sfruttati come capita in tutta
Italia, da nord e sud. Adnan si era messo in testa di liberare i suoi amici
dallo sfruttamento e aveva addirittura accompagnato uno di loro a sporgere
denuncia. Troppo, per qualcuno che evidentemente continua a credere che la
schiavitù sia qualcosa di cui scrivere e parlare solo quando si svolge lontano
da noi. Era stato minacciato più volte e non era tranquillo. Aveva anche
denunciato le minacce ma evidentemente non è bastato. Adnan è stato ucciso con
cinque coltellate: due alle gambe, una alla schiena, una alla spalla e una al
costato. Quella al costato, secondo la perizia sul cadavere, gli è stata fatale.
Sono bastate poche ore anche per trovare l’arma, un coltello di circa 30
centimetri. Ci sono anche quattro pakistani fermati per l’omicidio, un quinto è
accusato di favoreggiamento. «Una volta è stato pure in ospedale – racconta la
famiglia Di Giugno, titolare del bar frequentato da Adnan – lo avevano
picchiato». Jaral Shehryar, pakistano di 32 anni, titolare di una bancarella di
frutta e verdura, racconta: «Era bravissimo, gentile, quelli che lo hanno ucciso
no. Si ubriacavano spesso. Qualche volta andavano a lavorare nelle campagne ma
poi passavano il tempo ad ubriacarsi e fare baldoria». Anche suo cugino Ahmed
Raheel, che vive in Pakistan e con cui Adnan Siddique si era confidato, sembra
avere le idee chiare: «Aveva difeso una persona e lo minacciavano per questo
motivo – riferisce all’Ansa – Voleva tornare in Pakistan per la prima volta dopo
tanti anni per una breve vacanza ma non lo rivedremo mai più. Adesso non
sappiamo neanche come fare tornare la salma in Pakistan. Noi siamo gente povera,
chiediamo solo che venga fatta giustizia». Il presidente dell’Arci di
Caltanissetta Giuseppe Montemagno chiede che «si faccia piena luce sui motivi
alla base dell’omicidio di Adnan Siddique e sulla diffusione dello sfruttamento
dei braccianti agricoli nelle campagne tra le provincie
di Caltanissetta ed Agrigento. Oltre ai responsabili materiali – chiede il
presidente dell’Arci – dell’atroce delitto chiediamo agli inquirenti di
accertare quali siano le proporzioni del fenomeno del caporalato nel territorio
nisseno ed individuare eventuali altri responsabili». Perché la storia di Adnan,
al di là di quello che accerterà l’autorità giudiziaria sta tutta nelle pieghe
di un caporalato che sembra non avere paura di nessuno, che continua a cavalcare
impunito interi settori dell’agroalimentare e che tratta gli stranieri in
braccia. Tutti sono solo le loro braccia: le braccia per raccogliere la frutta e
la verdura e le braccia da armare per punire un connazionale che ha deciso di
alzare troppo la testa. E in questi tempi in cui da lontano osserviamo
gli Usa che si ribellano al razzismo forse sarebbe il caso di cominciare a
osservare anche le profilazioni che avvengono qui da noi, dove l’essere
pakistano ti relega al campo o sul cantiere senza il diritto di avere diritti,
dove una storia di violenza che si trascina da tempo finisce per essere
sottostimata dalle Forze dell’ordine e da certa stampa, dove un omicidio non
merita nemmeno troppo di finire in pagina perché anche se parla un’altra lingua
in fondo parla di noi. Parla tremendamente di quello che siamo.
Pd in ginocchio per Floyd, lite in aula: "Lo avete fatto per
Pamela?" Le repliche piccate alla messa in scena dei
Dem dopo il discorso di Laura Boldrini. Fdi attacca: "Lo avete forse fatto per
Pamela, per gli agenti che sacrificano la loro vita per proteggerci o per gli
italiani che si suicidano a causa della crisi?" Federico Garau, Martedì
09/06/2020 su Il Giornale. Ha scatenato un vero e proprio putiferio in
Parlamento, lasciando un'inevitabile lunga coda di polemiche, la teatrale messa
in scena seguita al discorso tenuto dall'ex deputata di Leu (ora tra le fila del
Pd) Laura Boldrini. Alla conclusione dei lavori, durante la serata di ieri, l'ex
presidente della Camera si è resa protagonista di un intervento per ricordare la
morte di George Floyd e condannare razzismo e discriminazioni di ogni genere.
Fin qui tutto nella norma, tuttavia il bello doveva ancora arrivare. Una volta
terminato il discorso della collega di partito, infatti, alcuni deputati del Pd
si sono inginocchiati, copiando con la carta carbone quella particolare forma di
protesta nata proprio negli Stati Uniti per contestare in modo pacifico i fatti
di violenza e di sangue attribuiti all'odio razziale, tra i quali è stato fatto
rientrare anche l'episodio di Minneapolis. "Sono qui a chiedere se ieri sera si
sono rispettati i regolamenti della Camera dei deputati quando a fine seduta
abbiamo visto occupare genuflessi l'emiciclo da alcuni deputati per la vicenda
di Floyd, che riguarda un'altra nazione ed un'altra situazione. Quella messa in
atto ieri dalla collega Laura Boldrini e da altri deputati del Pd è
una sceneggiata che squalifica anche la stessa lotta al razzismo", ha attaccato
stamani all'apertura dei lavori il deputato di Fratelli d'Italia Giovanni
Donzelli. "Vede, Presidente, non abbiamo visto nessuno inginocchiarsi quando è
stata uccisa Pamela, quando le forze dell'ordine si sacrificano per difendere il
popolo italiano o sono costrette al suicidio perchè abbandonate dallo Stato",
prosegue Donzelli. "Non abbiamo visto nessuno inginocchiarsi per gli italiani
che si sono tolti la vita per la crisi seguita al Coronavirus. Ma hanno fatto
bene a non inginocchiarsi, perchè in quest'aula non ci si inginocchia, si sta in
piedi e si risolvono i problemi degli italiani. Basta sceneggiate, non servono",
conclude. Dai banchi del governo si sono levati fischi e mugugni, come
d'altronde era ovvio attendersi. "Trovo incredibilmente strumentale che ogni
volta che si parla di questi temi l'aula si debba dividere, quando invece
il razzismo, la violenza, l'intolleranza dovrebbero unire tutti", replica Lia
Quartapelle del Pd. "Troppe volte si fanno dei distinguo incomprensibili e io
sono orgogliosa di far parte di un gruppo parlamentare che ieri ha voluto unirsi
alle piazze di tutto il mondo e sono orgogliosa si essermi inginocchiata in
segno di rispetto per chi soffre, anche in Italia, per le violenze e le
discriminazioni che avvengono tutti i giorni". Nicola Fratoianni di Leu cavalca
l'onda del razzismo per attaccare il deputato Fdi e difendere il gesto dei
colleghi. "Sono molto colpito dalle parole di Donzelli. Io trovo piena di
dignità e di rispetto per i valori di quest'aula l'iniziativa assunta ieri dai
miei colleghi. Definire una 'sceneggiata' quella scelta, continua a rimuovere il
gigantesco problema degli abusi e delle violenze, la cui origine è una sola:
l'odio razziale, il disprezzo per la diversità. Essere militanti,
quotidianamente, contro il razzismo è la più alta forma di rispetto nei
confronti del Parlamento". Anche i CinqueStelle entrano nella bagarre, prendendo
le parti dei colleghi con cui hanno messo in piedi la
maggioranza giallorossa. "Quando si condanna il razzismo bisogna sapere bene da
che parte stare. Il gesto fatto ieri sera deve essere rispetto e ci si deve
unire a quel gesto. Solo chi è in cattiva fede può fare interventi di un certo
tipo", afferma Giuseppe Brescia, presidente della commissione Affari
Costituzionali. La replica della Lega è affidata a Paolo Formentini. "Ieri siamo
rimasti basiti. Ma un conto è condannare in modo inequivocabile il razzismo e la
morte violenza di George Floyd, condanna alla quale ci uniamo. Un altro è dire,
come ha fatto Boldrini, che le manifestazioni si sono svolte con tranquillità,
perché non è vero. Basta ricordare le devastazioni e le violenze che abbiamo
visto nelle varie città degli Stati Uniti dopo la morte di George Floyd".
"Condanniamo il razzismo sempre, senza se e senza ma.Tuttavia la sinistra
continua e dividere il mondo in buoni e cattivi e loro, guarda caso, stanno
sempre dalla parte dei buoni", affonda Giorgio Silli di Cambiamo. "Che
ragionamento è dire che chi non si inginocchia non condanna il razzismo? Sarebbe
come dire che per essere antifascisti, occorre essere iscritti all'Anpi. Questi
sono modi di ragionare fuorvianti, che allontanano le persone dalla lotta al
razzismo o al fascismo", conclude. Una polemica che non pare tuttavia sopita, e
che avrà ancora degli strascichi.
La lezione
dello zio di Pamela: "Cosa non sa chi sta con Floyd".
Lo zio di
Pamela Mastropietro si è inginocchiato nei pressi della palazzina di via
Spalato, dove è stata trucidata la nipote, per lanciare un messaggio simbolico:
"Tutte le vite sono importanti, sogno il giorno in cui ci si inginocchierà per
qualsiasi vita ingiustamente portata via da questa terra". Elena Barlozzari,
Giovedì 11/06/2020 il Giornale. Si è inginocchiato assieme al resto della
famiglia davanti ad un grosso pino marittimo. Un vecchio albero che svetta tra
le palazzine di via Spalato, a Macerata. Sulla corteccia c'è inciso il nome di
sua nipote: Pamela Mastropietro, trucidata una notte di tre anni fa dal pusher
nigeriano Innocent Oseghale in un appartamento che si trova proprio su quella
strada. È un gesto simbolico, che Marco Valerio Verni, zio della vittima, spiega
così ai nostri taccuini: "Tutte le vite dovrebbero essere ritenute importanti.
Non solo alcune, a seconda della convenienza politica, mediatica o di altra
natura".
A distanza di
più di tre anni dalla morte di Pamela, sente di aver ricevuto giustizia?
"I dubbi sono
ancora tanti. Rispetto il lavoro degli investigatori, ma ci sono ancora troppi
punti da chiarire."
Quali?
"Oseghale non
può essere l’unico colpevole. È impossibile. Nella catena di eventi che parte
dall’allontanamento dalla comunità a doppia diagnosi dove era ricoverata e
arriva sino alla sua demoniaca fine ci sono dei coni d'ombra. Questo è il
classico caso in cui la verità storica è quella processuale rischiano di non
combaciare."
Perchè oggi si
è inginocchiato di fronte all'albero di Pamela come fa chi manifesta al grido
di black lives matter?
"Per lanciare
un segnale: tutte le vite dovrebbero essere ritenute importanti. Non solo
alcune, a seconda della convenienza politica, mediatica o di altra natura."
Che effetto le
ha fatto vedere le piazze italiane piene per Floyd?
"Rispetto chi
manifesta per lui. Anche io ho trovato assurda la sua morte. Anzi, uccisione.
Certo, mi sarebbe piaciuto vedere la stessa mobilitazione per mia nipote e per
denunciare altre vicende orrende".
Secondo lei
come mai nel nome di Pamela le piazze non si sono riempite?
"La storia di
Pamela è la sintesi di diverse tematiche scomode per una certa cultura, la
stessa che adesso spinge le folle nelle piazze."
Cosa c’è di
scomodo nella storia di una ragazza trucidata?
"L'immigrazione irregolare prima di tutto. È un fenomeno sul quale lucrano in
tanti, spesso nascondendosi dietro al dovere umanitario di accogliere chi ha
bisogno. Un principio che, se fosse diretto ad offrire protezione a chi
veramente fugge dalle guerre, sarebbe sacrosanto. Peccato però che attraverso i
flussi migratori, gestiti da vere e proprie organizzazioni criminali
transnazionali, arrivino anche tanti delinquenti, con tutto quello che ne
consegue in termini di violenza e degrado sociale. Molti hanno paura di essere
tacciati di razzismo anche solo affermando questa verità, eppure le prime
vittime spesso sono proprio i migranti, trattati alla stregua di vera e propria
merce di scambio o, per meglio dire, di schiavi."
L'ha stupita
vedere come qui da noi abbia destato più clamore un fatto di cronaca avvenuto
oltreoceano piuttosto che il caso di sua nipote?
"Purtroppo no,
qui da noi, rispetto ad una ragazza violentata, uccisa con due coltellate,
depezzata chirurgicamente, scarnificata, esanguata, asportata di tutti i suoi
organi interni, lavata con la varechina, messa in due trolley ed abbandonata sul
ciglio di una strada, ha fatto quasi più scalpore l'uovo lanciato nell'occhio
delle discobola Daisy Osakue. Fatto anch’esso da condannare, ma di cui è chiara
a tutti la diversa drammaticità rispetto al primo."
Un gruppo di
deputati del Pd, tra cui Laura Boldrini, si è inginocchiato alla Camera. Cosa ne
pensa?
"La Boldrini è
libera di fare quello che vuole, ci mancherebbe. Ma ricevo tanti messaggi di
gente che mi chiede e si domanda come mai la stessa attenzione non si sia avuta
proprio per Pamela, o per altri casi in cui il carnefice, o i carnefici, erano
di colore."
La trovata è
stata stigmatizzata dalle opposizioni...
"Beh, mi ha
fatto piacere che qualcuno si sia ricordato di Pamela, ma la memoria dovrebbe
essere costante e soprattutto democratica. Sogno il giorno in cui ci si
inginocchierà per qualsiasi vita ingiustamente portata via da questa terra,
secondo il concetto che all lives matter."
Natalia Aspesi per "la Repubblica" l'11 giugno 2020. Saremo tutti
rincitrulliti, come pensano i noiosi irresponsabili della Hbo e altre anime
buone, al punto che a scoprire o rivedere per la centesima volta Via col Vento
potremmo trovare carino il razzismo e non poi così grave che un poliziotto
bianco ammazzi un nero soffocandolo col ginocchio o in altre occasioni a calci o
fucile o fuoco, o ai tempi in cui è situato il film, con l'impiccagione? Forse
no, a voler pensare bene anziché male, si potrebbe credere a una vendetta degli
Oscar (o della Corea del Sud) contro il solito presidente Trump che se non
urlasse sempre sarebbe meglio, per averlo citato alla vittoria di Parasite «Che
viene da un paese con cui abbiamo problemi commerciali! », come esempio di film
americano e degno di essere premiato (a suo tempo, 9 Oscar). Si è trovato
finalmente il responsabile dei disordini razziali sempre più gravi negli Stati
Uniti, ed è questo film anziano, che compie adesso 81 anni, i cui primi
entusiasti spettatori probabilmente sono tutti defunti, e che in Italia arrivò
nel dicembre del 1951, assieme ai reggipetti a punta, alla cucina all'americana
e alle notizie sulle impiccagioni di neri da parte del KKK: impazzimmo, noi
fanciulle di allora, e mai sazie delle sue crinoline e chissà perché del pallido
e casto Leslie Howard, continuammo a milioni nel mondo a vederlo, tanto da
fargli incassare 3,44 miliardi di dollari. Avevamo già divorato prima della
guerra, nel 1937, il favoloso romanzo di Margaret Mitchell, ma sinceramente sia
del libro che del film ci parevano molto secondarie, irrilevanti, sia la guerra
civile che la presenza degli schiavi, perché per noi era solo la storia
appassionante di una birichina e di un seduttore, di una moglie santa e di un
marito dolorosamente fedele e della certezza di un futuro d'amore. Non si
cercava altro in una storia e certo rivedendo adesso Via col vento forse ci
sfuggirebbe ancora una lacrima di beatitudine: non avendo del tutto perso né il
senno né qualche accenno di storia, credo che malgrado le paure Hbo, non
riusciremmo a collegarlo a "Blak Lives Matter". Il famoso dileggiato buonismo è
del tutto fuori moda, un reperto dell'accoglienza e della comprensione, e forse
è la causa del cattivismo, del solo insulto, della sola rabbia e della sfiducia
in tutto. E soprattutto di un moralismo che da una parte organizza incontri
contro la legalizzazione dell'aborto, e dall'altra vuole condurci su un'altra
retta via, oscurando ogni tentazione cattiva, anche se molto romantica. Povera
Rossella, da noi invidiatissima per via del vitino di 40 cm.! E povero Red
Butler che a vederlo adesso pare Salvini, uno entusiasta del "Prima gli
italiani" (purché bianchi). C'è questa voglia di censura, una smania di
cancellare il passato che non si adatta alle paure del presente, la negazione
della storia, una pericolosa chiusura nel qui ed ora, da noi nei confini non
tanto di una nazione, ma delle regioni, e tra un poco potrebbe esser di valle in
valle. La storia va dimenticata, non serve, si potrebbe cancellare anche a
scuola, non c'è stata la schiavitù in America, e in Italia il fascismo ha fatto
cose buone. Ma chi vuole oscurare il passato ha un grande pubblico consenziente,
che non vuole sapere né pensare e affida la sua ignoranza e fragilità non tanto
a chi lo salva da un film senza peccato ma a chi offre una verità pronta, da
accettare senza riserve. Dal film certo era ed è tuttora impossibile eliminare i
neri in quanto schiavi, perché proprio la loro condizione fu la causa della
guerra civile a metà '800 tra il Nord che li voleva affrancare e il Sud che ne
aveva bisogno; eppure alla fine degli anni '30 quando l'enorme produzione fu
decisa, la schiavitù non c'era più ma i neri erano ancora una casta a parte e
non avevano diritti, compreso il voto. Ed è interessante vedere come già allora
la faccenda razziale nella produzione di un film con neri creasse molti
problemi. Il produttore David O' Selznick si definiva un liberale ed essendo
ebreo conosceva la discriminazione e il pregiudizio, e capì subito che il
fortunato romanzo della Mitchell, razzistissimo, andava ritoccato. Si circondò
di consulenti di colore, si rivolse ai giornali di colore, parlò con gli attori
di colore: gli fu chiesto di eliminare la parola nigger , anche se pronunciata
solo dai neri, sostituita dalle non meno antipatiche definizioni darkies e
inferiors e in cambio ottenne di poter sostituire il KKK con un gruppo
innominato di bianchi cattivi: certo non si poteva cancellare il fatto che
l'aristocrazia nera fosse quella dei domestici, e che sempre secondo il romanzo
fossero contenti di essere schiavi e adorassero i "badroni" bianchi. È poi
leggendaria la prima del film data ad Atlanta, quando la società bianca si disse
onorata di avere tutti gli attori compresi i tanti neri sul palco per
applaudirli, ma i neri no, grazie, alla cena e al ballo. La sera degli Oscar,
tra i candidati c'era anche Hattie McDaniel, la grassa cameriera nera che adora
Rossella, che concorreva per il premio alla non protagonista assieme a Olivia De
Haviland, per lo stesso film: vinse Hattie, la prima donna di colore a ottenere
un Oscar, che potè ritirare, senza però potersi sedere con gli altri vincitori
bianchi. Negli Stati uniti non succede più anche se c'è il peggio, ma in Italia
c'è qualche eroica signora che insulta sul tram le donne di colore obbligandole
a scendere e qualche vecchio scemo che sul treno pretende di vedere se un
ragazzo nero ha il biglietto. Dimentichiamo la storia, chiudiamo la scuola, non
serve E il fascismo ha fatto anche cose buone.
“Altissimi negri…” Io canto, e non chiamatemi razzista.
Michel Dessì l'11 giugno 2020 su Il Giornale. Quando è troppo è troppo! Ora la
situazione ci sta sfuggendo di mano. Non si può dire più nulla. Nulla.
Altrimenti sei razzista. Con il dissenso cresce anche la censura. Hanno
addirittura cancellato dal catalogo di Hbo il famosissimo film “Via col Vento”.
“È un film del suo tempo che raffigura alcuni pregiudizi etnici e razziali che
erano, disgraziatamente, dati per assodati nella società americana” ha detto un
portavoce della celebre tv a pagamento su Variety. Speriamo solo non
censurino l’Alligalli di Edoardo Vianello. Come farebbero i vecchietti in
vacanza senza il ballo che da decenni li accompagna nelle serate d’estate?
Soprattutto ora che si deve ballare a due metri di distanza. Io lo canto, e me
ne infischio.
“Nel continente nero
Alle falde del Kilimangiaro
Ci sta un popolo di negri
Che ha inventato tanti balli
Il più famoso è l’hully gully
Hully gully, hully gu…”
Dopo la morte ingiusta e orribile di George Floyd in migliaia si
sono rivoltati. Da nord a sud. Da est a ovest. Dall’America all’Italia; dalla
Francia al Brasile. Nel Mondo si è accesa la lampadina del razzismo. Una scusa
per molti di portare scompiglio e caos. I giornali di sinistra le hanno chiamate
invasioni pacifiche. Io, in molti casi, di pacifico ho visto ben poco. La folla,
dopo la morte dell’afroamericano Floyd, si è scagliata contro le statue di
diversi personaggi accusati di essere “razzisti” o “schiavisti”. I manifestanti
dal Minnesota a Londra, fino in Belgio, hanno preso di mira diverse effigi.
Hanno scatenato tutta la loro rabbia e frustrazione su delle statue che sono
state abbattute. Tirandole con delle corde. Poi, in molti casi, incendiate e
buttate in laghi o specchi d’acqua. Ma che hanno in testa? Speriamo solo non lo
facciano in Italia. Già si sono fatti sentire i “Sentinelli” (non so chi siano e
non lo voglio sapere) questi pazzi vorrebbero abbattere la statua di Indro
Montanelli. “E’ un razzista” dicono… Ma come può essere un gesto liberatorio
abbattere la statua di un giornalista libero e senza padroni?
Dai «Moretti» a Otello, il fanatismo che azzera la Storia.
Pierluigi Battista su Corriere della Sera l'11 giugno 2020. Nel nuovo
integralismo i cittadini sono trasformati in bambini bisognosi di protezione.
Dai «Moretti» a Otello, il fanatismo che azzera la Storia. Un tempo sarebbe
stata inconcepibile la distruzione della statua di Cristoforo Colombo . Nel
nuovo integralismo i cittadini sono tutti trasformati in bambini bisognosi di
protezione. C’è poco da sorridere, però. In effetti, sembra quasi uno scherzo o
una parodia, tanto è grottesca la notizia, che un’azienda svizzera abbia
deliberato la rimozione dagli scaffali dei cioccolatini «moretti», detti anche
«testa di moro», pericolosi veicoli di razzismo strisciante. O che i canali
Disney, sull’onda della messa sotto accusa di Via col vento, siano intenzionati
a mettere sull’avviso i giovani consumatori degli Aristogatti, Lilli e il
vagabondo con una scheda pedagogicamente corretta che dice: «Questo programma
potrebbe contenere rappresentazioni culturali ormai superate». C’è poco da
sorridere. Perché un po’ di anni fa avremmo liquidato come una boutade la
decisione di alcune università americane di sradicare dai piani di studio opere
scorrette di Shakespeare e le Baccanti: fatto. O di bloccare alla Sorbona la
messa in scena delle Supplici di Eschilo: fatto anche questo. O di rimuovere da
un’università inglese una targa con i versi di Rudyard Kipling, autore di un
libro molto pericoloso come Kime cantore, autore seriale di crimini culturali,
Il fardello dell’uomo bianco: fatto. Avremmo considerato impossibile l’accusa a
Dante Alighieri di essere «islamofobo». Sarebbe stata inconcepibile la
distruzione della statua di Cristoforo Colombo, o lo scempio vandalico che ha
deturpato quella di Churchill, l’eroe della guerra contro Hitler. O le protese
veementi al New York Times perché nella pagina delle opinioni se ne sia
pubblicata una troppo conturbante. E invece non dobbiamo sorridere: è tutto
vero, non è una parodia, non è uno scherzo. Non lo era nemmeno la manipolazione
della Carmen di Bizet al Maggio Fiorentino (avallata dal sindaco Nardella,
purtroppo) quando si manomise il finale per non dare alimento culturale al
femminicidio. È invece una forma di nuovo e prepotente fanatismo, non riducibile
nemmeno agli stereotipi del pur petulante «politicamente corretto», che vuole
sradicare il passato, l’arte e la cultura del passato, tutto ciò che appartiene
alla storia, alle idee, ai concetti, ai pregiudizi, anche agli orrori del
passato per fare tabula rasa di tutto ciò che ci ha preceduto, equiparato a
qualcosa di intrinsecamente peccaminoso e corrotto, da purificare con i precetti
della nuova ideologia, o da mettere dietro a una lavagna punitiva, come Via col
vento. Gli aggressivi funzionari della «neo-lingua» già analizzata da Orwell
definiscono pudicamente «ricontestualizzazione» (un po’ come i Lager maoisti
ribattezzati «campi di rieducazione»), questa demolizione e riscrittura delle
opere del passato, per stravolgere ed estirpare quella che i solerti esecutori
della Disney chiamano «rappresentazioni culturali ormai superate». Tra i nuovi
fanatici della censura, dell’iconoclastia, del rogo di libri e di film, il
passato dell’arte, della cultura e del pensiero non va studiato, rappresentato,
esaminato, criticato, va «superato», cioè distrutto, cancellato, epurato,
«ricontestualizzato» che è l’esatto opposto della doverosa contestualizzazione
di un testo, di un’opera, di un’idea, di una parola: cioè quello che si fa
normalmente senza bisogno di abbattere le statue come i talebani con quelle di
Buddha o dell’Isis a Palmira, o come le guardie rosse che perseguitavano i
musicisti nel caso avessero eseguito impura «musica occidentale» o come i
pasdaran khomeinisti che volevano ammazzare Salman Rushdie per i suoi versetti
blasfemi. Paragoni azzardati. Ma proviamo a leggere Amos Oz per verificare
l’azzardo: «Tutti i fanatici tendono a vivere in un mondo in bianco e nero. Il
fanatico è uno che sa contare fino a uno» e vuole azzerare il «mondo malvagio»
da soppiantare con il «mondo a venire». Ecco: azzerare. Esattamente fare del
mondo una pagina bianca in cui dopo aver cancellato tutto ciò che c’è di immondo
del passato si riparte dall’anno zero della purezza. E se l’arte, il cinema, la
cultura, i libri, il teatro, la musica, anziché adeguarsi talvolta con qualche
secolo se non millennio di anticipo alle direttive impartite con ciò che oggi
consideriamo il Bene e il Male, si ostinano a rappresentare scorrettamente i
conflitti della vita, la violenza, la sopraffazione, la discriminazione,
l’ingiustizia, insomma tutto ciò che è materia viva nella storia della cultura,
allora i nuovi guardiani della fede si incaricheranno di azzerare, rimuovere,
abbattere, manipolare, ricontestualizzare.
Dal Movimento anti-razzista alla rivoluzione culturale.
Piccole Note l'11 giugno 2020 su Il Giornale. Il Movimento
anti-razzista nato sull’onda dell’omicidio di George Floyd ha assunto carattere
iconoclasta. I manifestanti. in America e in Inghilterra soprattutto, hanno
preso di mira le statue: gettata a terra, a Bristol, quella di Edward Colston,
noto schiavista che la città ha onorato per i benefici da lui apportati.
Statue non grate. Se pochi piangeranno per la fine indecorosa
della statua di Colston, l’assalto ad altri monumenti ha suscitato reazioni:
così è stato per la deturpazione, avvenuta a Londra, della statua di Churchill,
punito per le sue propensioni razziste verso gli indiani e i palestinesi, ma al
quale è innegabile assegnare un ruolo primario nella sconfitta del nazismo
(Hitler vede così irriso il suo più acerrimo nemico: simbolismo alquanto
sinistro). Né si comprende la ratio della distruzione e il relativo affondamento
in acqua della statua di Cristoforo Colombo, avvenuto a Richmond: se certo il
navigatore genovese è reo di aver scoperto l’America, non gli si può attribuire
un ruolo nel genocidio dei suoi nativi, come hanno fatto i vandali (con
motivazione rimasta scritta sul residuo piedistallo). Ma al di là, va segnalato
che il sindaco di Londra, in sintonia l’onda, ha avviato una revisione dei
monumenti della città per decidere quali siano degni di rimanere, revisione che
potrebbe essere ribaltata in seguito, con riscrittura permanente della storia in
stile orwelliano (così in “1984”). Questo lato simbolico della protesta ha fatto
nascere paragoni, anche da parte di ambiti non avversi ai manifestanti, con la
furia talebana, che in Afghanistan fece strame di monumenti buddisti. Ma il
simbolismo delle statue buttate giù, nella storia recente, ha anche altri
precedenti. Le rivoluzioni colorate nell’Est europeo, che tanti punti in comune
hanno con il Movimento antagonista americano ed europeo (e nel Vecchio
Continente soprattutto britannico: Trump e Johnson, accomunati dalla sfida alla
globalizzazione, hanno gli stessi antagonisti), hanno una storia seriale di
statue abbattute, a sigillo dell’avvenuto regime-change. Come resta nella storia
l’abbattimento della statua di Saddam, a coronamento simbolico della prima
grande vittoria delle guerre infinite (anche qui il rimando al presente è
facile, dato che George W.Bush e Colin Powell, protagonisti pubblici di quella
guerra, si sono schierati in favore dei manifestanti contro Trump). Non solo
l’aspetto simbolico, l’accanimento contro certi monumenti pubblici ha fatto
assumere alla protesta sociale il carattere di una rivoluzione culturale (quella
cinese, non è un bel precedente). Analizzare con occhi nuovi la storia è
operazione legittima e benvenuta, dato che può portare a porre nuovi
interrogativi e favorire una maggiore comprensione di una materia in genere
appannaggio dei vincitori (in particolare quella moderna). Ma allo stesse tempo
c’è il rischio che storia stessa sia consegnata a improvvisati professori o di
una rischiosa palingenesi che, azzerando tutto, vedrebbe il sorgere di una nuova
Storia, a uso e consumo dei nuovi vincitori, quelli che si nascondono dietro le
attuali proteste e le alimentano (tutti i media mainstream Usa e gran parte
degli altri, oltre che le più potenti piattaforme web, la supportano, e non
certo casualmente). Peraltro, se proprio si vuole porre fine ai tanti simboli
del razzismo, occorrerebbe forse abolire il partito democratico americano che
oggi cavalca la protesta, dato che gran parte dei suoi esponenti, al tempo della
guerra di secessione, si schierò con i confederati contro l’abolizionista
Abraham Lincon.
Il rito dei democratici al Congresso. Proprio tale partito ha
dato vita a un singolare spettacolo al Congresso Usa, nel quale ha voluto
portare il gesto più potente e simbolico delle attuali manifestazioni
anti-razziste, che consiste nell’inginocchiarsi in pubblico in memoria di Floyd.
Un gesto di per sé bello, che rischia però di essere consegnato al simbolismo e
così svuotato del suo significato di preghiera e partecipazione. Meno bello se
viene chiesto, come accade durante le manifestazioni, ad altri estranei al
Movimento, con un’insistenza e una pervicacia che, anche se non ne deriva una
costrizione, assume il significato di una richiesta di sottomissione pubblica al
Movimento e alle sue ragioni (e, di fatto, anche al Potere che lo supporta).
Tornando allo spettacolo al Congresso, al quale la solennità e l’uso di una
stola cerimoniale ha fatto assumere i caratteri rituali (e di un rito più pagano
che laico), è singolare che, per manifestare la propria vicinanza agli
afroamericani, i membri del partito democratico abbiano deciso di indossare una
stola di Kante. Un tessuto particolare, il Kante, che ha nel simbolismo
cromatico rimandi iniziatici, la cui storia si “intreccia profondamente con
quella dell’Impero Ashanti“, dato che era appannaggio dei suoi regnanti. Tale
impero, che insisteva sul Ghana (dilatandosi ben oltre gli attuali confini del
Paese che affaccia sul Golfo di Guinea), fu uno dei più potenti regni
dell’Africa, un impero “schiavista” che “sul commercio di oro e schiavi (con i
colonialisti europei ndr) costruì la propria ricchezza”. La storia è bizzarra. E
riserva sorprese, anche a chi la vuole riscrivere.
Le riscritture della storia sono sempre su un lato solo della
strada. Toni Capuozzo l'11/06/2020 su Notizie.it. Vi
immaginate se la scuola italiana bruciasse la Divina Commedia perché nel Canto
XXVIII mette Maometto all’Inferno? Qualche dietrologo sostiene che il
coronavirus non esiste, o almeno è la scusa per imporre un nuovo ordine
mondiale. Fosse così, consoliamoci, perchè la Spectre composta da Soros e
Bildelberg, o da Trump e Bolsonaro, o dalla Cina e Bruxelles, o da chi più ne ha
più ne metta, sta fallendo. Il disordine è grande, e le incertezze si
moltiplicano. E non ci sono neppure bandiere sotto le quali stringersi, come
marines a Iwo Jima, siamo a corto di simboli. Prendi “Andrà tutto bene”: è ormai
il datato ricordo di un tempo innocente e ottimista, un coro poetico che ha
lasciato spazio alla prosa meno eroica delle fasi 2 e 3. Prendi il No al
razzismo, bandiera nobile ma troppo simbolica, quasi una moda, in
quell’inginocchiarsi in Parlamento, della ex presidente della Camera Laura
Boldrini e di altri con lei. “Quel” razzismo è una storia tutta americana, come
la apple pie. Ed è giusto che si sia solidali con chi vi si oppone, ma senza
confondere le acque, sapendo che è una storia loro, su cui adesso si illuminano
le telecamere dei telefonini, ma è antica e recente (ricordate i 58 morti del
1992 a Los Angeles dopo il pestaggio di Rodney King?), e comunque è loro e
almeno in questo non c’è nulla di cui scusarsi, per noi europei. Naturalmente
siamo dei gran percettori di mode, noi italiani: persino il termine “antifa”,
noi che siamo nati dalla Resistenza lo abbiamo preso in prestito dalle piazze
americane. C’è razzismo in Italia? A giudicare da come la comunità cinese ha
ripreso tranquillamente il suo posto, dopo la pandemia, si direbbe di no. A
guadare lo sfruttamento nelle campagne, certo, c’è da preoccuparsi, ma è piaga
sociale, che non ha a che vedere con il colore della pelle: possono essere
raccoglitori di fragole moldavi o rumeni, van bene lo stesso, purchè precari e
sottopagati. Più scomodo invece far notare che in meno di un anno, degli
11.800 migranti raccolti e sbarcati sulle nostre coste, l’Europa ne ha accolti e
ricollocati solo 464: abbastanza da sospettare un respingimento che meriterebbe
qualche inginocchiata davanti ai consolati di molti paesi amici. Viviamo di
simboli e mode, ed era ovvio che qualcuno, non avendo statue di Cristoforo
Colombo da decapitare come a Boston, a corto di piedestalli, avrebbe segnalato
come politicamente scorretto il monumento a Indro Montanelli, ai giardini di
Porta Venezia, e qualcuno starà cercando tra vecchi dvd quali film italiani
siano da mettere all’indice, come Via col vento. Intanto è curioso notare come
le riscritture della storia siano sempre su un lato solo della strada (e corso
Unione Sovietica a Torino?) e poi vi immaginate che la scuola italiana, già
deficitaria di suo, bruci la Divina Commedia perché nel Canto XXVIII mette
Maometto all’Inferno, tra i seminatori di discordia? Si resta con i simboli,
come quegli striscioni gialli che hanno raccontato il dolore di noi italiani per
la morte di Giulio Regeni, ma sono stati anche un simbolo identitario, politico.
L’Italia vende due fregate agli egiziani – qualcosa attorno ai dieci miliardi di
euro – e la famiglia di Giulio – che come famiglia ha il sacrosanto diritto di
dire qualunque cosa – dice che si tratta di un tradimento del governo, che si
tratta di armi e navi che serviranno a perpetuare la violazione dei diritti
umani. Di Maio imbarazzato, il PD, anche. Nessuno tra loro che noti come etica e
relazioni internazionali siano spesso separati in casa: facciamo le vie della
seta con il regime autoritario cinese che soffoca Hong Kong, compriamo aerei
dagli Stati Uniti dove i poliziotti fanno la caccia a i neri, intratteniamo come
tutti rapporti commerciali con paesi cui è meglio non misurare la temperatura,
quanto a diritti civili. Lia Quartapelle, PD, si spinge più in là: dice che
l’Egitto è il capofila di un “asse reazionario” che in Libia sostiene il
generale Haftar. Le anime belle sono sempre un po’ strabiche. Diciamo che le
parti contrapposte in Libia difettano di galantuomini, se con Serraj stanno la
Turchia e i Fratelli musulmani: fronte progressista? E torniamo
all’America. L’ultimo numero della rivista di Al Qaeda definisce Covid 19 un
“microscopico soldato di Allah” e le rivolte antirazziali una opportunità di
finire il lavoro iniziato l’11 settembre 2001. Certo, Trump è in difficoltà. E
Biden, se riuscisse a reclutare Michelle Obama come vice, un candidato alla
vittoria. Non sappiamo in quale ordine mondiale andrebbe iscritto questo
scenario. Ma è bene ricordare, senza illusioni, che le guerre le hanno sempre
iniziate i democratici americani. E che il problema razziale è diventato un
problema criminale incrociandosi, nella guerra per imporre Law and Order, con le
carcerazioni di massa, inaugurate da Bill Clinton.
Renato Farina contro gli anti-razzisti che cancellano la
storia: "Abbattono le statue e non i propri cervelli".
Renato Farina su Libero Quotidiano il 12 giugno 2020. La furia
iconoclasta di quest' anno ha strappato nuovi scalpi da appendere alla trave
alla quale i suoi protagonisti attuali saranno a loro volta impiccati tra
qualche anno. Il conto è provvisorio. Abbiamo segnato le statua di Cristoforo
Colombo affogata in un lago a Richmond, in America, colpevole di averla
scoperta; quella di uno a noi sconosciuto schiavista del '600 a Bristol e di
altri colleghi sparsi nel Paese; ha poi sfregiato a Londra quella di Winston
Churchill perché «era un razzista» avendo difeso le colonie della Regina in
India; in Belgio il monumento a Leopoldo II, oppressore del Congo. Molte altre
lapidi ed effigi sono in corso di sradicamento. In Italia essa si è diretta, per
la seconda volta in un paio d'anni, contro Indro Montanelli, per aver sposato,
secondo costumi africani degli anni 30, la dodicenne figlia di un capo etiope.
Ultimo caso notevole, che sobbolliva già da un po'. L'Olympiastadion di Berlino,
voluto dal regime nazista e inaugurato nel 1936 per ospitare i Giochi Olimpici
estivi, non essendo passibile di essere buttato giù da un corteo, sarà - dopo
una campagna di stampa su Zeit - ristrutturato demolendo tutti i simboli del
regime hitleriano: non solo le sculture, ma la stessa forma, troppo rievocativa
dell'estetica del III Reich. L'Herta Berlino sostiene questa idea. Ancora. In
Svizzera i supermercati hanno deciso di togliere dagli scaffali, per onorare
Georg Floyd, gli storici cioccolatini "moretti", che a suo modo sono un
monumento. E avete capito perché.
L'INVIDIA DEGLI OMETTI. Qui non ci mettiamo a difendere Colombo,
Churchill e Montanelli. Constatiamo che quelli che Nietzsche chiamava "ometti" o
"cinesini" se la prendono sempre per invidia con i grandi che hanno lasciato un
segno nella storia. Ma cerchiamo un po' di capire che cosa sta succedendo.
Quando un popolo, o chi per esso, ribalta un tiranno, ribalta anche i segni
della sua presenza. Darei una mano anch' io, se dovesse arrivare il califfato
islamico in Lombardia, a demolire le statue di Bin Laden (anche se è
impossibile: i musulmani non fanno statue). Un conto però è il repulisti di una
rivoluzione o dopo la fine di una guerra: i perdenti sono sempre colpevoli. È
accaduto e accadrà sempre. I romani spargevano sale, decretavano la damnatio
memoriae, neanche il nome doveva sussistere, perché i nomi contengono una forza
spirituale. Quello che sta capitando ora è tutta un'altra storia. Ad essersi
alzata e a non trovare dighe di buon senso e di onestà è l'onda della
purificazione "politically correct". Per chiarire il concetto, rispettandone
l'autore Tom Wolf: "politicamente corretto" è ciò che resta dopo il
rastrellamento con il forcone progressista della intera realtà culturale, della
eredità giuntaci dal passato bello o brutto che sia stato. Idee, parole, statue,
quadri, poesie giudicate fasciste, razziste, omofobe, islamofobe, sessiste,
imperialiste. Nei periodi di bonaccia questo vaglio spaventoso procede lento. Si
appunta sul vocabolario, agisce attraverso leggi contro opinioni fuori dai
canoni (vedi quella oggi in Parlamento). Poi di colpo prende forme devastanti,
come oggi. Essa non è dovuta a ignoranza. Anzi essa ha per ideologi gente
erudita. Costoro fanno così. Individuano un personaggio famoso che sta loro
odioso per ragioni politiche o semplicemente perché è apprezzato da gente
estranea ai loro circoli. Dopo di che cercano nei suoi armadi, in qualche
lettera, in un discorso bellico qualcosa che stoni rispetto ai dogmi del
pensiero unico d'oggi. Estrapolano dal contesto quanto occorre per la loro
indignazione, e lo indicano come idoneo al linciaggio. Un'operazione che
rinuncia a quella suprema onestà che è riconoscere la perenne imperfezione di
chiunque, anche di chi si erge a giudice. Senza prospettiva storica, senza
pietas, chiunque è reo di morte. Su questa base andrebbero abbattute le statue
di Giulio Cesare, che in Gallia sterminò un milione e passa di futuri francesi,
andrebbe divelto il monumento di Marco Aurelio, i russi dovrebbero dare alle
fiamme l'Arco di Trionfo. E l'intero patrimonio architettonico e letterario
classico, da Atene a Roma, da Aristotele a Seneca, dovrebbe essere cancellato:
schiavismo, umiliazione delle donne, imperialismo erano costumi praticati.
Oppure c'è la prescrizione? Non si costituisce nulla se non accettando e notando
la tradizione, con tutte le scorie che essa si porta dietro, e gli uomini che ne
sono stati l'emblema. Se la civiltà è sopravvissuta alla barbarie dopo la fine
dell'impero è proprio perché nei monasteri benedettini santi amanuensi
trascrissero opere che pure contenevano ideologie avverse al cristianesimo. E
costruirono sui templi pagani, senza distruggerli, cose nuove. Il campione del
pensiero moderno, Voltaire, che i progressisti citano continuamente, ingrassò
come i due schiavisti inglesi sul commercio di neri con le Americhe, e fu
violentemente antisemita (vedi i Dialoghi e il Candide). Antonio Gramsci scrisse
dal carcere cose turpi e razziste sui "negri" che riteneva "pericolosi" per aver
diffuso in Europa le loro danze inferiori. Che facciamo? Bruciamo i loro
monumenti o lo salviamo perché di sinistra?
STALIN IN SOFFITTA. E i monumenti nazisti, fascisti o comunisti?
Non faccio l'elenco di quelli belli da salvare, non ho abbastanza competenza. Ma
il genio umano per distrazione semina bellezza anche quando serve cause
ignobili. E noi siamo tutti figli di epoche dove i nostri padri hanno seguito
idoli buoni o perversi, ma sono i nostri padri. Piuttosto in questa epoca dove
non esiste memoria condivisa del passato, almeno sia praticato il rispetto delle
memorie altrui. Magari mettendo in campo se non l'arte del perdono quello
dell'umana convenienza. L'umanità cambia così spesso i suoi cavalli vincenti Mi
viene in mento quanto la saggezza contadina raccontò al grande scrittore
ebreo-russo Vasilij Grossman nel 1961 in Armenia, allora Urss. Erevan, la
capitale, era ancora sotto lo sguardo terrificante del "gigantesco maresciallo
di bronzo". Il monumento a Stalin eretto sul monte era un problema per le
autorità al tempo di Kruscev. Che farne? Bisognava demolirne la statua per
ragioni di opportunità politica e perché nemico del gentile cuore armeno. Ed
ecco che un contadino, durante un'assemblea, propose di seppellire il monumento
costato centomila rubli solo dieci anni prima, anziché distruggerlo. «Può
tornare comodo se cambia il governo». Del resto gli armeni com' è che difesero
il loro patrimonio di chiese cristiane in attesa dell'inesorabile devastazione
mongola: scolpirono sulle porte Cristo, Madonna e santi con occhi da mongoli. Ma
questo è un altro articolo.
Da huffingtonpost.it il 13 giugno 2020. La caccia alle statue di
personaggi storici giudicati oggi alla stregua di “razzisti, imperialisti” o
presunti tali deve finire. A levare la voce contro questa deriva - innescata
negli Usa, nel Regno Unito e altrove da frange del movimento Black Lives Matter
sulla scia della protesta contro l’uccisione di George Floyd - è Boris Johnson:
sceso in campo per denunciare “gli estremisti” nel giorno in cui Londra è stata
costretta a impacchettare vari monumenti, in primis quello dedicato a Winston
Churchill, per il timore di nuovi assalti. Johnson ha definito “assurdo e
vergognoso” che la statua del primo ministro della Vittoria sul nazismo abbia
dovuto essere coperta da una sorta d’involucro in modo da essere protetta. La
decisione è stata presa dal Comune di Londra, che ha riservato lo stesso
trattamento al cenotafio in onore dei caduti, nel cuore della capitale, ma anche
ad altre opere: compresa una raffigurante Nelson Mandela, minacciata da
contromanifestazioni ultranazionaliste. Il sindaco della città, il laburista
Sadiq Khan, ha invitato tutti i dimostranti “a restare a casa” nel rispetto
delle restrizioni dell’emergenza coronavirus. Mentre un raduno in ricordo di
George Floyd previsto per domani a Hyde Park è stato sospeso dagli stessi
promotori onde evitare il pericolo di scontri con la contemporanea iniziativa
opposta di estrema destra. Altre sigle del movimento antirazzista hanno tuttavia
manifestato stasera a Londra. Mentre i monumenti sotto tiro (anche senza contare
le annunciate ritorsioni di drappelli di nazionalisti contro le effigi di
progressisti o rivoluzionari e già entrati in azione a Bristol per sfregiare con
l’acido un busto di Alfred Fagon, poeta e attore d’origini giamaicane) si
moltiplicano in vista del weekend in diverse città. E, dopo le statue di
mercanti di schiavi di secoli passati quali Edward Colston (abbattuto giorni fa
a Bristol) o Robert Milligan (rimossa in anticipo), gli antirazzisti più
radicali mettono nel mirino decine di figure storiche di vario spessore: ex
governatori coloniali, leggendari navigatori come James Cook, il corsaro Francis
Drake (eroe dell’Inghilterra di Elisabetta I), capi di governo imperiali del
peso di Robert Peel o di William Gladstone, fino al quasi contemporaneo Robert
Baden-Powell, fondatore dello scoutismo tacciato in una fase della sua vita di
simpatie hitleriane. Commentando le minacce alla statua di Churchill, già
imbrattata da un drappello di dimostranti nei giorni scorsi di fronte a
Westminster con la scritta ‘fu un razzista’, il premier Tory ha paventato il
rischio che una protesta già definita legittima e “comprensibile” venga “presa
in ostaggio dagli estremisti”. “La statua di Winston Churchill in Parliament
Square è un memento permanente di quanto egli seppe conseguire per la salvezza
di questo Paese, e di tutta l’Europa, dalla tirannia fascista e razzista. È
assurdo e vergognoso che questo monumento nazionale debba essere messo ora a
rischio da manifestanti violenti”. ″È vero - ha ammesso Johnson - talora
Churchill manifestò opinioni che erano inaccettabili e sono inaccettabili per
noi oggi, ma egli è un eroe e merita in pieno il suo memoriale”. Secondo
l’inquilino attuale di Downing Street - divulgatore storico di successo,
ammiratore e biografo di sir Winston - il Regno Unito ha una storia comune da
ricordare. “Non possiamo cercare di riscrivere o censurare il nostro passato,
non possiamo pretendere di avere una storia diversa”, ha notato. “Vi sono
prospettive differenti su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ma le statue
innalzate dalle precedenti generazioni ci insegnano il nostro passato, con tutti
i suoi errori: abbatterle - ha concluso ammonendo a restare a casa - sarebbe
mentire sulla nostra storia e impoverire le future generazioni”.
Caso Floyd, la furia antirazzista diventa iconoclasta e corre
sui social: "Giù le statue". Pubblicato venerdì, 12
giugno 2020 da La Repubblica.it. L'ultima a cadere è stata la statua di
Cristoforo Colombo a Houston, in Texas, dopo quella di Minneapolis. Ma prima di
lui nel Regno Unito è toccato a Edward Colston, mercante-filantropo di Bristol
arricchitosi tuttavia nel '600 anche con il commercio degli schiavi, e a Winston
Churchill. La protesta antirazzista che divampa un po' dappertutto nel mondo nel
nome di George Floyd - l'afroamericano 46enne morto soffocato durante l'arresto
a Minneapolis - corre veloce anche sui social e diventa iconoclasta. Le prime a
farne le spese sono le statue di personaggi fino a ieri considerati icone di
civiltà, quando non di libertà e democrazia. Ma che adesso si sono trasformate
in simboli della schiavitù o dei regimi coloniali. "Se non fosse drammatico,
sarebbe solo grottesco", è il commento del governatore della Liguria Giovanni
Toti sull'accanimento contro Colombo. In Italia si è fatto sentire il movimento
dei Sentinelli di Milano, gruppo che si batte contro le discriminazioni razziste
e omofobiche, che ha inviato un appello al sindaco Giuseppe Sala e al Consiglio
comunale perché sia valutata la rimozione della statua di Indro Montanelli posta
nei Giardini a lui intitolati. Montanelli - affermano i Sentinelli - fino alla
fine dei suoi giorni ha rivendicato con orgoglio il fatto di aver comprato e
sposato una bambina eritrea di dodici anni perché gli facesse da schiava
sessuale, durante l'aggressione del regime fascista all'Etiopia. Ma il sindaco
Sala dice no alla rimozione del monumento: "Penso che in tutte le nostre vite ci
siano errori. E quello di Montanelli lo è stato - dichiara in un'intervista
al Giorno - Ma Milano riconosce le sue qualità, che sono indiscutibili". Anche
da Fucecchio in Valdarno, sua città natale, si leva un coro di no. E il
sindaco Alessio Spinelli parla di "follia, priva di ogni logica storica". La
statua del giornalista toscano non è l'unica finita nel mirino dell'antirazzismo
iconoclasta. Basta fare una rapida ricognizione su Twitter per trovare altre
proposte di abbattimenti. Come ad esempio la già contestata statua di Gabriele
D'Annunzio a Trieste, l'obelisco "Mussolini dux" al Foro italico a Roma o
l'effigie dell'esploratore Vittorio Bottego a Parma. Nonché i vari monumenti
all'Eroe dei due Mondi Giuseppe Garibaldi, più detestato al Sud di quanto si
possa immaginare come testimonia questo tweet di una utente di Napoli. Credo che
poche statue al mondo meritino la rimozione quanto questa del Criminale Nizzardo
nella immensa piazza di Napoli cui è stato imposto il suo nome dannato. Eppure
sta lì, nessuno lo tocca, nessuno se lo fila, e credo sia ormai quasi invisibile
per la gran parte di noi. A Torino il Kollettivo Studenti Autorganizzati (Ksa)
rivendica su Facebook lo sfregio dell'effigie di Vittorio Emanuele II. "Torino
come Bristol - si legge sul profilo del Ksa - Quando la giunta comunale di
Torino si indigna per una sbombolettata nera sulla statua di un colonialista di
m... noi rispondiamo che questa statua non è il nostro patrimonio culturale". Il
tam tam iconoclasta arriva anche in Sardegna. A Cagliari viene presa di mira la
statua del vicerè di Sardegna Carlo Felice, nella centrale piazza Yenne di
fronte al porto. Secondo i promotori di una petizione online, tra i quali
spiccano Francesco Casula, autore del libro "Carlo Felice e i tiranni sabaudi"
e Giuseppe Melis, docente universitario di marketing, il monumento andrebbe non
abbattuto ma "spostato" nell'androne dell'ingresso principale del Palazzo Regio
in piazza Palazzo. Ogni tanto, fra l'altro, la statua viene coperta e viene
proposto di intitolare un monumento ai Martiri di Palabanda, i promotori
(giustiziati) di una fallita rivolta contro i Savoia. L'opinione pubblica è però
divisa, fra chi considera l'opera un simbolo di "cagliaritanità" (Largo Felice è
uno dei luoghi più frequentati della città) e chi invece vi legge solo l'icona
di un tiranno senza scrupoli che ha calpestato i diritti dei Sardi. Ma c'è anche
chi la prende con ironia: Carlo Felice è troppo legato ai trionfi del Cagliari,
quando viene vestito di rossoblu. Potrebbe essere sostituito solo da una statua
di Gigi Riva...Sull'onda emotiva di George Floyd e della lotta al razzismo, è
tornato sotto alla luce dei riflettori mediatici anche un vecchio dibattito
sull'opportunità di abbattare il monumento al criminale di guerra
fascista Rodolfo Graziani ad Affile, un paesino di meno di 1500 abitanti in
provincia di Roma. "Un monumento alla vergogna" si legge su Twitter e Facebook,
contro il quale si era schierato pubblicamente anche il presidente della Regione
Lazio Nicola Zingaretti con un post che invitava a dire "no al revisionismo di
stampo fascista e alla memoria storica". Ad #Affile è ancora in piedi il
sacrario dedicato al gerarca e criminale di guerra #fascista Rodolfo #Graziani.
Il sindaco che l'ha eretto è già stato condannato per apologia di fascismo. Cosa
aspettiamo ad abbattere questo scempio? Ma il il primo cittadino Ercole
Viri difende l'opera: "Non si abbatte niente, quello è un museo dove sono
conservati i cimeli dei soldati, anche quello di mio nonno. Deve piacere agli
affilani. Io amministro loro, non i partigiani". Una polemica annosa quella di
Affile, che va avanti da tempo come nel caso del mausoleo di Michele Bianchi -
gerarca fascista e capo della massoneria calabrese - a Belmonte
Calabro (Cosenza), più volte danneggiato da atti vandalici e anche da un
incendio di matrice dolosa che nel 2016 ha colpito la pineta circostante.
Perché odiare Colombo? Orlando
Sacchelli il 12 giugno 2020 su Il Giornale. Con la scusa delle
proteste scatenate dall’uccisione di George Floyd a Minneapolis, negli Stati
Uniti si è diffusa un’onda iconoclasta contro le statue di alcuni personaggi
controversi. Tra questi incredibilmente è finito anche Cristoforo Colombo,
l’europeo che per primo mise piede nel “Nuovo mondo”. A Houston (Texas) qualcuno
ha dipinto di rosso le mani e la testa della statua di Colombo (guarda la foto),
mettendo anche un cartello con la scritta: “Tagliare la testa al nostro
oppressore”. A Boston (Massachusetts) una statua del navigatore genovese è stata
decapitata. Un’altra a Richmond (Virginia) è stata divelta e gettata in un lago.
Stessa sorte per la statua posta davanti al Campidoglio di Saint Paul, nel
Minnesota. A New York la polizia ha organizzato la sorveglianza della statua
posta a Columbus Circle, a Manhattan, al confine con Central Park. La statua si
trova di fronte al Trump International Hotel. Andrew Cuomo, governatore dello
stato di New York, ha detto di “capire i sentimenti contro Colombo e su alcuni
dei suoi atti”, ma ha poi sottolineato che la statua dell’esploratore
“rappresenta l’eredità e il contributo degli italoamericani” al Paese. Non è la
prima volta che Colombo finisce al centro delle polemiche. Tre anni fa Los
Angeles il consiglio comunale decise di sostituire il Columbus Day con
l’Indigenous and Native People Day, la festa delle popolazioni indigene e
native. La stessa decisione venne adottata a Seattle, Minneapolis, Albuquerque,
Phoenix e Denver. Il paradosso è che senza quel pezzo di storia di cui
Cristoforo Colombo indubbiamente fa parte gli americani di oggi non
esisterebbero. O, forse, sarebbero molto diversi. Come spiegò il filosofo
conservatore Roger Scruton i neo iconoclasti “vogliono i benefici dell’Occidente
senza i sacrifici che questi hanno comportato. È il nuovo ‘dream world’ di gente
che deve dimostrare di essere virtuosa”. Ma cosa viene contestato a Colombo? Non
tanto la sua scoperta quanto le conseguenze di ciò che fece in seguito sulle
persone che vivevano, in quell’epoca, nel Nord America (vedi genocidio di
Taìno). I movimenti a favore dei nativi americani si fecero più forti negli anni
Novanta, ponendosi al centro del dibattito storico a partire dalla pubblicazione
di un libro di Howard Zinn (Storia del popolo americano dal 1492 ad oggi), che
affrontava il punto di vista dei popoli oppressi. I difensori di Colombo hanno
sempre ribattuto soprattutto su un punto: le violenze commesse dagli
spagnoli avvennero soprattutto dietro ordini della monarchia spagnola. Veniamo a
tempi più recenti. Il Columbus Day venne celebrato la prima volta nel 1869 dagli
italo-americani di San Francisco. Fu solo nel 1937, per volere del presidente
Franklin Delano Roosevelt, che divenne una festa di tutti gli Stati
Uniti. L’evento più grande si svolge ancora oggi a New York, con la Columbus
Parade, lungo la Fifth Avenue. Una grande festa con bande, carri e figuranti e
la comunità italo-americana orgogliosamente in prima fila. Umberto Mucci,
presidente dell’associazione We The Italians, qualche anno fa in un’intervista
disse che “il Columbus Day ormai è la celebrazione dell’italo-americanità, non
di Cristoforo Colombo”. Se oggi Colombo viene contestato dagli ambienti della
sinistra radicale ma anche dagli anarchici, c’è stato un periodo in cui anche
i suprematisti bianchi se la sono presa col navigatore genovese, per negare la
sua scoperta dell’America, attribuita invece ai vichinghi.
Usa, Trump
celebra Colombo: "Un grande italiano". E si scaglia contro gli estremisti che
minano la sua eredità. Pubblicato domenica, 11 ottobre 2020 da La Repubblica.it.
"Con il Colombus Day ricordiamo il grande italiano che ha aperto un nuovo
capitolo della storia mondiale ed il permanente significato della sua azione per
l'emisfero occidentale". Così Donald Trump ha elogiato Cristoforo Colombo nel
tradizionale proclama del presidente statunitense per la festa con cui, il 12
ottobre, viene ricordato negli Stati Uniti l'esploratore genovese che per primo
arrivò sulle coste dell'America, non mancando di aggiungere l'affondo politico
contro "gli estremisti che stanno purtroppo stanno cercando di minare negli
ultimi anno l'eredità di Colombo". "Questi estremisti cercando di sostituire la
narrativa sui suoi enormi contributi con accuse di fallimenti, le sue scoperte
con atrocità, le sue conquiste con trasgressioni", continua Trump riferendosi in
questi termini sul dibattito in corso da anni negli Usa sulle responsabilità dei
primi esploratori nel genocidio delle popolazioni native compiuto poi dalle
potenze coloniali. Da anni diversi attivisti spingono per trasformare il
Columbus Day in una giornata nazionale dei popoli indigeni sottolineando che
l'arrivo di Cristoforo Colombo nelle Americhe diede inizio al genocidio dei
nativi americani. Intanto le autorità messicane hanno rimosso la statua di
Cristoforo Colombo a Città del Messico. Alcuni attivisti avevano annunciato che
avrebbero tentato di abbatterla domani per il Columbus day, giorno in cui si
celebra l'arrivo dell'esploratore in America, il 12 ottobre del 1492, durante
una manifestazione chiamata "La faremo cadere". Secondo quanto riferito dal
ministero della Cultura, la scelta di rimuovere il monumento è stata presa per
"esaminarlo ed eventualmente restaurarlo".
Flavio Pompetti per “il Messaggero” il 12/10/2020. Rimossa
temporaneamente per restauro. Il ministero della cultura messicano ha ordinato
la deposizione della statua monumentale di Cristoforo Colombo dal basamento
posto all' inizio del Paseo Reforma, l'elegante boulevard che taglia con una
diagonale il centro della capitale. La decisione salomonica ha sventato l'
eventualità che l' operazione fosse effettuata con la forza dal gruppo di
dimostranti che oggi si raduna dietro l' inequivocabile slogan: «La
abbatteremo». Il dodici di ottobre il Messico non celebra più da anni l'
anniversario della partenza della spedizione capitanata dall' esploratore
italiano dalla Spagna. La data è invece divenuta il «giorno della Razza», a
memoria delle radici etniche e culturali che sono state troncate dall' arrivo
dei conquistadores. La sindaca di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, dice che
i lavori di riparazione erano a lungo dovuti, ma non è in grado di specificare
la data in cui il monumento farà ritorno nella rotatoria dalla quale è stata
asportata. L' anno prossimo segna il cinquecentenario dell' inizio della
«Conquista», il bicentenario dell' indipendenza messicana e la scadenza del
settimo secolo dalla fondazione di Tenochtitlan, oggi capitale dello stato da
parte degli Aztechi. I lavori di restauro della statua saranno l' occasione di
una riflessione sul ruolo che il navigatore, e la spedizione da lui comandata,
hanno avuto nella storia del paese e delle Americhe. Il presidente messicano
Manuel López Obrador ha scritto quest' anno per la seconda volta una lettera con
la quale chiede che la corona, lo stato spagnolo e il Vaticano, presentino scuse
formali al suo paese per le «riprovevoli atrocità» commesse contro le
popolazioni indigene da parte dei conquistadores, con la benedizione della
chiesa. La missiva è stata consegnata a mano a papa Francesco dalla moglie di
Obrador, Beatriz Gutiérrez Muller, che ha incontrato il papa in Vaticano dopo la
visita con il presidente Mattarella. Gli spagnoli rifiutano di rispondere, ma
Francesco sembra più sensibile alla richiesta e la sua disponibilità aggiunge
un' altra voce al dibattito sulla sorte delle tante statue di Colombo
disseminate nel continente americano. Il nome del capitano italiano è stato
associato, a torto o a ragione, a un dibattito che negli ultimi quindici anni ha
polarizzato l' opinione pubblica di ognuno dei Paesi del nuovo mondo e alla
violenza che ha accompagnato la rimozione delle sue statue nel continente. Negli
Usa la polemica è stata raccolta dal presidente Trump, con una proclamazione a
difesa del «grande italiano», che il presidente ha firmato sabato scorso. Il
Columbus Day non è una festa nazionale, e la celebrazione è riservata alle
decisioni dei singoli Stati. La rigettano quelli più legati alle radici
indigene, come l' Alaska, il Maine, il Vermont, le Hawaii, il New Mexico, il Sud
Dakota e la Florida; la avversano anche negli Stati che l' hanno ancora in
calendario, gruppi di oppositori che preferiscono festeggiare nella stessa
giornata la multiculturalità dell' esperienza americana, e le tribù che
abitavano il territorio prima della conquista europea. La questione si è fusa
con quella della revisione storica che sta portando molti gruppi progressisti a
chiedere la rimozione delle statue che ancora celebrano la cultura degli stati
confederati del sud degli Stati Uniti, e con essa dell' economia della schiavitù
sulla quale la confederazione poggiava. Donald Trump è schierato per la
conservazione delle statue e dei simboli del passato e per lui la difesa di
Colombo è parte della stessa battaglia. «Gli estremisti (del revisionismo) ha
scritto sabato - vogliono rimpiazzare la discussione sul vasto contributo che
Colombo ha dato, con argomentazioni sui fallimenti. Vogliono contrapporre
atrocità alle sue scoperte. Noi invece raccogliamo lo spirito di ottimismo che
ha ispirato la sua spedizione e che ci ha permesso di costruire la nazione più
grande che il mondo abbia mai visto».
Massimo Gaggi per il ''Corriere della Sera'' il 12/10/2020. Gli
italiani d’America si mobilitano — utilizzando anche i volti popolarissimi di
Andrea Bocelli, del virologo della Casa Bianca Anthony Fauci e del governatore
di New York, Andrew Cuomo — per difendere la memoria di Cristoforo Colombo: si
celebra, infatti, oggi il Columbus Day (l’anniversario dello sbarco
dell’esploratore nel Nuovo Mondo, il 12 ottobre 1492). La ricorrenza, che da
qualche anno ha perso il sapore della grande sagra popolare, in metà del Paese è
stata addirittura soppressa e rimpiazzata con una celebrazione degli indigeni
d’America. Sotto attacco da anni da parte dei leader di minoranze etniche che
vedono in Colombo l’uomo che aprì la strada a una colonizzazione delle Americhe
che portò anche a genocidi dei nativi, il Columbus Day è divenuto occasione di
controversie ancora più accese all’inizio dell’estate: sull’onda delle proteste
razziali è nata una campagna per la rimozione delle statue di personaggi storici
ai quali oggi vengono attribuire responsabilità per lo schiavismo o le
discriminazioni razziali. Ci sono andati di mezzo anche i monumenti a Cristoforo
Colombo, molti dei quali sono stati danneggiati o, addirittura, abbattuti. E non
solo negli Stati Uniti: ieri a Città del Messico è stata rimossa, sostenendo che
necessita di restauri, una statua del navigatore genovese che alcuni gruppi di
attivisti avevano minacciato di distruggere oggi, nella ricorrenza del Columbus
Day. Per gli italiani, in realtà, Colombo è solo un simbolo sotto il quale
celebrare il contributo dato dal nostro popolo alla costruzione degli Stati
Uniti. Le statue del navigatore furono, infatti, costruite quasi tutte alla fine
dell’Ottocento quando i lavoratori provenienti dal nostro Paese subivano
discriminazioni culminate nell’eccidio di 11 italiani a New Orleans. È per
questo che mentre in molte città il Columbus Day è stato soppresso e in altre,
come San Francisco, è stato intelligentemente trasformato in una celebrazione
dell’Italian Heritage, senza riferimenti al navigatore, a New York, città
multietnica, ma con una forte presenza di italoamericani, Colombo viene ancora
celebrato. La tradizionale parata sulla Fifth Avenue quest’anno si svolgerà in
modo virtuale per via dell’epidemia da coronavirus, ma l’evento verrà comunque
teletrasmesso in diretta dalla rete Abc. E se Donald Trump, nella sua
proclamazione della festività ha usato la figura di Colombo per tornare ad
attaccare duramente gli «attivisti radicali» che cercano di demolire la sua
eredità storica, «estremisti che ignorano il valore delle scoperte e parlano
solo di atrocità», l’ambasciatore italiano a Washington, Armando Varricchio, nel
messaggio d’apertura della parade virtuale di oggi si sforza di depoliticizzare
la questione. Parlerà, infatti, quasi solo dei legami tra Italia e Stati Uniti
che si sono rafforzati anche negli anni complicati della presidenza Trump (con
momenti di tensione con vari Paesi europei ma non con l’Italia) e del ruolo di
una comunità italiana «divenuta parte viva e integrante della società
americana». La celebrazione odierna, preceduta ieri dalla deposizione da parte
del console italiano Francesco Genuardi e del presidente esecutivo della
Columbus Citizen Foundation Angelo Vivolo di una corona ai piedi della statua di
Columbus Circle a New York (un evento pubblico svoltosi senza contestazioni), è
stata fortemente voluta soprattutto dal governatore Cuomo. A differenza del
sindaco Bill de Blasio che, di origini italiane ma con un elettorato fortemente
multietnico, ha sempre tenuto una posizione defilata nelle dispute su Colombo,
Cuomo ha difeso a spada tratta questa festività fino a proporsi con «Grand
Marshal» della cerimonia che avrà come honoree Fauci, un italoamericano nato e
cresciuto a Brooklyn, e sarà accompagnata dalla voce di Bocelli, l’italiano più
amato dagli americani.
Attenzione a buttare giù le statue, si diventa come i
talebani. Giuliano Cazzola su Il Riformista il 12
Giugno 2020. È difficile esprimere un giudizio definivo sul destino dei
monumenti dedicati a personalità di altri tempi. Qualsiasi scelta si faccia
sulla loro permanenza o rimozione (anche violenta) dalle piazze in cui danno
riparo ai piccioni (una specie di volatile ingiustamente perseguitato) vi
sarebbero decine di controprove a giustificazione di una scelta differente. Ho
riflettuto, mentre scrivevo, che da noi a Rodolfo Graziani comandante
dell’esercito di Salò è dedicato una sorta di Mausoleo ad Affile, suo paese
natale. Graziani non è certo paragonabile ad un gentiluomo del Vecchio Sud come
il generale Robert Lee che guidò le truppe della Confederazione durante
la Guerra civile americana. Graziani, già nella sua esperienza coloniale, fu un
massacratore di migliaia di etiopici inermi. Credo, però, che non avrebbe molto
senso a tanti anni di distanza (Graziani morì nel 1955) prendersela con
quell’edificio (probabilmente bisognava provvedere sul momento). Di monumenti ne
sono caduti tanti, a testimonianza dell’odio represso della popolazione nei
confronti del personaggio raffigurato. Dopo il 25 luglio del 1943, la
popolazione di Roma si riversò nelle vie e strappò dalle loro basi i busti del
Duce. In Germania non credo che esistano monumenti a Hitler e ai suoi gerarchi.
Così nei Paesi ex Urss ed ex satelliti i monumenti a Stalin furono rimossi dopo
il rapporto di Kruscev al XX Congresso del Pcus. Nella Piazza Rossa si conserva
ancora la mummia di Lenin allo scopo forse di tenere occupato il posto quando
verrà il turno di Putin. Nella Repubblica Ceca si è aperto un conflitto
diplomatico con la Federazione russa per la rimozione della statua del generale
dell’Armata Rossa che liberò Praga dall’occupazione tedesca. Sono sconvolto per
la caccia becera e spietata ai monumenti, in corso, negli Usa, in nome di un
atteggiamento ritenuto “politicamente corretto” in seguito ad una grande sbornia
collettiva. Hanno imparato dai talebani o dai militanti dell’Isis a cancellare
le icone della propria storia. In quel Paese è scoppiato il senso di colpa del
razzismo, che, come abbiamo visto in questi ultimi giorni, sconvolge ancora
l’anima profonda dell’America, soprattutto perché non è quello della curva dello
stadio di una grande città, ma delle istituzione stesse. Non si sconfigge il
razzismo attraverso la distruzione dell’immagine di chi non poteva – per quei
tempi – non essere razzista, perché era cresciuto e vissuto in quella cultura. A
suo tempo trovai singolare che una persona della cultura e della storia (anche
famigliare) dell’onorevole Emanuele Fiano si fosse messo a fare la guerra non
solo ai nostalgici o ai neofiti del fascismo, ma anche ai collezionisti, ai
produttori di giocattoli (come ad esempio i soldatini raffiguranti i combattenti
della seconda guerra mondiale) e a chi, appeso al muro di casa sua, intende
conservare un ritratto di Mussolini, magari ereditato da chissà chi e riposto in
un sottoscala. È un’iconoclastia insensata, come se a cancellare ogni immagine
dei dittatori del secolo scorso ci si mettesse al sicuro dal ripetersi di
esperienze come quelle tragicamente vissute dai nostri genitori e nonni. Quando,
al contrario, sarebbe più urgente accorgersi del fascismo di nuovo conio che
siede in Parlamento (e che non è costituito dai nostalgici di quello antico).
Del resto, non si può chiedere a nessuno di anticipare l’evoluzione della
cultura e del pensiero nella storia dell’umanità. Prendersela con Via col
vento è da imbecilli, quando uno dei primi capolavori almeno sul piano tecnico
del cinema del secolo scorso è La nascita di una nazione (del 1915) di David
Griffith nel quale il Ku Kluk Klan era presentato come un sorta di esercito di
liberazione. Addirittura, qualcuno vorrebbe prendersela con Cristoforo
Colombo come se il grande navigatore che per caso “scoprì” l’America (e che morì
povero) potesse immaginare che dopo di lui sarebbero arrivati
i Conquistadores che, dopo aver bruciato le navi alle loro spalle, infettarono
di un coronavirus di quei tempi intere popolazioni. E come poteva un difensore
dell’Impero britannico come Winston Churchill essere contrario al colonialismo?
Occorre usare prudenza quando si gioca con la propria storia. Perché se si
volesse portare l’espiazione dei nostri errori fino in fondo, non ce la
caveremmo demolendo le statue dei protagonisti di altre epoche storiche.
Soprattutto noi europei dovremmo restituire alle nazioni e ai popoli
dell’emisfero meridionale la nostra ricchezza e il nostro benessere. Come ha
potuto fiorire nel Vecchio Continente un’idea tanto estesa e compiuta di tutela
dei lavoratori dalla culla alla tomba? Questo faro di civiltà, da additare come
esempio alle generazioni future; questo presidio che tutti i democratici sono
tenuti a difendere – si è tornati a ripetere la solita solfa – contro
la “barbarie del neoliberismo” avrà pure delle origini. Certamente. Lo stato
sociale è frutto dello sviluppo economico, assai intenso e duraturo in Europa e
soprattutto con radici lontane. Non è forse avvenuta nella vecchia Europa la
rivoluzione industriale? A voler rispondere onestamente, infatti, bisognerebbe
ricordare quanto la crescita economica sia dovuta all’enorme disponibilità di
materie prime a prezzi stracciati e dunque a quel fenomeno di cui noi europei
non possiamo andare molto fieri e che è noto col nome di colonialismo. Come
scrisse Alexis de Tocqueville (La democrazia in America): «Il legislatore (la
politica, ndr) somiglia all’uomo che traccia la sua rotta in mezzo al mare; può
dirigere la nave che lo porta, ma non può cambiarne la struttura, né creare i
venti, né impedire all’Oceano di sollevarsi sotto i suoi piedi».
Milano, manifestanti per Floyd vandalizzano sede di Fratelli
d'Italia. In merito alla vicenda verrà richiesta
un'interrogazione parlamentare diretta al ministro Lamorgese. Osnato di FdI:
“Incredibile che ogni qual volta ci sia una manifestazione di centri sociali e
manifestanti di sinistra, i controlli della Questura siano un colabrodo”.
Federico Garau, Domenica 07/06/2020 su Il Giornale. Tanta amarezza da parte del
deputato di Fratelli d'Italia, Marco Osnato, che ha denunciato un fatto
gravissimo avvenuto quest'oggi nel corso del flash-mob organizzato a Milano da
alcuni attivisti scesi in strada per protestare contro il razzismo e ricordare
la morte di George Floyd, il 46enne afroamericano ucciso da un agente di polizia
a Minneapolis (Stati Uniti). Durante la manifestazione, presentata come
pacifica, sarebbe stata vandalizzata la sede di FdI sita in viale Melchiorre
Gioia, presa di mira da alcuni partecipanti al corteo. Una vicenda, questa, che
il partito di Giorgia Meloni intende adesso avere delle risposte. “È incredibile
che ogni qual volta ci sia una manifestazione di centri sociali e manifestanti
di sinistra, i controlli della Questura siano un colabrodo”, attacca Marco
Osnato, come riportato da “AdnKronos”. In programma, adesso, una interrogazione
parlamentare rivolta direttamente al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese,
che dovrà fare chiarezza sull'atto vandalico avvenuto ai danni della sede di
FdI. “Una sede politica in pieno centro non presidiata, segreteria parlamentare
presa d'assalto a due passi dal ritrovo (abusivo o autorizzato non è dato
saperlo) della manifestazione”, ribadisce il deputato Osnato. “Foto e video
parlano chiaro e saranno inoltrate alle autorità competenti”, annuncia. Sul caso
è intervenuto anche Riccardo Truppo, rappresentante del coordinamento cittadino
di Fratelli d'Italia. “Non è dato sapere se il corteo sia stato autorizzato e se
avesse un percorso prestabilito dalla Stazione Centrale fino in Melchiorre
Gioia”, spiega Truppo. “Parliamo di quasi un chilometro di percorso. Difficile
crederlo dato che le norme anti-assembramento vietano cortei in movimento”.
La rabbia, in ogni caso, è tanta. E il pensiero va alla manifestazione
organizzata dal centrodestra lo scorso 2 giugno, resa invece subito oggetto di
polemiche. “Il 2 giugno il centrodestra ha organizzato una manifestazione in
piazza Duomo con regole ferree che abbiamo fatto rispettare. Come mai oggi non
c'erano gli stessi controlli?”, si domanda infatti con tono polemico il
rappresentante di Fratelli d'Italia. Organizzata dall'associazione "Razzismo
brutta storia", da sempre in prima linea per combattere ogni genere di
discriminazione, e da "Abba Vive", la manifestazione si è svolta sotto la
pioggia, in piazza Duca D'Aosta a Milano, ed ha coinvolto altre città italiane.
Circa un migliaio di persone hanno preso parte al raduno, senza rispettare le
norme di distanziamento. Ancora nessuna notizia in merito ai
presunti responsabili dell'atto vandalico perpetrato ai danni della sede di
Fratelli d'Italia. Gli accertamenti sono in corso.
Federico Garau
per Il Giornale.it il 10 giugno 2020. L'episodio della morte di George Floyd,
dopo la pantomima dell'inginocchiamento alla Camera dei deputati da parte di
alcuni membri del Pd seguita al discorso di Laura Boldrini, continua a dar modo
agli esponenti della sinistra di portare il tema "razzismo" come metro con cui
valutare qualsiasi genere di problematica o presunta tale: l'ultima in ordine
cronologico è la questione legata alla statua di Indro Montanelli ed ai giardini
pubblici di via Palestro a lui dedicati. A parlare sono "I Sentinelli" (che si
professano laici ed antifascisti, come si legge nello stesso simbolo che li
rappresenta), i quali in un post sulla pagina Facebook chiedono al sindaco di
Milano Giuseppe Sala di intervenire per cambiare la situazione in essere
nell'area verde in questione. "A Milano ci sono un parco e una statua dedicati a
Indro Montanelli, che fino alla fine dei suoi giorni ha rivendicato con orgoglio
il fatto di aver comprato e sposato una bambina eritrea di dodici anni perché
gli facesse da schiava sessuale, durante l'aggressione del regime fascista
all'Etiopia", attaccano gli attivisti. "Noi riteniamo che sia ora di dire basta
a questa offesa alla città e ai suoi valori democratici e antirazzisti e
richiamiamo l'intero consiglio a valutare l'ipotesi di rimozione della statua,
per intitolare i Giardini Pubblici a qualcuno che sia più degno di rappresentare
la storia e la memoria della nostra città Medaglia d'Oro della Resistenza",
proseguono nel post. "Dopo la barbara uccisione di George Floyd a Minneapolis le
proteste sorte spontaneamente in ogni città con milioni di persone in piazza e
l'abbattimento a Bristol della statua in bronzo dedicata al mercante e
commerciante di schiavi africani Edward Colston da parte dei manifestanti
antirazzisti di Black Lives Matter, richiama con forza ogni amministrazione
comunale a ripensare ai simboli del proprio territorio e a quello che
rappresentano". Una proposta che ha ovviamente trovato terreno fertile tra i
membri della maggioranza che sostiene il primo cittadino di Milano. "Credo che
la richiesta dei Sentinelli vada sicuramente discussa in consiglio. Quando ci
viene presentata una proposta noi siamo sempre pronti ad accoglierla e
discuterne, soprattutto quando tocca i temi dei diritti e della dignità delle
persone", dice il consigliere comunale nonchè presidente della Commissione pari
opportunità Diana De Marchi (Pd) riferendosi alla questione Montanelli, come
riportato da MiaNews. "Le motivazioni della richiesta di rimuovere la statua le
riconosco come valide perché quella è stata una brutta pagina della nostra
storia. Vanno indagate le motivazioni che hanno portato all'intitolazione e
valutare se siano ancora valide oggi. Da parte mia, farò in modo che se ne
discuta". Anche il consigliere Dem Alessandro Giungi ha dato la sua
"benedizione" all'iniziativa in un comunicato. "La questione messa in luce dai
Sentinelli merita di essere dibattuta in un approfondito dibattito in consiglio
comunale. Non è un tema semplice, ma come consiglieri dobbiamo farcene carico.
Su questa scia ho depositato nei giorni scorsi un ordine del giorno per
intitolare i giardini di via Ardissone, da poco riqualificati, a Rosa Parks",
rivela il Dem con orgoglio. "La richiesta è arrivata dai ragazzi della scuola
media Puecher che tramite un sondaggio online effettuato durante il periodo di
lockdown hanno avanzato questa proposta che si sposa con il ragionamento dei
Sentinelli e rilancia a Milano l'idea di dover dare rilevanza, anche con queste
iniziative, al tema dei diritti. Ricordiamoci anche che sono ancora poche le
intitolazioni dedicate alle donne in città", si legge ancora nella nota.
Indro
Montanelli, Sentinelli e Arci vogliono rimuovere la statua a Milano: "Bimba
eritrea per schiava sessuale". Salvini: "Che vergogna la sinistra".
Libero Quotidiano il 10 giugno 2020. Giù le mani da Indro Montanelli. A Milano
la sinistra, per mano di Sentinelli e Arci, chiedono ufficialmente al
sindaco Beppe Sala (del Pd) di rimuovere la statua del grande giornalista
fondatore del Giornale e de La Voce, che si trova nell'omonimo parco della città
in via Palestro nel quartiere di Porta Venezia, e di dedicare i giardini "a
qualcuno che sia più degno di rappresentare la storia e la memoria della nostra
città Medaglia d'Oro della Resistenza". La richiesta, pubblicata sulla pagina
Facebook del gruppo, arriva dopo le proteste e i cortei, che si sono tenuti
anche a Milano, per l'uccisione di George Floyd a Minneapolis. Secondo I
Sentinelli il giornalista "fino alla fine dei suoi giorni ha rivendicato con
orgoglio il fatto di aver comprato e sposato una bambina eritrea di 12 anni
perché gli facesse da schiava sessuale. Riteniamo che sia ora di dire basta a
questa offesa alla città e ai suoi valori democratici e antirazzisti". Nel
centrodestra reazioni indignate. "Che vergogna la sinistra, viva la libertà", è
il laconico commento di Matteo Salvini, leader della Lega.
Giampiero
Mughini per Dagospia il 10 giugno 2020. Caro Dago, non è certo la prima volta
che il presente si mette a fare a cazzotti contro le tracce del passato, com’è
successo adesso in Inghilterra dove la statua che ricorda un grande imprenditore
inglese del Settecento che si era arricchito con il mercato degli schiavi è
stata lanciata nelle acque di un fiume, e dove una statua in onore di Winston
Churchill è stata imbrattata da un qualche cretino del terzo millennio che ha
dato a Churchill del razzista. Per passare dalla farsa alle cose serie, in
Ungheria hanno rimosso da non molto una statua che onorava il maresciallo
sovietico Ivan Konev che era stato alla testa delle truppe russe che nel 1945
avevano spodestato i tedeschi da Praga, solo che era lo stesso maresciallo
sovietico alla testa dei carri armati che nel 1956 erano entrati a Budapest
senza che nessun ungherese li avesse invitati. Non solo: in un’altra zona di
Praga le autorità cittadine hanno deciso di erigere una statua in memoria del
controverso generale russo Vlasov, una delle figure più tragiche della Seconda
guerra mondiale. Uno dei più valorosi e intelligenti comandanti dell’Armata
Rossa, venne preso prigioniero dai tedeschi nella primavera del 1942. Convinto
com’era che i tedeschi avrebbero vinto la guerra e altrettanto convinto che
Stalin fosse un criminale politico, Vlasov valutò che gli fosse possibile
costituire uno spezzone di esercito russo democratico che combattesse a fianco
dei tedeschi e che a guerra finita fosse protagonista della ricostruzione
dell’Urss. Ambizione, ingenuità, una scelta disperata la sua? Un po’ di tutto
questo e anche se alcuni scrittori e studiosi, Alexander Solgenitsin su tutti
scrivono con rispetto di Vlasov, che alla fine della guerra tentò di darsi
prigioniero agli americani. Quelli lo rifiutarono e lui cadde nelle mani dei
russi, che lo impiccarono nell’agosto 1946s. E’ un fatto che nel maggio 1945 gli
uomini di Vlasov furono in prima linea nel sostenere l’insurrezione dei praghesi
contro i tedeschi. 300 di loro caddero in combattimento. I praghesi di oggi
hanno voluto ricordare l’impegno di Vlasov e dei loro uomini con una statua che
ne esalta la memoria. Ci sono statue e statue. Alessandro Robecchi sul “Fatto”
di oggi ha perfettamente ragione che il mausoleo eretto ad Affile nel 2012 in
onore del maresciallo Graziani è una vergogna e basta, data la truce fisionomia
del personaggio. Laddove avevano fatto benissimo l’allora sindaco di Roma
Francesco Rutelli e Gianni Borgna a tentare di intestare una via una ventina e
passa di anni fa a Giuseppe Bottai, un fascista di cui l’Italia non si deve
vergognare, uno che dopo aver votata o contro Mussolini nella seduta del Gran
Consiglio del fascismo del 25 luglio 1943, andò a combattere i tedeschi nella
Legione straniera. Fortemente contrastati, Rutelli e Borgna decisero di no.
Peccato, sarebbe stato un atto di lealtà verso la complessità di ogni comparto
della storia umana. E a proposito di tracce del passato, qualche semianalfabeta
che pur rivestiva cariche pubbliche ha di recente pronunziato parole minacciose
contro le tracce del regime fascista nell’architettura degli anni Trenta e
Quaranta, laddove la buona parte di quell’architettura figura tra le cose più
belle dell’intera architettura novecentesca. A cominciare dal meraviglioso
quartiere dell’Eur o dalla Sala delle Armi di Luigi Moretti di cui ancora
aspettiamo il restauro completo. Alla fine della guerra Moretti venne arrestato
e restò in carcere per un mese, e per fortuna che i suoi capolavori siano ancora
intatti nello splendore razionalista di cui costituiscono una campionatura
eccezionale. Per la recente puntata di una trasmissione Rai in cui la mia amica
disabile Fiamma Satta viene condotta ogni volta in carrozzella in un posto che
ne vale la pena, io e lei abbiamo circumnavigato assieme una scuola pubblica che
Moretti progettò alla fine degli anni Trenta in ogni suo stupefacente dettaglio.
Mirabilie che fanno da patrimonio dell’umanità. Altro che “tracce di un passato
da dimenticare”.
Giù le mani da Montanelli o cancellate pure Maometto.
Ricordate quando i talebani, in Afghanistan, distrussero a
colpi di dinamite le effigi storiche - compresi monumenti millenari - contrarie
al loro credo via via che conquistarono fette di terreno? Alessandro Sallusti,
Giovedì 11/06/2020 su Il Giornale. Ricordate quando i talebani, in Afghanistan,
distrussero a colpi di dinamite le effigi storiche - compresi monumenti
millenari - contrarie al loro credo via via che conquistarono fette di terreno?
Io lo ricordo bene, e ricordo lo sdegno unanime del mondo libero per quel
sacrilegio: la storia e la memoria non si toccano, barbari che non siete altro.
Bene, oggi i barbari siamo noi o, meglio, i barbari sono tra noi. Sull'onda
dello sdegno per il ragazzo di colore ucciso dal poliziotto bianco, in Occidente
è partita la caccia a distruggere o rimuovere tutto ciò che rimanda a un passato
di soprusi e violenze su minoranze e fasce deboli, re, imperatori o eroi che
siano. Siccome la mamma dei cretini è sempre incinta - e chi non vive e pensa di
suo è costretto a emulare - ieri a Milano un gruppo di squinternati appoggiati
da esponenti del Pd locale (ti pareva) ha annunciato un'iniziativa per fare
togliere dai Giardini pubblici di via Palestro la statua che rappresenta e
ricorda Indro Montanelli, in quanto convinto partecipante alla guerra coloniale
italiana in Abissinia del 1935, durante la quale - aggravante - a 23 anni si
fidanzò con un'indigena di soli 12 anni (episodio da lui raccontato -
conoscendolo - con un probabile eccesso di fantasia e licenza letteraria).
Applicare le regole e il sentire di oggi a fatti successi cent'anni fa - come
ben meglio di me spiega oggi su queste pagine Giordano Bruno Guerri - è un non
senso ridicolo (a quel tempo in Abissinia le ragazze a tredici anni erano già
madri). Ma se proprio vogliamo fare piazza pulita dei «pedofili» del passato, ho
un consiglio da dare al comitato anti-Montanelli e al Pd milanese. Cari signori,
procediamo per via gerarchica. E in cima alla lista metterei Maometto, il
fondatore dell'islam, che, superati i quarant'anni, accettò in dono come sposa -
in cambio della sua benevolenza nei confronti della sua tribù - Aisha, una bimba
di otto anni. So che non esistono monumenti o effigi di Maometto da rimuovere
perché quella religione li vieta, ma se vogliamo mettere al bando i simboli di
ciò che oggi è (giustamente) considerato impuro, beh l'islam non dovrebbe avere
diritto di cittadinanza nella civile Milano. Io penso che sarebbe un'operazione
demenziale contro la quale mi batterei. Quindi, per favore, giù le mani da Indro
Montanelli, perché altrimenti ognuno potrebbe sentirsi libero di alzarle su chi
gli pare.
Il dibattito sul monumento a Milano.
Montanelli e la sposa bambina africana: “perché quella statua va
tolta”. Redazione su Il Riformista l'11 Giugno 2020. Si abbattono statue in
tutto il mondo. Schiavisti, colonialisti, imperialisti. È uno degli effetti
della morte di George Floyd, il 46enne afroamericano ucciso in un violento
intervento della polizia a Minneapolis, nel pomeriggio del 25 maggio. Le statue
di Re Leopoldo II del Belgio, di Winston Churchill, di Cristoforo Colombo sono
state vandalizzate o abbattute. Si è riaperto allora il dibattito sulla statua
di Indro Montanelli nei giardini omonimi a Milano, in zona Porta
Venezia. L’organizzazione antifascista I Sentinelli di Milano hanno chiesto
infatti al sindaco Giuseppe Sala e al Consiglio Comunale di rimuovere il
monumento al giornalista in quanto “fino alla fine dei suoi giorni Montanelli –
Soldato in Etiopia, negli anni Trenta – ha rivendicato con orgoglio il fatto di
aver comprato e sposato una bambina eritrea di dodici anni perché gli facesse da
schiava sessuale”. Non è un dibattito nuovo. Già nel 2019, in occasione delle
manifestazioni per la Festa della Donna dell’organizzazione femminista
Nonunadimeno, la statua era stata imbrattata con della vernice rosa. La storia
risale al 1935, quando Montanelli, 26enne fascista, reporter, comandante di
compagnia del XX Battaglione Eritreo, comprò dal padre e sposò una 12enne
abissina di nome Destà. La vicenda venne raccontata nel libro XX Battaglione
Eritreo e dallo stesso giornalista, anni dopo, nel 1969, durante la
trasmissione L’ora della verità di Gianni Bisiach. In quell’occasione, però, il
giornalista trovò Elvira Banotti a contestare argomentazioni e aneddoti. “In
Europa si direbbe che lei ha violentato una bambina di 12 anni, quali differenze
crede che esistano di tipo biologico o psicologico in una bambina africana?“,
incalzò Banotti lasciando in alcuni tratti senza parole Montanelli. Banotti era
una giornalista e scrittrice italiana nata ad Asmara. Negli anni espresse anche
lei posizioni controverse, come per esempio contro “il totalitarismo gay”.
Difese Silvio Berlusconi nel dibattito sul processo Ruby. Resta comunque negli
archivi e nella memoria di molti quel botta e risposta, con un Montanelli
sconcertato, o quantomeno spiazzato, dalle parole della femminista. Il
giornalista, in Africa, aveva contratto un rapporto di madamato, ovvero una
relazione more uxorio in territorio coloniale. E per questo venne accusato da
Banotti; e per questo la sua statua è stata imbrattata dalle femministe con un
secchio di vernice rosa. A favore della proposta dei Sentinelli, di rimuovere la
statua, anche l’Arci: “Nella Milano Medaglia d’oro della Resistenza questa è
un’offesa alla città e ai suoi valori democratici”. Contraria su tutta la linea
la destra. In primis la Lega. “Giù le mani dal grande Indro Montanelli! Che
vergogna la sinistra, viva la libertà”, ha dichiarato il leader Matteo
Salvini. “Il fatto che il Partito Democratico ipotizzi di discutere l’idiozia
lanciata dai novelli stalinisti di voler mettere le mani sulla statua a ricordo
di Montanelli, un grande milanese e italiano, dimostra che il Dna della sinistra
caviale e champagne è sempre quello della cancellazione della storia scomoda“,
ha commentato il capogruppo della Lega al Comune di Milano e parlamentare,
Alessandro Morelli. Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza della Regione
Lombardia ed esponente di Fratelli d’Italia, si spinge fino a una fantomatica
“Floyd mania“: “È una vergogna, un attacco alla memoria di uno dei più grandi
giornalisti italiani. La Floyd mania sta offuscando le menti anche di qualche
consigliere comunale”. Anche tra i consiglieri comunali del Pd, in verità, la
proposta ha destato perplessità. Il capogruppo del partito, Filippo Barberis, ha
spiegato di essere “molto lontano culturalmente da questi tentativi di
moralizzazione della storia e della memoria che trovo sbagliati e pericolosi”. A
difesa del giornalista e della sua memoria anche Beppe Severgnini, allievo di
Montanelli e firma del Corriere della Sera: “Montanelli poi capì l’ingiustizia e
l’anacronismo di quel legame; ma non negò, né rimosse, la vicenda. La
giovanissima Destà andò poi in sposa a un attendente eritreo, e con lui fece tre
figli: il primo lo chiamarono Indro”. Per Severgnini “se un episodio isolato
fosse sufficiente per squalificare una vita, non resterebbe in piedi una sola
statua. Solo quelle dei santi, e neppure tutte”.
Indro Montanelli, pedofilo e razzista.
Mario Furlan il 12 giugno 2020 su Il Giornale. Indro Montanelli era pedofilo e
razzista. E’ quanto sostengono alcuni gruppi antirazzisti e femministi, che a
Milano vorrebbero rimuovere la statua del grande giornalista dai giardini
pubblici a lui intitolati. E che vorrebbero, naturalmente, intitolare i giardini
a qualcun altro. Più degno di lui. La colpa di Montanelli? Arrivato all’Asmara
nel 1935, reporter ventiseienne, viene nominato comandante di compagnia nel XX
Battaglione Eritreo, formato a ascari, mercenari locali. Era tradizione che gli
italiani trasferiti laggiù, a migliaia di chilometri da casa, si prendessero
come compagna una donna africana. Al giovane Indro venne proposta una minorenne
locale, e lui non si sottrasse. Si vollero bene. Ma per fortuna Montanelli capì
che quel legame era sbagliato. Quando la relazione terminò, la ragazza sposò un
attendente eritreo. Con lui fece tre figli, il primo lo chiamarono Indro. Eccola
qui, la grande colpa del grande scrittore. Ecco perché era razzista: perché si
era messo insieme ad una ragazza di colore (dovrebbe semmai essere il contrario:
un bianco che va con una nera dimostra che il colore della pelle non conta). Ed
ecco perché era pedofilo: perché lei non era ancora maggiorenne. Che dire,
allora, di Maometto, che ebbe la bellezza di 13 mogli, tra cui una schiava copta
(pure schiavista, oltre a razzista!), e addirittura 16 concubine? La sua moglie
più importante, Aisha, venne sposata formalmente quando aveva 6 anni. E il
rapporto venne consumato quando ne aveva 9. Oggi ci scandalizziamo per certe
cose. Aggiungo: per fortuna. Un maggiorenne che fa sesso con una
minorenne finisce in gattabuia; se la ragazzina è una bambina, buttano via la
chiave. Ed è giusto che sia così. Oggi. Ma allora le tradizioni, la cultura, la
mentalità erano completamente diverse. Si viveva meno, si moriva prima e si
doveva prolificare prima. A 13 anni Gandhi sposò una tredicenne ed ebbero cinque
figli. Sbagliato, sbagliatissimo. Come i matrimoni combinati. Ma allora era la
regola. E se provavi a ribellarti venivi condannato, come eretico e nemico dei
valori familiari. Ci sono istanze giuste, giustissime. Che però, portate
all’estremo, diventano ridicole. Da quando, negli Usa e in tutto il mondo, il
movimento Black lives matter ha ripreso vigore dopo la tragica uccisione di
George Floyd, la piaga del razzismo è tornata all’ordine del giorno. Era ora,
visto anche che Trump si è permesso di mettere sullo stesso piano i suprematisti
bianchi e gli antirazzisti. Dopo i disordini di Charlotteville nell’agosto 2017,
in cui una giovane antifascista venne uccisa da un estremista di destra, il
Presidente disse qualcosa che fa ancora accapponare la pelle: “There were very
fine people on both sides”, “C’erano ottime persone da entrambe le parti”. Come
dire che anche gli scagnozzi del Ku Klux Klan sono ottime persone. Ben venga il
rigurgito antirazzista. Ma evitando che, oltre al razzismo, prenda di mira anche
il buon senso. E’ ridicolo abbattere le statue di Cristoforo Colombo, colpevole
di avere scoperto il Nuovo Mondo, e quindi di avere dato il via al genocidio
degli indiani. Così come è ridicolo voler tirare giù i monumenti a Winston
Churchill, l’eroe della lotta a Hitler, perché credeva che i bianchi fossero più
intelligenti dei neri e degli orientali. Idiozie, che però nell’epoca
dell’imperialismo europeo andavano per la maggiore. E c’è chi, in nome
dell’antirazzismo, vorrebbe mettere al bando Shakespeare. Perché antisemita nel
Mercante di Venezia. Leonardo da Vinci, animalista e vegano ante litteram,
scrisse: “Fin dalla più tenera età, ho rifiutato di mangiare carne. E verrà il
giorno in cui gli uomini guarderanno all’uccisione degli animali così come oggi
si guarda all’uccisione degli uomini”. Se il tempo dimostrerà che aveva ragione,
tra uno o due secoli, chissà, i posteri inorridiranno al pensiero che ancora nel
ventunesimo secolo si mangiavano gli animali. Guardando i video-choc degli
allevamenti intensivi, in cui mucche, maiali e pulcini sono (mal)trattati come
oggetti, resteranno a bocca aperta. E abbatteranno le statue di tutti quanti,
prima di loro, non sono stati vegetariani: razzisti, anzi specisti, perché
teorizzavano la superiorità di una specie sull’altra. E perché giustificavano,
in questo modo, le peggiori violenze su creature inermi. Quando, nel lontano
1983, sostenni l’esame di Maturità, scelsi il tema dal titolo “Cosa significa
essere figli del proprio tempo”. Spiegai che vuol dire ritrovarsi nelle idee e
nelle usanze, giuste o sbagliate, della propria epoca e del luogo in cui si
abita. Ci vuole coraggio a non essere figli del proprio tempo: si finisce
incompresi. O emarginati. O incarcerati. O uccisi. La cultura cambia, la morale
cambia, e ciò che allora era giusto oggi è sbagliato. E viceversa.
L’antirazzismo è un dovere morale. Il politically correct è, invece, moralismo.
Ossia il tentativo di impancarsi ad eticamente superiori. E’ facile, e
gratificante: io mi sento moralmente superiore a te, perché tu hai fatto questo
e quest’altro di sbagliato. Visto che siamo uomini, quindi peccatori, trovare
qualcosa di sbagliato in qualcuno è facilissimo. E di questo passo dovremmo
abbattere tutte le statue, e cambiare in nome a tutte le strade. Non si
salverebbero nemmeno i santi: anche loro avevano difetti. Come disse Andreotti,
uno che di peccati se ne intendeva, “ distinguerei le persone
morali dai moralisti. Perché molti di coloro che parlano di etica, a forza di
discuterne, non hanno poi il tempo di praticarla.”
Statua di Montanelli a Milano, Di Maio: "Nessuno ha il diritto
di rimuoverla". Sala: "Contrario a toglierla, tutti facciamo errori".
Pubblicato venerdì, 12 giugno 2020 da La Repubblica.it. "A distanza di oltre 40
anni" - dall'agguato terroristico a Indro Montanelli - nessuno può "arrogarsi il
diritto di rimuovere la sua statua, di cancellare la memoria di quell'agguato.
Un agguato contro un uomo e contro la libertà che quell'uomo stesso, con grande
dignità, ha sempre rappresentato. Mi auguro che il Comune di Milano quella
libertà voglia difenderla. Pensiamo al futuro, costruiamo nel presente.
Prendiamo lezione dal passato e guardiamo avanti, con fiducia e determinazione.
L'Italia è anche questo e dobbiamo esserne orgogliosi". Con un lungo post su
Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio interviene nelle polemiche sulla
richiesta da parte dell'associazione I Sentinelli di Milano di rimuovere la
statua dedicata al giornalista nei giardini vicino Porta Venezia, cambiando
anche l'intitolazione dei giardini stessi. Una richiesta a cui risponde anche il
sindaco di Milano Beppe Sala dicendo di non essere favorevole. Tutto è nato
mercoledì, quando l'associazione antirazzista e per i diritti I Sentinelli di
Milano scrive una lettera pubblica al sindaco e al Consiglio comunale: "A Milano
ci sono un parco e una statua dedicati a Indro Montanelli, che fino alla fine
dei suoi giorni ha rivendicato con orgoglio il fatto di aver comprato e sposato
una bambina eritrea di dodici anni perché gli facesse da schiava sessuale,
durante l'aggressione del regime fascista all'Etiopia. Noi riteniamo che sia ora
di dire basta a questa offesa alla città e ai suoi valori democratici e
antirazzisti e richiamiamo l'intero consiglio a valutare l'ipotesi di rimozione
della statua, per intitolare i Giardini Pubblici a qualcuno che sia più degno di
rappresentare la storia e la memoria della nostra città Medaglia d'Oro della
Resistenza". Di Maio scrive su Facebook, accompagnando le sue parole con una
foto di Montanelli subito dopo la gambizzazione: "Il 2 giugno 1977, più di
quarant'anni fa, Indro Montanelli prese a camminare lungo la cancellata dei
giardini pubblici di Milano. Gli si avvicinarono due giovani. Uno dei due
estrasse dal giubbotto una pistola con silenziatore e sparò otto colpi. Quattro
proiettili andarono a segno: tre attraversarono la coscia destra e l'altro
trapassò un gluteo e si fermò contro il femore sinistro. Montanelli non cadde
subito. Il suo pensiero, anche in quegli istanti, fu quello di restare in piedi,
aggrappandosi a una inferriata che aveva accanto. In piedi, con la schiena
dritta, com'è sempre stato. Era stato colpito il più grande giornalista italiano
di allora, oggetto in quel periodo di una campagna d'odio senza precedenti. Le
Brigate Rosse rivendicarono l'attacco. Oggi, in quegli stessi giardini pubblici
di Milano, c'è una statua che ricorda quel momento. Ritrae Montanelli con la sua
Lettera 22 sulle ginocchia. E in passato, è vero, lui stesso criticò
quell'opera, sostenendo che i "monumenti sono fatti per essere abbattuti". Idee
e valori di un giornalista attento e scrupoloso, ma soprattutto di un uomo
libero. Anche questo era uno dei tratti che lo distingueva da tutti gli altri.
Montanelli vantava un'onesta intellettuale che gli permetteva di soprassedere
alle logiche dei personalismi e della vanità. Lavorava per raccontare i fatti.
Scriveva per la verità. Non aveva bisogno di elogi, né di onorificenze". "Non
sono favorevole alla rimozione della statua di Montanelli: penso che in tutte le
nostre vite ci siano errori, e quello di Montanelli lo è stato. Ma Milano
riconosce le sue qualità, che sono indiscutibili". Nel dibattito rovente sulla
richiesta di rimuovere la statua di Indro Montanelli dai giardini a lui dedicati
(e quindi di cambiare anche l'intitolazione) è intervenuto anche il sindaco di
Milano Beppe Sala. Con un parere - espresso in un'intervista al quotidiano Il
Giorno - che, per quanto non vincolante in quello che al momento resta un
dibattito accademico, comunque pesa. "Non mi piacevano tutte le sue posizioni, a
volte eccedeva in protagonismo. Ma aveva una penna straordinaria", ha spiegato
il sindaco. Nel post I Sentinelli collegano questa richiesta alla cronaca: "Dopo
la barbara uccisione di George Floyd a Minneapolis le proteste sorte
spontaneamente in ogni città con milioni di persone in piazza e l'abbattimento a
Bristol della statua in bronzo dedicata al mercante e commerciante di schiavi
africani Edward Colston da parte dei manifestanti antirazzisti di Black Lives
Matter richiamiamo con forza ogni amministrazione comunale a ripensare ai
simboli del proprio territorio e a quello che rappresentano". Le reazioni, in
due giorni, sono state tantissime. Politici, intellettuali, molti contrari
all'ipotesi con toni più o meno accesi (tra i più accesi quelli del segretario
della Lega Matteo Salvini) e con posizioni diverse nel centrosinistra, anche se
proprio il capogruppo del Pd a Milano Filippo Barberis ha già dato il suo parere
negativo. Ora arriva quello del sindaco Sala: ma a questo punto bisognerà vedere
se la proposta approderà comunque in Consiglio comunale. E la Fondazione
Montanelli Bassi di Fucecchio (Firenze) ha scritto al sindaco Sala per dire che
"anche il solo ipotizzare la rimozione della statua di Indro Montanelli sarebbe
un'offesa alla memoria del più popolare e apprezzato giornalista italiano del
Novecento". La missiva è firmata dal presidente della Fondazione, Alberto
Malvolti: "Le testimonianze lasciate da Montanelli e il contesto storico in cui
quei fatti avvennero - prosegue Malvolti - dimostrano che non ci fu alcuna
violenza né tanto meno ci furono atteggiamenti razzisti da parte di Indro, che
accettò quel "matrimonio" proposto dalla popolazione locale e celebrato
pubblicamente secondo gli usi e i costumi abissini".
Lorenzo Mottola per ''Libero Quotidiano'' il 12 giugno 2020. Nel
1935, l'allora giovane Indro Montanelli - era nato a Fucecchio (un paesotto di
20mila abitanti a metà strada tra Firenze e Pisa) il 22 aprile 1909 - già
laureato in Legge e già giornalista di qualche peso, con articoli pubblicati da
Il Frontespizio di Piero Bargellini, l' Universale di Berto Ricci, il Popolo d'
Italia di Mussolini e per il quotidiano francese Paris-Soir, decide di
partecipare da volontario all' impresa coloniale fascista in Etiopia. Il 27
giugno viene incorporato all' Asmara nel XX Battaglione eritreo (sarà questo
anche il titolo del suo primo romanzo, pubblicato per la prima volta nel 1936 e
recensito entusiasticamente sul Corriere della Sera da Ugo Ojetti; sarà poi
riedito nel 2010 con le lettere inedite ai genitori dal fronte) , come
comandante di un plotone di ascari. I quali, seguendo una consolidata
tradizione, lo invitano, pena la perdita di prestigio ai loro occhi, a prendere
per moglie una ragazzina di 12 anni. Indro ne parlerà più volte apertamente nel
corso della sua vita, anche in una celebre intervista televisiva del 1972, fino
a una "Stanza" del 2000 sul Corriere, poco prima di morire. Sempre rivendicando
il proprio operato e sempre uscendone a testa alta. Proprio per questo non si
comprendono le polemiche di questi giorni e le richieste al sindaco di Milano
Giuseppe Sala di rimuoverne la statua dall' omonimo parco, così come non si
spiegava l'atto vandalico che questa aveva subito l' anno scorso venendo
imbrattata di vernice rosa a opera delle femministe. Del resto, la parola
definitiva sullo "scandalo" eritreo l' aveva pronunciata nel giugno 2019 Angelo
Del Boca, il maggiore storico del colonialismo italiano, che proprio con
Montanelli si era reso protagonista di una lunga diatriba sull' uso dei gas
nella guerra d' Etiopia. Il grande giornalista lo negava, mentre il grande
storico cercava di dimostrarne l' impiego sistematico. Alla fine, la scoperta di
documenti ufficiali aveva chiuso la questione nel 1996. Questo per dire come l'
ex partigiano Del Boca non aveva certo remore nel contraddire e attaccare
Montanelli. Ebbene, l' autore di volumi fondamentali come Gli Italiani in Africa
Orientale (Laterza), I gas di Mussolini (Editori Riuniti), La nostra Africa
(Neri Pozza) e Italiani, brava gente? (Neri Pozza) e delle principali biografie
del Negus Hailé Selassié e di Gheddafi, intervistato per il Tg2 Dossier dedicato
a Montanelli da Miska Ruggeri, era stato chiarissimo: . Sulla stessa lunghezza
d' onda un altro storico, Giordano Bruno Guerri, secondo cui: «Non possiamo
giudicare la storia con gli occhi di oggi, perché altrimenti non capiamo nulla
del passato e lo distorciamo». Guerri allarga il discorso anche a chi tira in
ballo, per le stesse ragioni, le figure di Winston Churchill e di Cristoforo
Colombo, o un film come "Via col vento". «Lo schiavismo», ricorda lo scrittore,
«è certamente da condannare, ma fino al Seicento tutti lo accettavano». Quanto a
Montanelli «è chiaro che lui ha fatto una cosa deprecabile», acquistando una
bambina eritrea. «La pedofilia e, tanto meno l' acquisto di qualcuno, è
assolutamente inaccettabile. Però non si può giudicare un protagonista della
storia da un solo episodio. Montanelli ha fatto anche altro, è stato uno dei più
grandi giornalisti italiani del '900, gambizzato dalle Brigate Rosse». «Come
lui», prosegue lo storico toscano, «anche altri intellettuali, ad esempio
Pasolini, hanno delle macchie. Ma se dovessimo abolire le personalità storiche
che hanno avuto delle macchie nella loro vita, non rimarrebbe quasi più
nessuno».
Gad Lerner
su Indro Montanelli: "Oggetto di venerazione sproporzionata rispetto alla sua
biografia".
Libero
Quotidiano l'11 giugno 2020. Siamo alla follia targata Pd. Già, perché alcuni
esponenti del Pd, intercettando la proposta dei cosiddetti Sentinelli (gruppo
laico e antifascista, così come si presentano sui social), invocano la rimozione
della statua di Indro Montanelli a Milano, ai giardini di via Palestro. La
ragione? "Montanelli fino alla fine dei suoi giorni ha rivendicato con orgoglio
il fatto di aver comprato e sposato una bambina eritrea di dodici anni perché
gli facesse da schiava sessuale, durante l'aggressione del regime fascista
all'Etiopia". Dunque chiedono rimozione della statua e cambio del nome dei
giardini. E ora, nel primo mattino di giovedì 10 giugno, sulla questione
interviene Gad Lerner, il quale su Twitter afferma quanto segue: "Andiamoci
piano con l'abbattimento delle statue. Qualcuno potrebbe ricordare che la Bibbia
contempla schiavismo e patriarcato: rimuoviamo pure il Mosè di Michelangelo?". E
fin qui tutto bene. Poi, però, Lerner aggiunge un PS: "Montanelli è oggetto di
venerazione sproporzionata alla sua biografia, non alimentiamola boicottandolo".
Già, secondo Lerner, insomma, Montanelli è sopravvalutato. Il gigante assoluto
del giornalismo sarebbe oggetto di "venerazione sproporzionata" e il rischio
sarebbe di aumentare tal venerazione rimuovendo la statua. Una presa di
posizione che lascia letteralmente senza parole.
Paolo Guzzanti per ''il Giornale'' il 12 giugno 2020. Nel clima
di caccia alle statue che si è sparso nel mondo, ieri Gad Lerner ha attaccato,
con temerarietà e sprezzo del ridicolo, la memoria di Indro Montanelli,
scomparso da nove anni, twittando un messaggio ridicolo e imbarazzante. Questo:
«Montanelli è oggetto di venerazione sproporzionata, non alimentiamola
boicottandolo». Il retroscena è noto. Essendo l' Italia un Paese a rimorchio
degli altri anche per inerzia e pigrizia degli intellettuali e poiché in America
si abbattono le statue di generali e politici schiavisti dell' Ottocento, da noi
c' è chi ha pensato di ritirare fuori - e fuori contesto la storia raccontata
dallo stesso Montanelli secondo cui durante la guerra d' Abissinia per la quale
partì volontario, sposò una ragazza abissina che, come tutte le spose del suo
Paese, era minorenne. Vista con gli occhi di oggi, fu una cosa inaccettabile, ma
all' epoca era purtroppo normale. Lerner, però, nel suo messaggio pubblico, non
richiama questo evento arcinoto e per il quale le femministe si sono indignate,
ma attacca la persona e quella che definisce «venerazione» per Montanelli,
condivisa da tutto il mondo giornalistico e letterario e recentemente espressa
anche da Eugenio Scalfari, fondatore di Repubblica. Ora, io conosco bene Gad
Lerner con cui ho lavorato alla Stampa e ho talvolta apprezzato il suo
giornalismo, ma certamente non l' ho venerato e credo che non lo veneri nessuno.
Purtroppo Lerner ha nella sua storia professionale l' ombra di una vicenda che
non gli permette proprio di tenere un corso di antipedofilia, come ha fatto
attaccando un grande giornalista e protagonista. Morto, fra l' altro, sullo
stesso fronte politico su cui si trova Lerner: quello dell' antiberlusconismo,
dopo aver rotto con il suo ex editore che gli aveva permesso di sopravvivere con
un Giornale economicamente fallito. Il fatto è che Lerner, come direttore del
Tg1 Rai, mandò in onda un servizio vergognoso sulla pedofilia, con immagini
ignobili per le quali dovette scusarsi pubblicamente, di fronte all' Italia
stupita e indignata, per non avere controllato la messa in onda di materiale
pedo-pornografico. Le sue scuse furono chieste dai vertici della Rai e del mondo
giornalistico e politico. Fu, quel servizio, una macelleria di bambini già
violentati fisicamente e poi nelle immagini del telegiornale diretto da Gad
Lerner. Poi, per carità, ognuno su Montanelli può avere l' opinione che vuole e
forse Lerner vede oltre la stima, anche la «venerazione» (parola che ha scelto
lui) di chi lo ha stimato e amato, fra cui Marco Travaglio, direttore del Fatto
per cui scrive ora Lerner e che è stato un «Montanelli boy». È un fatto storico
che Indro Montanelli sia stato un rivoluzionario del giornalismo e un
coraggioso, che mai e poi mai, da vivo, avrebbe proposto il «boicottaggio» di
Gad Lerner, perché spropositatamente venerato. Certe cose un uomo non le fa: se
uno pensa di boicottare la memoria di un grande protagonista, deve almeno avere
un passato impeccabile nel campo per cui si scaglia contro un morto. E la storia
del vergognoso servizio in materia di pedofilia non ci sembra impeccabile, ma
più deplorevole degli usi e costumi del mondo coloniale di novanta anni fa.
Andrea Galli e Maurizio Giannattasio per corriere.it il 14 giugno
2020. Almeno cinque barattoli di vernice di colore rosso. Vernice utilizzata per
cospargere la statua di Indro Montanelli e farla colare sulla testa, sul busto,
sugli arti come sangue. E due bombolette di spray di colore nero. Spray
utilizzato per scrivere alla base del monumento, nei giardini tra le vie
Palestro e Manin intitolati proprio al giornalista e scrittore, due parole che,
nei piani degli esecutori, sintetizzano e spiegano l’agguato: «Razzista
stupratore». Il vandalismo è avvenuto nel pomeriggio di ieri. Del caso si occupa
la Digos. Un blitz che potrebbe avere avuto numerosi testimoni ed esser stato
ripreso dalle telecamere. Ci sono sì impianti, nelle strade adiacenti il parco e
all’interno della stessa area verde, ma è anche vero che esistono percorsi di
avvicinamento e allontanamento verso la statua «scoperti». L’indagine potrebbe
non essere fulminea. Come invece sembra essere stata l’azione. Quantomeno,
un’azione studiata, preparata. C’erano più persone, e magari altri complici a
far da palo lungo il perimetro dei giardini e in prossimità dei cancelli. A ieri
sera, nessuno ha rivendicato il blitz, eseguito dopo intensi giorni di dibattito
in seguito alla richiesta dei Sentinelli, che sostengono di battersi per i
diritti, di rimuovere il monumento in relazione al passato colonialista di
Montanelli, quando in Abissinia (era un giovane sottotenente) sposò e convisse
con una minorenne. Nei giorni scorsi i Sentinelli avevano scritto una lettera al
sindaco Beppe Sala e al consiglio comunale tutto. Più che una lettera, era stato
un appello. Ancor di più, un’esplicita richiesta da soddisfare nel breve
volgere. Ovvero rimuovere la statua ed erigerne altre dedicate a personalità più
«degne». E come una sequenza di voci contrarie s’era subito messa in moto, così
le reazioni nell’apprendere il vandalismo sono state immediate. Fra i primi a
intervenire, il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana: «Proprio
non ci siamo. L’odio, la cattiveria e l’astio sono sempre più dominanti sul
confronto civile e democratico. C’è da preoccuparsi seriamente». Roberto Cenati
guida l’associazione milanese dell’Anpi. E rimane fermo sulla posizione già
espressa, un invito ad analizzare l’intera vita e la professione del
giornalista: «Nessuno vuole difendere quel passato. Ma ricordo che il monumento
a Montanelli è stato costruito a pochi passi da dove fu gambizzato dai
brigatisti. Ha un significato particolare, questa statua. Quei terroristi
avevano voluto colpire la libertà di stampa. Sono preoccupato per questa deriva
iconoclasta che vuole emendare la storia». Non è la prima volta — e a registrare
i fatti il timore è che non sia l’ultima — che il giornalista diventa un
bersaglio. Scelto e colpito. Un simbolo eletto a rappresentazione del male e
meritevole di essere cancellato nella sua memoria. Le mosse dei Sentinelli
avevano seguito le «diramazioni» dell’assassinio negli Stati Uniti di George
Floyd. Era stata per esempio abbattuta la statua di Edward Colston, un mercante
di schiavi, e allo stesso tempo aveva subìto oltraggi il monumento a Winston
Churchill. Attaccare ovunque, attaccare in ordine sparso. Qui in Italia, per
appunto, ecco Indro Montanelli, inviato, scrittore, storico, narratore del
mondo. Difficile che nessuno abbia visto il blitz: era sabato, e di sabato i
giardini sono affollati. Sulla statua i vandali hanno dovuto arrampicarsi e
sostare, per versare la vernice; dopodiché, plausibilmente, hanno dovuto
scappare. Non sono passati inosservati.
"Razzista, stupratore", vandalizzata la statua di Montanelli.
Dopo le polemiche degli ultimi giorni ecco la
concretizzazione del forte astio emerso nei confronti del giornalista: statua
imbrattata con almeno quattro barattoli di vernice e scritta ingiuriosa sul
basamento della stessa. Federico Garau, Domenica 14/06/2020 su Il Giornale. Che
la statua di Indro Montanelli collocata nei giardini di via Palestro (Milano) a
lui dedicati fosse stata al centro delle polemiche in questi giorni è cosa
oramai risaputa, ma quanto accaduto nelle ultime ore va ben oltre delle semplici
rimostranze. Per la seconda volta nella sua storia, iniziata con l'inaugurazione
ufficiale il 22 maggio del 2006, è stata vandalizzata, questa volta da ignoti,
che l'hanno imbrattata utilizzando una vernice rossa. Il lavoro è stato poi
completato con l'aggiunta della scritta "Razzista stupratore", che campeggia in
nero sul basamento poco sotto l'incisione del nome del giornalista originario di
Fucecchio. Il primo episodio del genere risale all'8 marzo dello scorso anno
quando, in occasione dello svolgimento di una manifestazione femminista nel
giorno della Festa della donna, il gruppo "Non una di meno" imbrattò la statua
di Montanelli con una vernice rosa. Più recenti, invece, le proteste dei "laici
ed antifascisti" Sentinelli, che ne avevano chiesto la rimozione in un post
pubblicato su Facebook, spingendo anche per un cambio di intitolazione dei
giardini di via Palestro. "A Milano ci sono un parco e una statua dedicati a
Indro Montanelli, che fino alla fine dei suoi giorni ha rivendicato con orgoglio
il fatto di aver comprato e sposato una bambina eritrea di dodici anni perché
gli facesse da schiava sessuale, durante l'aggressione del regime fascista
all'Etiopia", avevano attaccato gli attivisti. "Noi riteniamo che sia ora di
dire basta a questa offesa alla città e ai suoi valori democratici e
antirazzisti e richiamiamo l'intero consiglio a valutare l'ipotesi di rimozione
della statua, per intitolare i Giardini Pubblici a qualcuno che sia più degno di
rappresentare la storia e la memoria della nostra città Medaglia d'Oro
della Resistenza". Proposte che, specie sull'onda delle polemiche sorte dopo la
morte di George Floyd, richiamata anche dagli stessi Sentinelli, avevano trovato
l'immediato consenso di alcuni consiglieri comunali del Pd. "Le motivazioni
della richiesta di rimuovere la statua le riconosco come valide perché quella è
stata una brutta pagina della nostra storia", aveva detto Diana De Marchi.
"Vanno indagate le motivazioni che hanno portato all'intitolazione e valutare se
siano ancora valide oggi. Da parte mia, farò in modo che se ne discuta". Almeno
quattro i barattoli di vernice svuotati sulla statua di Montanelli e lasciati
sul posto dai vandali unitamente ad alcuni sacchetti di carta. Preoccupazione
per la vicenda e per il crescente clima di tensione è stata espressa in serata
dal presidente della regione Attilio Fontana. "Proprio non ci siamo. L'odio, la
cattiveria e l'astio sono sempre più dominanti sul confronto civile e
democratico. C'è da preoccuparsi seriamente", ha commentato il governatore, come
riportato da Agi.
Da repubblica.it il 13 giugno 2020. Momenti di tensione tra
estremisti di destra e polizia a Londra dove i nazionalisti britannici si erano
dati appuntamento per una manifestazione "in difesa dei nostri monumenti". Lo
riporta la Bbc. L'altra protesta programmata nella capitale britannica, quella
del movimento Black Lives Matter, che nei giorni scorsi aveva anche visto
episodi di violenza contro alcune figure storiche del Regno Unito, era stata
annullata dagli organizzatori per evitare lo scontro con i gruppi di estrema
destra. Tra i manifestanti oggi anche Paul Golding, leader di Britain First, e
gruppi di tifosi di calcio provenienti da tutto il Paese. Alcuni si sono
radunati davanti alla statua di Winston Churchill, nella piazza del Parlamento,
altri davanti al Cenotafio. L'atmosfera si è surriscaldata quando alcuni
manifestanti hanno tentato di superare le transenne davanti a Downing Street e
hanno lanciato oggetti contro la polizia. Il ministro degli Interni, Priti
Patel, ha pubblicato su Twitter i video degli scontri definendoli "inaccettabili
atti di violenza". "Chiunque compia violenza o vandalismi dovrà risponderne
davanti alla giustizia - ha scritto Patel -. La violenza verso i nostri agenti
non sarà tollerata"
Da leggo.it il 13 giugno 2020. «Non mi piacciono le strette al
collo», ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox rilanciata da altri media,
parlando della pratica che ha provocato la morte dell'afroamericano George Floyd
durante il suo arresto, in una vicenda che ha scatenato proteste antirazziste
negli Stati Uniti e in altri paesi. Il presidente americano ha detto che in
"parlando in generale, bisognerebbe mettere bene" alle strette al collo. Ma è
anche apparso terribile che a volte è inevitabile agire in questo modo. «Qualche
volta, quando ti batti con qualcuno, è dura. E c'è qualcuno che stringe al
collo, e che fai? Ed è veramente una persona brutta, e tu lo sai, perché ne
compresi. Voglio dire, c'è gente veramente cattiva », ha anche detto Trump, in
quella che appare una giustificazione. «Stringi al collo qualcuno e che fai? -
ha continuato - dici, ripartiamo, non ti posso stringere il collo? è una
situazione molto difficile ».
Morte Floyd: a Parigi black-bloc in azione, scontri con la
polizia. Pubblicato sabato, 13 giugno 2020 da La
Repubblica.it. Si fa sempre più pesante il clima alla manifestazione di Parigi
contro le violenze della polizia bloccata a République: negli ultimi minuti si
registra un fitto lancio di sassi e altri oggetti contro gli agenti. Sono in
azione gruppi di black-bloc. Da parte delle forze dell'ordine sta arrivando
sulla folla una pioggia di lacrimogeni. La prefettura tollera la presenza di
6.000 persone sulla piazza nonostante le regole sanitarie post-lockdown vietino
ancora gli assembramenti di più di 10 persone. Impossibile, però, sfilare per la
città. La protesta è stata organizzata dal comitato Adama Traorè, dal nome del
giovane nero morto nel 2016 dopo essere stato fermato dalla Polizia. È comparso
anche un enorme ritratto che mostra un volto metà Traore, metà Floyd. La sorella
di Traore, Assa, ha detto alla folla: "Chiediamo tutti la stessa cosa, giustizia
equa per tutti". La tensione è salita soprattutto dopo che un gruppo di
militanti "ultras bianchi" ha dispiegato uno striscione sul tetto di un palazzo
che si affaccia su Republique, con le scritte "Razzismo anti-bianchi" e "White
lives Matter", in risposta allo slogan che echeggia nelle manifestazioni
americane di questi giorni "Black lives Matter". Sulla scia della morte di Floyd
e delle proteste globali, il governo francese è stato sottoposto a crescenti
pressioni per affrontare le accuse a lungo termine di eccessiva violenza da
parte della polizia, in particolare contro le minoranze. Il ministro degli
Interni, Christophe Castaner, ha promesso questa settimana di sradicare il
razzismo e ha annunciato il divieto per la polizia di usare strozzatori durante
gli arresti. D'altro canto, i sindacati di polizia francesi hanno tenuto le
manifestazioni, dicendo di essere stati ingiustamente etichettati come razzisti
a causa di pochi agenti con posizioni estremiste e di non avere abbastanza
strumenti per affrontare i sospetti violenti. Dopo l'incontro con i
rappresentanti sindacali, Castaner ha dichiarato che la polizia inizierà a
sperimentare l'uso allargato di pistole stordenti in futuro, nonostante le
preoccupazioni per la loro sicurezza.
Viviana Mazza per corriere.it il 22 giugno 2020. La statua che
raffigura Theodore Roosevelt a cavallo, e accanto a lui, a piedi, un nativo
americano e un africano, ha troneggiato all’entrata del Museo americano di
storia naturale di New York dal 1940. Ora sarà rimossa. A differenza di altre
statue attaccate dai manifestanti dopo l’uccisione di George Floyd, in questo
caso è stato il museo stesso a volerla rimuovere e il Comune ha dato il libera
finale. Gli attivisti lo chiedevano da tempo, ma il museo aveva difeso quel
«simbolo di un passato controverso dal quale possiamo imparare». Teddy Roosevelt
continuerà ad essere onorato come pioniere della tutela delle risorse naturali
(gli verrà dedicata anche la sala sulla Biodiversità, oltre a quelle che già
portano il suo nome). Il museo spiega che però la statua equestre andava rimossa
a causa della sua «composizione gerarchica» che rappresenta i neri e gli
indigeni come inferiori. Lo stesso Theodore Roosevelt IV, pronipote 77enne del
presidente americano (dal 1901 al 1909) e Premio Nobel per la Pace raffigurato
anche sul Monte Rushmore, si è detto d’accordo: «Il mondo non ha bisogno di
statue, relitti di un’atra era, che non riflettono né le virtù della persona che
intendono onorare, né i valori di uguaglianza e giustizia. Questa composizione
equestre non riflette l’eredità di Theodore Roosevelt. È tempo di rimuoverla e
andare avanti». Ma il presidente Donald Trump ha obiettato su Twitter:
«Ridicolo, non fatelo!» I critici di Roosevelt ricordano, tra le altre cose,
questa sua frase: «Non arrivo al punto di dire che l’unico indiano buono è un
indiano morto, ma credo che sia vero per nove su dieci». Barack Obama, tra gli
altri, ha invece celebrato il leader repubblicano progressista, definendolo il
promotore di «un sistema economico nel quale ogni uomo ha l’opportunità di
mostrare il meglio che è in lui». Roosevelt ha creato i parchi naturali
sottraendo le terre ai nativi. Era un uomo che pensava in linea con la visione
della superiorità bianca del tempo: voleva assimilare i nativi-americani,
rimuovendoli dalle loro terre e distruggendone la cultura, credendo che solo
così potevano accedere al Sogno americano e alla «rispettabile cittadinanza».
Da corriere.it il 23 giugno 2020. Momenti di tensione durante la
notte italiana in Lafayette Square a Washington, di fronte alla Casa Bianca,
dove i manifestanti hanno tentato di rimuovere la statua di Andrew Jackson. Per
disperdere la folla, affermano alcuni testimoni, la polizia avrebbe usato spray
al peperoncino. La polizia è intervenuta dopo che, cantando «Hey, Hey, Ho, Ho,
Andrew Jackson’s got to go», circa 150-200 manifestanti avevano cominciato a
legare la statua del settimo presidente degli Stati Uniti, con alcune corde.
Dopo alcuni scontri, durante i quali le forze dell’ordine hanno utilizzato anche
spray urticanti, i poliziotti sono riusciti a creare un cordone di sicurezza
attorno all’opera, che ritrae Jackson in sella a un cavallo. Jackson è finito
nel mirino del movimento antirazzista perché considerato responsabile del
cosiddetto «sentiero delle lacrime», la deportazione forzata dei nativi
americani dalle loro terre di origine. Per protesta contro la morte di George
Floyd molte sono le statue deturpate in America. «Numerose persone sono state
arrestate per questo vandalismo vergognoso. Attenti! — ha ammonito su twitter il
presidente Donald Trump mentre il segretario agli interni David Bernhardt che è
stato presente sulla scena ha rilasciato una dichiarazione in cui diceva: «Sia
chiaro: non ci inchineremo agli anarchici. La legge e l’ordine prevarranno e la
giustizia sarà servita...
Roberto Vivaldelli per ilgiornale.it il 28 giugno 2020. Sull'onda
delle proteste per la morte di George Floyd, il consiglio comunale di
Minneapolis è arrivato a votare - all'unanimità - una proposta radicale:
l'abolizione del dipartimento di polizia della città teatro dell'omicidio che ha
sconvolto l'America. Come spiega il New York Post, il voto unanime del civico
consesso non smantellerà automaticamente il dipartimento, ma è un primo passo in
un lungo processo legislativo che alla fine avrà bisogno del sostegno popolare
dei residenti nelle elezioni di novembre. Sarà necessaria la modifica dello
statuto comunale della città. Un progetto di emendamento pubblicato online
suggerisce di sostituire la forza di polizia con un "dipartimento di
prevenzione", composto da "ufficiali di pace" che garantiscano la sicurezza
pubblica con un "approccio olistico e orientato alla salute pubblica". "È tempo
di apportare cambiamenti strutturali", ha spiegato il consigliere comunale Steve
Fletcher all'Associated Press prima del voto. "È tempo di ricominciare da capo e
reinventare l'ambito della sicurezza pubblica". C'è però un ostacolo: il sindaco
di Minneapolis, Jacob Frey, non supporta la proposta e ha il potere di porre il
veto. Nel frattempo, in città, a Powderhorn Park, è spuntato dal nulla un
accampamento di oltre 300 homeless. Come riporta il New York Post, i residenti
del quartiere hanno deciso in un primo momento di non chiamare la polizia e
lasciare i senza tetto nelle loro tende improvvisate. Tuttavia, l'area è
diventata il ritrovo ideale di spacciatori e criminali in genere e due persone
sono finite all'ospedale a seguito di un'overdose. Carrie Nightshade è una mamma
e faceva parte, spiega il New York Post, di un gruppo di "donne bianche" che
avevano concordato di ignorare qualsiasi danno alla proprietà, inclusi quelli
alla propria abitazione. Ma ora si sente a disagio nel lasciare che i suoi due
figli, di 9 e 12 anni, giochino da soli nel parco. Un altro residente, Mitchell
Erickson, ha chiamato la polizia la settimana scorsa quando è stato minacciato
da due giovani fuori da casa sua, uno dei quali gli ha puntato una pistola al
petto mentre gli intimava di consegnarli di le chiavi della sua auto. "Mi pento
di aver chiamato la polizia" ha poi detto al Times. "Ho agito d'istinto. Ho
messo quei ragazzi in pericolo di morte chiamando la polizia". E mentre Donald
Trump si presente come il candidato che vuole ristabilire la legge e l'ordine
nelle strade d'America, come abbiamo raccontato a InsideOver l'esperimento della
zona occupata dai manifestanti in un'altra città americana, Seattle, finisce in
tragedia. Nelle scorse settimane, infatti, a seguito delle manifestazioni di
Black Lives Matter nella città sullo stretto di Puget, alcuni attivisti hanno
trasformato il quartiere di Capitol Hill in una "zona autonoma" senza polizia,
completamente autogestita dai residenti, denominata "Capitol Hill Organized
Protest”, o "Chop". Ma l’utopia del municipalismo libertario-anarchico alla
Bookchin ostile alle gerarchie, che tanto va di moda a sinistra, si è presto
trasformata in un incubo. Nella giornata di lunedì, infatti, il sindaco di
Seattle si è rivolto ai manifestanti sottolineando che “è ora che la gente torni
a casa” e lasci il quartiere di Capitol Hill.
Federico Rampini per “la Repubblica” il 28 giugno 2020.
L'Università di Princeton, una delle più prestigiose del mondo, cancella il nome
del presidente Woodrow Wilson che ne fu il rettore. La giustificazione: era
razzista. Nella campagna per eliminare dal paesaggio degli Stati Uniti ogni
traccia del passato schiavista o segregazionista, l'ultima vittima eccellente è
un leader che fu considerato tra i più progressisti della storia. Il consiglio
d'amministrazione dell'ateneo però non ha avuto esitazioni: «Il pensiero e le
politiche razziste di Wilson - si legge nel comunicato del Board of Trustees di
Princeton - rendono il suo nome inadatto a un'istituzione i cui studiosi e
studenti devono combattere il razzismo in tutte le sue forme». L'attuale
successore di Wilson alla guida dell'università, Christopher Eisgruber, ha
confermato che farà scomparire il nome dello statista, in particolare dalla
facoltà di Scienze politiche, Relazioni internazionali e Pubblica
amministrazione a lui intitolata (Woodrow Wilson School of Public and
International Affairs). Questa decisione, presa sull'onda della campagna
nazionale dopo l'uccisione di George Floyd, è un dietrofront totale rispetto a
quella di quattro anni fa: nel 2016 infatti le autorità accademiche di Princeton
avevano deciso di conservare il nome di Wilson su diversi edifici e programmi
universitari. Allora aveva prevalso il Wilson "buono", quello che è rimasto
nella storia per l'eredità progressista della sua presidenza. Nato nel 1856 in
uno Stato del Sud, la Virginia, il democratico Wilson dopo la carriera
accademica fu eletto alla Casa Bianca per due mandati e governò dal 1913 al
1921, quindi a cavallo della prima guerra mondiale. Nel resto del mondo fu
proprio il suo ruolo nella politica estera a farne uno dei leader americani più
amati e rispettati. Precursore di Franklin Roosevelt, fu lui a salvare una prima
volta l'Europa dal militarismo della Germania. Dopo la vittoria militare la
Società delle Nazioni per risolvere pacificamente le controversie fra Stati
(anche se poi il Congresso repubblicano sabotò la partecipazione degli Usa). Nei
suoi "Quattordici Punti" espose l'idea di un nuovo ordine internazionale basato
sulla liberaldemocrazia e l'autodeterminazione dei popoli. Ebbe scontri duri con
la Gran Bretagna e la Francia che difendevano i propri imperi coloniali. Nelle
sue tournée europee Wilson veniva acclamato come un benefattore. Anche negli
Stati Uniti la sua azione di governo ebbe un'impronta progressista: introdusse
per la prima volta una tassazione progressiva con aliquote "socialiste" (77%)
sugli alti redditi, e un'imposta di successione con effetti redistributivi.
Rafforzò l'antitrust. Tutto questo non conta più, in un clima dove le frange più
radicali della sinistra e del movimento Black Lives Matter guidano la grande
epurazione dei personaggi storici sulla base delle loro credenziali
anti-razziste. Su quel fronte Wilson, primo esponente del Sud eletto alla Casa
Bianca dopo la guerra civile, non passa gli esami. Mantenne la segregazione
all'interno dei vari rami dell'Amministrazione federale, esercito compreso.
Inoltre aveva una visione tipica di molti uomini del Sud riguardo alla
Ricostruzione, il periodo successivo alla guerra civile, considerandolo un'epoca
segnata da sopraffazioni da parte dei vincitori nordisti.
Razzismo: svolta in Mississippi, via la bandiera storica.
Pubblicato mercoledì, 01 luglio 2020 da La Repubblica.it. Svolta storica in
Mississippi: il governatore Tate Reeves, repubblicano, ha firmato la legge che
cancella i simboli confederati dalla storica bandiera dello Stato. Era l'unica
bandiera in Usa in cui figuravano gli emblemi di un passato considerato razzista
e legato all'oppressione dell'epoca della schiavitù. "Questo è un nuovo giorno
per il Mississippi", esultano i promotori della legge. "Questa non è un momento
politico per me ma un'occasione solenne per guidare la nostra famiglia del
Mississippi verso l'unità, per riconciliare e andare avanti", dichiara Reeves in
una nota, dopo il via libera del parlamento dello Stato alla legge per cambiare
la bandiera con la croce blu dei soldati confederati. I critici chiedevano da
decenni di cambiare la bandiera ma a fare la differenza è stato il movimento
contro il razzismo mobilitato dall'uccisione dell'afroamericano George Floyd da
parte della polizia.
Valeria Robecco per il Giornale il 30 giugno 2020. Dopo le statue
dei grandi personaggi «sudisti» e di Cristoforo Colombo, che il movimento per i
diritti civili americano reputa collegati alla schiavitù e al colonialismo, cade
un altro simbolo confederato. Il Mississippi, nel profondo sud degli Usa,
rimuoverà lo stendardo della Confederazione dalla sua bandiera (era l'ultimo
stato americano ad avere ancora l'emblema). Nel 2001 gli elettori avevano deciso
di mantenere il vessillo così com'era, considerandolo un ricordo dell'eredità
storica e degli antenati che avevano combattuto nella guerra civile. Ma dopo
l'ondata di proteste anti-razziste seguite alla morte dell'afroamericano George
Floyd a Minneapolis si è riacceso il dibattito sul simbolo confederato, e il
Parlamento statale ha dato il via libera alla rimozione. Il disegno di legge è
passato in entrambe le Camere, e ora è sul tavolo del governatore Tate Reeves
per la firma (il quale ha già annunciato il suo sostegno). «La discussione sulla
bandiera del 1894 è diventata divisiva quanto la bandiera stessa, ed è ora di
finirla», ha scritto Reeves su Twitter, precisando: «Non dobbiamo illuderci che
un voto in Campidoglio basti, il compito che abbiamo di fronte è riunire lo
stato». Secondo le norme del Mississippi, ora ci sarà una commissione incaricata
di progettare la nuova bandiera, che gli elettori dovranno votare a novembre.
Nel frattempo, in California, anche John Wayne potrebbe cadere sotto i colpi
delle proteste. I democratici locali, infatti, stanno facendo pressione per
togliere il nome e la statua della leggenda di Hollywood dall'aeroporto della
contea di Orange. «In tanti ormai chiedono di dare un nome nuovo allo scalo,
accusando Wayne di avere una visione suprematista e posizioni chiaramente contro
la comunità Lgbt e contro i nativi americani», hanno spiegato i promotori della
risoluzione, domandando di tornare a chiamarlo - come in origine - Orange County
Airport. Lo scalo commerciale di Santa Ana fu dedicato a John Wayne nel 1979, lo
stesso anno in cui l'attore, che risiedeva da molto tempo nella contea, morì. A
scatenare la polemica sono state le dichiarazioni della star in una controversa
intervista a Playboy del 1971: Wayne disse di «credere nel suprematismo bianco»
e di «non sentirsi in colpa» del fatto che cinque o dieci generazioni prima di
lui esisteva la schiavitù in America. Rispondendo poi a chi gli chiedeva se
dovesse essere tolta la licenza di insegnare all'attivista Angela Davis perché
afroamericana: «Non credo che si debba dare autorità a gente irresponsabile». I
dem hanno definito le affermazioni «razziste e bigotte», sottolineando che la
mossa fa parte del «movimento nazionale per rimuovere simboli del suprematismo
bianco». Sulla vicenda è intervenuto anche il presidente Donald Trump, definendo
su Twitter «un'incredibile idiozia» la proposta di cambiare il nome del John
Wayne Airport. Il tycoon, nelle ultime ore, è poi nuovamente finito al centro
delle critiche per aver ritwittato il video di una coppia in cui si vedono
l'uomo e la donna bianchi puntare armi da fuoco (una pistola e un fucile AR-15)
contro i manifestanti di Black Lives Matter che passavano davanti alla loro
abitazione di St. Louis, in Missouri. E ieri, intanto, sono comparsi in
tribunale per la seconda udienza preliminare i quattro ex agenti accusati della
morte di Floyd. Derek Chauvin è accusato di omicidio di secondo grado, mentre
Thomas Lane, J. Kueng e Tou Thao di aver aiutato e favorito il collega.
Da corriere.it il 2 luglio 2020. Anche i Sioux contro Trump.
Julian Bear Runner, presidente dell’Oglala Sioux tribal council, ha ammonito il
presidente a non visitare il 3 luglio, vigilia dell’Independence Day, il
monumento nazionale del Monte Rushmore in South Dakota perché aumenterebbe il
rischio coronavirus e violerebbe gli storici trattati tra il governo Usa e i
nativi americani per governare le sacre Black Hills. La visita, spiega, richiede
il permesso dei sette governi tribali Sioux. Gruppi di nativi americani stanno
già pianificando proteste, le polemiche sono esplose. Incurante di tutto, il
presidente si appresta a coronare il sogno di una vita: celebrare il giorno
dell’Indipendenza sotto i fuochi d’artificio di Mount Rushmore. Nell’area che
ospita il monumento vige dal 2010 il divieto di spettacoli pirotecnici a causa
del rischio di incendi della Black Hills, area ritenuta sacra dai nativi. È però
il passato di Mount Rushmore e il suo simbolismo in un momento storico come
quello attuale che alimenta l’ira contro quella che è ritenuta l’ennesima
sciagurata decisione di Trump. Il terreno su cui si erige il monumento che
raffigura, scolpiti nella roccia, i volti di quattro presidenti americani -
George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln - è
stato sottratto ai nativi Lakota Sioux nel 1800, e lo scultore dell’opera è un
suprematista bianco con legami con il Ku Klux Klan. Per i nativi il governo
dovrebbe restituire il terreno e il monumento andrebbe abbattuto perché simbolo
del «suprematismo bianco» e di quel «razzismo strutturale» che domina in
America. Senza contare che i presidenti Washington e Jefferson avevano tutti e
due degli schiavi. Quella di andare, nel bel mezzo della «battaglia delle
statue», a visitare un sito dalla storia controversa come il MonteRushmore, è
sicuramente una provocazione. Ma è anche una mossa molto abile: in difficoltà su
tutti i fronti — economia, coronavirus, proteste razziali — alle prese con un
avversario «soffice» come Biden che non riesce a demonizzare e coi sondaggi che
gli attribuiscono un crollo abissale dei consensi, come osserva Massimo Gaggi a
Trump non rimane che giocare la carta della difesa della storia dell’America
bianca.
Da corriere.it
l'1 luglio 2020. Mark e Patricia McCloskey. 63 anni lui, 61 lei. Bianchi,
avvocati. Vivono a St. Louis, nel Missouri,e compaiono in un video mentre
imbracciano un’arma semiautomatica, lui, e una pistola, lei, rivolti a un gruppo
di manifestanti del movimento Black Lives Matter. Il video è stato diffuso
domenica dall’emittente Abc, fra gli altri, e retwittato dal presidente degli
Stati Uniti Donald Trump. La coppia si rivolge ai manifestanti urlando e
continuando a brandire il fucile AR-14 e la pistola: «Questa è proprietà
privata, andate via». In alcuni momenti punta le armi contro i manifestanti che
si stavano dirigendo verso la casa del sindaco Lyda Krewson, rea di aver diffuso
le generalità dei residenti di St. Louis che avevano chiesto di togliere fondi
al Dipartimento di Polizia. «Sembrava la presa della Bastiglia. Pensavo che
saremmo morti e che avrebbero bruciato la nostra casa e ucciso il nostro cane»,
ha detto Mark McCloskey , polo rosa infilata in un paio di pantaloni kaki, in
un’intervista a Kmov. In realtà, le proteste erano pacifiche e nelle foto e nei
video non sembra esserci nessuno all’interno della proprietà dei McCloskey da
1,7 milioni di dollari. «Questa è tutta proprietà privata, non ci sono
marciapiedi pubblici o strade pubbliche. Eravamo soli di fronte a una folla
arrabbiata. Non appena ho detto che erano in un proprietà privata si sono
infuriati e hanno fatto a pezzi un cancello. Non so quante persone c’erano,
erano un numero alto, tutte arrabbiate, tutte urlanti, tutti che venivano verso
di noi» ha proseguito McCloskey. Il riferimento è a Portland Place, la via
privata in cui si trova la sua lussuosa abitazione. L’uomo parla del cancello
distrutto, ma i video mostrano che dopo il passaggio dei manifestanti era
intatto e aperto.
Cosa nascondono sui coniugi armati: le foto che non vi fanno
vedere. Il video della coppia di avvocati armati
contro i manifestanti ha fatto il giro del mondo. Ma un nuovo video mostra che
il corteo ha oltrepassato il cancello per entrare nella proprietà privata.
Alcune foto, poi, mostrano il cancello danneggiato. Francesca Bernasconi,
Mercoledì 01/07/2020 su Il Giornale. Una coppia armata, che punta fucile e
pistola contro una folla di manifestanti a St. Louis. Le immagini di Mike e
Patricia McCloskey, che gridano contro un corteo, imbracciando le armi, hanno
fatto il giro del mondo. Ieri, un gruppo di manifestanti si è diretto verso la
casa del sindaco di St. Louis, in Missouri, per chiederne le dimissioni, dopo la
diffusione dei dati di alcuni cittadini che avevano chiesto il taglio dei fondi
alla polizia. Il corteo, però, per raggiungere la casa del primo cittadino, si
era diretto verso la proprietà della coppia di avvocati, residente a in Portland
Place, nel quartiere lussuoso di Central West End. Tutta la scena è stata
immortalata in un video, in cui si vedono marito e moglie che, scalzi e
imbracciando un fucile e una pistola, gridano ai manifestanti di andarsene:
"Questa è proprietà privata, andate via", hanno intimato alle persone che
passavano davanti a casa loro, ribattendo di essere su un una strada e non nella
proprietà della coppia. Dal video, sembrava che il corteo si trovasse su una
strada, di fronte alla casa della coppia. Ma ora, è spuntato un altro video, che
circola su Twitter, in cui si vede chiaramente il momento in cui i manifestanti
attraversano un cancello. Poco dopo, le immagini mostrano i coniugi McCloskey
che, poco fuori dalla loro casa, intimano al corteo di allontanarsi.
Confrontando le immagini del video con quelle presenti su Google Maps, si nota
che il cancello che oltrepassano i manifestanti è uguale a quello della propietà
privata dei McCloskey in Portland Place. I manifestanti, quindi, per dirigersi
alla casa del sindaco, sarebbero passati attraverso una proprietà privata,
scatenando la reazione spaventata dei due avvocati che, impauriti dal corteo,
hanno imbracciato le armi. "Sembrava la presa della Bastiglia - ha commentato
Mark McCloskey nel corso di un'intervista a Kmov -Pensavo che saremmo morti e
che avrebbero bruciato la nostra casa e ucciso il nostro cane. Eravamo soli di
fronte a una folla arrabbiata". Non solo. Sui social circolano anche le foto
del cancello danneggiato. "Questi signori hanno avuto il cancello di casa
distrutto da una folla violenta che è entrata nella loro proprietà privata",
scrive un utente su Facebook, mostrando le immagini.
Zoomer contro boomer. la rivoluzione al tempo di Tik Tok (e
Trump). Riccardo Luna il 23 giugno 2020 su La
Repubblica. Un posto dove i giovani di tutto il mondo trascorrono ogni giorno
un'ora e mezzo del loro tempo, non fissando uno schermo e basta, come su Netflix
o YouTube, ma creando qualcosa ed esprimendosi, è il posto da guardare per
capire quando arriverà la rivoluzione. Quel posto evidentemente non è Facebook
(dove stanno i genitori e i nonni); non è Twitter (prediletto da politici e
giornalisti e utile semmai per interloquire con queste categorie); e non è
nemmeno Instagram (più adatto a selfie spettacolari). Quel posto è Tik Tok. Lo
avevamo già detto, segnalando la trasformazione che c'era stata nel social
network cinese dei video brevi e scemi, diventato recentemente il luogo
prediletto di espressione del movimento antirazzista. Infatti, grazie anche al
fatto che la durata delle clip era stata portata da 15 a 60 secondi, è su Tik
Tok che si potevano trovare i migliori video di Black Lives Matter. Storie,
commentate. Ora arriva la vicenda, irresistibile, degli adolescenti di Tik Tok
che sabotano la grande manifestazione elettorale di Donald Trump prenotando
online un milione di biglietti per lasciarlo solo in un palazzetto semivuoto a
Tulsa, Oklahoma. Vero, esagerato? Esagerato. Ma è vero che due settimane fa è
stata una utente di Tik Tok dello Iowa, Mary Jo Laupp, a lanciare l'idea del
sabotaggio, ma lei non è più da tempo una adolescente: ha 51 anni, è una
attivista dei diritti civili e firma i suoi video ironicamente come "nonna Tik
Tok". Da un video di Mary Jo la cosa ha preso piede grazie ad #AltTikTok, una
rete alternativa rispetto a quella ufficiale, dove si trovano così diverse dai
balletti e dalle challenge, un po' più toste. A rendere quel video popolare di
"nonna TikTok" virale è stata la rete di #alttiktok assieme ai fan del pop
coreano che sono moltissimi e molto attivi online (la settimana scorsa il
concerto in streaming dei BTS ha totalizzato quasi 800 mila spettatori paganti e
online). Così si dice. Possibile che i responsabili della campagna di Trump -
non esattamente degli sprovveduti - si siano fatti beffare da qualche migliaio
di adolescenti che si è registrata su un sito dovendo lasciare un numero di
telefono provvisorio? Sì, possibile, anche se probabilmente dietro il flop di
Tulsa non c'è solo Tik Tok (Donald Trump nei sondaggi è molti punti dietro Joe
Biden, qualcosa vorrà pur dire); ma sicuramente c'è anche Tik Tok che è
diventato ormai un'altra cosa. Uno strumento per l'attivismo giovanile. Ieri
infatti il social era invaso di video di "zoomer" (che non sono gli utenti di
Zoom ma gli esponenti della Generazione Z che hanno fra 13 e 25 anni), che
festeggiavano il flop del presidente facendo un balletto davanti ai biglietti
prenotati e non utilizzati per Tulsa sulla note di Macarena, una canzonetta
estiva di tanti anni fa, il 1993, quando loro non erano ancora nati. Insomma su
Tik Tok è andata in scena una sfacciatissima e allegra presa per i fondelli che
faceva da contraltare ad alcuni video postati il giorno prima dal palazzetto di
Tulsa dove si vedevano alcuni attempati sostenitori di Trump sbadigliare mentre
il presidente prometteva di fare di nuovo l'America grande, slogan che deve
sembrare una vecchia solfa persino per certi boomer (boomer: esponenti della
generazione del baby boom, nati fra le fine della seconda guerra mondiale e la
prima metà degli anni '60). Ora sarebbe un errore madornale dare Trump già per
sconfitto alle elezioni del 3 novembre partendo da questo episodio divertente ma
circoscritto. Anche perché ieri l'emittente più vicina alla Casa Bianca, Fox
news, si è affrettata ad annunciare che il palazzetto di Tulsa sarà anche stato
mezzo vuoto, ma il presidente ha battuto ogni record di ascolto in tv per il
sabato sera: quasi otto milioni di persone. Eppoi, come si diceva una decina di
anni fa a proposito di Twitter, "la rivoluzione non sarà twittata". E se non
basta un tweet a far cadere un regime, non basterà una goliardata su Tik Tok a
far sloggiare l'inquilino della Casa Bianca. L'attivismo va portato nelle piazze
e poi nelle urne, come ha ricordato qualche giorno fa l'ex presidente Barack
Obama. Epperò va annotato il cambio di registro che Tik Tok mette in campo:
intanto è un social dove i non più giovanissimi si sentono estranei, è un
terreno di gioco che ti fa sentire fuori posto se hai 30 anni. E' casa loro.
Eppoi il linguaggio che produce è allegro, beffardo, scanzonato. E come sapevano
già gli antichi romani, non c'è nulla che faccia più male a chi gestisce il
potere che uno sberleffo ben piazzato. Insomma se la sfida "zoomer contro
boomer" promette di essere il nuovo '68, forse una risata ci salverà.
Maria Giovanna Maglie per Dagospia il 19 giugno 2020. Caro Dago,
sono sparita per qualche settimana perché ho finito di scrivere un libretto sul
mostro cinese, che ci ha rovinato non solo la primavera. È un e-Instant book,
buona idea in epoca con pochi soldi e tanto tempo in casa, il 26 giugno sarà
on-line. Eccomi di nuovo su piazza, e da dove cominciare se non da settimane di
mumble mumble sull'informazione dagli Stati Uniti? Per fatto personale, in
attesa del prossimo martedì elettorale. Quello del 2016 ci vide in grande
spolvero a noi di Dagospia. Sabato a Tulsa, domani, oltre all'Arena nuova da
22.000 persone, è stata prenotata tutta l'area attigua del Centro Congressi per
altre 40.000 persone. Almeno 900.000 purtroppo rimarranno senza biglietto per
assistere, visto che, come comunica Brad Parscale, il genio dei social ora a
capo della campagna elettorale 2020, più di un milione ha fatto richiesta di
assistere all'incontro con il candidato Donald Trump. Parscale aggiunge che
prima di entrare a tutti verrà misurata la temperatura, fornito disinfettante
per le mani e mascherina apposita. Ci saranno anche precauzioni per il caldo e
acqua imbottigliata per tutti. Le precisazioni non sono casuali visto che
esponenti del Partito Democratico, gli stessi che da tre settimane organizzano
affollatissime e rissose manifestazioni di protesta, ora si dicono preoccupati
per un comizio nel quale le regole anti covid non verrebbero rispettate. Sembra
l'Italia, no? Lo stesso spudorato doppiopesismo. Domenica scorsa Donald Trump ha
compiuto 74 anni e il Comitato Nazionale Repubblicano e la campagna Trump 2020
hanno pubblicato i dati di raccolta fondi giornalieri. E' stato il più grande
giorno di raccolta fondi online di sempre, 14 milioni di dollari, battuto il
precedente record di raccolta fondi online di 10 milioni di dollari del 19
ottobre 2016. Suona familiare? Era 15 giorni prima di una vittoria data per
impossibile da tutti gli osservatori tranne qualche scriteriato, come chi
scrive. Mi sbagliavo clamorosamente allora e sicuramente mi sbaglio anche adesso
nel non cogliere i segnali della decadenza di Donald Trump, decadenza fisica che
precede la sicura sconfitta il 3 novembre. Oggi la notizia definitiva è che ha
bevuto tenendolo con due mani un bicchiere bagnato, e che è stato attento a
scendere una rampa scivolosa, coperta da un tessuto, senza gradinie nè
corrimano, al giuramento dei cadetti di West Point. Sotto alla giacca indossa
un corpetto antiproiettile che pesa più o meno 7 chili. Come twitta lui,
l'ultima cosa che ho intenzione di fare è cadere, per consentire ai propalatori
di false notizie di divertirsi. Ma chi non si diverte "rosica", come si dice a
Roma. Rosicano anche di più tutti quelli che hanno scritto che mai Donald Trump
avrebbe firmato un ordine esecutivo sulla riforma della polizia. Figurarsi,
specialmente in anno elettorale se il presidente, che è anche candidato alla
rielezione, avrebbe mai ho fatto una mossa che gli toglie voti tra la polizia e
l'elettorato conservatore. E poi in fondo una riforma di stretta sui poteri
della polizia non l'ha mai fatta il Democratico Bill Clinton, non ho mai fatto
il Premio Nobel per la pace Barack Obama …Così gran corsa mondiale a sminuire
l'evento, a chiamarlo passettino, a dire che in realtà non tocca i poteri veri
di law and order, quando Donald Trump ha firmato l'ordine esecutivo sulla
riforma della polizia definendola "una mossa storica per il futuro
dell'America"...La stretta al collo da parte della polizia sarà vietata a meno
che non sia a rischio la vita dell'agente. Occorre ripristinare "legge e ordine"
a livello nazionale e il governo è pronto ad aiutare, ha assicurato il
presidente. Le vittime delle violenze della polizia "non sono morte invano". Il
provvedimento di Trump si incardina su un piano di finanziamenti per «migliorare
gli standard» dell’azione di polizia. I fondi verranno versati solo ai
Dipartimenti che aboliranno l’uso del chokehold, «da mantenere solo come ultima
risorsa in caso di minaccia diretta per la vita del poliziotto».. Altro punto
chiave è la costituzione di un registro, una lista nera, per i poliziotti
violenti. L’obiettivo è evitare che un agente licenziato in un distretto possa
essere assunto in un altro, ricominciando come se non fosse successo nulla.
Ultimo passaggio: programmi di addestramento per consentire agli «operatori in
divisa» e agli assistenti sociali di gestire al meglio gli interventi che
coinvolgono «homeless» e persone con disturbi mentali. Trump ha detto di aver
incontrato «molti familiari di persone coinvolte in interazioni mortali con la
polizia». Nell’elenco fornito dalla Casa Bianca non ci sono i parenti di Floyd,
mentre invece figurano, tra gli altri, quelli di Ahmaud Arbery, il giovane
afroamericano ucciso in Georgia da due bianchi (non dalla polizia), mentre
faceva jogging. Durante 20 minuti di discorso il presidente si è attorniato di
ufficiali e leader sindacali degli agenti. Ha ripetuto che le forze dell’ordine
sono sostanzialmente sane; bisogna sradicare i comportamenti scorretti, violenti
di una piccola parte «degli uomini e delle donne in divisa blu»; non si può fare
a meno della polizia, non si può indebolirla, altrimenti sarebbe «il caos».
Leggo su molti giornali che non è quello che il movimento antifa e i Black Lives
Matter si aspettavano Evidentemente si aspettavano che venisse sciolto
qualsiasi Corpo di Polizia. Poi l'ordine lo gestiscono loro nel plauso mondiale?
Trump ha attaccato il suo predecessore Barack Obama e l’allora vice Joe Biden,
oggi candidato alla Casa Bianca: «in otto anni non sono riusciti a combinare
nulla in materia di sicurezza, perché non ne avevano la minima idea». Beh,
qualcosa Barack ha fatto, ha ricevuto in gran pompa alla Casa Bianca i capi di
Black Lives Matter, dandogli così una veste di rispettabilità al massimo
livello, che ora consente loro di sfasciare statue e monumenti. Alla fine del
discorso, scrive ad esempio la Stampa, il presidente ha spolverato il
repertorio elettorale: il virus «cinese», la «formidabile ripresa»
dell’occupazione e della Borsa. Vi aspettavate che il virus cinese venisse
definito repertorio elettorale a giorni alterni con quelli in cui viene
definito la più terribile pandemia che ci potesse colpire? Quanto all'economia,
qualche numero, dopo che un fugace ascolto di un TG5 qualunque mi ha messo in
allarme visto che sosteneva che l'economia americana è sull'orlo del baratro se
non già dentro. L’economia Usa, a sorpresa, ha creato 2,5 milioni di posti a
maggio, nonostante la crisi da coronavirus, dopo il crollo record di 20,5
milioni di addetti ad aprile. Gli analisti si aspettavano una discesa ulteriore
di 8 milioni di occupati. Un dato, perciò, in controtendenza rispetto alle
previsioni e ancora più sorprendente. Il mercato del lavoro Usa è migliorato
considerevolmente nella seconda metà di maggio, con le riaperture delle attività
commerciali dopo le chiusure di metà marzo. Il tasso di disoccupazione cala al
13,3%, contro il 14,7% di aprile, e un atteso aumento al 19,8%. Certo, difficile
fare il paragone con l'Italia, dove tra ammortizzatori sociali, litigati tra
imprese e Governo, e proibizione ancora per qualche tempo di licenziamento, uno
può anche fingere e mistificare, e lo fanno ah se lo fanno! Quindi che ha detto
Trump di repertorio polveroso elettorale? Ha detto che. «Questi numeri sono
incredibili» e che il rimbalzo aumenterà di intensità una volta che riapriranno
completamente tutti gli Stati, inclusi quello di New York e la California. Ha
poi spiegato che la ripresa evidenziata dal dato è stata possibile perché il
«paziente era molto forte», sottolineando come l'occupazione sta risalendo ai
livelli record pre-pandemici. Per Trump, il dato di maggio è precursore di un
lungo periodo di crescita economica: «Giugno e luglio saranno molto buoni, ma
settembre sarà spettacolare. Di sicuro lo saranno ottobre, novembre e dicembre.
E l'anno prossimo sarà uno dei migliori dal punto di vista economico», ha
concluso. Un po' di propaganda elettorale? Non è reato, non ancora, anche se
riguarda Trump, e di qui alle elezioni gli americani avranno il tempo di
verificare se ha mentito. Intanto una nota a margine per i militanti duri e puri
dell'antirazzismo Molte imprese nelle grandi città Usa erano state riaperte o
avevano intenzione di riaprire a metà maggio, ma poi hanno richiuso dopo il 25
maggio, dopo essere state saccheggiate durante le proteste per la morte di
George Floyd. Ciò potrebbe ritardare la loro riapertura di giorni o settimane e
causare un altro ciclo di perdite di posti di lavoro. Che c’entra poi Trump con
i misfatti della polizia?, La polizia statale in America dipende dal governatore
e la polizia municipale dal sindaco. Se sono brutali, corrotte, sarebbe il caso
di prendersela con gli amministratori locali Se sono Democratici, come nel caso
dello Stato del Minnesota e della città di Minneapolis, dove si è svolto
l’omicidio di George Floyd, saranno costoro a doverne rispondere. Dicono: come
puoi dimenticare il clima di divisione sociale che l'elezione di Trump ha
provocato, riportando alla superficie visto più profondo della storia americana
quello delle minoranze In specie dell'ex minoranza schiava di afroamericani? Non
starò qui a rispondere quanta strada e quanto rapidamente sia stata percorsa da
quando una giovane donna nera si rifiutò di alzarsi da un posto in autobus
riservato ai bianchi. Dico solo che l'attacco alle istituzioni portato con
sommosse saccheggi incendi blocchi stradali non ha niente a che vedere con
l'uccisione di Floyd e che è stato necessario proteggere la Casa Bianca. Qualche
stupore se Trump ha espresso l'intenzione di chiamare l'esercito in difesa della
nazione? Che c'entra questo con una giustificata reazione al razzismo, ammesso
che il razzismo ci sia? Trump è un conservatore, Trump è anche un uomo privo di
qualunque ideologia soverchia, in lui prevale lo spirito dell'imprenditore. Sa
benissimo che anche la pace sociale si fonda sulla riapertura rapida
dell'economia, sul fatto che tutti tornino a essere occupati e con le tasche
pieni di soldi, come stava cominciando stabilmente essere prima del virus
cinese. Proprio perché così stava cominciando ad essere, non solo l'opposizione
più radicale e prevenuta ma un po' tutto il Partito Democratico a corto di
argomenti si sono accaniti sulla pandemia e le sue conseguenze, cercando rogna
senza nessuna preoccupazione per il danno all'economia e cittadini. Campagna
elettorale? Certo, contro tutto e tutti. Com'era la storia del New York Times,
che ha pubblicato gli ultimi dati sull’occupazione, testimoni di un inizio di
ripresa, e si è visto invaso dalle proteste di decine di migliaia di lettori, e
accusato di aver favorito la campagna elettorale di Trump? A rivelare chi
strumentalizza chi potrebbe bastare l'ultima delle gaffe del candidato
Democratico ed ex vice di Barack Obama, Joe Biden, che ha detto, testuali parole
che, neanche a dirlo, non hanno menato scandalo sulla stampa internazionale
figurarsi italiana: “Se un americano di colore vota per Trump allora vuol dire
che non è un vero afroamericano”. Quindi c'è il nero buono, cioè quello che vota
solo democratico e va in piazza a comando, e c'è il nero cattivo, quello che
magari gli sta bene un presidente Usa che ha creato più posti di lavoro di
chiunque altro prima per i neri. Vi svelo un segreto. La comunità afroamericana
in parte la potete ormai inserire nella maggioranza silenziosa, o almeno fra i
molti che hanno un approccio meno ideologico alla politica, e non solo legato
all’esperienza interna al loro Paese. A novembre come al solito non si vota solo
per il presidente ma anche per il rinnovo della Camera dei Rappresentanti, è il
partito repubblicano si sta organizzando con i rappresentanti delle minoranze
non solo per la rielezione di Donald Trump ma per riconquistare la maggioranza
al Congresso...Cito da Atlantico Quotidiano, una delle due o tre, ma forse pecco
di ottimismo, testate che in Italia combattono le fake news sull'America
Segnatevi il nome di Errol Webber, 33 anni, americano di origini caraibiche,
trumpiano, che tenterà in California di strappare il seggio alla rappresentante
Dem del 37esimo Congressional District, Karen Bass, eletta dal 2011. Webber è
un Repubblicano tosto, Law & Order, che ha condannato le violenze seguite
all’omicidio di George Floyd. Segue con attenzione la politica italiana, di
recente è intervenuto anche nella vicenda degli insulti sui social a Matteo
Salvini e alla Lega dopo che l’ex ministro dell’interno osato esternare
solidarietà a Trump è a ripristino dello stato di diritto. “Spero di vedere
Salvini presto alla guida dell’Italia”, ha scritto in un post Webber. E si è
beccato anche lui la sua bella dose di insulti razziali a valanga a
dimostrazione del fatto che le minoranze piacciono solo se pronte al saccheggio
o fornite di bandiera rossa . Anche i repubblicani piacciono se si fanno piacere
un governo come quello di Conte, persino Donald Trump e, ricordate, è diventato
degno di citazione positiva quando è sembrato che appoggiasse entusiasticamente
#Giuseppi. Funziona così. A proposito di minoranze prese di mira non so se vi
è chiaro che gli italoamericani sono identificati come un gruppo conservatore
che ha votato per Donald Trump, nonché tutti discendenti di quel Cristoforo
Colombo le cui statue e monumenti vengono imbrattate o rimossi. A Filadelfia
gli italiani hanno dovuto presidiare la sua statua. Però, tutto il casino antifa
ha tirato l'attenzione sulla situazione italiana e sulla stravagante presunta
Alleanza del governo Conte con Trump. Scrive per difenderli Deanna Lorraine,
opinionista e youtuber conservatrice che “se ci fosse stato Salvini come
presidente del Consiglio, il coronavirus sarebbe stato sicuramente trattato
meglio dal governo italiano!”; del Movimento 5 Stelle che e' “anti-Trump e
filo-cinese”. Insomma si fa strada nella campagna elettorale in mezzo ai temi
nazionali predominanti e prevalenti che è necessario un ampio fronte
conservatore che si batta per democrazia e libertà contro le mire egemoniche
cinesi che si estendono con amicizie pericolose in Europa e in Africa. Una nuova
maggioranza silenziosa forgiata nei mesi dolorosi del virus cinese è nelle
settimane di eversione e saccheggi che vede in prima fila un'America trumpiana
che è anche black Scommettiamo? Stereotipi quanti ne volete, Ma come racconta
la afroamericana ed ex segretario di stato di W.Bush, Condoleezza Rice "l primo
repubblicano che ho conosciuto era mio padre, John Rice. Ed è tutt’oggi il
repubblicano che ammiro di più. Mio padre si è iscritto al nostro partito perché
i democratici nell’Alabama di Jim Crow nel 1952 non gli permettevano di avere la
tessera elettorale. I repubblicani si. “.Troppo conservatrice la Rice, una nera
per finta, come dice Joe Biden? Dimenticavo, ora si porta John Bolton, l'ex
Falco odiato e vituperato dagli anni di Bush senior e poi negli stessi anni
della Rice, e ora recuperato alla causa democratiche e antifa,. Donald Trump
prima lo ha messo al governo poi lo ha mandato via, visto che voleva fare una
guerra al giorno. Trump ha sicuramente sbagliato a prenderlo perché avrebbe
dovuto sapere chi era Bolton e quanto prepotente fosse la sua ideologia di
Falco, lui ora si vendica con un libro pieno di pettegolezzi, che sia il nuovo
eroe Dem è tra il grottesco e il tragico. Quel che Bolton nel suo libro non
scrive è che Trump è stato l’unico in grado di ammonire e minacciare la Cina,
colpevole di ritardi nel dare l’allarme, nel fornire informazioni corrette sul
coronavirus, responsabile diretta di costi umani ed economici incalcolabili. È
stato l'unico ad i additare l'altra responsabile, l'organizzazione Mondiale
della Sanità, per la sua dipendenza da Pechino. È stato l'unico insieme a Boris
Johnson a denunciare duramente la repressione brutale a Hong Kong della rivolta
popolare. Ma l’ha fatto, in compagnia della sola Gran Bretagna, anche nei
confronti dalla repressione brutale della polizia ad Hong Kong, Vent'anni fa
l'Occidente ha venduto un popolo ai comunisti cinesi. Doveva arrivare il
palazzinaro Trump a dire che non si fa così. Qualche voce dall'Europa?
Figuriamoci. La voce dell'Europa non si sente neanche sulle colpe della Cina nel
dilagare del virus proprio in Europa, ne' si sente sulle questioni commerciali.
Ma se a novembre Donald Trump sara' rieletto, si aprirà una resa dei conti su
diversi e numerosi terreni, e l'avvisaglia è la riduzione netta, 10mila soldati
su 34mila, delle truppe della NATO nelle basi in Germania. Avverrà a settembre,
l'ha annunciata ufficialmente l'ex Ambasciatore americano a Berlino, Richard
Grenell, ora rientrato a Washington per lavorare nell'Amministrazione, uno che
in questi anni l'Unione Europea nazione per nazione l'ha studiata con attenzione
e sagacia estreme A qualcuno sfugge che cosa significa in termini di
autorevolezza politica e di indotto economico? Questa riduzione evidenzia le
contraddizioni della Germania, che da una parte è in difficoltà grave perché per
la sua difesa le serve l'ombrello Nato, salvo rifiutarsi di pagare il dovuto dal
suo PIL e lasciare l'onere ai contribuenti americani che non ne possono più.
D'altra parte la Germania continua ad avere uno stretto rapporto con la Cina, ed
è su questo che Trump la inchioda. Nel suo recente discorso alla Fondazione
Adenauer, davanti agli esponenti del partito, la Merkel ha spiegato che le
preoccupazioni per i diritti umani non sono motivo sufficiente per compromettere
i rapporti con la Repubblica Popolare, che vanno preservati ad ogni costo,
pazienza se Washington e Pechino sono ai ferri corti. La cancelliera ha poi
fatto saltare il vertice di giugno, prendendo così un tempo prezioso per il
cinese Xi Jinping, visto che alla fine del vertice sarebbe stata costretta a
sottoscrivere anche lei un immancabile documento di condanna del comportamento
di Pechino. Conclusione: quando partirà lo scontro serio tra Cina e Stati Uniti
per il futuro assetto del mondo, l'Europa sarà assente, sarà in ritardo,
inseguirà la Germania e gli interessi della Germania, se non cambiano alcune
realtà nazionali. Poi c'è George Floyd, trasformato nel nuovo Martin Luther
King, vittima, santo ed eroe i cui peccati sono stati tutti dimenticati, meglio
ancora trasformati in virtù teologali. Ha alcun senso, segue una logica?
Rivolgersi ai media mondiali commossi, così impegnati nel racconto dell'icona da
dimenticare un minimo di malinconica ironia, per esempio a commento della
eulogia funebre dell'ex vicepresidente Joe Biden, che ha esordito con un, "Ora
è il momento della giustizia razziale". Poi, alla figlia di sei anni del defunto
ha detto: "Tuo padre ha cambiato il mondo". Come il mondo? George Floyd, un
delinquente comune, con una fedina penale piena di reati, è la povera vittima di
un poliziotto sociopatico e corrotto bianco che poteva essere fermato un po' di
anni fa, quando era sindaco la stessa Democratica che fino a un mese fa era in
predicato di diventare candidata alla vice presidenza con Biden, che però
rifiutò di aprire un'indagine su corruzione è razzismo in mezzo al corpo di
Polizia, e fare pulizia. Il razzismo torna sempre nelle vicende di una società
così multirazziale. La morte di Floyd è stata orribile, schiacciata la faccia
dalla forza di un ginocchio e di un corpo. Chissà come pensava l'idiota di
poliziotto di sfuggire, visto che tutto è avvenuto in presenza di una piccola
folla!, Siamo a Minneapolis, Stato del Minnesota , ancora una volta ricordiamo
che sindaco e governatore sono democratici e che forse da lì sarebbe stato
opportuno far partire autocritica e chiarezza. Invece la tragedia è stata colta
dai democratici come una occasione da non perdere per destabilizzare un paese
già piegato e piagato dal virus. Ce se ne vuole di incoscienza, bisogna essere
veri antiamericani per commettere uno scempio del genere! Manifestare contro
ingiustizie odiose come quelle razziali è giusto, che c'entra con sfasciare,
saccheggiare e rubare? Perché non una parola di condanna è stata spesa contro
amministratori e governatore di stati a guida Democratica, gli stessi in cui è
dilagata la peggiore forma di protesta? Elementare Watson, con un candidato
debole, sospetto, sul quale le unghie lunghe del me-too, ovvero denunce di
signorine incontrate occasionalmente e di passate collaboratrici per molestie e
ricatti sessuali, stanno per essere infilzate, e a chi tocca non s'ingrugna, lo
ha salvato solo il virus cinese finora; con un candidato così, dicevamo, bisogna
fare una grande ammuina. Solo che per coprire denunce e pochezza, l'hanno fatta
partire troppo presto, avrebbero dovuto aspettare il prossimo episodio di
razzismo reale o presunto, di qui a novembre il tempo è tanto, troppo per
reggere con saccheggi e furti, ed essere ancora ascoltati dagli americani.
Oltretutto danneggiando l'economia, che resta la vera preoccupazione nazionale.
Perché l'economia torni a funzionare è necessario che ci siano Law & Order,
altro che antifa e picchetti davanti alla Casa Bianca. Vale Insomma per gli
Stati Uniti come vale per l'Italia che non si può pensare di mantenere il potere
o di vincere elezioni mettendo a repentaglio la tenuta sociale di un Paese. Ma
per i democratici che hanno Biden come candidato già traballante ed ufficiale,
Barack Obama e i suoi cari come Longa manus e organizzatori dietro le quinte, i
media di tutto il mondo con qualche doverosa eccezione sull'attenti al progetto,
quel che conta a qualsiasi costo è sconfiggere il mostro, lo scandalo,
l'accidente Trump. Colui che non doveva diventare Presidente degli Stati Uniti e
invece per un maleficio lo è diventato, colui che ha fatto impallidire. lo
sdegno mondiale di 40 anni fa, quando osò diventare Presidente l'attore
californiano dalla faccia da scemo e dalle in certe letture, ma sicuramente uno
spietato reazionario, Ronald Reagan, e non solo, poi osò anche diventare
l'uomo che ha sconfitto il comunismo. Penso al Russiagate e al tentativo di
impeachment , quando si sarà diradata la nebbia terribile del virus cinese,
forse dopo le elezioni di novembre, la verità su Russia Gate, un gigantesco
complotto mondiale per impedire che Trump fosse eletto, verrà fuori. In mezzo
c'è anche un pezzo di Italia, di quelli che governavano in quegli anni.
L'Amministrazione ha messo insieme tutte le prove, Obama è coinvolto con tutte
le scarpe. Quando si parla di Deep state, quello a cui Trump fa veramente paura,
non si possono dimenticare anche un po' di repubblicani sconvolti dallo tsunami
del suo arrivo. D'altra parte basta ricordare che a Washington nel 2016 Hillary
Clinton prese più del 90% dei voti, forse l'unico luogo d'America nel quale la
previsione farlocca del New York Times fu rispettata. Donald Trump è fuori dagli
schemi, un po' folle, imprevedibile, arriva e rovescia il tavolo. Il suo è un
progetto rivoluzionario, e al contrario di quanto si racconta, è un conservatore
in nome della Working Class bistrattata, ignorata, calpestata dalla
globalizzazione e dalla finanza, una Working Class naturale alleata dell'
impresa che torna a costruire e produrre. A Donald Trump non interessa essere
simpatico e popolare tra i burocrati di Washington, è insofferente delle
regole, detesta gli ipocriti, ha la pessima abitudine di dire quello che pensa
nel momento in cui lo pensa, la politica non è statica per lui ma in continuo
movimento e distruzione. È un teorico del caos. Poi arriva al compromesso, ma
prima attacca alla gola. Ha frenato la talebanizzazione, la devirilizzazione, la
perdita di autorevolezza degli Stati Uniti, e lo ha fatto più o meno senza
sparare un colpo nel mondo,, cosa che non succedeva da molti decenni. La
scommessa di Xi Jinping, il nuovo Hitler, di sconfiggere e piegare l'Occidente
profittando della debolezza e dell'appeasement di una parte del mondo, anche in
Europa, ha un cavaliere nero che l'attende . E ar cavaliere nero non je devi…
Ps Articolessa gigantesca, mi è scappata la mano, o forse una al
mese fino a novembre ed è pronto il Dago libro.
Lo sgambetto di Bolton a Trump.
Orlando Sacchelli il 18 giugno 2020 su Il Giornale. Di sicuro gliel’aveva
giurata quando fu cacciato. Ora, a pochi mesi dal voto, il “falco” John
Bolton si vendica e nel suo libro (The Room Where It Happened) in uscita il 23
giugno, spara ad alzo zero contro Trump. Un fuoco amico, se così si può dire.
Nel suo dicastero alla Sicurezza nazionale Bolton restò in carica 17 mesi, dal 9
aprile 2018 al 10 settembre 2019. Trump ha reagito con prontezza passando subito
all’attacco via Twitter, con una recensione al veleno del volume in uscita: “Il
libro ‘estremamente noioso’ (New York Times) di Wacko John Bolton è fatto di
bugie e storie false. Ha detto tutto bene su di me, per iscritto, fino al giorno
in cui l’ho licenziato. Uno sciocco, noioso, scontento, che voleva solo andare
in guerra. Non ne ho mai avuto idea, è stato ostracizzato e scaricato
felicemente”. Ma di che parla Bolton? Dalle anticipazioni si capisce che il
volume affronta diversi retroscena, temi politici visti da dietro le quinte alla
Casa Bianca (compresi alcuni importanti viaggi all’estero del presidente)
ovviamente secondo il punto di vista dell’autore. Bolton ad esempio racconta
che durante il G20 in Giappone Trump avrebbe insistito molto affinché il
presidente cinese Xi Jinping comprasse soia e cerali dagli Usa, per favorire
alcuni stati rurali e quindi averne un vantaggio in termini di consenso in vista
delle elezioni. Un’altra accusa, ancora più infamante: Trump
avrebbe incoraggiato Xi Jinping nella costruzione di campi di internamento per
le minoranze musulmane. “Trump – scrive Bolton – disse che era la cosa giusta da
fare”. Nel libro l’ex responsabile della Sicurezza americana tocca anche il tema
Ucraina, di fatto confermando che Trump avrebbe fatto pressioni su Kiev affinché
indagasse sulla Burisma Holding di cui Hunter Biden (figlio dell’ex
vicepresidente), era membro del cda. Lo scorso 20 agosto, come scrive l’ex
consigliere della Casa Bianca, Trump avrebbe dichiarato di non essere favorevole
all’invio in Ucraina di materiale militare, fino a quando le autorità di Kiev
non avessero ripreso le indagini contro Hillary Clinton e Joe
Biden. Bolton sostiene anche di aver insistito molte volte con il presidente
affinché gli Usa sbloccassero gli aiuti all’Ucraina. La vicenda in seguito fu la
base per la procedura di impeachment contro Trump, finita con l’assoluzione del
presidente da parte del Senato Usa. Bolton affonda il coltello dicendo che Trump
non ha principi e non è adatto alla Casa Bianca. “Non credo che sia adatto per
il suo ufficio”, spiega a Abc News. “Non credo che abbia la competenza per
svolgere il lavoro. Non c’è davvero nessun principio-guida che sono in grado di
discernere (in lui) se non quello che giova alla sua rielezione”. “Credo
che Putin ritenga di poter usare Trump come un giocattolo”, ha aggiunto Bolton.
E sullo storico incontro con Kim Jong-un sottolinea che “c’era un’enorme
attenzione sulla ‘photo opportunity’ e sulla conseguente reazione della stampa”,
ma “nessuna idea di come incontri del genere potessero rafforzare la posizione
degli Stati Uniti”. E cita alcuni favori fatti ai dittatori, con i benefici
ricevuti dalle aziende cinesi Huawei e Zte e dalla banca turca Halkbank. Come
dicevamo Trump non ha gradito questo libro. E ha reagito a modo suo: “Bolton è
un bugiardo”, alla Casa Bianca “non lo sopportava nessuno”. Poi l’accusa forse
più grave: “Ha infranto la legge”, riferendosi al fatto che le
notizie riportate nel libro fossero riservate. Quanto ai rapporti internazionali
il presidente ha tenuto a ribadire: “Nessuno è stato più duro di me con la
Russia e con la Cina”. Paradossalmente neanche i democratici non hanno preso
bene la mossa di Bolton, più che altro nel tempismo. Lo spiega su Twitter Adam
Schiff, capo della commissione Intelligence della Camera: “Quando allo staff di
Bolton fu chiesto di testimoniare alla Camera sugli abusi di Trump, lo fecero.
Avevano molto da rimetterci, e dimostrarono coraggio. Quando fu chiesto a Bolton
si rifiutò, e disse che avrebbe fatto causa se gli fosse stato presentato un
mandato di comparizione. Invece, si è tenuto tutto per raccontarlo in un libro.
Bolton sarà uno scrittore, ma non è un patriota”.
Bolton: Trump voleva fare la pace con l'Iran.
Piccole Note il 22 giugno 2020 su Il Giornale. Nel suo libro di memorie, nato
per affondare Trump, John Bolton racconta il forcing forsennato per evitare
un’intesa tra il presidente Usa e l’Iran. Era l’agosto del 2019, vigilia del G-7
di Biarritz e in quell’estate Macron si propose come “mediatore” tra Iran e
Stati Uniti. A riferire le rivelazioni di Bolton è Haaretz, che racconta come
Macron avesse organizzato un vertice tra Trump e il ministro degli Esteri
iraniano Javad Zarif ai margini del G7 di Biarritz.
L’ostracismo di Bolton e Pompeo. L’allora Consigliere per la
Sicurezza nazionale Usa, in combinato disposto con il Segretario di Stato Mike
Pompeo, tentarono in tutti i modi di “convincere Trump a respingere qualsiasi
proposta” in tal senso. Ma furono spiazzati dalla mossa di Macron, che invitò
Zarif a Biarritz, “aprendo le porte a un possibile incontro” tra i due. Macron,
ricorda Bolton, aveva convinto Trump ad abbandonare la strategia della massima
pressione adottata fino a quel momento nei confronti di Teheran, e, all’opposto,
l’avrebbe persuaso ad aprire “una "linea di credito" internazionale verso
l’Iran, che avrebbe alleggerito in parte la grave pressione economica” causata
dal ripristino delle sanzioni da parte dell’America. Bolton scrive che, sbarcato
a Biarritz, Trump ebbe un “incontro riservato, fuori programma, con Macron, nel
corso del quale i due hanno parlato solo dell’Iran […]. Trump in seguito ha
parlato di quella conversazione come ‘la più bella ora e mezza che abbia mai
trascorso'”. Bolton racconta come Netanyahu abbia tentato più volte di
contattare Trump, per farlo desistere dal passo, ma inutilmente. A far scudo al
presidente, secondo l’ex Consigliere Usa, sarebbe stato il genero Jared Kushner
e il segretario del Tesoro Steven Mnuchin, convinti che quella del premier
israeliano, che pretendeva di decidere della politica estera Usa, fosse
un’ingerenza indebita. Bolton annota che avrebbe minacciato Trump di dimettersi
se l’incontro fosse andato in porto. Una minaccia analoga sarebbe stata avanzata
dal Segretario di Stato Mike Pompeo.
Affondato l’accordo che poteva cambiare il mondo. L’incontro tra
Trump e Zarif, ormai è storia, saltò. Secondo Bolton, il presidente Usa si
sarebbe convinto che non poteva procedere sulla via indicata da Macron e l’Iran
ci avrebbe messo del suo, chiedendo più del necessario. La rivelazione di Bolton
è di grande interesse: se in realtà è solo una conferma di quanto venne
registrato da tanti media internazionali, compreso, nel suo piccolo, anche
il nostro sito, è conferma autorevole.
Rendere Trump “inaffidabile” per la destra. Certo, il volume è
infarcito di menzogne – sul punto rimandiamo a Piccolenote -, ma Bolton ha tutto
l’interesse invece a scrivere, sul punto, la verità, o almeno parte di essa. Ciò
perché, essendosi posto come mission la distruzione di Trump, la rivelazione di
un Trump conciliante con l’Iran serve a metterlo in cattiva luce con la destra
israeliana e Usa, almeno quella parte convinta che sia necessario incenerire
l’Iran. Trump, sta dicendo loro Bolton, non è l’alfiere anti-Iran descritto da
tutti i media internazionali. Anzi…Tali ambiti di destra rigettano i democratici
perché temono che una vittoria di Joe Biden aprirebbe le porte a un nuovo
accordo Usa-Iran, sulla falsariga di quello realizzato da Obama. Bolton dice
loro che sul punto in realtà Trump è addirittura meno affidabile di Biden, dato
che peraltro è al secondo mandato, quindi più libero, e non c’è più lui a
frenare. Resta che nelle sue memorie Bolton dice una mezza verità: è, infatti,
invero incredibile un ripensamento all’ultimo minuto di Zarif e Trump, dopo
tante intese sottotraccia che avevano addirittura fatto volare Zarif a Biarritz.
La verità è che in quei giorni Netanyahu, come scrivemmo al
tempo, attaccò la Siria in profondità, con un attacco che non aveva precedenti,
e soprattutto inviò alcuni droni contro Hezbollah a Beirut, mossa quest’ultima
che rischiava di aprire una incontrollabile guerra tra Hezbollah e Israele, che
avrebbe coinvolto giocoforza l’Iran. L’attacco, cioè minacciava di far esplodere
il Medio oriente, cosa che non avvenne sia per la ragionevolezza dimostrata da
Hezbollah, come scrisse Haaretz, ma soprattutto perché Trump rinunciò alla pace
con l’Iran, tranquillizzando il premier israeliano.
Trump apre al Venezuela. Pagina istruttiva di come si sia
dipanata la presidenza Trump, tra possibilità distensive e spinte frenanti da
parte dei suoi bellicosi supporter apparenti. Simpatica la reazione di Trump al
libro di Bolton. Il presidente americano ha infatti commentato che l’ex
Consigliere per la Sicurezza nazionale è un “pazzo [ ]. Voleva andare in guerra
con tutti. Non ho mai visto una guerra che non gli piacesse” (Wall Street
Journal). Vero, ed è alquanto inquietante Bolton sia diventato un’icona dei
democratici, i quali pur prendendo le distanze, accreditano come vangelo le sue
“verità” (New York Times). A proposito di distensioni e freni, e di tentati
regime-change ad opera dell’ex Consigliere per la Sicurezza nazionale, di grande
interesse un’intervista esclusiva di Axios al presidente Usa, nella quale Trump
si dice disponibile a incontrare il presidente venezuelano Nicolas Maduro,
perché “non sono mai contrario agli incontri”, dimostrando certa freddezza nei
confronti di Juan Guaidò, l’uomo designato dai neocon, e Bolton in particolare,
a prenderne il posto. Apertura di credito per ora solo simbolica (la campagna
elettorale non permette tale sviluppo perché susciterebbe troppe reazioni), ma
che apre prospettive, dati anche i nuovi rapporti tra Caracas e Teheran a
seguito della spedizione di un carico di petrolio iraniano al Venezuela col
tacito placet di Washington (Piccolenote).
Paolo Mastrolilli per “la Stampa” il 21 giugno 2020. Compare
anche il nome del premier italiano Conte, nel libro «The Room Where It
Happened», che l' ex consigliere alla Sicurezza John Bolton ha scritto contro
Trump. È un passaggio breve, ma significativo, perché conferma che in occasione
del G7 il capo di Palazzo Chigi aveva fatto capire a quello della Casa Bianca di
essere favorevole a riammettere la Russia nel club dei 7 grandi del mondo. Che
Roma fosse più disponibile di altre capitali europee verso Mosca non è una
novità, nonostante avesse accettato le sanzioni dopo l' invasione della Crimea,
che avevano penalizzato la nostra economia. La linea era simile durante gli
esecutivi precedenti a guida Pd, anche se il governo gialloverde l' aveva
accentuata, con tutti i sospetti sui rapporti tra M5S e Cremlino, e le denunce
di possibili finanziamenti alla Lega, emerse dopo gli audio delle conversazioni
di Gianluca Savoini all' Hotel Metropol il 18 ottobre 2018. Nel caso di Conte,
però, il delicato intreccio con Putin si allarga all' inchiesta aperta dal
segretario alla Giustizia Barr e dal procuratore Durham sull' origine del
Russiagate, alimentando i dubbi di un do ut des avvenuto con Trump, sulla
falsariga di quanto era accaduto quando aveva chiesto all' ucraino Zelensky di
fargli «un favore», indagando gli interessi a Kiev dei Biden. Mossa che poi
aveva portato all' impeachment alla Camera.
Gli incontri. Il Russiagate ha origine a Roma, perché la Link
Campus University è il luogo dove nel marzo del 2016 il professore maltese
Joseph Mifsud, poi misteriosamente scomparso, aveva incontrato il consigliere di
Trump George Papadopoulos. Il 26 aprile Joseph aveva rivisto George a Londra, e
gli aveva confidato che i russi avevano rubato le mail di Hillary. La teoria di
Papadopoulos è che fosse una trappola tesa dai nemici di Donald nell'
amministrazione Obama, affinché la campagna presidenziale del repubblicano
facesse un passo falso che consentisse di incastrarlo. Anche Trump si è convinto
di questa versione, e quindi ha chiesto a Barr di aprire un' inchiesta per
svelare le malefatte del «deep State» contro di lui. L' Italia è sospettata di
aver collaborato, perché allora a Palazzo Chigi c' era Renzi, che era schierato
con Clinton, e durante la sua visita di stato alla Casa Bianca del 18 ottobre
2016 aveva chiesto aiuto ad Obama contro le interferenze politiche di Mosca in
Italia. Nel giugno del 2019 Trump aveva fatto sapere a Conte che Barr e Durham
volevano venire a Roma per chiedere cosa sapevamo di questa vicenda. All' epoca
il governo gialloverde traballava e il destino del premier era incerto. Chigi
aveva accettato la richiesta, e il 15 agosto Barr e Durham avevano incontrato il
direttore del Dis Vecchione. Un appuntamento irrituale, perché il protocollo
avrebbe voluto che Barr vedesse il suo omologo ministro della Giustizia.
L' amico Giuseppe. Alla fine di agosto, nel pieno delle
trattative per il nuovo governo, Conte era andato a Biarritz per il G7. Non
aveva avuto un bilaterale con Trump, ma lo aveva incontrato, e il 27 Donald si
era augurato via Twitter che «l' altamente rispettato primo ministro della
repubblica italiana, Giuseppi Conte», fosse confermato. Un mese dopo Barr e
Durham erano tornati a Roma, presumibilmente per raccogliere le informazioni
domandate a ferragosto, e l' inchiesta sul Russiagate aveva assunto carattere
penale. Conte aveva poi detto al Copasir che le visite erano state regolari. I
democratici si aspettano che Durham incriminerà qualche membro dell'
amministrazione Obama, della Cia o dell' Fbi, prima delle presidenziali del 3
novembre, per imbarazzare Biden. E l' Italia potrebbe risultare come uno dei
passaggi chiave, facilitato dalla sintonia fra Conte e Trump sulla Russia di cui
parla Bolton.
Soros e Obama: il potere ombra contro Donald Trump.
Roberto Vivaldelli il 4 luglio 2020 su Inside Over. La morte
di George Floyd ha innescato una “rivoluzione culturale”, animata da Black Lives
Matter e dalle altre organizzazioni della sinistra americana, che ha l’obiettivo
di sostituire radicalmente lo status quo e la storia d’America con i nuovi
valori ultra-liberal del politicamente corretto. L’odio di sé – che caratterizza
questi i nuovi movimenti progressisti che vogliono cancellare la storia –
rappresenta un lascito del puritanesimo. Come nota Robert Huges nel suo
saggio La cultura del piagnisteo. La saga del politicamente corretto, i Puritani
si ritenevano, a buon diritto, vittime di una persecuzione, designate a creare
uno Stato teocratico le cui virtù trascendessero i mali del Vecchio Mondo e
riscattassero così la caduta dell’uomo europeo. La democrazia americana, nota
Hughes, “consistette nell’infrangere la condizione di vittima coloniale, creando
uno Stato laico in cui diritti naturali dell’individuo si ampliassero senza
sosta a vantaggio dell’eguaglianza”. Ma i nuovi “rivoluzionari” politicamente
corretti non agiscono da soli e in piena autonomia. Come scrive Tino Oldani
su Italia Oggi, recentemente il Wall Street Journal, come ha opportunamente
segnalato Paolo Panerai su Orsi & Tori di sabato scorso, denuncia il dilagare
del “giacobinismo” negli Stati Uniti, ne sottolinea il pericolo per la tenuta
della cultura liberale, e lo dimostra raccontando decine di casi in cui nomi
noti del mondo giornalistico, accademico e artistico, per nulla estremisti, sono
stati epurati e licenziati sui due piedi soltanto per avere espresso la loro
opinione, che per una sola parola o un solo aggettivo non collimava con quelle
estremiste del movimento Black Lives Matter (Blm). In tutti i casi si trattava
di opinioni moderate, per nulla di stampo razzista, ma soltanto dubbiose sul
fatto di manifestare in piazza e nelle strade con la violenza e i saccheggi.
Metodo che, con i cortei Blm, ha dilagato in molte città americane. Tucker
Carlson (Fox News) protagonista del programma televisivo d’approfondimento
politico più seguito in America, con oltre 4 milioni di spettatori che lo
seguono quotidianamente, è da settimane vittima del boicottaggio di decine e
decine di aziende che hanno rinunciato agli spazi pubblicitari durante lo show.
Motivo? Ha osato criticare Black Lives Matter e i suoi metodi violenti. Come
nota Oldani, nell’editoriale del Wsj mancano però i nomi dei due grandi padri
putativi del nuovo “giacobinismo” in salsa politically correct: il finanziere
George Soros e l’ex presidente Usa Barack Obama.
George Soros e la guerra permanente contro Trump. Il finanziere
Soros, fondatore dell’organizzazione filantropica Open Society Foundations, non
ha mai realmente smesso di fare la guerra al Presidente Usa Donald Trump. Come
spiegava IlGiornale.it la scorsa estate, Soros, che nel 2016 aveva investito
diversi milioni di dollari a sostegno di Hillary Clinton, è sceso nuovamente in
campo a favore del Partito democratico americano e ha fondato, secondo quanto
riportato da Politico, un super Pac, chiamato Democracy Pac, che fungerà da
“hub” per le sue spese elettorali in vista del 2020. Negli Stati Uniti il Pac –
acronimo di Political action committee – è un comitato che raccoglie fondi per
effettuare donazioni a sostegno dei candidati alle elezioni. I Pac più
importanti sono quelli creati per sostenere il candidato presidente degli Stati
Uniti. Soros ha investito 5,1 milioni di dollari nel Democracy Pac, solo nel
2019, secondo i documenti depositati presso la Commissione elettorale federale.
È nota inoltre la vicinanza di Black Lives Matter all’orbita dell’Open Society
Foundations. Come scrive Italia Oggi, l’attivista afroamericana Candace Owens,
tra le più attive nel “Blacks for Trump”, ha accusato Soros di avere versato 33
milioni di dollari al Blm. Effettivamente, la Open Society ha effettuato una
serie di donazioni a enti che collaborano con il movimento Blm a livello
mondiale, tra cui la britannica Release Leads, che nel 2018 ha ricevuto 280 mila
dollari. È inoltre noto che alla presidenza della Osf sieda Patrick Gaspard,
afroamericano, ex capo di gabinetto di Barack Obama alla Casa Bianca, nonché
autorevole esponente del partito democratico Usa. Le organizzazioni
riconducibili al finanziere hanno inoltre sponsorizzato le manifestazioni
femministe contro The Donald. Più di 50 associazioni che hanno organizzato e
aderito alla Women’s March svoltasi a Washington D.C nel gennaio 2017 – con
Trump appena insediatosi – e in molte città del mondo contro il presidente
eletto Donald Trump, sono state finanziate dalla Open Society
Foundations di George Soros. A sostenerlo non era una testata conservatrice
statunitense bensì la giornalista Asra Q. Nomani sul New York Times, musulmana,
femminista e nota attivista dei movimenti liberali nell’Islam. Senza dimenticare
che il finanziere ha sponsorizzato, nell’ottobre 2018, le proteste contro il
giudice conservatore Kavanaugh. Alla manifestazione contro il giudice
conservatore, in effetti, hanno preso parte tutte le associazioni supportate
dalla rete del finanziere: l’American Civil Liberties Union, la Leadership
Conference on Civil and Human Rights, Planned Parenthood, NARAL Pro-Choice
America, the Center for Popular Democracy, Human Rights Campaign e molte altre.
“MoveOn.org – spiega Nomani – l’organizzazione vicina ai democratici e fondata
grazie al denaro di Soros, ha inviato al suo esercito di seguaci un modulo dove
poter richiedere i biglietti del treno per arrivare a Capitol Hill”. Ad animare
la protesta contro il giudice Kavanaugh c’era anche USaction (ora People’s
Action) che, secondo Open Screts, nel solo 2018, ha ricevuto dal Soros Fund
Management circa due milioni di dollari.
I rapporti fra la “talpa” anti-Trump e l’Open Society. Parliamo
ora del processo di impeachment sull’Ucrainagate, conclusosi con un nulla id
fatto. La “gola profonda”, il “whistleblower” che ha denunciato Donald Trump per
le presunte pressioni esercitate nei confronti del presidente ucraino Zelensky,
dando di fatto avvio alla procedura di impeachment, che Real Investigations ha
individuato in Eric Ciaramella, riceveva e-mail sulla politica ucraina da un
alto dirigente della Open Society Foundations, la rete filantropica fondata dal
finanziere George Soros. Le e-mail, risalenti al 2016 e diffuse dal giornalista
investigativo John Solomon, dimostrano i contatti fra l’Open Society e
l’amministrazione Obama sugli spostamenti del magnate e sui contenuti degli
incontri privati del finanziere a Kiev.
Uno dei destinatari delle e-mail della Open Society, insieme a
Ciaramella, era l’allora Segretario di stato aggiunto per gli affari
europei Victoria Nuland, con la quale la “gola profonda” ha lavorato a stretto
contratto. In una mail del 9 giugno 2016, Jeff Goldstein, analista politico
presso l’Open Society Foundations, scrive a Nuland e Ciaramella, i destinatari
principali della missiva. “Volevo farvi sapere che il signor Soros ha incontrato
Johannes Hahn (commissario europeo, ndr) a Bruxelles oggi. Una delle questioni
sollevate durante l’incontro riguardava la preoccupazione per la decisione di
ritardare la liberalizzazione dei visti per la Georgia e le implicazioni per
l’Ucraina”. Le e-mail, oltre a dimostrare i rapporti fra la “talpa” che ha
denunciato il presidente americano e l’organizzazione di Soros, dimostra anche
l’ingerenza dell’amministrazione Obama nel Paese dell’ex Unione sovietica
attraverso la rete filantropica fondata dal magnate. George Soros ammise, in
un’intervista rilasciata alla Cnn, di aver contribuito attivamente al
rovesciamento dell’ex presidente ucraino Viktor Yanukovych.
Barack Obama: così ha “sabotato” l’amministrazione Trump sin
dall’inizio. Arriviamo infine a Barack Obama. Come nota Italia Oggi, nel corso
degli anni, per opera soprattutto di Obama, il connubio tra il partito
democratico Usa e il movimento Blm ha prodotto una progressiva radicalizzazione
culturale sui temi razziali, che è andata avanti di pari passo con il Metoo
femminista e con la tutela dei diritti sessuali Lgbt (lesbiche, gay, bisessuali,
transgender). Un’arma politica da usare contro Donald Trump. Ma la guerra di
Barack Obama contro Trump non si è certo limitata a soffiare sul fuoco delle
proteste. Come abbiamo rilevato su InsideOver, l’ex presidente Barack Obama ha
avuto un ruolo chiave nell’orchestrare il falso scandalo del Russiagate e
nell’alimentare la narrativa della collusione fra la Campagna di Donald Trump e
il Cremlino a cavallo fra il 2016 e il 2017. Secondo il New York Post, le
recenti rivelazioni nell’ambito della lunga battaglia giudiziaria dell’ex
consigliere per la sicurezza nazionale Michael T. Flynn conferma che Obama ha
svolto un ruolo centrale in tutta la vicenda. Gli appunti scritti a mano
dall’agente dell’Fbi Peter Strzok mostrano che Obama, in combutta con Joe Biden,
incoraggiò il bureau e del Dipartimento di Giustizia a indagare su Flynn,
nonostante i gli alti funzionari dell’Fbi avessero confermato che le azioni del
tenente generale e le sue telefonate con l’allora ambasciatore russo Sergey
Kislyak sembrassero “legittime”.
Il tycoon nell'angolo. Trump
travolto dal Coronavirus, ma non è il peggiore. Paolo Guzzanti Il Riformista il
23 Giugno 2020. E adesso, pover’uomo? Ci mancava anche che John Bolton, con
quella sua faccia e quei baffi spioventi alla Mark Twain, con il suo
libro-pugnalata-alle-spalle, The Room Where it Happened, gli desse l’ultimo – in
ordine di tempo – bacio di Giuda. E poi lo scherzo tremendo dei ragazzini – se è
vera la storia – che hanno fatto finta di comprare tutti i posti del comizio del
presidente, senza pagarli e mandando deserto lo stadio, centinaia di sedie
vuote, che figura. Povero, povero, vecchio panzone zazzeruto Donald Trump, viene
da dire. Trump è odiato, come ogni presidente e candidato repubblicano. Trump è
additato al disprezzo mondiale esattamente come lo fu, George W. Bush, trattato
come un imbecille guerrafondaio. E suo padre, il presidente George Bush Senior?
Altro farabutto, per le piazze internazionali: ex capo della Cia, non dico
altro, autore insieme al generale nero Colin Powell dell’attacco all’Iraq che si
era annesso il Kuwait, e collaboratore di Ronald Reagan. La fine è nota. Ma,
proviamo – giusto per giocare – a guardare se per caso Trump fosse il minor male
possibile. Fino al Coronavirus la presidenza Trump aveva queste caratteristiche.
Primo: l’economia non era mai volata così in alto senza perdere un colpo; Wall
Street sfondava i suoi record storici e – questa la grande novità – gli
afroamericani per la primissima volta nella loro storia di poco più di mezzo
secolo di vera crescita nella scala dei diritti e del benessere, avevano piena
occupazione, reddito, scuole, sanità. Sì, certo: George Floyd e le altre vittime
della polizia hanno mostrato un grande marcio. Ma non un nuovo marcio. Anzi, lo
slogan “Black Lives Matter” significa proprio che la morte di Floyd ha solo
riaperto una vecchia piaga secolare: la brutalità poliziesca letale
prevalentemente con i discendenti degli schiavi rapiti in Africa dagli inglesi.
Verissimo, ma queste porcherie poliziesche non sono una novità dell’era Trump.
La novità dell’era Trump è che un solo episodio, delle centinaia e anche
migliaia che accadono in un anno, ha scatenato la rivolta globale dell’America
contro l’America e degli antiamericani fuori dall’America, sempre contro
l’America. Chi scrive ricorda per averli vissuti e accompagnati questi
sentimenti molto forti contro gli Stati Uniti almeno dal 1958
quando Eisenhower fece sbarcare i Marines a Beirut e fu il primo gesto
imperiale, dopo la fine della guerra di Corea. Tutti in piazza. Poi tutti in
piazza contro Kennedy per la crisi dei missili a Cuba, poi tutti in piazza
contro Lindon Johnson, poi tutti in piazza contro Nixon e la guerra
del Vietnam e poi tutti zitti con Jimmy Carter che perdeva e le prendeva sempre,
ma tutti odiavano Ronald Reagan – il cow boy, l’attorucolo di serie B che ci
voleva portare alla guerra mondiale contro l’Urss, e poi grande comprensione
per Bill Clinton che bombardava Belgrado dalle piste di casa nostra, e di nuovo
furia iconoclasta prima contro i già citati Bush e ora contro il perfetto “The
Donald”, così scorretto, odioso, abominevole, com’è mai possibile che qualcuno
lo abbia eletto. E, invece, lo hanno proprio eletto. E, benché le probabilità
siano in netto calo, potrebbero ancora rieleggerlo. Tuttavia: avete notato che
questo Presidente, ora al termine del suo primo mandato che probabilmente
resterà l’unico, non ha fatto male a una mosca? Non fatto guerre, né sbarchi? È
vero: mentre aveva a cena a Mar A Lago il presidente cinese Xi, fece partire una
sventagliata di missili su un campo d’aviazione siriano vuoto, senza fare una
sola vittima. Ma, e questo ci sembra un punto centrale, doveva sempre lottare
contro il suo consigliere personale alla sicurezza, che sarebbe proprio il
baffuto John Bolton, il quale voleva sempre spingerlo all’azione militare. Per
Bolton, l’America avrebbe dovuto attaccare la Corea del Nord, l’Iran, la Siria,
prepararsi a fare a botte con la Turchia e anche con la Russia, mentre
consigliava di avere l’arma al piede per la Cina, E poi, voleva assolutamente
l’invasione immediata del Venezuela di Chavez. Oggi racconta che Trump era un
po’ attratto dall’idea: «Sarebbe fico – cool – andare in Venezuela e buttare
fuori quel Maduro», diceva. Ma non l’ha fatto. Ma Bolton l’ha scritto, col dente
avvelenato per essere stato messo alla porta da Trump che non ne poteva più di
un consigliere che aveva come unica proposta la guerra. Trump non vuole una
guerra. E l’ha dimostrato proprio con la sua campagna, poco capita in Europa,
dell’America First. A noi europei è stata tradotta come una arrogante
manifestazione di supremazia, mentre invece – se leggete bene – il significato è
un altro: gli Stati Uniti si sono svenati dalla Seconda guerra mondiale fino a
ieri mattina per proteggere con le loro armi e con i soldi dei loro
contribuenti, i loro alleati. I cimiteri di guerra di tutto il mondo sono pieni
di soldati americani morti a decine di migliaia di chilometri da casa e il
risultato economico è stato quello che a molti sfugge: la Germania, colpevole di
aver scatenato per il proprio egoismo due devastanti guerre mai conosciute prima
dall’intera umanità, dopo aver perso anche la seconda, ha detto di aver capito:
risparmiando una grossa fetta del suo budget che sarebbe andato alle spese
militari, ha investito sui prodotti d’eccellenza a partire dalle auto in
concorrenza con quelle americane, prodotte con fatica da un Paese che si svena
per pagare anche la protezione della Germania. Risultato: Trump ritira in questi
giorni dalla Germania – che detesta – circa ventimila soldati americani con
tutte le loro costosissime attrezzature, militari che stavano a fare la guardia
al tesoro tedesco. Trump inoltre se ne sta andando dall’Afghanistan, vale a dire
dal posto in cui gli americani si trovavano per riparare l’onta dell’Undici
Settembre, dalla Siria, dal medio e lontano Oriente, oltre che dall’Europa. Ma,
attenzione, c’è la Cina. Il vecchio titolo del film di Marco Bellocchio “La Cina
è vicina” è Disneyland a confronto della situazione di oggi. Ma prima di tornare
alla Cina vogliamo ricordare che John Bolton, si è trasferito armi e bagagli nel
campo di Agramante, ovvero si è schierato con Joe Biden, l’avversario di Trump
alle prossime elezioni di Novembre, ex vice presidente di Barack Obama e padre
di Hunter (strano nome che vuol dire cacciatore) con cui faceva affari molto
importanti in Ucraina. Ricordate la storia dell’Impeachement chiesto dalla
speaker democratica Nancy Pelosi? Trump secondo la Pelosi, si sarebbe rivolto al
presidente ucraino per estorcergli gli atti della procura di Kiev che indagava
sui due Biden padre e figlio, che non devono essere proprio mammolette. È un
fatto che la Procura di quel Paese indagasse su molte “bribes”, mazzette
elargite in una campagna affaristica di vendita di armi e altri beni strategici
all’Ucraina, in funzione antirussa, dopo l’annessione dell Crimea da parte di
Putin. L’impeachment non ha avuto altro effetto che quello di aprire la campagna
elettorale di novembre e Trump ne è uscito illeso grazie ai voti repubblicani
del Senato che lo ha difeso in modo compatto. Poi sono accadute le cose che
sappiamo: Covid ha fatto saltare la borsa e l’economia americana. E poi la
terribile e molto istruttiva vicenda di George Floyd, seguita da altri casi
simili e preceduta da migliaia di altri casi. Il Paese che ha più profittato,
per non dire goduto, di quel che accadeva, è stato certamente la Cina. Che si è
mangiata Hong Kong e dà chiari segnali di voler fare altrettanto con l’isola di
Taiwan. Ma questa vicenda ci riporta a Bolton e al suo libro in cui si racconta
“ciò che succedeva in quella stanza”, perché l’ex guerrafondaio che consigliava
continuamente a Trump l’intervento militare e che per questo fu licenziato, si è
vendicato rivelando un dettaglio atroce, terribile per il presente e per il
futuro di Trump. Infatti, ha raccontato che il Presidente, prima che scoppiasse
la pandemia, aveva fatto al presidente cinese Xi un’offerta indecente: «Io la
sosterrò sempre, come unico e più autorevole cinese di tutti i tempi, ma le
chiedo in cambio di qualcosa per me, sostenendo la mia rielezione alla Casa
Bianca con ogni mezzo possibile». Nero su bianco e purtroppo, o per fortuna,
quelle parole non erano smentibili: Trump ha formalmente protestato contro il
malcostume di pubblicare libri dopo aver coperto posizioni delicate nel governo,
ma sono chiacchiere. Intanto, Trump si è messo di traverso alla Cina, benché
tutte le analisi economiche garantiscono che i due grandi Paesi, Stati
Uniti e Cina, non potranno farsi alcuna guerra perché hanno un disperato bisogno
l’uno dell’altro. Washington sta puntando tutto sull’India, premendo affinché
questo secondo Grame Paese si sbrighi ad occupare la posizione di eccellenza
cinese e i risultati già si vedono: le truppe cinesi sparano sui soldati indiani
lungo una frontiera che non è mai stata garantita da nessuno. Adesso, che cosa
farà lo zazzerone ferito? Trump è per ora ai minimi termini, anche se quattro
mesi sono lunghi da passare. Ma l’America è ancora arroventata dalla rivolta,
Biden canta vittoria nei sondaggi e molti topi repubblicani già saltano dalla
nave.
Russiagate: “Barack Obama ha minato lo stato di diritto”.
Roberto Vivaldelli il 30 giugno 2020 su Inside Over.
L’ex presidente Barack Obama ha avuto un ruolo chiave nell’orchestrare il falso
scandalo del Russiagate e nell’alimentare la narrativa della collusione fra la
Campagna di Donald Trump e il Cremlino a cavallo fra il 2016 e il 2017. Secondo
il New York Post, le recenti rivelazioni nell’ambito della lunga battaglia
giudiziaria dell’ex consigliere per la sicurezza nazionale Michael T. Flynn
conferma che Obama ha svolto un ruolo centrale in tutta la vicenda. Gli appunti
scritti a mano dall’agente dell’Fbi Peter Strzok mostrano che Obama, in combutta
con Joe Biden, incoraggiò il bureau e del Dipartimento di Giustizia a indagare
su Flynn, nonostante i gli alti funzionari dell’Fbi avessero confermato che le
azioni del tenente generale e le sue telefonate con l’allora ambasciatore russo
Sergey Kislyak sembrassero “legittime”. Gli appunti di Strzok offrono maggiori
dettagli sul famigerato meeting del 5 gennaio 2017 nello Studio Ovale al quale
parteciparono, oltre a Obama e Biden, anche il consigliere per la sicurezza
nazionale Susan Rice e il vice procuratore generale Sally Yates. Apprendendo che
l’Fbi era pronta a chiudere le sue indagini su Flynn con un nulla di fatto e
senza aver rilevato illeciti, Obama e Biden suggerirono di trovare un’altra via
giudiziaria per incastrare Michael T.Flynn attraverso il Logan Act che impedisce
ai cittadini americani non autorizzati di impegnarsi in “qualsiasi
corrispondenza o rapporto con qualsiasi governo straniero”. Cosa ancor più grave
Barack Obama in persona ordinò di tenere l’amministrazione entrante all’oscuro
di tutto: “Assicuratevi di rivolgervi alle persone giuste”.
Gli appunti di Strzok inguaiano Biden e Obama. Come abbiamo già
avuto modo di appurare qui su InsideOver, le note scritte a mano dall’ex agente
dell’Fbi Peter Strzok rappresentano, secondo gli avvocati di Michael T. Flynn,
primo consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump, “prove
sbalorditive” che ora rischiano seriamente di inguaiare Joe Biden e Barack
Obama, che hanno sempre negato ogni coinvolgimento nella vicenda. “Secondo gli
appunti di Strzok, sembra che il vicepresidente Biden abbia sollevato
personalmente l’idea del Logan Act”, hanno rilevato gli avvocati della difesa
Jesse Binnall e Sidney Powell. “È diventato un pretesto per indagare sul
generale Flynn”. Il Logan Act, che risale al 1799, impedisce ai cittadini
americani non autorizzati di impegnarsi in “qualsiasi corrispondenza o rapporto
con qualsiasi governo straniero”. Nessuno negli Stati Uniti è mai stato
condannato per aver violato questa legge. Al momento la Campagna di Joe Biden
non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito al coinvolgimento dell’ex
vicepresidente nella vicenda. Come abbiamo spiegato qui, nei giorni scorsi la
corte d’appello federale di Washington D.C. ha ordinato al giudice federale
Emmet Sullivan di accogliere la richiesta presentata nelle scorse settimane dal
dipartimento di Giustizia di ritirare le accuse contro l’ex consigliere per la
sicurezza nazionale di Donald Trump, Michael Flynn. Nello specifico, tre giudici
della corte d’appello hanno infatti accolto la richiesta del generale di
intervenire presso il giudice che si era rifiutata di accogliere la richiesta
del dipartimento di Giustizia, richiedendo un parere legale esterno contro
questa mossa.
“Obama ha minato lo stato di diritto”. Come nota il
professor Matthew Spalding su RealClearPolitics, si sta ampiamente
sottovalutando ciò che l’attacco dell’amministrazione Obama al tenente generale
Michael Flynn significa per il governo costituzionale degli Stati Uniti. “La
campagna sistematica per minare un’amministrazione presidenziale in entrata
attraverso indagini politicizzate non è un altro scandalo politico, ma minaccia
una vera crisi costituzionale” sottolinea Spalding. “Se le azioni che stanno
diventando note sono vere, l’amministrazione Obama ha sovvertito principi
fondamentali e ha minato lo stato di diritto impiegando l’apparato di
intelligence della nazione per interrompere la transizione al potere
dell’amministrazione Trump, che è stata eletta dal popolo americano”. Ecco
riepilogati alcuni dei fatti più gravi da RealClearPolitics: 1) Sulla base di
prove molto fragili, l’Fbi ha avviato un’indagine di controspionaggio sulla
campagna presidenziale di Trump, un’inchiesta che ha incluso la sorveglianza di
almeno tre funzionari della campagna e l’ottenimento di un mandato di
sorveglianza Fisa con informazioni non verificate. 2) Nell’ambito di tale
indagine, qualcuno alla Casa Bianca o ai più alti livelli delle agenzie di
intelligence ha fatto trapelare ai media informazioni classificate su una
telefonata del dicembre 2016 tra il neo-consigliere per la sicurezza nazionale
Flynn e l’ambasciatore russo. 3) Sebbene il personale dell’Fbi avesse deciso di
chiudere le indagini su Flynn per mancanza di prove il 4 gennaio, gli alti
funzionari del bureau hanno deciso di tenere aperto il caso. Ventiquattro ore
dopo, il direttore dell’Fbi James Comey ha incontrato il presidente Obama, il
vicepresidente Biden e altri funzionari della Casa Bianca e dell’intelligence. È
stato discusso il caso Flynn e James Comey è stato incaricato di informare il
presidente eletto Trump del famigerato dossier Steele, che è stato finanziato
indirettamente dalla campagna di Clinton. 4) Invece di informare il presidente
eletto Donald Trump sull’ipotesi che Flynn e altri nella sua campagna fossero
legati ai russi, il direttore dell’Fbi – in piena collaborazione con il
presidente Obama – ha fatto del suo meglio per mantenere Trump all’oscuro
dell’intera portata dell’indagine. 5) Il 24 gennaio (secondo giorno di Flynn
come nuovo consigliere per la sicurezza nazionale), il direttore dell’Fbi ha
inviato due agenti alla Casa Bianca per preparare una trappola per Flynn e per
farlo licenziare contro il parere del procuratore generale. “Ognuno di questi
casi è problematico. Ma il tutto (insieme a tutte le altre cose che stiamo
apprendendo) è peggio della somma delle parti: sembra essere un modello di
politicizzazione della giustizia per sovvertire l’esito del nostro sistema
elettorale” nota il professor Spalding. In buona sostanza: un vero e proprio
“golpe” orchestrato ai danni di Donald Trump.
E se il vero Russiagate fosse dei Clinton?
Roberto Vivaldelli su Inside Over il 26 settembre 2020. Il procuratore John
Durham, incaricato dall’Attorney general William Barr di fare chiarezza sulle
origini del Russiagate e verificare se la condotta delle agenzie governative è
stata “lecita e appropriata”, si sarebbe interessato alle indagini sulla Clinton
Foundation, la Fondazione “filantropica” di Bill e Hillary Clinton. Secondo
il New York Times, l’avvocato del Connecticut ha cercato documenti e interviste
inerenti la condotta dei federali e su come questi ultimi hanno gestito
l’indagine sulle accuse di corruzione politica presso la Fondazione Clinton,
secondo persone che hanno familiarità con la vicenda. Secondo il quotidiano
vicino ai dem, non è chiaro se gli investigatori di Durham cercassero violazioni
nell’indagine della Fondazione Clinton, né se questo interessamento alla
Fondazione Clinton giocherà un ruolo importante nell’esito – attesissimo – delle
indagini del Procuratore. Come ricorda il New York Times, l’indagine sulla
Fondazione Clinton è iniziata circa cinque anni fa, sotto l’amministrazione
Obama, e si è bloccata in parte perché non ci sarebbero stati i margini né le
motivazioni per emettere citazioni in giudizio. Ad oggi, il caso non ha portato
ad accuse penali. Il sospetto è che Hillary Clinton usasse un server di posta
privato e distruggesse le sue e-mail per nascondere comunicazioni che potrebbero
documentare le attività della Fondazione.
Che cosa c’entrano i Clinton con il Russiagate? Secondo quanto
riportato da Fox News, parte dell’indagine del procuratore statunitense John
Huber sulla Fondazione Clinton sarebbe ora in carico a John Durham. Motivo? Ci
sarebbe un legame – diretto – con le origini del Russiagate. Una fonte che ha
familiarità con le indagini di Durham lo ha confermato proprio a Fox News. Nel
novembre 2017, l’allora procuratore generale Jeff Sessions ha incaricato Huber,
l’avvocato statunitense dello Utah e altri procuratori senior, di valutare
“alcune questioni” riguardanti la vendita di Uranium One e altri rapporti
relativi alla Fondazione Clinton. Huber è stato anche incaricato di esaminare la
gestione da parte dell’Fbi dell’indagine sulle e-mail di Hillary Clinton.
Secondo i critici, quando era Segretario di Stato, Hillary Clinton usò la sua
carica per aiutare la Russia ad acquisire il controllo di un quinto delle
riserve americane di uranio in cambio di milioni di dollari versati alla Clinton
Foundation, la fondazione di famiglia. Che cos’è l’affare Uranium One? Il
colosso statale russo per l’energia atomica, la Rosatom, acquisì il controllo
della compagnia canadese Uranium One e, tramite essa, di un quinto delle riserve
minerarie di uranio negli Stati Uniti per un valore di decine di miliardi di
dollari. Ovviamente, essendo l’uranio un bene strategico, con evidenti
implicazioni per la sicurezza nazionale, l’acquisizione ha avuto bisogno del via
libera di una commissione governativa. Mentre i russi presero gradualmente il
controllo di Uranium One in tre transazioni distinte dal 2009 al 2013, secondo
il New York Times il presidente canadese della compagnia con sede a
Toronto, Ian Telfer, fece quattro donazioni diverse alla Clinton Foundation
attraverso la fondazione di famiglia, per un totale di 2,35 milioni di dollari.
Curioso, no? Ora si tratta di stabilire quale sia la connessione fra questa
vicenda riguardante la Fondazione Clinton e l’indagine condotta da Durham.
Vicino l’esito delle indagini di Durham. All’inizio di settembre,
il presidente del comitato giudiziario del senato Lindsey Graham ha lasciato
intendere che gli sviluppi nelle indagini di Durham sono vicini. La prova che
qualcosa si stia muovendo è la notizia emersa non più tardi di una decina di
giorni fa: secondo un rapporto declassificato del Dipartimento di Giustizia, i
dati di più di due dozzine di smartphone appartenenti ai membri del team di
Mueller sono stati “cancellati” prima che l’ispettore generale del Doj potesse
esaminarli. Secondo Fox News, il rapporto del Dipartimento di Giustizia dimostra
che i dati sono andati persi dopo che gli smartphone hanno subito danni
irreparabili allo schermo, sono andati persi o sono stati bloccati dopo che gli
utenti hanno provato a inserire il pin più volte.
Da ilmessaggero.it il 7 ottobre 2020. Si arricchisce di nuovi
elementi l'intricata vicenda del Russiagate, l'inchiesta sui presunti legami
Trump-Putin (mai provati), poi divenuta Obamagate nella contronarrativa
repubblicana, che accusa l'establishment democratico di avere organizzato una
montatura ai danni dell'allora candidato repubblicano Donald Trump. Il numero
uno dell'intelligence Usa, John Ratcliffe , Director of National Intelligence
(Dni), ha declassificato un memo inviato nel 2016 dalla Cia all'allora direttore
dell'Fbi James Comey, nel quale si indicava che informazioni di intelligence
suggerivano che la candidata democratica alla presidenza, Hillary Clinton, aveva
approvato un piano per collegare la campagna di Trump all'hackeraggio del
Democratic National Committee, di cui venne accusata la Russia. La scorsa
settimana, durante un'audizione davanti alla commissione Giustizia del Senato,
Comey affermò di non ricordare di aver ricevuto il documento. Insieme a lui,
destinatario del memo era anche il capo della sezione controspionaggio dell'Fbi
Peter Strzok, che guidò le indagini sull'uso di un server di posta elettronica
personale da parte di Hillary Clinton, all'epoca in cui era segretario di Stato.
Una pratica vietata. Le tre pagine del documento, in parte coperte da omissis,
sono state inviate da Ratcliffe ai presidenti e ai membri delle commissioni
Intelligence di Senato e Camera dei Rappresentanti. Insieme al memo, sono state
desecretate anche alcune note scritte dall'allora direttore della Cia, John
Brennan. La scorsa settimana, Ratcliffe aveva già reso noto un sommario relativo
al contenuto del documento ora declassificato, nel quale sosteneva che la
Clinton avrebbe approvato il piano per prendere di mira Trump il 26 luglio del
2016, mentre le note scritte a mano da Brennan riguardavano un briefing con il
presidente Barack Obama alla fine di luglio. Ratcliffe spiegava che le
informazioni relative al presunto piano della Clinton venivano da un'analisi di
intelligence russa della quale le autorità Usa erano entrate in possesso.
Ratcliffe suggeriva anche che, poiché le informazioni provenivano dalla Russia,
andavano gestite con attenzione, perché potevano essere state intenzionalmente
manipolate. Da questo complicato intreccio, nel memo della Cia inviato a Comey e
Strzok si afferma che il 'pianò della Clinton serviva a distrarre l'attenzione
dei media e dell'opinione pubblica dalla vicenda che la riguardava direttamente:
lo scandalo legato all'uso di un server privato di posta elettronica durante il
suo incarico da segretario di Stato. Le note dell'ex direttore della Cia
Brennan, inoltre, descrivono la «presunta approvazione da parte di Hillary
Clinton il 26 luglio (2016, ndr) di una proposta avanzata da un suo consigliere
di politica estera per diffamare Donald Trump, alimentando uno scandalo riguardo
alle interferenze dei servizi di sicurezza russi». Le note di Brennan presentano
anche tre 'puntì provenienti da «Potus», l'acronimo usato per indicare il
presidente degli Stati Uniti, vale a dire Barack Obama. Nell«unico punto non
coperto da omissis si legge, »qualsiasi prova di collaborazione tra la campagna
di Trump e i russi«». Infine, le note di Brennan comprendono un altro elenco di
'puntì sotto l'intestazione «JC», che potrebbe fare riferimento al direttore
dell'Fbi James Comey. Questo starebbe a significare che Brennan fornì un
briefing anche a Comey o ricevette l'ordine di farlo. Ce n'è abbastanza, secondo
gli ambienti repubblicani, per rendere ancora più concreta l'ipotesi del
complotto anti-Trump, legando artificiosamente il suo nome alla Russia, prima
con l'indagine condotta dall'Fbi e poi con quella affidata al procuratore
speciale Robert Mueller. E tuttavia, al di là delle esasperazioni legate alla
attuale campagna presidenziale, una lettura attenta dei documenti e della
tempistica degli eventi dell'epoca, prima e dopo il 26 luglio 2016, data del
presunto 'via liberà della Clinton al piano anti-Trump, offre diversi spunti di
riflessione. Come fa notare l'Epoch Times, il 22 luglio 2016, Wikileaks rese
pubbliche migliaia di email del Democratic National Committee (Dmc), lo stato
maggiore dei Democratici Usa. Poco più di un mese prima, il Dnc aveva denunciato
l'hackeraggio dei suoi server da parte di pirati informatici russi. Il 25 luglio
del 2016, Jake Sullivan, uno dei principali consiglieri politici della campagna
di Hillary Clinton, parlò pubblicamente di possibili legami tra il candidato
repubblicano Donald Trump e la Russia. Lo stesso giorno, l'Fbi confermò di avere
aperto un'indagine sull'hackeraggio dei server del Dnc. Il 26 luglio, la Clinton
accettò la nomination democratica alla Presidenza. Lo stesso giorno, secondo
quanto lascerebbero intendere i documenti ora declassificati, la Clinton approvò
il piano contro la campagna di Trump. Sempre lo stesso giorno, l'ex agente
segreto britannico Christopher Steele, produsse una bozza del suo famoso
'dossier' anti Trump (che poi si scoprì essere stato finanziato dai
Democratici), nel quale si affermava anche l'esistenza di una vasta operazione
di hackeraggio da parte della Russia. Infine, sempre il 26 luglio del 2016, il
diplomatico australiano Alexander Downer informò il vice capo missione
dell'ambasciata Usa a LOndra di avere avuto una conversazione con un giovane
consulente della campagna di Trump, George Papadopoulos, nel quale questi lo
aveva informato che la Russia era in possesso di materiale «sporco» sulla
Clinton, sotto forma di migliaia di email hackerate. Secondo numerose
testimonianze e secondo quanto anche attestato dal rapporto sul Russiagate del
procuratore speciale Robert Mueller, che accorpò l'indagine dell'Fbi,
Papadopoulos ricevette a sua volta l'informazione dal misterioso professore
maltese Joseph Mifsud, dopo un incontro alla romana Link Campus University.
Mifsud, come è noto, è scomparso da anni. Per chiedere informazioni sul conto di
Mifsud, il ministro della Giustizia Usa William Barr e il procuratore John
Durham, al quale è stata affidata la contro-inchiesta sul Russiagate, nel 2019
volarono in due occasioni a Roma, per incontrare i vertici dell'intelligence
italiana, che hanno sempre smentito qualsiasi coinvolgimento nella vicenda.
Proseguendo con la cronologia, il 27 luglio 2016, Trump in una conferenza stampa
disse: «Russia, se stai ascoltando, spero che tu sia in grado di trovare le
30mila email mancanti». Il riferimento era alle email transitate sul server
privato di Hillary Clinton, all'epoca in cui era segretario di Stato,
misteriosamente scomparse o cancellate. Il giorno seguente, il 28 luglio,
l'avvocato dell'Fbi Lisa Page scrisse un sms al capo della sezione
controspionaggio Peter Strzok (col quale, emerse in seguito, aveva una
relazione): «Avete già aperto (un'indagine, ndr) su di lui?». Al messaggio, la
Page allegò un link a un articolo intitolato, «Trump e Putin. Sì, c'è veramente
qualcosa». Strzok rispose al messaggio: «Aperto su Trump? Se Hillary volesse,
sai che ci sarebbero 5 uffici pronti». Il 29 luglio del 2016, il direttore
dell'Fbi Comey, il vice direttore dell'Fbi Andrew McCabe e i vertici del Bureau,
fecero una riunione per discutere della “soffiata” ricevuta dal diplomatico
australiano Downer, oltre che di altre informazioni avute su due membri della
campagna di Trump, Carter Page e Paul Manafort. In seguito, McCabe riferì
all'ispettore generale del dipartimento di Giustizia, che condusse un'indagine
interna sulla gestione della vicenda Russiagate, che non ricordava di aver
partecipato a quella discussione. Il 30 luglio, l'ex agente britannico Steele,
ingaggiato per produrre il dossier anti Trump e informatore dell'Fbi, produsse
un memo nel quale sosteneva che da otto anni la Russia stava 'coltivandò Trump.
Inoltre, riferiva di un presunto timore del Cremlino riguardo alle conseguenze
dell'hackeraggio dei server del Democratic National Committee. Il 31 luglio,
Strzok in un'email segnalava l'apertura ufficiale di un'indagine sui presunti
legami tra la campagna Trump e la Russia. Nome dell'indagine, “Crossfire
Hurricane”. Elemento scatenante della stessa, la conversazione tra Papadopoulos
e Downer e il precedente contatto tra lo stesso Papadopoulos e Joseph Mifsud.
Troppo presto per trarre delle conclusioni, anche perché è lecito attendersi la
pubblicazione di altri documenti riservati, oltre alle conclusioni dell'indagine
affidata al procuratore Durham. “Colpi a sorpresa” che potrebbero essere svelati
in vista delle elezioni presidenziali di novembre, nelle quali Trump userà l’
«Obamagate, come egli stesso ha ribattezzato il Russiagate, per sostenere ancora
una volta la tesi di un complotto democratico ai suoi danni. Quel che è certo è
che la vicenda è tutt'altro che conclusa.
Russiagate,
i documenti declassificati nelle mani di Durham.
Roberto
Vivaldelli su Inside Over l'8 ottobre 2020. I documenti declassificati del
Russiagate sono finiti nelle mani di John Durham, il procuratore incaricato
dall’Attorney general William Barr di fare luce sul presunto complotto ai danni
del Presidente Usa Donald Trump nonché di esaminare la condotta delle agenzie
governative nelle fasi iniziali dell’indagine sulla collusione russa (mai
provata). Come riporta Axios, il direttore dell’intelligence nazionale Ratcliffe
ha approvato la pubblicazione di documenti da destinare al Dipartimento di
Giustizia e, in particolare, di un ampio fascicolo di mille pagine consegnato a
Durham, secondo una fonte con conoscenza diretta della vicenda. La stessa fonte
ha spiegato che Ratcliffe ha lavorato su questo lotto di documenti per diverse
settimane.
Fascicolo di
mille pagine consegnato Durham. Come ricorda Axios, gli alleati di Trump da
tempo sostengono che l’indagine di Durham si tradurrà nella formulazione di
accuse verso i massimi funzionari dell’amministrazione Obama. Ad oggi, Durham ha
emesso una sola dichiarazione di colpevolezza di un ex avvocato dell’Fbi, Kevin
Clinesmith, che ha ammesso di aver alterato un’e-mail utilizzata per ottenere un
mandato di sorveglianza sull’ex consigliere della campagna di Trump, Carter
Page. In risposta allo scoop di Axios, Ratcliffe ha confermato in una
dichiarazione: “Sotto la mia direzione, l’Ufficio del Direttore
dell’intelligence nazionale ha fornito quasi 1.000 pagine di materiali al
Dipartimento di giustizia in risposta alla richiesta di documenti del signor
Durham, incluso un nuovo lotto che gli avvocati del Dipartimento di Giustizia
possono ora visionare immediatamente”. “Continuerò a garantire la risposta della
comunità dei servizi segreti alle richieste del Doj” ha sottolineato Ratcliffe.
“Non vediamo l’ora di supportare il Doj in ulteriori declassificazioni coerenti
con le loro indagini”. “Come ha chiarito il presidente – ha rimarcato – dobbiamo
essere adeguatamente trasparenti con il popolo americano e dare loro la fiducia
che lo straordinario lavoro dei professionisti dell’intelligence non venga mai
usato impropriamente o politicizzato”.
Le ultime
rivelazioni sul Russiagate. Nelle scorse ore John Ratcliffe ha declassificato un
memo inviato nel 2016 dalla Cia all’allora direttore dell’Fbi James Comey, nel
quale si indicava che informazioni di intelligence suggerivano che la candidata
democratica alla presidenza Clinton aveva approvato un piano per collegare la
campagna di Trump all’hackeraggio del Democratic National Committee, di cui
venne accusata la Russia. La scorsa settimana, durante un’audizione davanti alla
commissione Giustizia del Senato, l’ex direttore dell’Fbi James Comey affermò di
non ricordare di aver ricevuto il documento. Insieme a lui, destinatario del
memo era anche il capo della sezione controspionaggio dell’Fbi Peter Strzok, che
guidò le indagini sull’uso di un server di posta elettronica personale da parte
di Hillary Clinton, all’epoca in cui era segretario di Stato. Le tre pagine del
documento sono state inviate da Ratcliffe ai presidenti e ai membri delle
commissioni Intelligence di Senato e Camera dei Rappresentanti. Insieme al memo,
sono state desecretate anche alcune note scritte dall’allora direttore della
Cia, John Brennan. Secondo le note declassificate, dunque, Brennan e la comunità
dell’intelligence statunitense sapevano mesi prima delle elezioni del 2016 che
le accuse collusione erano il risultato di un’operazione organizzata dalla
campagna di Hillary Clinton. Come già illustrato da InsideOver lo scorso 30
settembre John Ratcliffe, ha inviato una lettera al presidente della Commissione
Giustizia del Senato, Lindsey Graham, in merito ai nuovi documenti di
intelligence declassificati, secondo i quali Hillary Clinton, allora candidata
democratica alla presidenza, approvò personalmente uno sforzo “per suscitare uno
scandalo contro il candidato alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump
legandolo a Vladimir Putin e all’hackeraggio dei russi del Comitato nazionale
democratico”. Secondo i suoi appunti scritti a mano, l’ex direttore della Cia
John Brennan avrebbe successivamente informato il presidente Obama e altri alti
funzionari della sicurezza nazionale del piano della candidata dem, inclusa la
“presunta approvazione da parte di Hillary Clinton, il 26 luglio 2016, di una
proposta di uno dei suoi consiglieri di politica estera, per denigrare Trump
scatenando uno scandalo che denunciasse interferenze da parte dei servizi di
sicurezza russi”.
Durham, Barr e
quei viaggi in Italia. William Barr e John Durham non sono tornati a casa a mani
vuote dopo i due incontri con i vertici dei servizi segreti italiani del 15
agosto e 27 settembre 2019. Secondo quanto riportato dal Daily Beast, Barr e
Durham erano particolarmente interessati da ciò che i servizi segreti italiani
sapevano sul conto di Joseph Mifsud, il docente maltese al centro del
Russiagate, colui che per primo – secondo l’inchiesta del procuratore Mueller –
avrebbe rivelato a Papadopoulos l’esistenza delle mail compromettenti su Hillary
Clinton. Mifsud avrebbe fatto domanda di protezione alla polizia in Italia dopo
essere “scomparso” nel nulla. Nella deposizione audio del docente maltese che i
servizi italiani hanno fatto ascoltare ai procuratori americani, Mifsud
spiegherebbe il motivo per il quale “alcune persone” vorrebbero fargli del male.
Una fonte del ministero di Giustizia italiano, parlando a condizione di
anonimato, avrebbe confermato che Barr e Durham hanno ascoltato il nastro e ci
sarebbe stato uno scambio di informazioni fra i procuratori americani e
l’intelligence italiana. Secondo Fox News, infatti, l’indagine del procuratore
Durham “si è estesa” sulla base “delle prove raccolte durante un recente
viaggio a Roma con il procuratore generale William Barr”.
Il dossier Steele non era attendibile e i funzionari di Obama
lo sapevano. Roberto Vivaldelli il 12 giugno 2020 su
Inside Over. Nuovi documenti declassificati dal direttore dell’intelligence
nazionale John Ratcliffe e consegnati ai senatori Gop Chuck Grassley e Ron
Johnson dimostrano che all’inizio del 2017 la comunità d’intelligence e i
principali funzionai dell’amministrazione Obama sapevano che il screditato
dossier sulla presunta collusione fra la Campagna di Trump e la Russia,
realizzato dall’ex spia britannica Christopher Steele e finanziato da Fusion
Gps, Washington Free Beacon, dalla Campagna di Hillary Clinton e dal Comitato
nazionale democratico, non era attendibile. Ratcliffe ha diffuso l’allegato di
due pagine, aggiunto alle conclusioni di gennaio 2017 di Fbi, Cia e della
National Security Agency sulla presunta collusione russa dove è scritto nero su
bianco che le informazioni fornite da Steele al bureau erano confermate “in
maniera limitata”. Come riporta il Washington Examiner: “Una fonte dell’Fbi
[Steele] che utilizza fonti secondarie identificate e non identificate ha
offerto volontariamente informazioni altamente sensibili dal punto di vista
politico nell’estate del 2016 sugli sforzi della Russia nell’interferire nelle
elezioni presidenziali statunitensi”, si legge nell’allegato. “In questo caso
abbiamo solo una limitata conferma della segnalazione della fonte e non
l’abbiamo utilizzata per raggiungere le conclusioni analitiche della valutazione
di Cia, Fbi e Nsa”. Sebbene la relazione di Steele avesse “solo una conferma
limitata” e non fosse inclusa nel corpo principale dell’ICA, l’Intelligence
Community Assessment, è stata tuttavia inserita nell’allegato all’ICA stesso
declassificato da Ratcliffe. Come ha poi scoperto l’ispettore generale del
Dipartimento di Giustizia Michael Horowitz nella sua indagine, il rapporto
Steele fu allegato all’ICA per volontà “dei funzionari dell’Fbi” e su
particolare pressione dell’ex vicedirettore Andrew McCabe.
Lindsey Graham convoca al Congresso gli ex funzionari di Obama.
Il presidente del Comitato giudiziario del Senato Lindsey Graham, che ha il
compito di fare luce sulle origini del Russiagate e dell’inchiesta condotta dal
Procuratore speciale Robert Mueller, ora ha l’autorità di convocare a
testimoniare gli ex funzionari dell’amministrazione Obama. Sono circa una
cinquantina gli ex funzionari che Graham potrebbe convocare davanti al Comitato
giudiziario del Senato, tra cui l’ex direttore dell’Fbi James Comey, l’ex
direttore della Cia John Brennan e l’ex consigliere per la sicurezza nazionale,
Susan Rice. I democratici hanno chiesto a Graham di fare un passo indietro ma i
repubblicani si sono rifiutati di arretrare e hanno dichiarato che resta da
esaminare e verificare se le principali agenzie governative hanno
deliberatamente spiato e cospirato contro Donald Trump. Pochi giorni fa l’ex
vice procuratore generale Rod Rosenstein è stato il primo testimone a essere
sentito dal comitato giudiziario del Senato presieduto da Graham nell’ambito
dell’indagine sulle origini del Russiagate. Graham ha interrogato con insistenza
a Rosenstein sulla legittimità della nomina del procuratore speciale Robert
Mueller a capo dell’inchiesta, che non ha rilevato alcun collegamento tra la
squadra di Trump e le ingerenze russe sulla campagna elettorale. L’ex numero due
del dipartimento di Giustizia ha ammesso che non avrebbe firmato il mandato del
2017 per la sorveglianza Fisa dell’ex consigliere di Trump, Carter Page.”Non
credo che l’indagine sia stata corrotta, ma certo comprendo la frustrazione del
presidente alla luce del risultato, ovvero che non vi è alcuna prova di
cospirazione tra i consiglieri della campagna elettorale di Trump e i russi.
Indaghiamo su persone che non sono necessariamente colpevoli. E non ho mai
presunto che questa gente fosse colpevole di nulla”, ha affermato Rosenstein.
Quegli incontri a Roma fra l’Fbi e l’ex spia Steele. C’è un filo
diretto che collega l’inchiesta sulle origini del Russiagate a Roma. Come
ricordava La Stampa lo scorso febbraio, proprio a Roma, il 3 ottobre 2016, si
era svolto un incontro segreto e cruciale tra gli investigatori dell’Fbi e il
loro informatore britannico Christopher Steele, autore del famoso rapporto sulle
presunte relazioni pericolose fra Trump e il Cremlino. Un dossier che poi si è
rivelato essere in larga parte infondato e falso, come lo stesso ex membro
dell’agenzia di spionaggio per l’estero della Gran Bretagna ha ammesso in
seguito, finanziato peraltro da Fusion Gps, dal Comitato nazionale democratico,
dalla Campagna di Hillary Clinton e dal Washington Free Beacon. In buona
sostanza, dai nemici di Trump. L’inchiesta dell’Fbi sulle connessioni tra la
campagna di Trump e la Russia portò alla nomina del consigliere speciale Robert
Mueller, il quale ha prodotto il dossier conclusivo sull’inchiesta che
stabilisce che non c’è alcuna collusione fra Donald Trump e la Russia, come
dichiarato anche dal Procuratore generale William Barr. Steele, ricorda La
Stampa, dopo la carriera nell’intelligence, aveva successivamente fondato una
sua agenzia investigativa, la Orbis, e in tale veste aveva conosciuto Michael
Gaeta, assistente legale presso l’ambasciata degli Stati Uniti a Roma. Una volta
avviata l’inchiesta “Crossfire Hurricane”, l’Fbi aveva riaperto il canale con
Steele attraverso Gaeta. Quindi il 3 ottobre del 2016 Gaeta aveva invitato l’ex
agente dei servizi segreti a Roma, offrendogli 15.000 dollari per scambiare
informazioni con tre agenti impegnati nell’indagine su Trump. La conversazione
in un luogo segreto era durata circa tre ore, e Steele se era offerto anche di
mettere l’Fbi in contatto col manager dell’hotel di San Pietroburgo che aveva
visto Trump con le prostitute. Il tutto è contenuto nel rapporto su “Crossfire
Hurricane” che l’Inspector General del dipartimento alla Giustizia Michael
Horowitz ha pubblicato il 9 dicembre scorso, dalla pagina 108 alla pagina 115, e
ancora a pagina 386.
Ritirate le
accuse contro Flynn: così si sgonfia il Russiagate.
Dopo le recenti rivelazioni sulla cattiva condotta dell'Fbi, decadono tutte le
accuse contro il tenente generale Michael Flynn, ex consigliere per la sicurezza
nazionale di Trump. Fu una delle prime vittime del Russiagate. Roberto
Vivaldelli, Giovedì 07/05/2020 su Il Giornale. Come aveva
anticipato IlGiornale.it lo scorso 29 aprile, ora è ufficiale: decadono
ufficialmente tutte le accuse contro il tenente generale Michael T. Flynn,
consigliere per la sicurezza nazionale di Donald Trump dal 20 gennaio al 13
febbraio 2017, tra le prime "vittime" dell’inchiesta sul Russiagate. Secondo
quanto riportato dall'Associated Press, il Dipartimento di Giustizia ha
confermato poco fa che farà decadere tutte le accuse contro il primo consigliere
per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump. Nei documenti giudiziari
depositati stamani, il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che sta
abbandonando il procedimento giudiziario "dopo un'analisi ponderata di tutti i
fatti e le circostanze del caso, comprese le informazioni recentemente scoperte
e divulgate". Come riporta l'Adnkronos, il dipartimento di Giustizia ha detto di
non credere più di avere le prove a sostegno di accuse contro il generale. "Il
governo non è persuaso che l'interrogatorio del 24 gennaio 2017 fu condotto su
basi investigative legittime e quindi non crede che le dichiarazioni di Flynn
possano costituire una prova anche se fossero non vere - si legge nella mozione
-inoltre non crediamo che il governo possa neanche provare oltre ogni
ragionevole dubbio che vi siano state dichiarazioni false". Poco prima della
presentazione di questa mozione uno dei principali procuratori del caso, Brandon
Van Grack, che era stato uno dei collaboratori di Mueller, ha lasciato
all'improvviso e senza spiegazioni l'incarico. Il Dipartimento di Giustizia ha
affermato di aver concluso che l'interrogatorio di Flynn da parte dell'Fbi era
"ingiustificato" e che è stato condotto "senza alcuna legittima base
investigativa". Com’è emerso la scorsa settimana, il team legale del tenente
generale Michael T. Flynn ha chiesto alla Corte federale di rendere nota una
prova “decisiva” che dimostra la sua innocenza nonché la cattiva condotta degli
agenti dell’Fbi che lo interrogarono. Nello specifico, un giudice federale
statunitense ha desecretato documenti del Federal Bureau of Investigation (Fbi)
che dimostrano come l’ex consigliere di Trump sia stato vittima di un "piano
deliberato" del bureau allo scopo di incastrarlo. I documenti dissecretati
includono una nota scritta di Bill Priestap, allora direttore del
controspionaggio dell’Fbi, nel quale viene suggerita agli agenti dell’agenzia la
condotta da adottare negli interrogatori a carico del generale Flynn: "Quale
dovrebbe essere il nostro obiettivo? L’ammissione della verità, o spingerlo a
mentire, così da poterlo processare e/o farlo licenziare?", recita la nota. Come
illustrato da InsideOver, ora i repubblicani passano al contrattacco. Come rende
noto Fox News, i deputati Jim Jordan e Mike Johnson hanno chiesto che il
direttore dell’Fbi Christopher Wray fornisca al Congresso una serie di
informazioni dopo le rivelazioni su Flynn: in particolare, i repubblicani vicini
a Trump chiedono chiarimenti sul misterioso agente dell’Fbi, Joe Pientka, che
partecipò all’interrogatorio con l’ex consigliere per la sicurezza
nazionale. Fox News ha precedentemente stabilito che Pientka era altresì
coinvolto nell’indagine sull’ex collaboratore Trump, Carter Page. Oltre a
un’intervista a Pientka, i repubblicani hanno chiesto di parlare con Bill
Priestap, ex vicedirettore della divisione controspionaggio dell’Fbi. E nelle
ultime ore si è fatto sentire anche l'influente senatore Lindsey Graham, che
ospite di Sean Hannity ha dichiarato che le indagini del Procuratore generale
Robert Mueller "erano illegittime sin dall'inizio".
Stefano Graziosi per ''La Verità'' il 21 luglio 2020. La gioiosa
macchina da guerra del Russiagate perde altri pezzi. Venerdì scorso, la
commissione Giustizia del Senato ha pubblicato due documenti che minano in gran
parte alla base il cosiddetto «dossier Steele»: un fascicolo, redatto dall'ex
spia britannica Christopher Steele, che costituì a lungo un punto di riferimento
per chi considerava Donald Trump un burattino nelle mani del Cremlino. In
particolare, il dossier sosteneva che l'attuale presidente americano fosse sotto
ricatto da parte dei russi, a causa di alcune sue attività sessuali scabrose,
consumatesi nel 2013 in un hotel di lusso a Mosca. In secondo luogo, il dossier
venne più volte usato dall'Fbi come pezza d'appoggio per chiedere e ottenere
mandati di sorveglianza sul consigliere di Trump, Carter Page. Peccato che il
documento si sia dimostrato nel tempo largamente infondato e scarsamente
attendibile: soprattutto perché si scoprì che era stato finanziato dagli
avversari politici dell'allora candidato repubblicano (a partire da Hillary
Clinton). E adesso le nuove rivelazioni del Senato rischiano di picconarne
ulteriormente la credibilità. Vediamo la faccenda nel dettaglio. Il primo
documento, pubblicato venerdì, è un riassunto - lungo 57 pagine - di un
interrogatorio, condotto dall'Fbi nel gennaio 2017, di un'importante fonte dello
stesso Christopher Steele (rimasta tuttavia anonima). Secondo il testo, la fonte
dichiarò ai funzionari del Bureau che delle informazioni presenti nel dossier
non erano attendibili, aggiungendo di non aver mai riferito all'ex spia alcune
delle «notizie», riportate nel documento. Tra l'altro, si fa riferimento al
fatto che le principali fonti cui Steele si rivolse non avessero quasi mai
informazioni di prima mano. Ad essere affrontata, è anche la questione delle
attività sessuali scabrose con alcune prostitute che il dossier attribuiva a
Trump nell'hotel Ritz Carlton di Mosca. Sotto questo aspetto, la fonte ha
riportato che l'«attività sessuale non ortodossa» del futuro presidente al Ritz
era fondata su «voci e speculazioni» e che quindi «non era stato in grado di
confermare la storia». Lo stesso fatto che Trump sarebbe finito sotto ricatto
dei russi viene presentato «come una "conclusione logica", piuttosto che come un
resoconto». In tal senso, anche il secondo documento - diffuso venerdì - va
nella stessa direzione. Si tratta di alcune note, scritte dall'allora
(controverso) agente dell'Fbi, Peter Strzok, a margine di un articolo del New
York Times, pubblicato il 14 febbraio 2017 e dedicato a presunti collegamenti
del comitato elettorale di Trump con l'intelligence russa. Nel dettaglio, sono
due gli aspetti più rilevanti che emergono: nelle sue note, Strzok non metteva
solo in dubbio l'«affidabilità» di Steele ma, più in generale, la stessa
esistenza di una collusione tra il comitato di Trump e i servizi russi,
smentendo così seccamente alcune parti dell'articolo. «Non abbiamo visto prove
di individui affiliati al team di Trump in contatto con [funzionari
dell'intelligence russa]», si legge in una delle annotazioni. Del resto, che il
dossier di Steele fosse controverso e traballante era già stato sottolineato, a
dicembre scorso, dall'ispettore generale del Dipartimento di Giustizia, Michael
Horowitz, che - a pagina 413 del suo rapporto - scrisse: «[L'Fbi] ottenne
informazioni da una fonte di Steele nel gennaio 2017, che sollevarono
significative domande sull'affidabilità del resoconto di Steele, il quale venne
usato per chiedere i mandati per mettere sotto controllo Carter Page». Gli
agenti, proseguiva Horowitz, non hanno ciononostante informato della faccenda il
Dipartimento di Giustizia e la notizia venne omessa, quando fu chiesto il
rinnovo del mandato per sorvegliare Page. Lo stesso ex vicedirettore del Bureau,
Andrew McCabe, in audizione alla Camera nel dicembre del 2017, ammise in
riferimento al dossier: «Non siamo stati in grado di provare l'accuratezza di
tutte le informazioni». Insomma, se l'Fbi nutriva seri dubbi sul dossier di
Steele e la stessa fonte dell'ex spia aveva confermato la farraginosità del
documento, per quale ragione - anziché procedere a una sua radicale verifica -
il Bureau continuò a utilizzarlo per chiedere il rinnovo dei mandati di
sorveglianza su Carter Page, nel corso della primavera del 2017? Ma soprattutto
su quali basi e per quale ragione l'Fbi proseguì la sua inchiesta sul comitato
elettorale di Trump, visto che - al di là del dossier di Steele - non c'erano
prove, secondo gli stessi agenti, di collusione con il Cremlino?
“Vi dico come è nato il Russiagate”.
Matteo Carnieletto il 6 giugno 2020 su Inside Over. Simona
Mangiante ha 34 anni e, a partire dal 2016, si trova al centro del cosiddetto
Russiagate, ovvero l’inchiesta riguardante la presunta intromissione di Mosca
nelle elezioni che hanno portato all’elezione di Donald Trump. Lei afferma di
essere innocente, anche se per molti rappresenta un agente provocatore in grado
di scatenare una delle più incredibili storie di spionaggio degli ultimi anni.
Avvocato Mangiante, mi scuserà se quest’intervista Le sembrerà
troppo simile a un interrogatorio, ma dovrà ammettere che, quella in cui si è
venuta a trovare, è davvero una vicenda particolare. Con il suo aiuto, mi
piacerebbe ripercorrerla. Da dove vuole partire?
«Dal mio interrogatorio con l’Fbi.
Ho parlato con due agenti che hanno cominciato a pormi domande sul mio passato,
con domande piuttosto retoriche, alcune anche tendenziose, per costruire una
storia di spionaggio. Sono diventata l’obiettivo di accuse di spionaggio…»
Che tipo di domande le hanno fatto?
«Mi hanno chiesto se avessi altri
passaporti, se fossi stata adottata, se i miei genitori fossero di nazionalità
russa e se parlassi il russo».
E poi cosa è successo?
«Queste domande mi sembravano al
limite tra la cinematografia e la realtà. Ad alcune ho reagito con una sana
risata, come quando mi hanno detto che avevo un accento russo. Parlo cinque
lingue, ma…»
Tra queste c’è anche il russo?
«No, è una di quelle lingue che non
parlo affatto. Ma dicevo: il livello di domande era molto grossolano, fino a
quando siamo arrivati a Mifsud. È a questo punto che capisco che lui è una
persona legata al Russiagate. George mi aveva detto che aveva lavorato con lui
al London center, tra l’altro prima che ci andassi a lavorare anche io. Non
avevo minimamente l’idea che il professore citato nell’accusa di George fosse
lui».
Nelle carte, diceva, si parlava inizialmente di un generico
professore…
«Sì, anzi. Non si parlava di un
generico professore, ma di un “overseas professor”, indicato come agente russo…»
A questo punto scopre il nome di Mifsud…
«Sì e gli agenti mi chiedono se
l’avessi mai conosciuto. Io rispondo di sì, di averlo conosciuto anni fa, in un
contesto molto diverso, il circuito dei socialisti, tramite Gianni Pittella. A
questo punto divento l’unico persona sul suolo americano che conosce il
cosiddetto “comodo sconosciuto” che tutti possono dipingere come gli pare.
Pensavo di rendere un favore all’Fbi, ma hanno iniziato a vedermi con sospetto…»
E così è diventata la Mata Hari d’America…
«Sono diventata un elemento scomodo
ma importante perché ero la fidanzata del “paziente zero” del Russiagate».
Cosa succede poi?
«Si scatena un effetto domino. Vengo
convocata due volte. La prima al congresso, davanti a Nancy Pelosi, e poi al
Senato. Al Congresso si parla di Mifsud per ore e io faccio presenti le sue
connessioni. Nulla è stato contraddetto delle mie testimonianze. È però iniziato
il contrattacco mediatico dei democratici e divento io la spia russa».
E questo è quello che è successo una volta scoppiato il caso
Russiagate. Ma facciamo un passo indietro: come ha conosciuto Mifsud?
«L’ho conosciuto nel 2010, o forse
era il 2011, ad un convegno organizzato da Gianni Pittella all’Europarlamento.
Mi è stato presentato come professore che aveva grandi contatti con il mondo
politico, in particolare con i socialisti…»
Chi gliel’ha presentato?
«Gianni Pittella».
Direttamente lui?
«Sì sì. Tra l’altro me l’ha
presentato come una persona a lui vicina. Questo non significa che Pittella
c’entri qualcosa con Mifsud nella vicenda americana, ma è un dato di fatto che
conferma le connessioni del professore con i socialisti e non con quel mondo che
aveva interessi a far eleggere Trump. L’ho incontrato più volte al Parlamento
europeo, dove portava gli studenti da Londra. Ma Mifsud è venuto anche in
Italia: ha partecipato alla campagna elettorale di Pittella e alla Link Campus».
Da Bruxelles a Londra, per lavorare al London Center di
Mifsud.
«È stata un’esperienza breve – tre
mesi – dove ho ricoperto il ruolo di direttrice di relazioni diplomatiche
internazionali. Inizialmente pensavo di focalizzare il mio lavoro sulla
legislazione europea e sulla regolamentazione europea che poteva interessare i
clienti, ma non se n’è mai visto uno. Era una struttura disorganizzata in cui
orbitavano persone che avevano più o meno il mio profilo che si sedevano attorno
a un tavolo e si cimentavano in un progetto diverso. Io a quel punto non avevo
chiaro cosa facessero. Mi hanno proposto dei meeting in Medio Oriente, ma era
tutto disorganizzato».
Quando si è insospettita?
«Quando Nagi Idris mi ha fatto
conoscere un attivista dei diritti iracheno e mi invita ad un meeting segreto in
Libano, dove decido di non andare. In quella missione nessuno sapeva cosa andava
a fare né chi fossero i partecipanti per una questione di sicurezza
internazionale».
Come mai hai deciso di non andare?
«Perché mi sembrava estremamente
sospetta. Ho lavorato nel mondo diplomatico per sette anni e non esistono
simposi dove non devi sapere chi non partecipa. A meno che non ci siano
organizzazioni terroristiche o situazioni di estrema pericolosità».
Qual era il ruolo di Mifsud al London center?
«Mifsud era il co-direttore del
London center. Era anche il presidente della London academy. Ma io poco dopo ho
deciso di lasciare e di tornare a fare l’avvocato. Ricordo che c’è una in cui
prendo le distanze dal London center e chiedo a Mifsud di cancellare il mio nome
dal loro sito perché non volevo essere associata ad alcuna delle loro pratiche».
Ha conservato questa mail?
«L’ho inoltrata al Congresso e
all’Fbi».
Gianni Pittella: come l’hai conosciuto?
«È un caro amico di mio padre, che
ho conosciuto da ragazzina. Non è un personaggio chiave del Russiagate perché
non ha alcun coinvolgimento in questa storia. È stato una delle persone vicine a
Mifsud per anni».
Qual erano i rapporti tra loro due?
«Era un rapporto di stima reciproca.
Mifsud partecipava a diversi eventi organizzati da Gianni Pittella. Il
professore era una persone che orbitava nei circuiti socialisti, Pittella è una
figura di rilievo di questi circuiti. È quindi normale che si conoscessero».
Secondo lei, i legami tra Mifsud e il governo italiano
dell’epoca – ovvero Renzi – sarebbero stati più intensi di quanto potremmo mai
immaginare.
«Dicevo che Mifsud era molto vicino
al governo italiano nell’epoca in cui Renzi era il primo ministro. Anche perché
il professore era un sostenitore di Renzi».
Ma come fa a dire una cosa simile senza alcuna prova?
«Io ho parlato di governo italiano e
mi pare ovvio. Sappiamo che Mifsud ha vissuto a Roma per molto tempo in una casa
pagata dalla Link e sappiamo che è stato nascosto dall’Italia. Sono deduzioni,
le mie. Non ho mai fatto altro che fornire i fatti e Mifsud era legato a
personalità politiche italiane».
Chi sono?
«Pittella e Vincenzo Scotti, per
esempio. E in Gran Bretagna a Boris Johnson. Era molto legato al mondo politico
occidentale».
A proposito di Mifsud. Che fine ha fatto?
«È un grosso mistero. In nessuna
circostanza una persona scompare come ha fatto lui. C’è sicuramente qualcosa di
losco, ma so che Mifsud è stato recentemente localizzato in Umbria e questo mi
fa pensare che sia vivo e vegeto in Italia».
Come ha conosciuto George Papadopoulos?
«Abbiamo cominciato a parlare quando
ho iniziato a lavorare per il London Center. Mi ha contattata via Linkedin
dicendomi: “Ah, vedo che lavori anche tu per il London center” e così abbiamo
iniziato a sentirci. All’epoca lavorava per la campagna di Trump e prima di
incontrarci a New York, a fine marzo 2017, sono passati un po’ di mesi.
E lui come ha incontrato Mifsud?
«A Roma durante un viaggio alla Link
con Nagi Idris. All’epoca è stato presentato da Vincenzo Scotti. Mifsud sembrava
molto interessato al suo lavoro per la campagna di Trump e il resto è storia».
Papadopoulos incontra Scotti a marzo 2016. Voi vi siete visti
per la prima volta a New York nel 2017. Ti ha mai parlato di quell’incontro? Ti
ha mai detto che gli era stato fatto avere del materiale sensibile su Hillary?
«Mi ha parlato di Mifsud come di un
personaggio strano e mi chiedeva cosa pensassi di lui. Non mi ha mai parlato di
lui come di una persona che gli aveva offerto del materiale sulla Clinton ma di
una persona, un millantatore, che si era presentato come una persona connessa al
governo russo ma che in realtà non gli aveva neanche presentato l’ambasciatore
russo a Londra».
Cosa crede che sia venuto a fare Barr in Italia?
«È venuto a cercare di capire quale
fosse il motivo per cui l’Italia non sta dando informazioni su Mifsud. È
un’ulteriore prova che l’Italia può esser coinvolta, se non nel Russiagate,
nella scomparsa di Mifsud».
Il procuratore John Durham sta lavorando all’indagine penale
sulle origini del Russiagate. Lei o suo marito ci avete mai parlato?
«No, mai».
Ma non le sembra inverosimile che tutto questo sia stato
pensato solo per attaccare Trump?
«Io ora mi farò attaccare, ma credo
che tutte queste operazioni rappresentano la delegittimazione della democrazia e
della presidenza americana. Ci si attacca a tutto per delegittimare Trump. Anche
il coronavirus è stato usato per attaccare il presidente americano, che è una
delle persone più odiate al mondo. Nessuno parla dei risultati della sua
amministrazione. Il russiagate è una delle più grandi bufale della storia».
Vedremo…
Ha collaborato Roberto Vivaldelli
“Durham pronto con le accuse. E quei viaggi in Italia…”
Mauro Indelicato, Roberto Vivaldelli il 19 agosto 2020 su Inside Over. Il
professor Joseph Mifsud era in Italia dal 2017 al 2019, secondo le prove e le
dichiarazioni delle persone coinvolte. Nello stesso periodo viaggiava
liberamente in Europa. Ora però non sappiamo dove sia”. A parlare
con InsideOver è l’avvocato svizzero-tedesco del docente maltese al centro del
Russiagate, Stephan Claus Roh, nato in Germania e residente a Monaco, con studi
a Zurigo, Londra Hong Kong e Berlino ed esperto fiscalista. Com’è noto,
l’attenzione del Procuratore americano che indaga sulle origini del Russiagate,
John Durham, e dell’Attorney General William Barr si focalizza sull’opaca
condotta dell’Fbi e del Dipartimento di Giustizia e sul sospetto che le agenzie
federali abbiano abusato dei loro poteri e agito in maniera illegittima nei
confronti della campagna di Trump del 2016 allo scopo di “sabotare” l’elezione
del tycoon in (probabile) collaborazione con i servizi segreti stranieri
(Australia, Italia, Regno Unito). Secondo i repubblicani, infatti, le indagini
sulla presunta collusione fra la Campagna di Trump e la Russia erano solo
pretesto “per aprire una massiccia operazione di spionaggio” sul candidato
repubblicano alle elezioni presidenziali del 2016. Secondo gli inquirenti
americani, Joseph Mifsud potrebbe aver avuto un ruolo chiave in questa
incredibile spy story internazionale. Secondo la ricostruzione ufficiale,
infatti, il docente affermò in un incontro dell’aprile 2016 a George
Papadopoulos, consigliere della campagna di Trump, di aver appreso che il
governo russo possedeva “materiale compromettente” (dirt) su Hillary Clinton “in
forma di e-mail”. Papadopoulos avrebbe ripetuto tali informazioni all’Alto
Commissario australiano a Londra, Alexander Downer, che a sua volte riferì tutto
alle autorità americane. Da qui, il 31 luglio 2016, partirono le indagini
dell’Fbi sui presunti collegamenti fra Trump e la Russia, accuse che in
seguito si sono dimostrate false. È dal 31 ottobre 2017 che del professore
Joseph Mifsud non si ha ufficialmente traccia. Come ha successivamente stabilito
un’inchiesta della Verità, il misterioso docente maltese della Link è rimasto
nascosto per qualche mese ad Esanatoglia, nelle Marche, ospite di Alessandro
Zampini, compagno di Vanna Fadini (Gem), società che gestisce tutti i servizi e
paga gli stipendi ai dipendenti dell’Università capitolina. “L’ultimo contatto
diretto con il Professor Mifsud lo abbiamo avuto alla fine del 2018.
Indirettamente lo abbiamo sentito fino all’inizio del 2019” ci racconta Stephan
Roh. Secondo le ultime ricostruzioni dei media americani, John Durham potrebbe
completare la sua indagine penale entro la fine dell’estate. Roh concorda con
questa tesi: “Crediamo che il Procuratore John Durham abbia in archivio gli
elementi necessari per presentare le accuse”. Bisogna tenere presente però che
“il sistema giudiziario americano è complesso e, a meno che il signor Durham non
abbia già raccolto confessioni o accordi, dovrà valutare attentamente se questo
caso che ha un grande impatto politico sia abbastanza forte da reggere dinanzi a
una giuria (forse influenzata) e quando avrà diritto di procedere formalmente
alla luce delle regole elettorali statunitensi”. Lo stesso avvocato di Mifsud è
stato più volte sentito da Durham: “Ho avuto lunghe discussioni con il signor
Durham e ho posto delle domande, ma mi ha solo detto che gli sono piaciuti i
suoi viaggi in Italia, il che è certamente un buon segno”. Il completamento
dell’indagine di Durham potrebbe avvenire in una fase molto delicata per la
politica Usa. Si avvicinano infatti le elezioni presidenziali, le stesse dove
Trump correrà per la riconferma e dove le ombre del Russiagate del 2016 non si
sono mai del tutto diradate. A tal proposito l’avvocato Roh, in merito una
possibile influenza della spy story internazionale sulle prossime consultazioni,
sembra per il momento non volersi sbilanciare molto: “Non so se questa vicenda
avrà ripercussioni sul voto”, ha risposto il legale di Mifsud. Quest’ultimo
intanto continua ad essere cercato anche nel nostro Paese e non solo per gli
strascichi di quanto avvenuto nel corso della campagna presidenziale Usa del
2016. Come si sa, il professore maltese è indagato dalla procura
di Agrigento per presunte “spese folli” attuate durante il suo periodo passato
al timone del consorzio universitario della città siciliana. Una vicenda
risalente a quasi un decennio fa, visto che Mifsud è stato presidente dell’ente
universitario dal 2009 al 2013. In quegli anni, secondo le accuse mosse dagli
inquirenti agrigentini partite dagli esposti di alcuni ex componenti del Cda
dello stesso consorzio, il professore avrebbe usato denaro pubblico per proprie
esigenze private oppure per finanziari viaggi solo ufficialmente istituzionali.
Una vicenda su cui si sta cercando di fare luce, ma in cui sono sorte non poche
difficoltà delle indagini proprio perché Mifsud al momento è introvabile. Anzi,
nello scorso mese di dicembre una fonte vicina alla procura di Agrigento ha
dichiarato ad InsideOver che, tra le stanze del tribunale siciliano, l’idea è
che il professore maltese difficilmente in futuro potrà essere ascoltato:
“All’80% Mifsud è morto – è stato il commento raccolto a dicembre dal palazzo di
giustizia agrigentino – Non si hanno sue notizie da anni”. Sull’inchiesta che
coinvolge il principale protagonista della spy story in Sicilia l’avvocato Roh
al momento non sembra avere novità: “Rispetto a quanto trapelato nei mesi scorsi
– ha aggiunto il legale – Non sono in possesso di ulteriori elementi”.
Un’indagine, quella agrigentina, che appare come un piccolo tassello capace però
di aggiungere un altro importante indizio in una delle trame giudiziarie più
clamorose che hanno interessato il nostro Paese negli ultimi anni.
1. DAGONOTA il 20 agosto 2020. La Casa Bianca sta valutando cosa
conviene che il ministro della Giustizia Barr faccia in base a sondaggi mirati e
riservati che si stanno eseguendo a pioggia. Il report del Senato ha comunque
irritato Trump.
Luca Fazzo per “il Giornale” il 20 agosto 2020. Una spia russa
attiva per anni a Roma, sotto il naso dei nostri servizi segreti: anzi,
addirittura nel cuore dell'Università che della nostra intelligence era il cuore
accademico e di relazioni, la Link Campus dell'ex ministro dell'Interno Vincenzo
Scotti. Il nome della spia: Joseph Mifsud, il professore maltese che dell'ateneo
romano era docente e socio, svanito nel nulla proprio a Roma e invano cercato
dalla Fbi in mezzo mondo. Personaggio ambiguo, inafferrabile (in tutti i sensi),
finora sospettato di essere stato in qualche modo al servizio della Cia
dell'epoca di Barack Obama, e di avere collaborato con le manovre per bloccare
l'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca nel 2016. E che ora invece vede il
proprio ruolo interpretato in maniera diametralmente opposta. Mifsud in quegli
anni avrebbe lavorato per il Gru, il servizio segreto del Cremlino. Una svolta
che costringe a rileggere in toto la parte italiana del Russiagate. Ma anche a
chiedersi come sia stato possibile che il controspionaggio italiano, affidato
all'Aisi, non si sia accorto che proprio alla Link, nelle stesse aule dove
dirigenti delle nostre forze di polizia e di intelligence tenevano corsi e
conferenze, si muoveva - e a volte sedeva accanto a loro sul palco dei relatori
- una spia al soldo di un paese straniero. A lanciare la nuova pista è una fonte
autorevole e ben documentata. A Mifsud è dedicato un ampio capitolo nel quinto
volume, reso disponibile online nei giorni scorsi, della monumentale relazione
conclusiva della commissione Intelligence del Senato statunitense sulle manovre
che la Russia avrebbe messo in atto per condizionare la corsa alla Casa Bianca
di cinque anni fa. La commissione bipartisan ha concluso i suoi tre anni di
indagini affermando di avere trovato «prove irrefutabili» delle operazioni russe
per inquinare la campagna elettorale ma ha altrettanto nettamente concluso
«senza alcuna esitazione» di non avere trovato alcuna prova di una collusione
tra Trump e i russi per condizionare l'esito del voto. Ma le manovre ci furono,
dice la commissione. Ed è qui che appare Mifsud. Perché il professore maltese è
il contatto diretto di George Papadopoulos, collaboratore della campagna
elettorale di Trump, cui la relazione dedica ben sessanta pagine (da 464 a 524)
del suo quinto e ultimo volume. Papadopoulos accusa da sempre Mifsud di avergli
teso una trappola proponendogli delle mail di Hillary Clinton che in apparenza
compromettevano la rivale di Trump, ma erano destinate in realtà a ritorcersi
contro il candidato repubblicano, che sarebbe stato accusato di utilizzare
materiale proveniente da Mosca. Papadopoulos sostiene che in questa operazione
Mifsud aveva avuto la collaborazione dei servizi segreti italiani, decisi, con
l'allora premier Matteo Renzi, ad aiutare gli amici della Cia vicini al
presidente uscente Barack Obama. Ora la commissione guidata dal repubblicano
Rubio e dal democratico Warner riscrive la storia. A pagina 465 del volume, si
afferma come i rapporti di Papadopoulos con Mifsud fossero altamente sospetti e
che Mifsud mostrava capacità e metodi da agente segreto, e non si mostrano dubbi
sui suoi datori di lavoro: «Mifsud era al corrente di aspetti della campagna
russa sulle elezioni del 2016» e le date delle sue rivelazioni a Papadoupolos
sulle mail di Hillary coincidono con le incursioni informatiche del Gru nei
server del comitato nazionale democratico, «molte settimane prima che qualunque
informazione venisse resa pubblica. Inoltre le sue informazioni coincidevano con
il progetto del Gru di danneggiare la candidatura di Hillary Clinton». Ma ora
dove è finita la spia venuta dal freddo?
Così è caduta anche l'ultima bugia sul Russiagate.
Secondo gli avvocati dell'ex consigliere per la sicurezza nazionale di Trump,
presto verranno rese note delle prove che potrebberlo scaglionarlo da ogni
accusa. Fu accusato di aver mentito circa i suoi rapporti con Mosca nel 2017.
Roberto Vivaldelli, Mercoledì 29/04/2020 su Il Giornale. Flynn, consigliere per
la sicurezza nazionale di Donald Trump dal 20 gennaio al 13 febbraio 2017, tra
le prime “vittime” dell’inchiesta sul Russiagate. Il presidente Donald Trump ha
condiviso un post su Twitter in cui si dice che il suo ex consigliere per la
sicurezza nazionale sarà "scagionato questa settimana" da ogni accusa. Flynn, 61
anni, accusato di aver mentito alle autorità circa i suoi rapporti con Mosca, ha
intrapreso una battaglia legale per chiedere l'archiviazione del caso e, stando
a quanto emerso negli ultimi giorni, il suo team legale avrebbe presentato alla
Corte una prova "decisiva" che dimostrerebbe la sua innocenza nonché la cattiva
condotta degli agenti dell'Fbi che lo interrogarono. Tale prova rimane per ora
"top secret" ma il deputato repubblicano Devin Nunes, intervistato dalla
conduttrice Fox Maria Bartiromo, ha svelato che il tenente generale
dell'esercito sarà completamente scagionato entro una settimana da tutte le
accuse a suo carico. Secondo il commentatore di Fox News Gregg Jarrett, Michael
Flynn è vittima di uno dei peggiori abusi giudiziari nei tempi moderni: "un uomo
innocente che è stato ingiustamente preso di mira dall'Fbi, perseguito
ingiustamente dal consigliere speciale Robert Mueller e costretto a dichiararsi
colpevole" scrive. La verità, prosegue, è che il tenente generale dell'esercito
in pensione "non ha mai fatto nulla di male" e "non ha commesso crimini". È
stato raggirato "da funzionari senza scrupoli dell'Fbi", quindi "perseguito
incessantemente dalla squadra di procuratori eccessivamente zelanti di Mueller
che erano disperati nel tentare di dimostrare che il presidente Trump e la sua
campagna fossero collusi con la Russia per vincere le elezioni presidenziali del
2016". Una cospirazione che, ovviamente, non è mai esistita. La tesi
dell'avvocato di Flynn, l’avvocato Sidney Powell, è chiara: sostiene che l’Fbi
abbia "manipolato" i verbali del suo interrogatorio del 2017, durante il quale
l'ex consigliere per la sicurezza nazionale si sarebbe dichiarato di colpevole
di aver mentito ai federali. In una mozione di 27 pagine, Powell chiede al
tribunale che esamina il caso di "respingere l’intera accusa" per "l’oltraggiosa
cattiva condotta del governo” e degli agenti del Bureau che hanno manipolato le
dichiarazioni di Flynn sui suoi rapporti e contatti con l’ambasciatore
russo Sergey Kislyak. Uno degli agenti dell’Fbi che condusse l’interrogatorio a
Flynn fu peraltro Peter Strzok, licenziato quando la squadra investigativa del
Consigliere speciale Robert Mueller scoprì gli sms denigratori contro il
Presidente Trump che l’agente federale scambiava con la sua collega e amante
Lisa Page. Secondo l’avvocato dell’ex consigliere per la sicurezza nazionale di
Trump, Strzok condusse l’interrogatorio in maniera tale da portare Michael T.
Flynn a mentire. "Un comportamento scioccante" ha spiegato Powell.
"La Russia dietro l'elezione di Trump nel 2016": le
conclusioni dell'inchiesta del Senato Usa. Pubblicato
martedì, 18 agosto 2020 su La Repubblica.it da Albereto Flores D’Arcais. Nel
2016 la Russia ha condotto un'aggressiva campagna per influenzare le elezioni
presidenziali e favorire l'arrivo di Donald Trump alla Casa Bianca. È questa la
conclusione a cui è giunta la commissione sull'intelligence del Senato Usa, a
guida repubblicana, nel rapporto finale sull'inchiesta durata tre anni e mezzo.
Si tratta del quinto e ultimo rapporto sull'interferenza elettorale di Mosca. Il
rapporto non fornisce abbastanza prove per decidere se il comitato elettorale di
Trump fosse consapevole di queste influenze. Ma stabilisce che le manovre russe
ci sono state oltre ogni ragionevole dubbio. La giuria del Senato ha descritto
il rapporto di oltre 1.300 pagine, come "la descrizione più completa fino ad
oggi delle attività della Russia e della minaccia che rappresentavano''. Un
gruppo di repubblicani ha presentato "punti di vista aggiuntivi'' al rapporto
affermando che dovrebbe essere più esplicito nel sottolineare che la campagna di
Trump non fosse a conoscenza dell'attività russa cosa, i democratici sostengono
il contrario. Il rapporto mostra ampie prove di contatti tra i collaboratori di
Trump e persone legate al Cremlino, compreso l'allora capo della campagna Paul
Manafort e Konstantin Kilimnik, identificato per la prima volta come un agente
segreto russo che potrebbe essere stato legato alle interferenze gestite
dall'intelligence militare di Mosca. Nel rapporto Mueller, Kilimnik era indicato
come una persona in contatto con gli 007 russi. Lo scorso anno Robert Mueller,
l'ex procuratore speciale alla guida dell'indagine Russiagate, aveva pubblicato
un rapporto in cui sosteneva che Mosca avesse interferito nelle elezioni
attraverso i social media aggiungendo che la campagna di Trump ne avesse
beneficiato consapevolmente. Mueller non aveva accusato nessuno di cospirazione
con i russi. Durante la sua testimonianza nel luglio 2019davanti alle
commissioni Giustizia e intelligence della Camera, aveva spiegato che il
presidente ha sempre rifiutato di farsi interrogare dal suo team ma anche che le
indagini non sono mai state limitate o ostacolate. L'audizione allora era stata
chiesta dai democratici per fare chiarezza sugli aspetti considerati irrisolti
del rapporto sull'inchiesta. Mueller aveva risposto per tre ore alle domande
dei membri della commissione Giustizia e per altre due ore a quelle della
commissione Intelligence della Camera. Dalle ultime indagini del Senato emerge
adesso anche che la campagna di Trump suggerì al consigliere informale e vecchio
amico di Trump, Roger Stone, di ottenere informazioni sul materiale
compromettente di WikiLeaks su Hillary Clinton e il partito democratico. La pena
di Stone è già stata commutata dal presidente.
Così i
funzionari di Obama hanno incastrato Flynn.
Roberto
Vivaldelli su Inside Over the world il 12 maggio 2020. Il direttore generale
dell’intelligence nazionale Richard Grenell ha declassificato alcuni file
riguardanti ex funzionari dell’amministrazione Obama che sarebbero coinvolti nel
cosiddetto “complotto” ai danni dell’ex consigliere per la sicurezza nazionale
di Donald Trump, Michael T. Flynn, incastrato dall’Fbi per dei presunti legami
con il Cremlino (fu, infatti, la prima grande vittima dell’inchiesta sul
Russiagate). Lo riporta Abc News. Grenell, che rimane l’ambasciatore degli
Stati Uniti in Germania, oltre ad aver assunto il ruolo di capo
dell’intelligence, è stato visto la scorsa settimana nella sede del Dipartimento
di Giustizia, nello stesso momento in cui l’Attorney general William Barr ha
deciso di archiviare il caso Flynn e di far cadere tutte le accuse contro il
generale.
“Così Obama e
i suoi funzionari hanno tentato di incastrare Trump”. Nel frattempo, il
Presidente Donald Trump ha lanciato una serie di tweet a raffica contro il suo
predecessore, Barack Obama, facendo diventare virale la parola chiave
#Obamagate, sostenendo che il suo è stato “il più grande crimine politico della
storia americana fino ad oggi”. Trump ha aggiunto, attraverso un retweet di Buck
Sexton che Obama “ha usato le sue ultime settimane in carica per sabotare la
nuova amministrazione”. Nel frattempo, anche i media conservatori si scagliano
contro l’ex presidente. Sean Hannity ha aperto il suo programma televisivo
su Fox News proprio sull’Obamagate, criticando duramente l’ex presidente e la
sua amministrazione per come sono state condotte le indagini sul Russiagate e su
Michael Flynn.”Molti funzionari attuali ed ex hanno motivo di essere
preoccupati” ha sottolineato Hannity. “Le mie fonti [mi] stanno raccontando
stasera che alcuni di loro si sono già presi i più costosi avvocati di
Washington, Dc”, ha aggiunto. “Forse sanno cosa sta per succedere. Forse è per
questo che quasi 2000 ex impiegati del Doj hanno firmato una lettera contro Barr
per aver fatto cadere le accuse contro Flynn. Il tempismo è sospetto, non
credete?”. Secondo Mollie Hemingway, ospite di The Ingraham Angle, le ultime
rivelazioni sul caso Flynn dimostrano che l’ex presidente Barack Obama ha
cercato di utilizzare le indagini sul Russiagate per sabotare l’amministrazione
Trump. Nel mirino dei repubblicani c’è l’incontro del 5 gennaio 2017 a cui hanno
partecipato Obama, l’allora vicepresidente Joe Biden, l’ex direttore dell’Fbi
James Comey, l’allora capo della Cia John Brennan e l’ex direttore
dell’intelligence nazionale James Clapper.
Rudy Giuliani:
“Una cospirazione orchestrata da Brennan e Comey”. In un’intervista rilasciata a
una radio di New York, l’ex sindaco della Grande Mela Rudy Giuliani, consulente
legale personale del presidente Donald Trump, ha parlato della decisione del
Dipartimento di Giustizia di far cadere le accuse contro l’ex consigliere per la
sicurezza nazionale, Michael Flynn. Secondo Giuliani, l’ex direttore della Cia
John Brennan e l’ex capo dell’Fbi James Comey, fautori del “golpe” contro Donald
Trump, potrebbero essere incriminati per “alto tradimento”. “Penso che Brennan
abbia gestito questa dannata cosa” ha detto Giuliani. “Penso che Brennan abbia
gestito la parte riguardante Papadopoulos-Carter Page perché si tratta di un
piano di controspionaggio molto elaborato”. Come scrive il New York Post,
il RussiaGate ora è lettera morta, e l’ObamaGate sta prendendo il suo posto.
“Fino a che punto l’allora presidente cercò di sabotare il suo successore?” si
chiede la testata americana. Ora è chiaro, prosegue il New York Post, “che l’Fbi
di Obama-Comey e il Dipartimento di Giustizia non hanno mai avuto nulla di più
sostanzioso della finzione ridicola del dossier Steele per giustificare
l’indagine di controspionaggio su campagna di Trump”.
Così si sono
cadute le accuse contro Flynn. Il Dipartimento di Giustizia ha affermato di aver
concluso che l’interrogatorio di Flynn da parte dell’Fbi era “ingiustificato” e
che è stato condotto “senza alcuna legittima base investigativa”. Com’è emerso
la scorsa settimana, il team legale del tenente generale Michael T. Flynn ha
chiesto alla Corte federale di rendere nota una prova “decisiva” che dimostra la
sua innocenza nonché la cattiva condotta degli agenti dell’Fbi che lo
interrogarono. Nello specifico, un giudice federale statunitense ha desecretato
documenti del Federal Bureau of Investigation (Fbi) che dimostrano come l’ex
consigliere di Trump sia stato vittima di un “piano deliberato” del bureau allo
scopo di incastrarlo. I documenti dissecretati includono una nota scritta di
Bill Priestap, allora direttore del controspionaggio dell’Fbi, nel quale viene
suggerita agli agenti dell’agenzia la condotta da adottare negli interrogatori a
carico del generale Flynn: “Quale dovrebbe essere il nostro obiettivo?
L’ammissione della verità, o spingerlo a mentire, così da poterlo processare e/o
farlo licenziare?”, recita la nota.
Gianluca Borrelli per termometropolitico.it il 15 maggio 2020.
Obamagate: ecco di cosa si tratta. In questi ultimi giorni sta impazzando sui
social il tema dell’Obamagate: pochi però sembrano aver compreso cosa stia
succedendo esattamente. Questo termine è diventato virale da quando lo ha
twittato Trump, ma perché Trump lo ha scritto proprio ora? Cos’è cambiato negli
ultimi giorni? E che c’entrano Renzi e l’Italia? Obamagate: sicuri di aver
capito di cosa si tratta?
La notizia degli ultimi giorni è la pubblicazione delle
trascrizioni degli interrogatori fatti tra il 2017 e il 2018 dall'“intelligence
oversight committee” (sostanzialmente la commissione di controllo dei servizi
segreti). In questi atti si fa riferimento a un coinvolgimento diretto di Barack
Obama relativamente al caso delle indagini sul generale Michael Flynn in
predicato di entrare nella amministrazione Trump in qualità di DNI (Director of
National Intelligence). Questi atti erano secretati e non si era mai riusciti a
renderli pubblici per via di molte ostruzioni da parte di alcuni importanti
personaggi, qualcuno di essi persino nominato da Trump. In particolare quello
che negli ultimi tempi aveva cercato più di tutti di evitare queste
pubblicazioni è stato Christopher Wray (repubblicano), capo dell’FBI, nominato
nel 2017 da Trump per sostituire James Comey (anche lui repubblicano, che era
stato nominato da Obama). La questione Flynn era legata al tentativo di palesare
una collusione tra Trump e la Russia, in modo da dimostrare che le elezioni del
2016 erano viziate e quindi da cancellarne il risultato, come se non fossero mai
esistite. In un modo o nell’altro volevano mandare via Trump dalla Casa Bianca.
Dimostrare che Flynn era colpevole era un primo passo importante per cercare di
dimostrare la colpevolezza di Trump. La scoperta di documenti fino a poco tempo
fa tenuti segreti ha ribaltato il tavolo, e ora quello che rischia di più non è
Trump ma Obama.
Informazioni da tenere a mente. Ci sono alcune cose molto
importanti sul funzionamento della politica americana che molti non sanno, ma
che bisogna conoscere per seguire gli eventi che ci accingiamo a raccontare: le
elezioni Usa si tengono il primo martedì utile del mese di novembre di ogni anno
bisestile. Il primo giorno del mese non è considerato utile quindi le date
oscillano dal 2 all’8 novembre. Questo meccanismo funziona dal 1848, senza
eccezioni. Il vincitore viene dichiarato “presidente eletto”, ma non entra in
carica fino al 20 gennaio dell’anno seguente, quando si tiene il
giuramento. Trump è stato dichiarato presidente eletto il 9 novembre del 2016,
ma ha iniziato il suo mandato il 20 gennaio del 2017. Fino a quel momento è
rimasto in carica Obama con pieni poteri. Ci sono quindi circa due mesi e mezzo
di “interregno”. Questo dettaglio che non tutti conoscono, come vedremo, è
fondamentale per lo sviluppo dell’Obamagate, perché i fatti contestati
relativamente al caso Flynn sono avvenuti durante questa finestra temporale. A
differenza di quanto si crede il Presidente (anche dopo il giuramento) non è
affatto un monarca con pieni poteri. Certo ne ha molti, ma su molte altre cose
deve ricevere l’approvazione delle Camere. In particolare lui può nominare chi
vuole per una qualsiasi carica del suo gabinetto, ma la cosa deve essere
ratificata dal Senato. La Camera (House of Representatives) invece agisce più su
questioni di budget che di nomine ed ha altre caratteristiche. Questo tornerà
utile per capire anche perché nel 2018, con le elezioni di “mid-term” (medio
termine) Trump si è focalizzato solo sul Senato ignorando quasi del tutto il
rinnovo della Camera. È importante sapere che pur avendo formalmente la
maggioranza in Senato (51-49, diventati poi 53-47 dal 2019) Trump ha avuto non
poche difficoltà a fare approvare i membri del suo gabinetto. Trump è molto
amato dagli elettori repubblicani (oltre il 90% lo approva), non dai politici
repubblicani, ai quali, nel 2016, ha tolto la scena in modo completamente
inatteso. Il fatto che un personaggio politico si dichiari repubblicano non vuol
dire che sia certamente vicino a Trump, anzi. Questo è forse il punto più
importante e al tempo stesso il più ignorato dalla stampa italiana. Il partito
repubblicano (GOP) pur essendo il partito di Trump era ed è pieno di gente che
letteralmente lo odia (never-trumpers). Dei nemici acerrimi che lui si è creato
negli anni, soprattutto durante le primarie repubblicane. Se non si conosce
questo fatto non si riesce a comprendere perché ci sia voluto tutto questo tempo
per fare emergere questi dettagli, e non si comprende perché Obama abbia
rischiato tanto. Evidentemente sapeva di avere le spalle ben coperte anche da
alcuni repubblicani che non vedevano l’ora di vedere cadere Trump (senza che la
responsabilità fosse attribuita a loro, ovviamente, altrimenti la base
elettorale li avrebbe linciati). Ad uno sguardo esterno superficiale il GOP
infatti sembra unito. Invece al suo interno c’è una lotta feroce tra correnti
che ricorda un po’ la nostra Democrazia Cristiana. Chi non comprende questo
punto essenziale non può capire cosa è successo davvero. Trump non ha lottato
solo contro i democratici, gli uomini delle istituzioni nominati dai
democratici, contro i media mainstream (CNN, MSNBC, Washington Post, NYTimes).
Trump ha lottato soprattutto contro una parte consistente del partito
repubblicano che ha cercato in tutti i modi di aiutare i democratici a farlo
fuori, cercando di non uscire allo scoperto.
Come si arriva all’Obamagate -- Le “carte” di Granell. Cosa
dicevano esattamente quelle carte che Granell ha portato all’Attorney General
(qualcosa di simile al nostro ministro della Giustizia) William Barr? Cosa era
stato chiesto in quelle udienze a porte chiuse della commissione sui servizi
segreti? Le domande erano tutte a proposito del Russia-gate e della presunta
collusione tra Trump e Putin. E che cosa si è scoperto leggendo queste audizioni
segrete? Che nessuno dei protagonisti aveva la benché minima prova che Trump
avesse avuto contatti con i russi, né lui ne i suoi collaboratori. Per
dimostrare la collusione tra Trump e i Russi le indagini si erano concentrate su
4 collaboratori: Papadopoulos, Flynn, Carter Page, Manafort. Il nome in codice
di questa operazione era Crossfire Hurricane (nome preso da un documentario sui
Rolling Stones). Alla base di questa operazione, per giustificare l’apertura di
queste indagini, oramai è chiaro che c’era solo il deprecato Steele Dossier.
Dossier creato da un ex agente segreto britannico, Christopher Steele, su
richiesta di una società legale chiamata Fusion GPS, il cui capo si chiama Glenn
Simpson (personaggio misterioso e molto difficile da interrogare). Per Fusion
GPS lavora anche Nellie Ohr moglie di Bruce Ohr, all’epoca numero 4 dell’FBI,
che avrà un ruolo importante per reinserire in circolo il dossier che era stato
inizialmente rifiutato dall’FBI. La Fusion GPS viene pagata 12 milioni di
dollari da Hillary Clinton e dal DNC (partito democratico americano) per fare
una ricerca (opposition research) contro Trump. Curiosamente la Fusion GPS aveva
iniziato questo suo lavoro nel 2015 per mandato del Washington Free Beacon,
finanziato da Paul Singer che al tempo stesso ha finanziato la campagna
elettorale presidenziale di Jeb Bush e Marco Rubio. Dietro il famigerato Steele
Dossier c’erano inizialmente la famiglia Bush e Marco Rubio, rivali di Trump
alle primarie repubblicane. Solo in un secondo momento sono subentrati i
Clinton, apportando denaro fresco alla causa (i famosi 12 milioni). Il dossier
contiene materiale non verificato a detta dello stesso autore, e proveniente da
agenti segreti russi pagati da Steele coi soldi ricevuti da Simpson a sua volti
avuti da Hillary Clinton. Se già a questo punto vi chiedete come mai un dossier
pagato da un avversario politico (e non verificato) possa essere usato per una
indagine segreta dell’FBI e per una campagna di diffamazione a mezzo stampa
durata per anni, senza che nessuno si chieda la legittimità di tutto questo, non
siete i soli. Glenn Simpson si trova al centro anche di un altro episodio
chiave. Il meeting alla Trump Tower.
Obamagate: Il meeting alla Trump Tower. A metà del 2016 il figlio
di Trump, Don Junior, incontra una avvocatessa russa che promette di avere prove
contro la Clinton. Ovviamente era solo un adescamento. Questa avvocatessa di
nome Natalia Veselnitskaya cena con Glenn Simpson sia la sera prima che la sera
dopo l’incontro alla Trump Tower. Una curiosa coincidenza che fa sospettare
l’ennesima trappola. Anche qui ci sarebbe da chiedersi come mai se Hillary
Clinton può pagare 12 milioni per fare creare un dossier da agenti segreti
inglesi e russi, Don Junior non possa incontrare qualcuno che promette di avere
documenti contro la Clinton. Perché se lo fa la Clinton pagando agenti russi si
chiama “opposition research” ed è legale, mentre se lo fa il figlio di Donald
Trump senza pagare nessuno si chiama collusione e tradimento ed è illegale?
Anche questa è una bella domanda e la risposta è sempre la stessa: dipende dal
proprio “colore” politico. Per i nemici le regole si applicano, per gli amici si
interpretano. Chi è spettatore esterno e disinteressato può farsene una propria
opinione. Dalle carte de-secretate si capisce che i vari componenti dei
dipartimenti di giustizia uscente, DOJ FBI e CIA, scelti da Obama, la mattina
venivano interrogati sotto giuramento in sessioni segrete dalla Commissione di
controllo dei servizi segreti della Camera e dicevano di non avere prove; la
sera andavano in TV sulla CNN e sulla MSNBC a dire che le evidenze erano chiare
e inequivocabili contro Trump.
Nessun hackeraggio dai russi. C’è la conferma che nessuna agenzia
ha mai verificato che il server di posta del DNC (partito democratico) sia stato
hackerato dai russi, perché a nessuna agenzia pubblica è mai stato permesso di
metterci le mani sopra. Ad essere incaricata è stata la società
privata Crowdstrike (che qualcuno ricorderà perché Trump aveva chiesto aiuto al
presidente Ucraino a proposito di questo). Il capo di Crowdstrike si
chiama Shaun Henry e lui non ha mai detto di avere le prove che fossero stati i
russi. Praticamente non esiste alcuna prova da nessuna parte che le email di
John Podesta (che ricordiamo dimostravano come il partito democratico americano
avesse truccato le primarie per favorire Hillary Clinton contro Bernie Sanders)
siano state hackerate dai russi. Assange di Wikilieaks, che ha reso pubbliche
quelle email, ha sempre negato di averle ricevute dai russi. Più probabilmente
si è trattato di un’attività interna. Una perizia che è filtrata stabiliva che
il tempo di download era di 87 secondi per 1976MB di dati. È più simile al tempo
di trasferimento dati su una chiavetta USB, piuttosto che un hackeraggio
trans-oceanico. È più probabile quindi che sia stato un impiegato del partito
democratico furioso per il fatto che Bernie Sanders fosse stato trattato in quel
modo. Alcune teorie cospirative collegano questo evento alla morte misteriosa di
tale Seth Rich.
Obamagate: mentivano tutti. Di sicuro dai documenti ufficiali una
cosa si capisce: quando dicevano di essere sicuri che fossero stati i russi
mentivano. Tutti. Uno di quelli che più sosteneva questa tesi sul coinvolgimento
dei russi era proprio Adam Schiff, democratico, membro senior del comitato di
controllo dei servizi segreti della Camera dei deputati americana. È lui ad
interrogare Shaun Henry, ma in TV va a dire qualcos’altro. Messo spalle al muro
da Tucker Carlson in un memorabile scontro, accusa Carlson di essere al servizio
dei russi e gli dice che Ronald Reagan si starà girando nella tomba guardandolo,
per come tradisce gli Stati Uniti in favore della Russia. Guardate bene questo
video. Tucker Carlson è stato il primo, tra i conduttori televisivi più
importanti (è da tempo quello con lo share maggiore in prima serata, e nel mese
di aprile ha superato in numeri assoluti persino Hannity) a tirare fuori il
tutto la sera del venerdì 8 maggio chiedendo le dimissioni di Adam Shiff e
accusando pesantemente alla fine del video alcuni esponenti del partito
repubblicano a lui particolarmente invisi come Mitch McConnel, Lindsey Graham e
Richard Burr (trascurandone curiosamente altri ben più direttamente coinvolti,
come poi vedremo). Subito dopo Tucker Carlson sullo stesso canale ogni sera dal
lunedì al venerdì c’è Hannity, che dedica ben due segmenti alla questione. Il
primo intervistando Trey Gowdy (repubblicano), e il secondo nel quale c’è
anche Matt Gaetz (repubblicano, ma di una corrente politica molto diversa da
quella di Gowdy). Questo secondo segmento è stato poi rimosso dal canale YouTube
della Fox. Noi lo abbiamo trovato su un altro canale (dove sarà almeno fino a
quando non lo cancelleranno per violazioni del copyright). Intorno al minuto
23:30 del video, Matt Gatez dice che lui, Jordan, Nunes e Meadows cercavano di
inchiodare i democratici attraverso l’uso delle “subpoena” (citazione in
giudizio) ma che Trey Gowdy e Paul Ryan lo hanno impedito. Quest’ultimo in
particolare aveva il potere di emettere questi provvedimenti essendo Speaker of
the House (equivalente del nostro Presidente della Camera). Verso il minuto 24
si sente Hannity dire: “he made a mistake” (tradotto: ha fatto un errore)
cercando di difendere Gowdy che era stato con lui fino a pochi minuti prima.
Diceva Ronald Reagan “mai parlare male in pubblico di un tuo
collega repubblicano”. Trey Gowdy è andato poi anche da Tucker Carlson a
spiegare il suo punto di vista ammettendo di aver commesso molti sbagli e di
essersi fidato di quello che gli dicevano Rod Rosenstein (anche lui
repubblicano, di cui parleremo dopo) e altri, senza andare a leggere i documenti
per conto suo. Per uno che è famoso per non aver mai perso una causa in vita
sua è davvero difficile credere che non si sia letto i documenti ora noti a
tutti grazie a Grenell. Documenti segreti ai quali solo lui Devin Nunes e Adam
Schiff avevano completo accesso. Tornando alle accuse verso l’amministrazione
Obama molti sostengono in sostanza che si è trattato di un tentativo fallito di
colpo di stato da parte dell’amministrazione Obama, dell’FBI, della CIA, con
l’aiuto di alcuni media amici (e col supporto velato di una parte
dell’establishment repubblicano), contro Trump.
Obamagate: Colpo di Stato? A parlare più esplicitamente di colpo
di stato (coup d’état) è l’ex giudice Jeanine Pirro.
Chiariamo alcuni altri punti per comprendere meglio l’intera e
complessa questione. Queste interrogazioni sono avvenute quasi tutte quando la
maggioranza era repubblicana. In particolare a fare le domande più argute c’era
Trey Gowdy (come gli riconosce lo stesso Hannity in uno dei video postati
sopra). Egli non è affatto un never-trumper, è un ex militare della South
Carolina (quando gli chiedono qualcosa in TV lui risponde “yes sir!” con un
atteggiamento da militare di carriera), ha i capelli bianchi non perché sia
vecchio ma perché è quasi albino. Non odia affatto Trump ma era della corrente
di Marco Rubio, che odiava e odia Trump come pochi (come dicevamo curiosamente
Tucker Carlson non nomina mai Marco Rubio ma si accanisce spesso contro altri
senatori). Trey Gowdy fa le domande più argute, capisce tutto sin dall’inizio, e
invece di rendere la cosa pubblica sta zitto o fa uscire fuori solo cose che non
aiutino troppo Trump e Devin Nunes (grandissimo alleato di Trump). L’ordine che
aveva ricevuto era evidentemente quello di non aiutare Trump, e lui non lo
aiuta, lasciando Devin Nunes da solo a contrastare Adam Schiff (che nel
frattempo andava raccontando in TV di avere delle prove schiaccianti contro
Trump). La parola di Nunes contro quella di Schiff. Trey Gowdy in TV diceva di
fidarsi di quello che stava facendo l’FBI e che si fidava ciecamente
di Rosenstein, che scopriremo essere un personaggio chiave della cospirazione.
Gli faceva eco lo stesso Marco Rubio, spesso ospite alla CNN, dicendo anche che
nel FISA emesso su Carter Page c’erano altre ragioni oltre al deprecato Dossier
Steele pagato 12 milioni da Hillary Clinton. Ma viene subito contraddetto da un
altro senatore, che secondo Tucker Carlson è il “barometro del GOP”: Lindsay
Graham. Quest’ultimo è una banderuola ed è stato uno di quelli che ha più
attaccato Trump all’inizio. È un “never trumper” della prima ora che poi ha
raddrizzato il tiro quando lo ha ritenuto necessario, e lui, che ha letto le
carte senza “omissis” sul caso FISA, smentisce Rubio e dà ragione a Devin Nunes
e al deputato John Goodlatte. Del caso FISA legato a Carter Page parleremo dopo.
La svolta di Graham. Lindsey Graham che inizialmente era contro
Trump inizia a difenderlo: è il segnale che la maggioranza silenziosa del GOP è
passata finalmente dalla parte di Trump. La corrente di Graham può essere
paragonata in qualche modo a quella dei Dorotei di democristiana memoria. Da
questo momento gli equilibri si spostano. Paul Ryan, speaker della Camera
annuncia che non si candiderà più, e con lui nemmeno Trey Gowdy. Marco Rubio
inizierà a parlare quasi solo di politica estera e non entrerà più in conflitto
diretto con Trump. A differenza di Ted Cruz, anche lui acerrimo rivale di Trump
durante le primarie del 2016, ma fedelissimo alleato dopo (al punto da implorare
quasi Trump per fare un comizio con lui in Texas per aiutarlo a confermarsi
nella carica di senatore nel 2018), Marco Rubio non ha mai fatto pace con Trump.
Tuttora i due sembrano quasi evitarsi a vicenda. Può essere interessante notare
che Gowdy non si è ripresentato alle elezioni di mid-term del 2018 pur essendo
uno dei deputati uscenti più importanti nella legislatura, ora fa il
“contributor” (collaboratore esterno) della Fox News. Il suo era un collegio di
quelli sicuri, il suo ritiro, pur essendo giovane, e considerato molto in gamba,
è molto indicativo.
Tornando alle “carte” di Grenell. I documenti segreti sono stati
resi pubblici grazie a Richard Grenell: ambasciatore USA in Germania (e,
incidentalmente, unico gay dichiarato della amministrazione Trump). È stato
nominato da Trump come direttore nazionale dell’intelligence (DNI) ad interim,
dopo le dimissioni di Joseph Maguire, che aveva sostituito Dan Coats
(repubblicano, che Trump ha identificato come “never-trumper” troppo tardi). In
realtà Trump voleva nominare John Ratcliffe, deputato texano vicino a Jim
Jordan, ma una quindicina di senatori repubblicani (probabilmente legati alla
famiglia Bush, al senatore Marco Rubio, più altri che odiavano Trump per altri
motivi come Mitt Romney) gli hanno fatto capire che avrebbero votato contro
negandogli la fiducia. Quando c’è uno stallo politico dopo delle dimissioni, per
non lasciare il posto vacante, sale ad interim il secondo in comando che in quel
caso era Maguire (altro never-trumper ma più guardingo). Il secondo in comando
pero non può restare in quel ruolo troppo a lungo senza essere ratificato dal
Senato e quindi dopo un certo numero di mesi decade, lasciando di nuovo il posto
libero per un altro interim. Scaduto il tempo di Maguire questa volta Trump
nomina Grenell, in attesa di poter fare passare finalmente John Ratcliffe. La
prima cosa che fa Grenell è inserire nel suo team Kash Patel, che aveva già
lavorato con Devin Nunes. Grenell, sorprende tutti, non guarda in faccia a
nessuno, prende questi documenti segreti e li rende pubblici, forzando la mano
all’attuale direttore FBI Christopher Wray (rimasto oramai quasi l’unico nemico
interno visto che quasi tutti gli altri sono stati scoperti e sostituiti). Wray
è considerato ostile a Trump alla stregua di Rosenstein da molti commentatori. I
documenti desecretati da Grenell, dicono tra l’altro che il 4 gennaio del 2017
-- durante il periodo di transizione tra l’amministrazione uscente e quella
subentrante -- gli agenti dell’FBI (tra i quali persino lo zelota anti-Trump
Peter Stzrok, di cui parleremo dopo) dichiarano il caso Flynn sostanzialmente
chiuso e Flynn innocente. A quel punto al 7 piano (dove risiede Comey, capo
dell’FBI) si manda il chiaro ordine di tenere tutto aperto e di cambiare il
verdetto. Il giorno dopo Obama chiama a sé tutti i suoi (Clapper, Brennan,
Comey, Stzrok, McCabe, Sally Yeats e ovviamente anche Joe Biden) per organizzare
quello che a destra definiscono l’agguato al generale Flynn. Nelle riunioni che
si susseguono e che sono documentate nelle carte Obama chiede a tutti come
procedono le ricerche per incastrare Flynn, col quale lui aveva avuto pesanti
screzi nel 2014.
Che cosa aveva fatto Flynn? Di che cosa è accusato Flynn? Di aver
parlato con Sergey Kislyack, ambasciatore russo, pochi giorni prima. Loro lo
sapevano perché lo stavano intercettando (anche lui con un ordine FISA che non
trovava giustificazioni). Nelle telefonate i due non si dicono niente di strano,
infatti nessuno contesta il contenuto in sé la telefonata. Va anche detto che
Flynn in quei primi giorni di gennaio, sapendo di dover diventare DNI (ruolo poi
preso da Coatts e ora di Grenell ad interim) parla con ambasciatori di mezzo
mondo. Nelle note raccolte dall’FBI gli ordini erano precisi: confonderlo in
modo che si potesse dire che aveva mentito per fare si che non diventasse DNI o
che si dimettesse quanto prima e possibilmente che finisse sotto processo.
Agenti dell’FBI lo approcciano senza avvisarlo che lo stanno interrogando; nei
film di solito c’è la frase “hai il diritto di restare in silenzio, quello che
dici potrà essere usato contro di te”. In quel caso invece gli dicono che non
c’è bisogno che ci sia un avvocato, quindi di fatto lo ingannano. Gli chiedono
se ha parlato con l’ambasciatore Kislyak, lui risponde che non si ricorda, aveva
parlato con tanta gente, loro registrano tutto di nascosto. Gli agenti vanno dal
vice presidente Mike Pence e gli dicono che Flynn gli ha mentito perché non gli
ha detto che aveva parlato con Kislyak facendo intendere che ci fosse una trama
con la Russia. Pence interviene e chiede che si dimetta quanto prima. Gli agenti
questa volta prendono Flynn e gli dicono “avevi detto che non avevi parlato con
Kislyak e invece abbiamo le prove della registrazione della vostra telefonata,
confessa!”. Lui non ricordandosi cosa aveva detto e intimorito (pare che abbiano
minacciato anche di fare arrestare suo figlio se non avesse confessato) e senza
poter nemmeno parlare con un avvocato confessa di aver mentito sul fatto che
avesse parlato con Kislyak. Come altra prova a favore di Flynn c’è il fatto che
dopo il primo interrogatorio a tradimento gli agenti hanno riportato che lui non
aveva mentito, infatti lui semplicemente non ricordava e non si sentiva sotto
interrogatorio. Gli ordini dall’alto hanno imposto di cambiare questo verdetto e
di cercare di incastrarlo. A questo punto a chiunque si chiedesse ma che male
c’era a parlare con un ambasciatore di un Paese straniero la risposta è
semplice: assolutamente niente. È una strategia di intimidazione vecchia quanto
il maccartismo: una cosa che in America si era già vista. La prova più evidente
di questo è che Flynn è accusato di aver mentito all’FBI, non di aver
complottato con la Russia. Altra cosa che va precisata: c’è una legge che
prevede che quando un cittadino mente all’FBI è passibile di condanna penale,
anche se non è sotto giuramento. Per completare l’informazione va detto che era
stato Kislyak a chiamare Flynn (come molti altri ambasciatori del resto) con la
scusa di congratularsi della nomina, e che di seguito ci fossero state altre
telefonate il 29 dicembre 2016 a seguito delle sanzioni imposte da Obama contro
la Russia che avevano portato alla espulsione di 35 russi. Insomma Flynn aveva
la colpa di aver risposto alle telefonate dell’ambasciatore russo in America.
Questo dà la misura del clima di isteria collettiva generato dai media contrari
a Trump: quasi nessuno alza il dito per dire che è una caccia alle streghe e chi
lo fa viene accusato di essere un traditore e un agente russo (abbiamo visto
come Adam Schiff in diretta accusi Tucker Carlson proprio di questo).
Altrettanto stranamente nessuno si è mai sognato di accusare Obama di
complottare coi russi malgrado fosse stato colto a parlare di nascosto con
Medvedev di “maggiore flessibilità” dopo la sua rielezione. Anche qui sembra
esserci una doppia morale, avranno pensato omnia munda mundis…Che questo
processo a Flynn fosse una montatura se ne era già accorto qualcuno nel febbraio
2018. Non troppo stranamente, invece, nessuno in Italia aveva mai sentito
parlare di articoli come questo. Qui arrivano solo mere traduzioni di servizi
della CNN, del Washington Post, e del NY Times. Senza nessuna vera analisi.
Obama rompe il silenzio. Interessante notare che Obama ha poi
detto in pubblico che riteneva uno scandalo che fosse assolto uno spergiuro, ma
come qualcuno (Johnatan Turley, giurista democratico) gli ha fatto notare Flynn
non aveva parlato sotto giuramento, e poi lo stesso Obama aveva fatto graziare
l’ex senatore Ted Stevens (dell’Alaska) proprio in circostanze simili, tra
l’altro per un processo proprio di fronte allo stesso giudice Sullivan. Memoria
corta?
Il caso dell’Unmasking. C’è un altro problema legato alla
questione Flynn, e questo sarà probabilmente il fatto per il quale qualcuno
dell’amministrazione Obama, rischia davvero la galera: l’Unmasking (il
disvelamento). In pratica nel gennaio 2017 qualcuno della amministrazione Obama
ha tolto il segreto sul nome di Flynn quando l’indagine era appena iniziata, ed
ha fatto trapelare (leaking) tutta la storia, nome dell’accusato compreso, alla
stampa. In particolare fu comunicato tutto a David Ignatius del Washinton Post.
Secondo il racconto di Adam Entous nella redazione del WaPo erano divisi sul se
pubblicare o no questa storia. Per una cosa del genere si rischiano fino a 10
anni di carcere. Fino a qualche giorno fa si credeva che fosse stata Sally
Yates, ma dai documenti de-secretati sembra invece che lei ne fosse all’oscuro,
come di molte altre cose (cosa molto strana per un Attorney General, ma come
abbiamo visto anche Jeff Sessions, suo successore, venne ignorato
completamente). Chi è stato quindi a fare Unmasking+Leaking? Grenell ha appena
dichiarato che sta dando a William Barr la risposta a questa domanda. Chiunque
sia questa persona rischia più di ogni altra di finire dietro le sbarre. Si
tratta di un crimine grave perché compromette le indagini in modo pesante. Se si
vuole fare condannare qualcuno in tribunale è un errore gravissimo. Se lo si
vuole fare condannare dalla pubblica piazza fomentata dalla stampa allora è un
altro discorso, ma resta un crimine, e in questo modo si dimostra che non si sta
cercando giustizia ma un linciaggio mediatico. La cosa più interessante che è
venuta fuori è che le richieste di unmasking sarebbero venute da decine di
membri della amministrazione Obama, compreso Joe Biden. Ma la cosa più
sorprendente sembra essere che un gran numero di esse sarebbe stata richiesta da
Samantha Power, ambasciatrice all’ONU ai tempi di Obama. Sarebbe da chiedersi
per quale motivo la Power, che si occupava di tutt’altro, fosse così interessata
a Flynn. La cosa si fa ancora più misteriosa quando si capisce che la Power,
sotto giuramento, sostiene di non ricordare nessuna di queste richieste. In
totale ci sono decine di richieste di unmasking contro Flynn, apparentemente
chieste da 39 persone diverse a poche ore una dall’altra. Il sospetto a questo
punto è che qualcuno le abbia attribuite a persone ignare per poter reiterare le
richieste senza destare troppi sospetti o per depistare qualsiasi indagine.
Riassumendo: secondo le accuse dei repubblicani Obama ha dato
l’ordine diretto di incastrare un generale a 3 stelle (Flynn) in predicato di
diventare DNI, per odio personale e perché altrimenti avrebbe scoperto tutto
quello che era successo nei mesi precedenti contro di lui e i gli altri 3
personaggi citati (operazione Crossfire Hurricane). Una volta fatto fuori Flynn,
hanno messo fuori gioco Jeff Sessions, accusando anche lui di aver parlato mesi
prima con Kislyak in un evento pubblico dove c’erano decine di ambasciatori
quando era senatore (anche a lui chiedono se avesse parlato in passato con
questo ambasciatore Kislyak e lui non ricordava). Va detto che Sessions è
evidentemente affetto da demenza senile. Chi lo ascolta, anche se non conosce
l’inglese, capisce che è ormai non è più tanto sveglio, nella migliore delle
ipotesi. Trump lo aveva messo lì per riconoscenza, visto che era stato il primo
senatore repubblicano ad appoggiarlo quando tutto il resto del partito era
contro di lui. Sessions quindi ricusa sé stesso, ma non si dimette, e mette come
suo secondo in comando Rod Rosenstein. Quest’ultimo di fatto diventa per due
anni il vero Attorney General. Nominalmente era Jeff Sessions ma di fatto era
Rosenstein. Anche lui repubblicano si scopre essere uno dei più feroci
“never-trumper”. Cerca di trovare sponda nella amministrazione Trump per farlo
esautorare con il 25esimo emendamento della costituzione (quando un presidente
non è più considerato in grado di intendere e di volere).
Fallisce il piano di Rosenstein. Ma Mike Pence resta fedele a
Trump e siccome la firma del vicepresidente era imprescindibile per cacciare
Trump, il piano fallisce. Fallito il piano, Rosenstein negherà di averlo anche
solo pensato e si dedicherà a portare avanti il lavoro che aveva iniziato
l’amministrazione Obama rinnovando le richieste FISA contro i 4 target della
amministrazione Obama ancora una volta (il Crossfire Hurricane). Successivamente
nomina lo Special Counsel capeggiato da Robert Mueller (anche lui repubblicano,
che aveva servito sia sotto Bush figlio che sotto Obama), dandogli uno scopo di
ricerca molto ampio, al punto che fanno condannare Manafort per delle frodi
fiscali risalenti a 12 anni prima. Ah, incidentalmente Manafort era già stato
accusato nel 2008 di frode fiscale relativamente al periodo intorno al 2006, ma
il prosecutor (pubblico ministero) che aveva indagato su di lui a quel tempo
aveva deciso che era innocente. Chi era quel prosecutor? Si chiamava Rod
Rosenstein e non è un omonimo. È la stessa persona che 10 anni prima lo aveva
assolto (potremmo dire graziato) e ora lo condannava per lo stesso crimine, nel
tentativo di estorcergli qualche testimonianza per fare fuori Trump. Manafort
però non ha alcuna prova contro Trump. Gli viene chiesto di testimoniare contro
Trump. Sarebbe la sua parola contro quella di Trump, per i media basterebbe per
fare abbassare il consenso degli elettori repubblicani verso Trump, ma Manafort
non cede e lo condannano a 7 anni e mezzo di carcere. Trump potrebbe emettere il
perdono presidenziale ma se lo facesse i sondaggi lo vedrebbero quasi certamente
scendere. Con ogni probabilità lo farà scarcerare il 4 novembre, a urne chiuse.
10 anni prima Rosenstein e Manafort erano dalla stessa parte. Manafort è sempre
stato considerato molto vicino alla famiglia Bush. Questi ultimi odiano Trump in
modo particolare, G.W. Bush ha dichiarato pubblicamente di non avrebbe votato
per Trump (facendo capire che avrebbe votato per Hillary) pur essendo anche lui
ovviamente repubblicano. Il ruolo di Manafort è stato importantissimo nella
primavera del 2016 per fare scattare la nomination di Trump. Manafort ha infatti
convinto moltissimi super-delegati repubblicani (delegati non eletti durante le
primarie, ma per meriti speciali) a passare con Trump (fino a quel momento erano
pochissimi) facendogli scattare la soglia della nomination con largo anticipo.
Coi soli delegati eletti sarebbe stato matematicamente impossibile. Manafort era
conosciuto per questa estrema capacità di fare lobby e di fatto consegnò la
nomination definitivamente nelle mani di Trump. Inutile dire che i Bush e il
vecchio establishment videro la cosa come un tradimento. La sentenza per mano di
Rosenstein era anche una sorta di vendetta per aver contribuito a fare vincere
Trump. Rosenstein sapeva benissimo cosa aveva commesso Manafort in quegli anni
essendo stato proprio lui a graziarlo anni prima facendo finta di non vedere. E
quindi sapeva come fargli pagare il tradimento verso i Bush. Ovviamente una
storia di tasse del 2006 non poteva essere usata per corroborare la narrativa di
collusione con la Russia, ma a questo punto non importava più a nessuno.
Uno dei più grossi nemici di Rosenstein era Jim Jordan che lo
accusava apertamente in pubblico: C’era un odio palese tra i due. Ad un certo
punto Jim Jordan viene accusato da alcuni suoi ex colleghi di essere stato a
conoscenza e di aver taciuto a proposito di un episodio di abusi sessuali in
palestra nei primi anni 90. Non sorprenderà nessuno sapere che queste persone
che tutto a un tratto accusavano Jordan avevano scelto tutte la stessa agenzia
legale: ancora la famigerata Fusion GPS. Le accuse saranno poi tutte ritirate
poco dopo.
Obamagate e Italia -- Cosa c’entra Renzi? Dall’Obamagate
all’Italia -- Il caso Italia-Renzi riguarda il caso Papadopoulos (il quale tra
l’altro in quel periodo si è sposato con una italiana: Simona Mangiante). Questi
era stato adescato nella primavera del 2016 da un professore,
tale Mifsud (accademico maltese), il quale aveva fatto credere a Papadopuolos di
poter avere informazioni sulle email cancellate della Clinton. L’accusa mossa
dal dipartimento di giustizia, che all’epoca era quello di Obama, era che
Papadopoulos tramite Mifsud avesse contattato i russi in quanto quest’ultimo
appunto sarebbe stato un agente russo. Il problema è che Mifsud non era un
agente vicino ai russi, lui prendeva ordini dai servizi segreti occidentali,
quindi era un agente della CIA. Chiaro segno che Papadopoulos era stato adescato
per essere poi accusato ingiustamente. Lo scopo era quello di trovare
pretesti per dire che gli associati di Trump erano in contatto con i russi e uno
di questi tramiti sarebbe stato proprio Mifsud. Peccato che, come abbiamo detto
Mifsud fosse un agente dell’occidente e non avesse alcun contatto coi russi.
Papadopoulos era visto come un anello debole, infatti gli mandarono
anche Stephan Halper, un vecchio agente CIA molto legato alla famiglia Bush per
cercare di fargli fare qualche sciocchezza per poi poterlo accusare, ma
Papadopoulos rispose bene. Tanto che le sue risposte vennero poi nascoste nel
rapporto in quanto sarebbero apparse come prove a sua discolpa. Riescono a fare
condannare Papadopuolos con la stessa accusa fatta a Flynn: di aver mentito
all’FBI (non sotto giuramento ma durante un interrogatorio normale). Lo
incastrano per aver fornito una data scorretta di una o due settimane mentre
ricostruiva tutti i suoi movimenti (che loro sorvegliavano da tempo) e appena
lui sbaglia a riferire una data gli mettono le manette ai polsi. Il giudice che
lo ha giudicato ha tenuto a precisare, nella sentenza, che considerava l’evento
davvero di pochissimo valore e pertanto gli dava il minimo possibile, 14 giorni
di reclusione. Nella sentenza viene detto anche che questo non ha niente a che
vedere con la Russia, esattamente come era successo con il caso Manafort. Ok
tutto chiaro, ma cosa c’entrava Renzi? Quasi nulla in realtà, semplicemente i
servizi segreti italiani si sarebbero messi a disposizione dell’amministrazione
Obama per aiutare Mifsud e gli altri attori della CIA e dell’FBI a circuire
Papadopoulos. L’Italia ha dato supporto a questa operazione. Ma davvero avrebbe
potuto fare diversamente? Quando poi nell’estate del 2019 William Barr, attuale
Attorney General (successore di Jeff Sessions) ha chiesto dei documenti al
governo Conte, nel periodo di transizione tra Conte 1 e Conte 2, gli hanno dato
tutto, persino il BlackBerry di Mifsud dove certamente c’erano prove del
coinvolgimento degli agenti di CIA e FBI nella cospirazione contro Trump. Le
prove sono state consegnate allo “special prosecutor” John Durham, il quale dopo
l’acquisizione di queste prove ha fatto cambiare lo scopo dell’indagine, da
conoscitiva a criminale. Questo vuol dire che forse alcuni di questi
protagonisti durante l’era Obama finiranno alla sbarra col rischio di venire
condannati per cospirazione contro il candidato Trump e successivamente contro
il presidente eletto Trump.
Obamagate: cospiratori alla sbarra. Se questo scenario si
materializzasse sarebbe uno scandalo senza precedenti e Obama stesso
rischierebbe moltissimo, non certo la galera (magari qualcuno dei suoi si ma lui
no) quanto piuttosto vedere passare alla storia la sua amministrazione come
forse una delle peggiori di sempre. Ecco cosa è l’Obamagate. Ovviamente in
tutto questo Renzi non rischia praticamente nulla ed è stato chiamato in causa a
sproposito. Per concludere la carrellata dei bersagli dell’FBI targata
Obama/never-trumpers resta Carter Page che viene chiamato in causa per primo e
solo per il “FISA abuse”. Come abbiamo visto si è poi scoperto che non era solo
lui ad aver subito questo trattamento ma che erano in 4 (Crossfire Hurricane).
Era stato messo sotto sorveglianza durante il periodo 2016-2017 senza che ci
fosse una reale giustificazione. Il rapporto Horowitz (nominato da Obama come
Ispettore Generale e mantenuto in quel ruolo da Trump) mostrerà poi che erano
stati commessi 17 abusi, uno dei quali commesso da tale Clinesmith dell’FBI, che
lavorava sotto Peter Stzrok. Quest’ultimo passerà alla storia per i messaggi
cospiratori scambiati con la sua collega ed amante Lisa Page, nei quali
mostravano terrore verso l’ipotesi che Trump potesse vincere e si immaginavano
come baluardi che avrebbero impedito in ogni modo che questo accadesse. E se
pure Trump avesse vinto le elezioni lui aveva una “insurance policy” (un asso
nella manica) per risolvere comunque il problema. Parole inquietanti soprattutto
se dette da quello che nei fatti era il numero 2 dell’FBI. Durante l’audizione
alla Camera, sotto giuramento ha detto che “noi” intendeva “noi cittadini
americani, col nostro voto”. Sta al giudizio del lettore farsi una propria
opinione in merito. Tornando a Clinesmith questi avrebbe modificato la mail
ricevuta dalla CIA nella quale si diceva che Carter Page era un loro
collaboratore affidabile, invertendo il significato della comunicazione, per poi
inoltrarla al Tribunale del FISA (che autorizza lo spionaggio dei cittadini
americani). Potrebbe sembrare una sciocchezza, in fondo chi è questo Carter
Page? Un collaboratore marginale di Trump, quindi che segreti avrebbe mai potuto
rivelare? Lui nessuno. Peccato che quando si autorizza l’intercettazione di un
cittadino americano si autorizza automaticamente l’intercettazione di TUTTI
quelli coi quali entra in contatto, quindi anche Trump…Insomma chiedere
l’autorizzazione FISA su Carter Page significava di fatto chiedere
l’autorizzazione a intercettare Trump e tutto il suo staff. Tutto questo
avveniva nel 2016 prima delle elezioni, prima che Trump vincesse, ed è
continuato fino a metà 2017, quando era già presidente, con la firma finale di
Rod Rosenstein. In pratica spiando Carter Page l’FBI spiava il proprio
presidente (cosa non proprio nuova a dire il vero). A questi quattro si è
aggiunto successivamente come bersaglio Roger Stone, vecchio consigliere di
Trump, reo -- a detta di chi lo accusava -- di aver cercato di ottenere
informazioni sulle solite 33000 email che la Clinton aveva cancellato dal suo
server privato (e che lei diceva che parlavano solo delle lezioni di yoga e poco
altro), ma questa è un’altra storia. Se vogliamo ricapitolare su come abbia
fatto Trump a salvarsi con tutti questi nemici possiamo provare a elencare chi
gli è stato leale e ha impedito che le cose andassero peggio: Michael Rogers,
capo della NSA (National Security Agency) nominato da Obama, scopre i primi
tentativi di abuso delle intercettazioni e riesce inizialmente a bloccarli.
Nella audizione pubblica negherà che il conteggio dei voti negli stati chiave
sia stato alterato da qualcuno per favorire Trump. Nel video che segue Joe Di
Genova spiega perché: Mike Pence: viene invitato da Rosenstein a tradire Trump
sostituendolo sulla base del 25esimo emendamento, diventando lui presidente al
posto di Trump, ma si rifiuta. Devin Nunes: racconta prima di tutti quello che
viene fuori dalle interrogazioni relative ai FISA abuse subendo critiche feroci
da tutte le parti. Aveva ragione su tutto. Ci sono voci secondo le quali il
ruolo di Kash Patel sarebbe stato determinante per portare a termine il “Nunes
memo”.
Jim Jordan: protagonista di un momento chiave dell’impeachment.
Sondland parla di “quid pro quo” di Trump e Jordan lo smonta con un
controinterrogatorio degno del finale di un film. William Barr: era Attorney
General anche con Bush padre (quasi 30 anni fa), considerato fedele ai Bush
viene approvato senza problemi dal Senato per sostituire Jeff Sessions. Si
dimostrerà l’alleato più forte che Trump avrebbe potuto desiderare.
Richard Grenell: viene mandato per sostituire Maguire in attesa
della conferma di Ratcliffe e in pochi giorni sbanca tutto svelando tutto il
materiale secretato da esponenti del suo stesso partito.
Mark Meadows: Unico dei 4 cavalieri dell’Apocalisse di Trump che
non avevamo ancora citato. Ha abbandonato il seggio alla Camera dei deputati per
dirigere lo staff della Casa Bianca, in pochi giorni ha stanato “Anonymous” che
aveva pubblicato editoriali sul NYTimes e scritto un libro contro
Trump rivelando dettagli dall’interno della Casa Bianca. Si trattava di Victoria
Coates, ora mandata da Meadows a pettinare la sabbia dell’Arabia
Saudita. Qui tutta la storia
I 4 cavalieri dell’Apocalisse trumpiana. Adam Schiff ha coniato
questo termine per i 4 suoi avversari più fastidiosi, appunto, i 4 cavalieri
dell’apocalisse “trumpiana”:
Devin Nunes – cavaliere della morte
Jim Jordan – cavaliere della guerra
Trey Gowdy – cavaliere della carestia
Mark Meadows – cavaliere della pestilenza
Possiamo tranquillamente sostituire Gowdy con Matt Gaetz e il
quadro è perfetto. Come sono divisi i blocchi del partito repubblicano americano
(GOP)?
Guardando i voti espressi nelle camere possiamo dire che i
trumpiani duri e puri sono circa il 25%, poi c’è il ventre molle della vacca,
quelli che prima abbiamo definito “Dorotei” che hanno circa il 50% degli eletti,
e infine c’è circa il 25% di deputati più vicini alla alleanza Bush-Rubio.
Questi ultimi sono praticamente sovrapponibili, come politica estera, ai
centristi democratici come Hillary Clinton. I leader di Camera e senato del GOP
sono Kevin McCarthy e Mitch McConnell e appartengono al ventre molle del GOP. In
questo momento, grazie al fatto che il consenso verso Trump della base
elettorale repubblicana è sopra il 90% sono in stretta alleanza con il gruppo
dei trumpiani. Per definizione stessa del gruppo, i trumpiani sono quelli che
sono politicamente vicini a Jim Jordan, leader indiscusso della corrente e molto
molto amato dalla base elettorale. Per molti il vero successore di Trump. Al
momento sembra reggere il patto Jordan-McCarthy-Graham-McConnell-Trump. L’altro
25% per ora si mimetizza col resto del ventre molle della vacca, ed esce fuori
solo a Senato per mettere veti a qualche nomina a loro sgradita. Così sarà
probabilmente fino a novembre, poi si vedrà. Come ultimo dettaglio aggiungiamo
la storia con la quale Adam Schiff viene ingannato da dei comici russi che gli
fanno credere di avere foto di Trump nudo. Impressionante è l’ipocrisia con la
quale egli aveva condannato Don Jr Trump per aver fatto la stessa identica cosa.
Lui ci casca al punto da fare mandare dal suo staff una email chiedendo di
ottenere quel materiale compromettente, per poi essere deriso. Nota dell’autore:
tutti questi fatti sono stati raccontati sulla base di articoli pubblicati dalle
più prestigiose testate sia di destra che di sinistra. Ci sono link ad articoli
del NY Times, del Washington Post, della Associated Press, video della Fox News
e della CNN e di moltissime altre testate giornalistiche. Questa versione dei
fatti aderisce alle ricostruzioni fatte da grandi giornalisti di inchiesta, sia
di destra che di sinistra, come John Solomon e Glenn Greenwald (premio
Pulitzer). Molte cose ancora mancano, come il caso delle email di Hillary
Clinton, ma di questo ve ne parleremo in un’altra puntata.
Yurii Colombo per “il Manifesto” il 21 maggio 2020. Ieri
l'ufficio del procuratore generale dell' Ucraina ha aperto un procedimento
giudiziario con l' accusa di alto tradimento contro l' ex presidente Petr
Poroshenko. La decisione è stata presa dopo che il deputato della Rada Andrey
Derkach aveva consegnato una chiavetta con «documenti compromettenti» alla
magistratura. Di che cosa si trattasse lo si è saputo poco dopo quando il
portale 112.ua rendeva pubbliche la registrazioni di colloqui telefonici
avvenuti tra il 2015 e il 2016 tra l' ex presidente ucraino, Joseph Biden e John
Kerry allora rispettivamente vice presidente e segretario di Stato americani. Le
registrazioni non aggiungo no nulla di nuovo a quanto si sapeva e cioè del
tentativo esplicito da parte Usa di mettere sotto tutela la politica e l'
economia del paese come se si trattasse di una qualsiasi colonia. Nella prima
conversazione tra Poroshenko e Kerry, Biden viene indirettamente chiamato in
causa in relazione alle vicende della compagnia bancarottiera petrolifera
ucraina Burisma, di cui il figlio di Biden, Hunter, era consulente. Il
segretario di Stato chiede esplicitamente nella conversazione a Poroshenko di
licenziare il procuratore Viktor Shokin, che stava indagando su Burisma. In
ballo un miliardo di dollari per la devastata economia ucraina che se «le cose
non si aggiustassero» potrebbero non arrivare. In una successiva telefonata del
22 marzo 2016, Biden non usa perifrasi: «Se ci sarà un nuovo governo e un nuovo
procuratore generale, sarò pronto a firmare pubblicamente prestiti per 1
miliardo». Un'ulteriore riprova di chi fa e disfa a proprio piacimento ai piani
alti del Fondo monetario internazionale. Dimissioni del governo e del
procuratore che poi arriveranno puntuali. Ma la «devozione» dell' ex capo di
Stato del Tridente ai voleri di Washington è ancora più evidente in una
telefonata successiva con Biden. Poroshenko propone un suo uomo, Yurii
Lutshenko, come nuovo procuratore, «sempre che a te vada bene» aggiunge con
sussiego. Biden accetta di buon grado: «Lutshenko è in contatto con l'
ambasciata americana, la quale è pronta ad accettare il procuratore a Kiev come
assistente e consigliere». Un quadretto davvero patetico in cui il presidente di
uno Stato sovrano eletto dal popolo, si comporta come un maggiordomo di fronte
al suo padrone. La vicenda ha comunque una scarsa valenza interna : il ruolo
politico di Poroshenko è oggi davvero marginale se pochi giorni fa Zelensky si è
potuto permettere di nominare un suo mortale nemico come Michail Saakashvili a
suo braccio destro per le «riforme strutturali». Poroshenko è da tempo un dead
man walking seppellito sotto 16 indagini giudiziarie in corso a suo carico. Ieri
Zelensky ha liquidato il caso con una battuta: «sono curioso di sentire cosa
dirà in tribunale... secondo me ha tanto da dire» ha affermato l' ex -comico. L'
incriminazione di Poroshenko è in realtà una carta nella corsa alla Casa bianca.
Joe Biden dopo aver accusato Donald Trump di aver fatto pressioni sul leader
ucraino Zelensky per ottenere l' incriminazione del figlio, e aver usato questo
argomento nel fallito tentativo di impeachment, è ora costretto sulla difensiva.
Anche perché - come sottolinea il giornale di Kiev Strana - proprio durante il
rush finale autunnale della campagna elettorale, i giudici potrebbero chiamare a
deporre proprio Biden e Kerry. L' assist di Zelensky a Trump alla fine c' è
stato e potrebbe aiutare il presidente in carica a recuperare, almeno in parte,
i 6 punti che per i sondaggi al momento lo dividono dal candidato democratico.
Intanto i giornali americani di area dem sembrano aver trovato chi starebbe
tirando le fila del complotto. Secondo il Washington Post il nuovo scandalo è
simile a quello del 2016 «quando agenti russi hackerarono e pubblicarono e-mail
del candidato democratico Hillary Clinton». Una tesi cara anche a Poroshenko L'
ex presidente ha accusato la «quinta colonna del Cremlino di aver avviato un'
operazione in grande stile per minare il sostegno bipartisan Usa all' Ucraina».
Stefano Graziosi per “la Verità” il 21 maggio 2020. L'Obamagate
si arricchisce di dettagli. Martedì, il director of National intelligence,
Richard Grenell, ha desecretato parte di una mail che il consigliere per la
sicurezza nazionale di Obama, Susan Rice, aveva spedito a sé stessa il 20
gennaio 2017. La prima parte di questa mail era già nota e documentava un
incontro, avvenuto nello studio ovale il 5 gennaio 2017, sulle presunte
collusioni tra il generale Mike Flynn (in procinto di diventare consigliere per
la sicurezza nazionale di Trump) e il Cremlino: incontro a cui avevano preso
parte - oltre alla stessa Rice - Obama, Joe Biden, il direttore dell' Fbi James
Comey e il viceministro della Giustizia Sally Yates. Secondo il pezzo
desecretato, Comey dichiarò che Flynn parlasse «frequentemente» con l'
ambasciatore russo, Sergej Kislyak, e che temesse quindi potesse fornire a
quest' ultimo delle «informazioni sensibili». «Il presidente Obama», prosegue la
mail, «ha chiesto se Comey stava dicendo che il National security council non
avrebbe dovuto trasmettere informazioni sensibili relative alla Russia a Flynn.
Comey rispose: "È possibile". Ha aggiunto che finora non ha alcuna indicazione
che Flynn abbia passato informazioni classificate a Kislyak, ma ha osservato che
"il livello di comunicazione è insolito"». Gli aspetti controversi non sono
pochi. In primis, Comey fece riferimento alla frequenza delle conversazioni tra
Flynn e Kislyak (nel dicembre 2016), parlando ambiguamente di «livello di
comunicazione insolito». Tuttavia l' allora direttore del Bureau non fece cenno
a contenuti problematici e anzi ammise di non avere indicazioni che Flynn stesse
passando informazioni riservate ai russi. Si potrebbe pensare che non fosse
appropriato per Flynn parlasse con un ambasciatore straniero di politica
internazionale. Il generale si stava tuttavia preparando a diventare consigliere
per la sicurezza nazionale e avviene sovente che funzionari in procinto di
assumere un simile ruolo abbiano contatti preliminari con diplomatici e politici
stranieri nella cosiddetta «transizione». A questo si aggiunga che, il 4 gennaio
2017, l' Fbi stesse chiudendo le indagini su Flynn per assenza di «informazioni
dispregiative» sul suo conto. Eppure, lo stesso 4 gennaio, l' inchiesta venne
riaperta dai vertici del Bureau. Inoltre, come emerso da documenti recentemente
pubblicati, i principali funzionari dell' amministrazione Obama ascoltati dalla
Camera tra il 2017 e il 2018 hanno negato di aver posseduto delle «evidenze
empiriche» di una collusione tra il comitato di Trump e Mosca. Insomma, se non
c' erano prove, per quale motivo Comey continuò a indagare su Flynn e arrivò a
consigliare a Obama - su sua stessa richiesta - di non condividere informazioni
con l' amministrazione entrante? Delle due l' una. O si credeva realmente che
Flynn fosse una spia russa (ma in questo caso non informare il team entrante
avrebbe costituito un attentato alla sicurezza nazionale) oppure si stava
cercando un pretesto per colpire il generale e di conseguenza lo stesso Trump.
Del resto, non dimentichiamo che, lo scorso aprile, sono stati diffusi documenti
dell' Fbi in cui si faceva riferimento alla volontà di far licenziare Flynn.
Infine, non è chiaro per quale motivo la Rice - che pure in un' intervista a Pbs
nell' aprile 2017 aveva detto di non sapere nulla di un' eventuale sorveglianza
del comitato di Trump - ha avvertito l' urgenza di spedire a sé stessa una mail,
che documentava un meeting del 5 gennaio, soltanto il 20 gennaio: due settimane
dopo quell'incontro e - soprattutto - lo stesso giorno del giuramento di Trump.
C' è chi ipotizza una giustificazione retrospettiva. Ma non è tutto. Perché la
mail della Rice conferma ulteriormente che Obama e Biden fossero pienamente a
conoscenza che Flynn risultasse sotto controllo. Certo, è un po' strano che un'
amministrazione in carica lasciasse sorvegliare i collaboratori di un presidente
in pectore del partito opposto: soprattutto in assenza di prove atte a
giustificare simili indagini. È anche in tal senso che non si capisce per quale
ragione il capo di gabinetto di Obama, Denis McDonough, chiese di svelare il
nome di Flynn nelle intercettazioni di Kislyak: richiesta inoltrata il 5 gennaio
(lo stesso giorno del meeting alla Casa Bianca e 7 giorni prima che il
Washington Post rivelasse l' esistenza delle conversazioni, scatenando un
terremoto politico su Trump). Ricordiamo per inciso che - insieme a McDonough -
inoltrarono richiesta anche Biden e - strana coincidenza - l' allora
ambasciatore americano in Italia: quel John Phillips che, molto vicino a Matteo
Renzi, gli diede il proprio endorsement in occasione del referendum
costituzionale del 2016. L'Obamagate sta insomma collegando nuovamente il nostro
Paese al caso Russiagate. Sarà dunque una coincidenza che, secondo
indiscrezioni, l' ex premier stia cercando di far ottenere adesso la delega ai
servizi segreti a un fedelissimo, come Ettore Rosato? «Una coincidenza oggi, una
coincidenza domani Sono troppe coincidenze che coincidono», avrebbe detto Totò.
Quel boicottaggio che ferì il mondo. Il 24 maggio 1980 la
definitiva rinuncia degli Usa ai Giochi di Mosca.
Riccardo Signori, Domenica 24/05/2020 su Il Giornale. Oggi l'Olimpiade è già
accantonata: è bastato un virus per rispedirla a tempi migliori. Si spera. Ma
allora, 40 anni fa, la sbarra calò il 24 maggio 1980: venne ufficializzato un
destino annunciato da mesi di schermaglie e trattative. Ancora una volta i
Giochi olimpici finivano sotto l'oscuro riflesso del boicottaggio. Un
boicottaggio che ferì il mondo. Quattro anni prima, a Montreal, restarono a casa
i Paesi africani: i cinque cerchi ne perdevano uno. Stavolta il mondo dello
sport olimpico fu invischiato in una guerra politica, figlia del pericoloso
braccio di ferro instaurato da Unione Sovietica e Stati Uniti. Due blocchi
schierati per amore dello sport o per necessità di appartenenza politica, che i
numeri tradussero con la presenza di 80 nazioni (oltre alla Liberia presente
solo alla inaugurazione) e 60 rinunce. Gli Usa erano una delle quattro nazioni
mai mancata ai Giochi. Con loro Germania ovest, Giappone e Canada, Norvegia
primo Paese europeo ad aderire, Arabia Saudita, un pezzo di Africa. I Giochi di
Mosca dovevano far storia. Ma tutti avevano pensato ad un altro tipo di storia:
prima volta in un Paese socialista, gran ritorno della Cina popolare, dopo 27
anni di assenza, grazie alla strategia di Juan Antonio Samaranch, sessantenne
catalano, ricco collezionista di francobolli sportivi, destinato a subentrare a
Lord Killanin alla presidenza del Cio. «Perforata la muraglia cinese» intonarono
gli entusiasti sostenitori della universalità olimpica. La storia, invece, prese
un'altra via allo scadere del 1979 quando, nella notte di Natale, i sovietici
attuarono l'intervento armato in Afganistan e due giorni dopo si aggiunsero
100mila uomini, 1800 carri armati e 4000 aerei. Fu il via al Vietnam rosso, come
lo definirono gli storici, e l'inizio della fine della quiete olimpica. Jimmy
Carter scatenò la rappresaglia Usa, i giochi sotterranei della Cia fecero il
resto. L'idea del boicottaggio poteva rafforzare la leadership del presidente in
vista delle elezioni. Ma gli andò male: vinse Ronald Reagan. Il 12 aprile a
Colorado Springs il comitato olimpico Usa votò il boicottaggio con 1604 voti
favorevoli, 797 contrari, due astenuti. Annuncio velato da malinconia e
commozione, precisando però «Se il presidente Carter darà il suo assenso o se
entro il 24 maggio la situazione internazionale diventerà compatibile con
l'interesse nazionale e la sicurezza del paese non sarà più minacciata, l'Usoc
invierà gli atleti alla Olimpiade». Era quella la data limite per tutti: le
mediazioni di Lord Killanin fallirono. Altri Paesi trovarono soluzioni creative
per non urtare gli Usa. Il 19 maggio il governo italiano aderì al "no",
lasciando però libera decisione al Coni, che il giorno dopo decise per il si ai
Giochi: inviò atleti sotto la bandiera del Cio e scritta Coni, niente inno,
nessuno alla sfilata d'apertura, rimasero a casa i militari. Stratagemma imitato
dagli inglesi, che vennero meno al no dettato dalla signora Thatcher. Olimpiadi
senza gioia ma nemmeno vergogna, venne raccontato. Vinse chi c'era. Quattro anni
dopo sovietici e Paesi consociati restituirono lo sgarbo.
Rapporti America-Cina: Kissinger, Mao e una frase molto
attuale. Pubblicato lunedì, 18 maggio 2020
su Corriere.it da Sergio Romano. Nell’articolo di Guido Santevecchi sui rapporti
fra la Cina e gli Stati Uniti (newsletter del 15 maggio) è citato un recente
ammonimento di Henry Kissinger diretto al Paese di cui è stato un brillante
Segretario di Stato, fra il 1969 e il 1977 durante le presidenze di Richard
Nixon e Gerald Ford. «Il confronto sta diventando conflitto e può finire in un
esito disastroso per l’umanità». Kissinger parlava a Pechino nello scorso
novembre e la frase conferma la sua familiarità con la Repubblica popolare che
ha visitato frequentemente negli ultimi decenni, e mi ha ricordato la
conversazione con un ambasciatore cinese, il generale Huan Chen, veterano della
Lunga Marcia, mentre l’Italia stava negoziando a Parigi, nel 1968, la ripresa
dei suoi rapporti diplomatici con Pechino. Durante le trattative, lunghe e
laboriose, capitava spesso di prendere fiato parlando d’altro. Un giorno in cui
le due delegazioni aspettavano istruzioni dai loro rispettivi governi, Huan
cominciò a parlare degli Stati Uniti e disse a un certo punto che erano il Paese
da cui la Cina era stata meglio trattata negli anni in cui le potenze europee
avevano molto spesso dimostrato di avere una sgradevole mentalità coloniale. Il
giudizio sorprese gli italiani. Anche gli Stati Uniti, come altri Stati europei
(fra cui l’Italia ) avevano partecipato nel 1900 alla guerra contro i «Boxer»,
un gruppo di società cinesi che davano la caccia a cristiani e europei
definendosi «pugili della giustizia e della concordia». E molti ancora
ricordavano la crisi dello stretto di Formosa, nell’agosto del 1958, quando i
cinesi, dal continente, martellavano instancabilmente con i loro cannoni le
isole di Quemoy e Matsu. Gli americani mandarono la flotta e lasciarono sapere
che una delle navi conteneva un ordigno nucleare. Alla fine fu Mao che gettò la
spugna. Dette ordine di interrompere i bombardamenti, si concentrò sul «grande
balzo in avanti» per l’industrializzazione e lasciò Formosa (oggi più nota come
Taiwan) ai nazionalisti di Chiang kai shek. Il giudizio così filoamericano del
generale Huan Chen mi sembrò quindi sorprendente sino a quando nel febbraio del
1972 vedemmo il viaggio di Nixon a Pechino sugli schermi delle televisioni di
tutto il mondo e apprendemmo che era stato preceduto e preparato da alcuni
viaggi segreti di Kissinger in Cina dove aveva ripetutamente incontrato il
ministro degli Esteri Chu en lai. Capii meglio quello che era accaduto quando
lessi una frase attribuita allo stesso Kissinger che potrebbe tornare utile
domani a Donald Trump e a Xi Jinping: «Gli Stati non hanno né amici permanenti
né nemici permanenti. Hanno solo interessi». Come altre frasi efficaci anche
questa ha molti padri. Ma Kissinger e Chu e sono fra quelli ne hanno fatto l’uso
migliore.
Marina
Valensise per ''Il Messaggero'' il 12 maggio 2020. Heinz Kissinger aveva nove
anni nel 1933, quando Hitler venne nominato Cancelliere. Era il figlio di un
ebreo tedesco assimilato, un uomo pio, insegnante a Fürth, cittadina
manifatturiera di 70 mila abitanti in Baviera, che l' aveva cresciuto nel culto
di Goethe, Lessing e Felix Mendellsohn, votandolo all' ideale della Bildung (la
tradizione tedesca di auto-formazione). Da un giorno all' altro, si trovò
braccato da bande di ragazzetti in camicia bruna, costretto a cambiare strada, a
disertare la piscina, a fingersi cattolico per giocare a pallone. Nel 1938, alla
viglia della Kristallnacht, la madre Paula Stern, figlia di un mercante di
bestiame e perciò dotata di senso pratico, riuscì a ottenere un visto per l'
America. Così la famigliola riparò a Washington Heights, Upper Manhattan, fra la
comunità di ebrei tedeschi detta per scherzo The Fourth Reich, dove il vecchio
padre, ormai vinto dalla vita, cercò di riciclarsi come contabile.
LA CARRIERA.
Divenuto adulto, laureato a Harvard con tesi su Metternich e Castlereagh,
scrittore di successo con un saggio del 1957 sulle armi nucleari, professore a
Harvard, consulente del governo, diplomatico di prestigio, consigliere per la
sicurezza nazionale e Segretario di Stato dal 1969 al 1977, durante le
presidenze di Richard Nixon e di Gerald Ford, e Premio Nobel per la Pace nel
1973, Henry Kissinger, che era diventato americano dopo essersi arruolato nell'
esercito ed essere tornato in Germania per insegnare a dare la caccia ai
nazisti, avrebbe minimizzato il peso della persecuzione subita nell' infanzia.
Eppure, solo un biografo dal cuore duro potrebbe negare l' impatto che la
parabola del padre ebbe sulla visione del figlio e resistere alla tentazione di
considerare l' attenzione al realismo e l' assenza di illusioni una sorta di
compensazione all' impotenza del padre.
LE CRISI. È l'
assunto sul quale si fonda Barry Gewen, redattore di lungo corso alla New York
Times Book Review. Il suo libro oscilla tra il ritratto intellettuale e il
compendio politico. Dalla storia del Cile moderno, dove il colpo di Stato del
1973 contro il presidente Salvator Allende, primo comunista regolarmente eletto,
un putsch gradito a Washington ma indipendente dall' amministrazione americana,
è riportato alla sola matrice militare, sebbene Kissinger ammonisse Non vedo
perché dovremmo stare a guardare un Paese che diventa comunista per l'
irresponsabilità del suo stesso popolo?, si passa alla crisi della democrazia
nella repubblica di Weimar. Dalla seconda guerra mondiale alla Guerra fredda,
dalla guerra nel Vietnam all' invasione della Cambogia e all' umiliazione da
parte di Ronald Reagan che considerava superata la realpolitik, e non volle
Kissinger alla Segreteria di Stato. Seguendo un periplo movimentato, Gewen
finisce per assolvere da ogni accusa di cinismo, opportunismo, machiavellismo e
diabolica spregiudicatezza il maestro della realpolitik, che perseguì l'
interesse nazionale e l' equilibrio di poteri per garantire la stabilità dell'
ordine mondiale.
LE CAMERE A
GAS. Lo shock subito da bambino, l'aver visto tramontare da un giorno all' altro
gli ideali del padre, l' aver visto inghiottire zii e cugini nelle camere a gas,
l' aver assistito inerme alla distruzione della democrazia, in nome della
democrazia e attraverso le procedure della democrazia, costituiscono il nucleo
tragico del pensiero politico di Kissinger che affonda le radici nel pessimismo
europeo del Novecento, e nella diffidenza verso la democrazia moderna condivisa
da altri emigrati eccellenti, come Leo Strauss, Hannah Arendt e Hans Morgenthau,
accomunati nella riflessione sulla morte della civiltà e dall' avvento
inaspettato della barbarie, prodotto e nemesi dell' idea di progresso. Alla fine
di tante digressioni, resta da capire se, e fino a che punto, il realismo
politico, e per esempio la teoria dell' effetto domino in Asia, sia stato
obiettivamente efficace nell' azione diplomatica di un pensatore di spicco.
Inglesi e americani, storia dei cugini
separati dalla lingua comune.
Paolo Guzzanti il 13 Dicembre 2019 su Il Riformista. «Peccato, abbiamo tante
qualità condivise, ma siamo separati dalla lingua comune» decretò
l’irlandese Oscar Wilde di ritorno dagli Stati Uniti dove aveva denunciato allo
sbalordito doganiere: «Nulla da dichiarare tranne il mio genio». Americani e
inglesi sono più o meno lo stesso popolo? Oppure due popoli lontani e persino
nemici? Oggi conosceremo i risultati delle elezioni nel Regno Unito e una delle
poste in gioco è proprio la relazione speciale con gli Stati Uniti. Winston
Churchill, che scrisse una eccellente Storia dei popoli di lingua inglese, che
gli valse il premio Nobel per la letteratura (non potendolo ricevere per la
guerra vinta) esaltava con forti sentimenti di fratellanza gli statunitensi, ma
li considerava cugini – benché sua madre stessa fosse americana – e non fratelli
o figli, come invece gli australiani, i neozelandesi e anche i canadesi e
persino i sudafricani. Gli yankee sono un altro paio di maniche e hanno creato
una lingua americana loro e persino un loro sport che arbitrariamente chiamano
Football per declassare a Soccer, il vero football inventato dagli inglesi e
diffuso nel mondo. Gli americani considerano il soccer un gioco da signorine e
infatti la nazionale femminile di calcio americano in genere vince i campionati
del mondo. Ma la questione aperta e di cui vedremo gli sviluppi (o il
fallimento) nel 2020 è quella di un nuovo spettacolare rilancio del rapporto
speciale fra Stati Uniti e Regno Unito che prevede due presupposti. Il primo,
che Londra esca davvero dall’Unione Europea come Johnson si è impegnato a fare,
senza saper bene dire come. Il secondo punto, o condizione, è che Donald
Trump sia rieletto fra un anno e che possa proseguire nella politica di rapporti
super-speciali con Canada e Messico da una parte e lanciando dall’Atlantico un
ponte fino alla Torre di Londra, accogliendo il Regno Unito nell’area di
sviluppo americana. “The Donald” ha spiegato più volte prima a Theresa May e poi
a Boris Johnson che se il Regno Unito si deciderà a troncare i legami con
Germania e Francia, diventerà il primo partner degli Stati Uniti, in pratica un
matrimonio. Non è la prima volta, ma non è finita sempre bene. Guardiamo la
storia. Tutti sappiamo che le 13 colonie inglesi in America che si ribellarono
alle tasse sul tè e al divieto di avere rappresentanti (“No taxation without
representation”) ottennero l’indipendenza dopo una dura guerra contro i
mercenari tedeschi arruolati dall’Inghilterra, ma quasi nessuno ricorda più,
nemmeno negli Stati Uniti, la terribile guerra fra le due nazioni ormai separate
fra il 1812 e il 1816, quando nacque l’inno nazionale “The Star Spangled
Banner” scritto sotto il bombardamento inglese sul porto di Baltimora. Gli
inglesi bloccavano le navi americane che commerciavano con l’Europa in barba al
blocco inglese contro Napoleone e arruolavano con la forza i loro equipaggi. Gli
americani risposero attaccando il Canada che era la loro Vandea dove si erano
rifugiati i traditori lealisti. Gli inglesi armavano gli indiani affinché
attaccassero i coloni americani e alla fine tutti si stancarono di quel bagno di
sangue che terminò tuttavia con una schiacciante vittoria americana sull’armata
britannica a New Orleans quando era già stata firmata la pace. Ma la notizia non
era arrivata. Pochi sanno, o ricordano, che un secolo fa la frizione fra i due
Paesi si acuì di nuovo e che proprio Winston Churchill cominciò a penare alla
possibilità di uno scontro armato con gli Stati Uniti che volevano a tutti costi
fare ciò che poi effettivamente fecero: distruggere l’impero britannico
cominciando a sostenere l’India di Gandhi e poi appoggiare le guerre di
indipendenza di tutte le colonie del regno. Churchill era un fanatico
sostenitore dell’Empire che pronunciava aristocraticamente “Empaaaa” e gli
americani avevano appena distrutto l’impero spagnolo con una guerra che aveva
messo nelle loro mani sia Cuba che le Filippine. Quando Hitler attaccò la
Francia e l’Inghilterra, Churchill supplicò il presidente americano Franklin
Delano Roosevelt di consegnargli cinquanta fregate residuate dalla prima guerra
mondiale, ma Roosevelt non ne voleva sapere perché il popolo americano era
totalmente ostile alla guerra europea e gli americani di origine irlandese, fra
cui il padre del futuro presidente John Fitzgerald Kennedy ambasciatore
americano a Londra (e contrabbandiere di alcool durante il proibizionismo grazie
alla sua copertura diplomatica) facevano più meno apertamente il tifo per i
tedeschi in odio agli inglesi. Roosevelt inondava Churchill di enfatici messaggi
di solidarietà e spediva grandi convogli di viveri e munizioni all’Inghilterra
con la legge “Depositi e prestiti”, la cui contropartita era dichiarata: dopo la
vittoria sulla Germania e il Giappone, l’Inghilterra avrebbe dovuto abbandonare
l’impero e specialmente l’India. Ciò era insopportabile per il primo ministro
britannico più famoso di tutti i tempi che ingaggiò una partita doppia con il
“caro presidente” americano, quando l’Unione Sovietica attaccata da Hitler si
trovò alleata degli occidentali. Sia Churchill che Roosevelt si resero conto che
la partita con Stalin era non soltanto complicatissima, ma anche cinica e che
con il dittatore sovietico si sarebbero potuto fare molti doppi giochi.
Churchill fece il primo viaggio a Mosca volando per quaranta ore in un lungo
giro che lo portò in Africa e poi a Teheran. Stalin e Churchill non si piacquero
ma al terzo giorno si ubriacarono insieme per una lunga notte di baldorie e
Churchill promise al georgiano il mantenimento dei confini che aveva guadagnato
dall’alleanza con Hitler fra il 1929 e il 1941. Roosevelt allacciò allora una
relazione parallela antagonista e i due si rimpallarono l’assetto generale del
dopo guerra fino alla conferenza di Yalta su posizioni lontanissime, anche se la
filmografia ufficiale li mostrava affratellati. Gli americani avrebbero voluto
sbarcare subito in Normandia, puntare su Berlino e poi dedicarsi al Giappone
senza perdere tempo. Churchill li costrinse a sbarcare in Africa e a risalire
l’Italia per penetrare il ventre molle del Mediterraneo e curare gli interessi
dell’area di influenza inglese. Il maresciallo britannico Montgomery, che aveva
battuto Erwin Rommel, “la Volpe del Deserto” tedesca, odiava il generale
americano George Smith Patton, e tutti seguitarono ad odiarsi anche dopo la fine
della guerra quando le due diplomazie entrarono in conflitto sulla politica da
usare con i sovietici, dopo il celebre discorso nell’università americana di
Fulton nel 1946 dove Winston Churchill usò per la prima volta il termine “iron
courtain”, la cortina di ferro fatta calare dall’Unione Sovietica dal Baltico a
Trieste. I servizi segreti dei due Paesi di lingua inglese si scannarono (si può
godere la splendida serie “Traitors” con il raffinato dettaglio di una spia
americana smascherata perché pronuncia la parola “Opera”, nel senso di opera
lirica “Op’era”, anziché “Oppra” come vuole la fonetica britannica) con una
lunga scia di morti, mentre i servizi inglesi erano stati irreparabilmente
penetrati dai sovietici grazie al tradimento dei “Cinque di Cambridge” e in
particolare dell’aristocratico Kim Philby che finì i suoi miseri giorni in un
gelido scantinato di Mosca. Americani e inglesi si consideravano reciprocamente
come inaffidabili, mentitori e traditori. L’apice dello scontro si ebbe nel 1956
con Suez. L’Egitto si era ribellato al padronato britannico cacciando il
collaborazionista re Faruk ed era arrivato al potere Gamal el Nasser, un
colonnello filosovietico che nazionalizzò il Canale di Suez. Anthony Eden, primo
ministro britannico organizzò un piano per ucciderlo e poi attaccò l’Egitto con
la Francia e il sostegno di Israele. Da Mosca, il successore di Stalin, Nikita
Krusciov – che pure aveva i suoi guai con la rivoluzione ungherese che represse
con i carri armati – disse semplicemente che se inglesi e francesi non avessero
immediatamente sospeso il loro attacco, avrebbe risposto con armi atomiche. Eden
si rivolse a Washington dove era Presidente l’ex comandante in capo delle Forze
alleate Dwight “Ike” Eisenhower, che vedeva gli inglesi come il fumo negli
occhi, disse: «Siamo d’accordo con i russi». Gli inglesi si ritirarono ma non
perdonarono. La loro India era persa, l’impero era caduto e gli Stati Uniti li
avevano rimpiazzati come poliziotto armato del mondo. In contropartita, quando
il presidente Lyndon Johnson chiese agli inglesi di aiutare gli americani in
Vietnam, il numero 10 di Downing Street rispose con il gesto dell’ombrello.
Lezione
Usa, la kryptonite che minaccia le democrazie occidentali.
Paolo Delgado il 7 febbraio 2020 su Il Dubbio. Il siparietto tra Trump e la
Pelosi conferma la malattia in atto: l’avversario che diventa nemico e va
demonizzato e distrutto. É valso per Berlusconi e ora è in atto per Matteo
Salvini. Pelosi vs Trump. In diretta tv di fronte a milioni di americani e di lì
rapidamente in tutto il mondo, è andata plasticamente in scena la crisi di
sistema che dilania tutte le società occidentali e della quale non si intravede
l’esito, anche perché nessuno osa metterla a tema e chiamarla con il suo nome.
Due giorni fa, in diretta tv di fronte a milioni di americani e di lì
rapidamente in tutto il mondo, è andata plasticamente in scena la crisi di
sistema che dilania tutte le società occidentali e della quale non si intravede
l’esito, anche perché nessuno osa metterla a tema e chiamarla con il suo nome.
La sequenza va ricapitolata. La speaker della Camera Nancy Pelosi presenta il
presidente, che si accinge a svolgere il tradizionale discorso sullo Stato
dell’Unione con formula diversa da quella tradizionalmente in uso: «E’’ mio
onore e privilegio introdurre il presidente degli Stati Uniti». E’ uno sgarbo
voluto e plateale al quale Trump risponde con scortesia anche maggiore: consegna
in anticipo il testo del discorso alla speaker ma, quando lei tende la mano,
evita di stringerla. Ma Mrs. Pelosi non ha alcuna intenzione di farsi battere
nella sfida a chi palesa maggiore disprezzo e scortesia istituzionale. Mentre
Trump parla, alle sue spalle, fa le facce, scuote le spalle, alla fine strappa
platealmente il testo del discorso e alla fine rincara giustificandosi: «Era la
cosa più cortese che potessi fare». Non è un increscioso siparietto. E’ il
riflesso fedele della spaccatura verticale che diviso l’intera società americana
dopo l’elezione di Trump, quattro anni fa. Non si tratta più, infatti, di
semplice ancorché radicale ed estrema opposizione politica. E’ invece un rifiuto
quasi più antropologico che politico, nel quale si mischiano elementi etici ed
estetici che prevalgono sulle scelte politiche vere e proprie
dell’amministrazione. Il presidente, a sua volta, replica accusando i rivali di
essere né più né meno che traditori dell’America. Capita negli Usa, ma potrebbe
essere l’Italia. L’opposizione all’ascesa di Salvini si nutre degli stessi
elementi di rifiuto totale, antropologico, che innervano quella anti- Trump
dall’altra parte dell’Atlantico. E’ un calderone nel quale, anche qui, si
mischiano elementi estetici, etici e politici, in nome di una superiorità morale
culturale della quale gli elettori, per loro colpa, non si avvedono. Il leit-
motiv americano nelle chiacchiere da drugstore – ‘ Il presidente dovrebbero
eleggerlo solo New York e Los Angeles – ha il suo corrispettivo fedele nei
discorsi da bar, o peggio da salotto buono, che si sono sprecati da due anni a
questa parte: «Forse andrebbe ripensato il suffragio universale» . Sia pure con
notevoli differenze il problema potrebbe presentarsi domani nel cuore d’Europa,
in Germania, come il caso della Turingia, la crepa attraverso la quale rischia
di incunearsi il virus nazistoide dell’Afd, è eloquente. In Francia, del resto,
solo l’obbligo repubblicano di sbarrare la strada al Front National di Marine Le
Pen ha consentito l’arrivo all’Eliseo di un outsider come Macron. La fragilità
di un sistema basato sulla delegittimazione reciproca e totale degli avversari è
evidente. La pietra angolare di ogni sistema democratico è infatti proprio la
reciproca legittimazione almeno dei principali attori in campo. L’obiezione per
cui già nella prima Repubblica italiana questo elemento fondativo della
democrazia compiuta era assente è solo molto parzialmente fondata. Intanto
perché il paragone con una fase segnata da estrema e ultimativa contrapposizione
internazionale è poco proponibile, ma soprattutto perché, nonostante
la conventio ad excludendum, nei fatti la reciproca legittimazione tra Dc e Pci
era sostanzialmente presente persino negli anni ’ 50 e anzi proprio il frequente
richiamo all’ arco costituzionale, cioè tra i partiti che avevano discusso e
varato la Carta, era la rete di protezione che, funzionando come dispositivo di
legittimazione reciproca, metteva il sistema al sicuro da scosse distruttive. E’
vero che da quel patto costituzionale restava fuori il Msi neofascista, ma anche
il quel caso la delegittimazione era vera solo al centro, non nelle
amministrazioni locali, dove al contrario le alleanze tra Dc e Msi erano spesso
praticate, e nessuno si pensò mai seriamente, nonostante la legge Scelba che
vietava la ricostituzione del Pnf, di mettere fuori legge il Msi. In ogni caso,
anche una reale assenza di legittimazione, ha significato ed esiti diversi se
applicata nei confronti di un attore politico molto minoritario o se adottata
invece per forze politiche che rappresentano molti milioni di elettori, di fatto
metà Paese. Il primo Paese occidentale in cui, dopo la guerra fredda, è entrato
in tacito vigore il meccanismo che campeggia oggi ovunque è stato proprio
l’Italia. Nei confronti di Berlusconi è stata sperimentata per la prima volta
una dinamica che non revocava in dubbio le sue politiche ma la sua stessa
legittimità a occupare una postazione politica di primo piano. Il miraggio
inconfessato era chiaro: una volta scomparsa l’anomalia Berlusconi il sistema
sarebbe tornato alla normalità. Si trattava quindi solo di resistere negando
all’intruso ogni legittimità politica. E’ la stessa fantasia che viene applicata
oggi nei confronti dei ‘ populisti’ e/ o sovranisti: sono un male pericoloso ma
passeggero, passato il quale il sistema tornare alla sua normalità, senza più
Trump, o Salvini, o le Pen, o l’AfD. Si tratta quasi certamente di un calcolo
sbagliato. Quel sistema non c’è più. L’eventuale scomparsa dei Trump o dei
Salvini lascerebbe solo spazio a rimpiazzi dello stesso genere. Con forze
politiche che rappresentano la metà di un Paese, poco importa se la metà più o
meno uno, non ci si può misurare negandone la legittimità politica, altrimenti a
uscirne delegittimato e condannato prima o poi a franare è l’intero sistema. Per
questo dalla sceneggiata di Washington a uscire sconfitto non è stato uno dei
due contendenti ma l’intero sistema democratico americano. In Italia e in
Europa, però, la situazione non è diversa. Né migliore.
La nuova "Età del ferro" chiede un nuovo accordo.
Due saggi usciti negli Usa spiegano come siano ormai tramontate le illusioni di
stampo «neocon». Marco Gervasoni, Sabato 01/02/2020, su Il Giornale. Dopo il
drone degli Stati Uniti contro il generale Soleimani, abbiamo potuto leggere
tante analisi affrettate e superficiali a proposito di una supposta vocazione
neocon dell'amministrazione Trump. Come il suo predecessore Bush junior, il
presidente americano perseguirebbe un cambio di regime in Iran, secondo l'idea
dell'esportazione della democrazia e degli Stati Uniti poliziotti del mondo.
Niente di più fuori luogo, come dimostrano due recenti libri su quella che
possiamo definire, se non proprio la dottrina, la Trump strategy. Che ha rotto
radicalmente con i neocon, molti dei quali persino passati con il Partito
democratico, per adottare una strategia jacksoniana, dal nome del suo
predecessore Andrew Jackson: gli Stati Uniti devono intervenire all'estero il
meno possibile, e solo quando sono realmente minacciati gli interessi nazionali
ed economici. Rispetto all'epoca di Bush jr. e di Clinton, ma anche di Obama, è
cambiato tutto. Quella infatti era ancora l'età delle illusioni, come titola il
libro di Andrew J. Bacevich The Age of Illusions. How America Squadered its Cold
War Victory (Metropolitan Books) cominciata con la caduta del muro di Berlino,
che aveva illuso gli Stati Uniti di poter controllare il mondo attraverso
l'egemonia sulle istituzioni multilaterali. L'età delle illusioni è anche quella
della globalizzazione che, sul versante delle relazioni internazionali, ha
prodotto un «neoliberalismo globalizzato». Al posto del vecchio consenso
bipartisan della guerra fredda, retto da un cold war liberalism, si è affermato
un nuovo liberalismo, fondato su un'idea di libertà che enfatizzava l'autonomia
a detrimento della tradizione e i diritti al posto dei doveri. Per Bacevich, un
intellettuale di punta della galassia conservatrice americana mai attratto dalla
retorica neocon, quella politica è stata del tutto fallimentare, come dimostra
la presidenza Obama. Da questo punto di vista quindi Trump appare assai meno una
meteora e semmai il frutto del lavorio di tendenze critiche, presenti nel
partito repubblicano, che per anni hanno contestato l'interventismo, il
multilateralismo e il globalismo: Trump non ha fatto che raccogliere questa
tradizione politica nel momento in cui quella liberale era fallita. Se l'età
delle illusioni è finita, da quale è stata sostituita? Secondo il politologo
Colin Dueck, dall'età del ferro, come titola il suo libro, Age of Iron: On
Conservative Nationalism (Oxford University Press), nel senso dell'Esiodo di Le
opere e i giorni, un'età popolata di «gente mortale... potente e terribile». Una
nuova età, dalle avvisaglie visibili nel periodo cominciato con la crisi del
2007-2008, ma inaugurata nel 2016 dalla vittoria del referendum sulla Brexit e
dall'elezione di Trump. Fuor della metafora esiodea, l'età del ferro è quella
del ritorno della politica di potenza, dello stato nazione, del nesso
strettissimo tra politica (ragion di Stato) ed economia, dei dazi come strumento
di politica estera: soprattutto è quella caratterizzata dal ritorno della figura
del capo politico, che viene impropriamente chiamato «l'uomo forte». In questa
età del ferro, in cui il realismo politico, come scrive John Mearsheimer, tende
a sostituire il liberalismo, si forgia un conservatorismo nuovo e diverso
rispetto all'epoca in cui la lettura condivisa del mondo si reggeva su una
filosofia della storia progressista, un calco povero e ingenuo del positivismo
ottocentesco, solo potenziato dall'ottimismo spinto dal dominio della tecnica.
Secondo Dueck, anch'egli un intellettuale di punta delle nuove tendenze nazional
conservatrici, è Trump a incarnare perfettamente il leader dell'età del ferro,
una strategia che in politica estera è fondata sull'alternarsi di escalation e
di descalation: la prima serve a collocare gli Stati uniti da un punto di vista
di forza per ottenere un deal, un accordo, a cui Trump vuol giungere con mezzi
pacifici. Pur essendo stato il libro pubblicato qualche mese prima del drone
americano contro Soleimani, in questa decisione abbiamo visto in azione proprio
l'alternarsi di escalation e di descalation teorizzata da Dueck. Entrambi gli
autori, Bacevich e Dueck, sono convinti che, anche dovesse vincere un
democratico nelle elezioni di quest'anno, il multilateralismo figlio del
liberal-globalismo non tornerà più, e che anche un presidente di sinistra sarà
spinto a seguire una politica nazionalista, come quella di Trump. Resta da
capire se questa età del ferro sia un periodo di transizione verso un nuovo, e
per il momento davvero inedito, scenario, oppure se sarà destinata a durare a
lungo.
Chiara Rossi per startmag.it l'11 febbraio 2020. Per decenni la
Cia e i servizi segreti tedeschi hanno spiato le comunicazioni crittografate di
Paesi alleati e avversari tramite società svizzera Crypto. L’inchiesta del
Washington Post e Zdf. Guardarsi dai nemici è bene, ma dagli amici è meglio. Per
più di mezzo secolo, i governi di tutto il mondo si sono affidati a un’unica
società, la svizzera Crypto AG, per crittografare le proprie comunicazioni di
intelligence. Ma ciò che nessuno dei suoi clienti ha mai saputo è che Crypto AG
era segretamente controllata dalla Cia e dalla Bnd (i servizi segreti tedeschi).
Le due agenzie avrebbero truccato i dispositivi dell’azienda in modo da poter
violare i codici utilizzati dai Paesi per inviare messaggi crittografati. È
quanto emerso da un’inchiesta congiunta del Washington Post, dell’emittente
tedesca Zdf e la tv svizzero-tedesca Srf. La società svizzera Crypto AG,
produttrice di dispositivi di crittografia della seconda guerra mondiale, è
stata leader di mercato fino al 21° secolo. Il fatto che avesse sede in un Paese
neutrale, non allineato ai blocchi della Guerra Fredda, costituiva un quid in
più. Peccato però che i clienti non sapessero che la tecnologia fosse in mano
americana e tedesca. Come emerge dall’inchiesta delle tre testate, la società
svizzera ha guadagnato milioni di dollari vendendo attrezzature in oltre 120
paesi. Tra i suoi clienti c’erano l’Iran, le nazioni dell’America Latina, India,
Pakistan e persino il Vaticano. Ma anche gli alleati della Nato e paesi amici
come Irlanda, Spagna, Portogallo, Italia e Turchia. Inoltre, gestiva
informazioni governative provenienti da numerosi paesi africani, asiatici e
sudamericani. Il controllo di Cia e Bnd su Crypto AG ha permesso agli americani
e ai tedeschi di vedere comunicazioni segrete da oltre 130 governi e servizi di
informazione in tutto il mondo. Le ricerche condotte dai giornalisti della tv
svizzero tedesca Srf, dell’emittente tedesca Zdf e del quotidiano statunitense
Washington Post si basano su conversazioni con ex dipendenti dei servizi di
intelligence e Crypto AG e in particolare su un documento che la stessa Cia ha
redatto dal titolo “Minerva – una storia”. Quel documento mostra che gli
americani e i tedeschi considerano l’operazione Minerva, in seguito Rubicon, un
successo senza precedenti. L’operazione di spionaggio è iniziata nel 1970. Nel
1994 il Bnd tedesco è uscito da Crypto AG, temendo che l’operazione sarebbe
venuta alla luce e avrebbe compromesso i rapporti con la Nato. Tuttavia, secondo
il rapporto la Cia ha venduto le sue parti dell’azienda solo nel 2018. Nel 2018,
gli azionisti hanno in gran parte smantellato Crypto AG. Da quel momento due
società hanno rilevato i componenti rimasti: CyOne Security fornitore esclusivo
del governo svizzero e Crypto International, che ha assunto il marchio e nega di
avere nulla a che fare con i servizi governativi.
Anna Guaita
per ''Il Messaggero'' l'1 luglio 2020.
IL CASO.
Sarebbe stato John Bolton un anno fa, nel marzo del 2019, a informare Donald
Trump che Vladimir Putin aveva messo una taglia sulla vita dei soldati americani
in Afghanistan. L'ex consigliere per la sicurezza nazionale ha confermato
all'Associated Press che il nuovo RussiaGate, rivelato per primo dal New York
Times venerdì scorso, ha origini più lontane di quanto si credesse. Dal primo
allarme sarebbe dunque passato più di un anno, durante il quale i talebani
avrebbero ricevuto oltre mezzo milione di dollari, per aver posto bombe che
hanno fatto saltare per aria jeep che trasportavano militari Usa. I fatti
raccontati sui media americani sarebbero di una gravità eccezionale, se
venissero confermati. Il NY Times rivela anche che i servizi americani avrebbero
trovato la traccia di trasferimenti elettronici di somme dai russi ai talebani
attraverso una banca russa.
I RAPPORTI.
L'unica cosa di cui si è sicuri per ora, tuttavia, è che i rapporti di varie
agenzie dell'intelligence sono arrivati alla Casa Bianca almeno tre volte. La
prima volta nel marzo del 2019, per bocca di John Bolton. La seconda volta nel
febbraio 2020 con un rapporto scritto dei capi delle squadre speciali in
Afghanistan (Seals, Berretti Verdi, Rangers ecc.) La terza volta a voce durante
un incontro del Gabinetto di sicurezza nazionale. Finora la Casa Bianca non è
stata molto trasparente nelle sue reazioni. Trump ha twittato che nessuno lo
aveva informato. E i suoi collaboratori hanno sostenuto che le informazioni non
erano abbastanza affidabili da essere incluse nel briefing presidenziale.
Numerosi esperti sottolineano invece che se l'informazione era stata giudicata
abbastanza affidabile da informarne l'alleato britannico, è impossibile che non
sia stata data anche al presidente se non altro perché poteva venire a galla in
conversazioni fra i due leader. La ritrosia del presidente a far luce su questo
possibile nuovo RussiaGate rientra comunque nella sua abitudine di diffidare dei
servizi americani e avere fiducia piuttosto in Vladimir Putin.
L'AVVICINAMENTO. Negli ultimi mesi, poi il presidente ha fatto passi di amicizia
verso il collega, dichiarando di volerlo fare rientrare nel Gruppo dei Sette
(G7), e poi annunciando il ritiro di 10 mila soldati di stanza in Germania, un
atto visto come un grande regalo alla Russia. Ma ieri, dopo un briefing alla
Casa Bianca, esponenti del Congresso di entrambi i partiti hanno chiesto che le
possibili colpe russe vengano indagate e accertate. Il presidente della
Commissione intelligence della Camera, il democratico Adam Schiff, ha
raccomandato che «invece di invitare la Russia al G7 si considerino nuove
sanzioni per bloccare le sue attività maligne». E repubblicani, come il senatore
del Nebraska Ben Sasse, chiedono che «si vada fino in fondo, per capire se il
presidente sapeva o no». Il rivale democrarico di Trump, Joe Biden ha aggiunto
che se fosse vero, Trump sarebbe colpevole di «inadempienza del proprio dovere».
A dare anche maggior peso alle rivelazioni, è giunto ieri un articolo del noto
giornalista Carl Bernstein, che ha raccolto informazioni sulle telefonate di
Trump ad altri leader. Numerose testimonianze, confermate anche da membri dei
governi interessati ed ex collaboratori del presidente, mostrano un Trump docile
con uomini forti come Vladimir Putin e il turco Recep Tayyp Erdogan e villano
con leader donne, come Angela Merkel e Theresa May. «Alcune delle cose che le ha
detto sono semplicemente incredibili: l'ha chiamata stupida e accusata di essere
nelle mani dei russi...», racconta Bernstein riferendosi alla cancelliera. Il
suo «cameratismo» con Putin certo non è cosa nuova. Trump ha sempre rifiutato
l'idea che i russi abbiano interferito nelle elezioni del 2016 per favorire la
sua candidatura. Ha rigettato le scoperte dell'intelligence americana e
sostenuto di credere di più al russo. Il rapporto del procuratore speciale
Robert Mueller aveva puntato il dito contro i servizi segreti militari russi, il
Gru. I rapporti presentati dagli agenti americani oggi puntano di nuovo il dito
sul Gru. Il loro mandato sarebbe lo stesso: destabilizzare gli Usa.
Afghanistan, "Così Mosca pagava i talebani per uccidere i marines".
Pubblicato martedì, 30 giugno 2020 da La Repubblica.it. Gli 007 Usa hanno
intercettato dati elettronici su trasferimenti finanziari da un conto bancario
controllato dallo spionaggio militare russo ad un conto legato ai talebani. Lo
scrive il New York Times, sostenendo che si tratta di una delle prove a sostegno
della loro conclusione che Mosca ha pagato segretamente "taglie" per uccidere
soldati Usa in Afghanistan. Un caso che sta già diventando un grosso problema
politico per il presidente Donald Trump, che all'inizio ha negato di essere
stato informato delle operazioni russe. Il candidato democratico Joe Biden lo ha
già attaccato direttamente: "Se Trump ha saputo che i russi pagavano i talebani
per uccidere i nostri soldati e non ha fatto niente, non può fare il presidente
degli Stati Uniti", ha detto l'ex vicepresidente in una conferenza stampa a
Wilmington, nel Delaware. Biden ha definito "inadempienza dei propri doveri" la
presunta mancata reazione contro Mosca da parte di Trump. Tornando alla
ricostruzione del Nyt, gli analisti dell'intelligence Usa hanno valutato che i
trasferimenti erano molto probabilmente parte del programma di ricompense
descritto da alcuni detenuti nei loro interrogatori. Gli investigatori hanno
identificato anche numerosi afghani in un network legato alla sospetta
operazione russa, compreso un uomo che si ritiene abbia servito come
intermediario per distribuire alcuni dei fondi e che ora si ritiene sia in
Russia. Le intercettazioni dei fondi hanno rafforzato le rivelazioni degli
interrogatori, aiutando a ridurre un precedente disaccordo tra gli 007
sull'affidabilità dei detenuti. La circostanza mina ulteriormente l'affermazione
di Trump che le informazioni erano troppo incerte perché gli fossero riferite.
Ad arricchire il quadro, le rivelazioni questa settimana di alcuni dirigenti
afghani che si incastrano con la valutazione degli 007 americani. Si tratta di
diversi imprenditori che trasferivano soldi attraverso il sistema informale
"hawala", arrestati in Afghanistan negli ultimi sei mesi e sospettati di far
parte di un anello di intermediari che hanno operato tra lo spionaggio militare
russo (Gru) e militanti talebani. A casa di uno di loro è stato trovato mezzo
milione di dollari. Tutta la storia rischia di essere un nuovo serio problema
per Donald Trump, come al solito sospetto di contiguità eccessiva con la Russia.
Il problema di fondo è che la sua linea di difesa sul caso è in crisi: il
presidente ha sostenuto di non essere stato informato e che l'intelligence non
lo ha fatto perché non riteneva credibili le notizie. La Casa Bianca ha
sostenuto che non c'era consenso tra gli 007. Ma il New York Times, autore del
primo scoop, ha rivelato ora che il "commander in chief" ricevette
un'informazione scritta a fine febbraio nel briefing d'intelligence quotidiano.
E che la conclusione dell'intelligence era così seria e solida da finire in una
pubblicazione della Cia il 4 maggio. Non solo. Secondo l'Ap, la valutazione
degli 007 era inclusa in almeno un altro briefing scritto all'inizio del 2019.
Le informazioni di intelligence, tra l'altro, sono state condivise recentemente
con la Gran Bretagna e, in teoria, dovrebbero essere state veicolate a tutti i
Paesi alleati presenti in Afghanistan. Ora Trump è sotto pressione perché deve
spiegare se ha ricevuto quelle informazioni per iscritto, se le ha lette e, nel
caso, perché non ha risposto adeguatamente, esponendo i militari americani ad
una ulteriore minaccia: nel 2019 sono morti 20 soldati Usa in Afghanistan, anche
se finora l'indagine dell'intelligence si è concentrata su un'autobomba
dell'aprile 2019 che uccise tre marine. E' noto che il presidente non presta
grande attenzione ai briefing degli 007, ma questo non lo esimerebbe da
eventuali responsabilità. Ad aggravare il quadro le rivelazioni alla Cnn del
giornalista del Watergate Carl Bernstein sulle centinaia di telefonate a ruota
libera con i capi di Stato stranieri, che hanno indotto alcuni suoi ex alti
dirigenti a ritenerlo un "pericolo alla sicurezza nazionale" per la sua
impreparazione. Telefonate dove inseguiva la sua agenda personale e alternava le
adulazioni di Putin alle offese verso la "stupida" Merkel. I democratici sono
andati all'attacco costringendo la Casa Bianca ad informare un gruppo ristretto
di repubblicani e democratici. Quest'ultimi sono rimasti insoddisfatti e hanno
suggerito nuove sanzioni a Mosca. "Il presidente Usa non dovrebbe invitare la
Russia al G7 o al G8. Dovremmo considerare quali sanzioni sono appropriate per
prevenire ulteriormente le attività maligne della Russia", ha detto il
presidente della commissione intelligence della Camera Adam Schiff. Ma anche
diversi repubblicani incalzano Trump a verificare le informazioni e a dare
eventualmente una risposta al Cremlino. Mosca nega ogni coinvolgimento. "Si
tratta solo di lotte politiche interne. Ci sono forze negli Usa che stanno
cercando di ostacolare i piani di Trump di ritirare le truppe dall'Afghanistan:
vogliono rimanere perché questo è un business redditizio per un'intera categoria
di rappresentanti politico-militari", ha accusato l'inviato presidenziale russo
per l'Afghanistan Zamir Kabulov.
Soros e lo
scandalo Afghanistan.
Piccole Note
il 30 giugno 2020 su Il Giornale. Nella precedente nota avevamo dato notizia
dell’ennesima “rivelazione” dell’intelligence USA riguardanti asseriti pagamenti
di taglie da parte dei russi ai talebani per l’assassinio di soldati americani.
Il caso monta. Per avere un’idea del caos scatenato dalla “rivelazione”, basta
guardare gli articoli dedicati dal New York Times e dal Washington Post
all’argomento. Sul WP: “Non contare sul fatto che i repubblicani facciano
qualcosa sull’ultimo scandalo che riguarda la Russia”. “Gli assistenti di Trump
avevano troppa paura per riferirgli delle taglie dei russi?“. “Il Gop si
interpella nuovamente sul perché Trump non sia più duro nei confronti della
Russia“. Sul Nyt, invece, un solo articolo, ma massivo e di apertura: che
contiene nuove asserite rivelazioni: “Trump a febbraio è stato informato delle
possibili taglie dei russi“. Nessuno dei due maggiori quotidiani Usa riporta nei
titoli le due smentite: la prima, che potrebbe essere tacciata di parte (come
d’altronde le rivelazioni medesime), del Consigliere per la Sicurezza nazionale
di Trump, il quale afferma che il presidente non ha mai visto quei rapporti. La
seconda, molto più autorevole, è del Pentagono, che informa come quelle
rivelazioni raccolte da fonti “open source” non siano corroborate da prove,
comunicazione lapidaria quanto appunto ignorata.
I russi e
l’Afghanistan. Interessante un articolo del Wp che, al contrario degli altri,
chiede un parere ai russi, che non solo affermano che si tratta dell’ennesima
bufala, ma che nessuno farebbe mai una cosa del genere, perché prima o poi si
saprebbe, con tutto quel che consegue… logica stringente, dato anche che i
destinatari dei “doni” russi non sono proprio delle figlie di Maria e anzi
avrebbero tutto l’interesse a seminare zizzania. Il Wp riporta come i russi
siano molto interessati all’Afghanistan, come fosse una rivelazione geopolitica
bomba, mentre si tratta di una annotazione che appartiene alla storia, dato che
da tempo hanno aperto colloqui con i talebani, in parallelo agli Usa. Interesse
della Russia è stabilizzare il Paese, come spiegano al Wp gli esperti russi, per
evitare che la follia jihadista diventi realtà stabile del Paese e dilaghi oltre
i confini russi. Da questo punto di vista, spiegano gli esperti di Mosca, i
talebani si sono rivelati, nonostante tutto, un baluardo contro l’isis, da tempo
impegnata a prendere il controllo dell’estremismo afghano. Da qui i contatti dei
russi con i jihadisti locali, che peraltro hanno rapporti ben più oscuri con gli
Usa, dato che al Qaeda, di cui i talebani sono una costola, nasce come esercito
irregolare Usa lanciato a bomba contro i sovietici nella lunghissima guerra
afghana, che vide impegnati i russi contro i cosiddetti mujaheddin, molti dei
quali si erano affiliati all’organizzazione di Osama bin Laden, allora
funzionale agli interessi americani. Un esercito che peraltro ha dilatato in
maniera massiccia le coltivazioni di oppio nel Paese asiatico, da allora il
principale produttore mondiale (scalzando così il triangolo d’oro. Il Triangolo
d’oro è un’area dell’Indocina situata tra Birmania, il Laos e la Thailandia. La
produzione di eroina in quest’area raggiunse il picco in parallelo con
l’intervento Usa in Vietnam. Corsi e ricorsi storici), e inizia a trafficare in
droga, commercio che servì a finanziare la guerra per procura contro Mosca e poi
il terrorismo internazionale (sul traffico di droga in Afghanistan, un articolo
del Guardian).
Prolungare la
guerra e sabotare i negoziati Start. Secondo i russi interpellati dal Wp, la
rivelazione dell’intelligence Usa serve ad agitare le acque afghane, cioè a
evitare che vada a compimento l’accordo tra talebani e Washington che dovrebbe
portare al ritiro dei militari Usa dal Paese, chiudendo la prima delle guerre
infinite. Vero, tanto che lo scandalo esplode mentre le trattative vanno a
chiudersi, come dimostra la recente conversazione telefonica tra il Segretario
di Stato Mike Pompeo e i rappresentanti dei talebani (al Jazeera). Ma anche, a
più ampio raggio, per evitare il prolungamento dell’accordo Start sulla
produzione delle armi nucleari tra Mosca e Washington, che in questi giorni si
va profilando. Ne scrivevamo su Piccolenote sabato scorso, spiegando che lo
scandalo dei premi russi ai talebani esplode mentre Marshall Billingsea, per la
parte Usa, e Sergei Ryabkov, per i russi, stanno negoziando un prolungamento
dell’accordo Start sulle armi nucleari, intesa che la rivelazione rischia di
mandare a vuoto. A quanto pare a dar fuoco alle polveri di questo nuovo scandalo
è stato Bellingcat, uno strano team investigativo internazionale specializzato
nel riferire asserite malefatte russe. Bellingcat vs Billingsea, guerra di
assonanze. Il fondatore di Bellingat in un’intervista al Guardian, ebbe a
dire: “Riceviamo molti dei nostri soldi da donatori come la Open Society
Foundation [l’istituzione internazionale per le sovvenzioni finanziata dal
miliardario George Soros]”…Inutile rammentare che Soros ha il pallino della
Russia, avendo finanziato le rivoluzioni colorate nell’Est europeo, ultima delle
quali quella Ucraina. Nel suo ultimo libro-ciarpame, del febbraio del 2020,
individuando l’attuale momento come “rivoluzionario” (tale la potenzialità per
certi ambiti della pandemia Covid-19), individuava ancora una volta in Putin il
nemico da abbattere. E, insieme a lui, Trump.
Rivelazioni-bomba sui negoziati Usa-Russia sull'atomica.
Piccole Note il 27 giugno 2020 su Il Giornale. Un’unità dell’intelligence russa
avrebbe “offerto ricompense” ai talebani per gli attacchi compiuti in
Afghanistan, inclusi quelli contro obiettivi americani. La rivelazione giunge da
fonti interne all’intelligence Usa ed è stata sparata dai media americani con la
consueta inconsistenza giornalistica, cioè prendendo per vangelo quanto riferito
da fonti interessate e di parte, use anche a manovre oscure, che più volte si
sono rivelate fuorvianti (vedi Russiagate), senza porre e porsi le domande del
caso. Per rendere più odiosa la notizia, l’intelligence ha specificato che tale
attività segreta avveniva mentre si “svolgevano i negoziati” tra talebani e
americani, così che ai buoni americani, desiderosi di porre fine a una guerra,
sono contrapposti i cattivi russi, che pervicacemente hanno proseguito la loro
opera assassina nonostante le possibilità di pace. E per renderla ancor più
odiosa, e di più facile diffusione nel nostro Continente, le stesse fonti
riferiscono anche che la stessa agenzia russa è responsabile di alcuni “tentati
omicidi e altre attività coperte” in Europa. Che sia una bufala è palese, e tra
qualche mese, quando avrà avuto il suo effetto, è anche possibile che la
menzogna di oggi verrà rivelata come tale, come avvenuto per altre similari in
precedenza. Ma non è questo il punto, piuttosto occorre interpellarsi sul perché
tale notizia dirompente sia uscita proprio adesso, dopo mesi in cui la consueta
attività di disinformazione riguardo asserite malefatte russe, verso i quali
manca solo l’accusa di mangiare i bambini, era andata in qualche modo in sonno,
per lasciar posto a informazioni similari riguardanti i cinesi.
Bomba atomica
sul negoziato. Se si guarda l’agenda degli avvenimenti internazionali si può
notare che la “rivelazione” cade con un tempismo perfetto. Lunedì e martedì
scorso Sergei Ryabkov, viceministro degli Esteri russo, e Marshall S.
Billingslea, inviato presidenziale speciale degli Stati Uniti per il controllo
degli armamenti, si sono incontrati a Vienna per negoziare un prolungamento del
trattato START. Si tratta del primo incontro di alto livello tra russi e
americani dopo un lungo gelo. E che è stato reso possibile dalla
contro-inchiesta sul Russiagate, che ha evidenziato le manipolazioni degli
investigatori Usa per costruire inesistenti legami tra i russi e lo staff di
Trump nelle presidenziali 2016 (rivelazioni oscurate dai media). Caduto il Muro
di menzogne che aveva creato un abisso tra Trump e Putin, l’amministrazione Usa
ha così potuto tentare di riprendere il filo del dialogo Est-Ovest, peraltro su
un tema più che cruciale come quello delle armi atomiche. L’incontro deve
salvare l’ultimo trattato sulle armi nucleari che, se non sarà rinnovato, andrà
a scadenza a febbraio. Data apparentemente lontana, ma non troppo, dato che i
tempi di un simile negoziato sono lunghi e incombono le presidenziali Usa di
novembre. Se ci sarà un cambio della guardia alla Casa Bianca, difficilmente un
nuovo inquilino avrà modo di agire in tal senso, troppo stretti i tempi. La
rivelazione di “fonti dell’intelligence” Usa è tesa a mandare a vuoto i
negoziati avviati a Vienna: un rappresentante degli Stati Uniti non può
accordarsi con una nazione che ha perso vite di soldati americani. Si può
immaginare il caos che deriverebbe dal decadere anche di quest’ultimo trattato
sulle armi nucleari: senza tale freno, ricomincerà la corsa all’atomica.
Far cadere
Putin e Trump. Presumibilmente è proprio ciò che vogliono certi ambiti
internazionali votati al caos. The Nation ricorda che a spingere Trump a
stracciare il trattato INF, che regolava la produzione e il dispiegamento delle
atomiche a medio raggio, è stato il suo ex Consigliere alla Sicurezza nazionale
John Bolton (il giornale Usa elenca gli altri suoi nefasti successi in seno
all’amministrazione Usa, in un articolo in cui lo definisce, con certa
puntualità, “terrorista in gessato”). Si vuole innescare una nuova corsa agli
armamenti, nell’intento di ripetere quanto avvenne per l’Unione sovietica,
crollata sotto il peso del collasso dei prezzi del petrolio, già in atto, e il
prosciugamento delle risorse di Mosca nella corsa nucleare (causali cui va
aggiunta la guerra afghana, fattore che può ricrearsi in Siria o altrove –
Ucraina?). Non solo obiettivi di lungo periodo, la “rivelazione” vuol evitare
che Trump, che sta puntando molto su questo negoziato, ottenga un successo
diplomatico in vista delle presidenziali prossime venture. L’incontro di Vienna
prelude a un accordo. Ma, oltre ai negoziati a distanza, di certo proseguiti,
per concluderlo serve un ulteriore incontro. Ed è certo che Trump avrebbe voluto
che l’intesa si concretizzasse in un vertice tra lui e Putin. Adesso tutto è più
complicato. Ed è anzi possibile che a questa prima rivelazione si aggiungano
dettagli ulteriori che la rendano ancor più odiosa, o se ne aggiungano altre
dello stesso tenore. I terroristi in gessato – per stare alla definizione di The
Nation – sanno fare bene il loro mestiere. Posta alta, vicenda da seguire.
Le guerre
dei presidenti americani, dal 1945 a oggi.
Mauro Leonardi su agi.it l'8 gennaio 2020. Tutti i presidenti Usa hanno iniziato
una guerra, o l'hanno continuata. Da Truman a Obama, tutti i conflitti. Con la
pioggia di missili iraniani sulle basi USA in Iraq, l'anno inizia nel peggiore
dei modi possibili ma, dopo l'assassinio del generale Soleimani la reazione
iraniana era scontata, anzi era l'unica possibile. Per questo desta solo
preoccupazione il tweet di Trump quando dice: "Abbiamo di gran lunga l'esercito
più potente e ben equipaggiato al mondo". Sarebbe troppo semplice, però,
prendersela con Trump visto che tutti - proprio tutti - i presidenti americani
fanno la guerra. Avviene quando, secondo loro, c'è da difendere gli interessi
degli USA. E non importa se sono repubblicani o democratici. Pare essere il
destino del Capo dell'America: alla fine, se pensi sia nei tuoi interessi, la
guerra la fai. È stato detto che Soleimani fosse "mostruoso" e naturalmente
altri hanno detto che mostruoso era Trump. Ma la vera mostruosità è quello di
rendere ineluttabile un meccanismo per cui, per ogni mandato, un Presidente
degli USA deve fare almeno una guerra. Chi non ci credesse può facilmente fare
una ricerchina e scoprire tutte le guerre dei Presidenti degli Stati Uniti; io
l'ho fatto a partire dalla seconda guerra mondiale e la offro qui sotto in
sintesi.
Harry Truman
(1945-1953, Democratico) è stato l'uomo della Guerra di Corea.
Dwight D.
Eisenhower (1953-1961, Repubblicano) ereditò la Guerra di Corea e giunse
all'armistizio ma impegnandosi nell'escalation della Guerra Fredda: aveva l'idea
che gli americani dovessero essere più aggressivi nei confronti di Mosca.
John
Fitzgerlad Kennedy (1961-1963, Democratico) portò in pochi mesi i consiglieri
militari statunitensi in Vietnam da qualche centinaio a 16.000 e, di fatto, fu
l'iniziatore del conflitto che avrebbe segnato l'America per generazioni. Fu
anche il presidente della Baia dei Porci, e cioè del tentativo, fallito, di
invadere la Cuba di Fidel Castro.
Lyndon
Johnson (1963-1969, Democratico) fu colui che prese il posto di Kennedy e verrà
ricordato per l'escalation della Guerra del Vietnam. Nel 1965, Johnson ordinò
anche l'invasione della Repubblica Domenicana per rovesciare il governo
socialista di Juan Bosch Gavino.
Richard Nixon
(1969-1974, Repubblicano) chiuse la guerra in Vietnam dopo un'escalation di
bombardamenti a tappeto sulle città e le campagne del Nord e, segretamente, in
Cambogia e Laos. Divenne, nonostante non lo avesse iniziato, il simbolo negativo
di quel conflitto.
Gerald
Ford (1974 -1977, Repubblicano): in così poco tempo, il successore di Nixon non
combatté tecnicamente alcuna guerra, anche se chiese al Congresso il permesso di
farne una. Infatti, nonostante gli accordi di Pace di Parigi del 1973, nel
dicembre del 1974, le colonne militari nord-vietnamite si diressero verso il Sud
e il governo sud-vietnamita chiese aiuto agli Usa. Ford allora decise
l'intervento ma Capitol Hill disse di no.
Jimmy
Carter (1977-1981, Democratico): quando l'unione sovietica invase l'Afghanistan
mandò aiuti militari segreti ai mujaheddin afghani, attraverso i sauditi e i
pachistani. Fu la sua guerra e l'embrione di quella che divenne la jihad di
Osama Bin Laden contro gli Stati Uniti. Carter fallì anche il blitz militare per
liberare gli ostaggi dell'ambasciata americana a Teheran.
Ronald
Reagan (1981-1989, Repubblicano), dopo aver chiuso la Guerra Fredda, fu
protagonista di due azioni militari: l'invasione di Grenada nel 1983, decisa
perché un regime filo marxista non si affiancasse a quello di cubano in
quell'area; il bombardamento di Tripoli nel 1986 con l'obiettivo di colpire
Gheddafi.
George H. W.
Bush (1989-1993, Repubblicano) combatté e vinse la prima guerra del Golfo, dopo
l'invasione da parte di Saddam Hussein del Kuwait. Diede anche l'ordine di
invadere Panama: nel dicembre del 1989, 24.000 soldati americani sbarcarono nel
piccolo, ma importantissimo stato del Centroamerica per abbattere il dittatore
Manuel Noriega.
Bill
Clinton (1993-2001, Democratico) inviò e poi ritirò le truppe americane dalla
Somalia. Due anni dopo, ordinò i raid aerei contro i serbi di Bosnia per
costringerli a trattare e, dopo gli accordi di Dayton, dispiegò una forza di
pace nei Balcani. Nel 1998, in risposta agli attentati di Al Qaeda, per
ritorsione fece bombardare obiettivi in Afghanistan e in Sudan. Un anno dopo, il
teatro di guerra tornò ad essere i Balcani: gli Usa furono protagonisti della
Guerra del Kosovo e della caduta di Milosevic.
George W.
Bush (2001-2009, Repubblicano) è il presidente delle due ultime guerre americane
(a questo punto, "penultime") in grande stile: Afghanistan e Iraq come risposta
all'attacco delle Torri Gemelle. Se la prima ebbe l'appoggio di quasi tutti gli
americani, la seconda invece venne largamente contestata dall'opinione pubblica
statunitense e mondiale.
Barack
Obama (2009-2017, Democratico) è da subito contrario all'invasione dell'Iraq,
eletto per far tornare le truppe a casa da Bagdad e Kabul, e vincitore del Nobel
per la Pace, oltre ai noti interventi in Siria, Libia, Iraq e Afghanistan, ha
bombardato anche lo Yemen, la Somalia e il Pakistan. Secondo alcuni analisti è
stato il presidente americano che ha tenuto in guerra gli Stati Uniti per più
tempo.
Sono
ragionamenti semplici, che chiunque può fare, e convergono verso un'unica
domanda semplice: per quale motivo ogni Presidente degli Stati Uniti, a
prescindere dalla sua appartenenza politica, si sente in dovere di fare almeno
una guerra durante il proprio mandato?
Tutte le
guerre dei presidenti americani. Democratico o repubblicano: non c'è molta
differenza se sei il comandante in capo e devi difendere gli interessi
dell'America.
Lo speciale sulla guerra in Siria Michele Zurleni su Panorama il 3 Settembre
2013. Barack Obama era l'uomo che doveva far uscire l'America da due guerre e
ora rischia di essere il presidente che coinvolgerà gli Stati Uniti in un'altra
azione militare. Lui, contrario all'invasione dell'Iraq, eletto per far tornare
le truppe a casa da Bagdad e Kabul, dopo aver deciso di entrare in guerra con la
Libia nel 2011, ora dovrà (Congresso permettendo) dare l'ordine di attaccare la
Siria. L'emblema, l'icona di un'America diversa, multilaterale e impegnata a
ricostruire la sua influenza globale sulla base del soft power, si ritrova,
improvvisamente, dall’altra parte della barricata, laddove sedeva il suo tanto
contestato predecessore, George W. Bush. E' il destino del Comandante in Capo.
Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale non c'è presidente americano che non
sia stato coinvolto in una guerra. Repubblicano e democratico che fosse. Con
molte differenze, storiche e politiche, a seconda del conflitto preso in esame.
Ma quando siedi nello Studio Ovale e devi difendere gli interessi strategici
degli Usa, alla fine, se ritieni di dover usare la forza, lo fai. Questo è un
elenco delle guerre dei presidenti degli Stati Uniti dal 1950 in poi.
1) Harry
Truman, 12 aprile 1945 - 20 gennaio 1953 (Democratico). Fu l'uomo della Guerra
di Corea. Quando le truppe di Pyongyang e della Cina invasero la zona sud della
penisola coreana, il successore di Franklin Delano Roosevelt, su mandato
dell'Onu, decise di rispondere. Fu il primo conflitto armato della Guerra
Fredda. Truman diede l'ordine di intervenire senza chiedere l'autorizzazione del
Congresso degli Stati Uniti. Non era necessario, disse, perché la risoluzione
delle Nazioni Unite gli dava la legittimità di iniziare le operazioni belliche
senza avere il segnale verde da Capitol Hill. Fu il primo a bypassare il
parlamento americano. Molti altri presidenti seguiranno questa "tradizione".
2) Dwight D.
Eisenhower, 20 gennaio 1953 - 20 gennaio 1961 (Repubblicano). Il generale del
D-Day, il soldato che aveva sconfitto sul fronte occidentale la Germania
nazista, quando venne eletto presidente ereditò la Guerra di Corea, ma solo per
condurre le trattative che nel luglio del 1953 portarono all'armistizio tra le
parti. Ma Ike fu soprattutto un presidente impegnato nell'escalation della
Guerra Fredda con l’Unione Sovietica. La sua idea era che la politica americana
doveva essere più aggressiva nei confronti di Mosca. Quella fu la sua arma in
quel conflitto.
3) John
Fitzgerlad Kennedy, 20 gennaio 1961 - 22 novembre 1963 (Democratico). Nel suo
breve mandato, l'uomo della Nuova Frontiera, moltiplicò il numero di consiglieri
militari statunitensi in Vietnam, portandoli da poche centinaia a 16.000 in
pochi mesi. Fu, di fatto, il vero inizio del conflitto che avrebbe segnato
l'America per generazioni. JFK fu anche il presidente della Baia dei Porci, il
tentativo, fallito, di invadere la Cuba di Fidel Castro. Una smacco politico (ma
anche militare) per gli Stati Uniti. La terza guerra, quella che Kennedy evitò,
avrebbe potuto essere la più terribile. Ma fu grazie alla sua fermezza che i
sovietici ritirarono i missili da Cuba, dopo una crisi internazionale che
avrebbe potuto portare a un conflitto nucleare.
4) Lyndon
Johnson - 22 novembre 1963 - 20 gennaio 1969 (Democratico). Il presidente
dell'escalation in Vietnam: in politica estera, il texano che prese il posto di
JFK dopo l'assassinio di Dallas, verrà ricordato per questo. Grazie
all'incidente del Golfo del Tonchino, l'attacco a una nave militare americana
(architettato ad arte dall'amministrazione statunitense, secondo molti storici e
giornalisti), Johnson ottenne carta bianca dal Congresso per la guerra nel sud
est asiatico. Centinaia di migliaia di soldati vennero mandati in Vietnam,
migliaia di loro tornarono nei body bags, nei sacchi neri che custodivano i loro
cadaveri. Nel 1965, Lyndon Johnson ordinò l'invasione della Repubblica
Domenicana per rovesciare il governo socialista di Juan Bosch Gavino.
5) Richard
Nixon, 20 gennaio 1969 - 9 agosto 1974 (Repubblicano). Durante la campagna
elettorale che lo portò alla Casa Bianca promise di mettere ne al conflitto e di
"conquistare la pace nel Pacifico". Alla ne, fu lui a chiudere il capitolo della
guerra in Vietnam dopo un’escalation di bombardamenti a tappeto sulle città e le
campagne del Nord e (segreti) in Cambogia e Laos, azioni per le quali venne
duramente criticato. Nixon divenne il simbolo (negativo) di quel conflitto così
contestato da una parte della società americana nonostante non fosse stato lui a
iniziarlo.
6) Gerald
Ford, 9 agosto 1974 - 20 gennaio 1977 (Repubblicano). Nel suo breve periodo alla
Casa Bianca, il successore di Nixon dovette affrontare una sola crisi bellica,
ma non combattè alcuna guerra. Nonostante gli accordi di Pace di Parigi del
1973, nel dicembre del 1974, le colonne militari nordvietnamite si diressero
verso il Sud. Il governo sudvietnamita chiese aiuto agli Usa. Gerald Ford allora
si rivolse al Congresso un pacchetto di aiuti militari per 520 milioni di
dollari, ma Capitol Hill disse di no. Il 21 aprile del 1975, il presidente Thieu
si dimise e due giorni dopo, Gerald Ford tenne un discorso in cui affermò che
per gli Usa, il conflitto in Vietnam era definitivamente chiuso.
7) Jimmy
Carter, 20 gennaio 1977 - 20 gennaio 1981 (Democratico). La sua reazione
all'invasione sovietica dell'Afghanistan fu quella di mandare aiuti militari
(segreti) ai mujaheddin afghani, attraverso i sauditi e i pachistani. Quella fu
la sua guerra. Ma anche l'embrione di quella che divenne la jihad di Osama Bin
Laden contro gli Stati Uniti. Carter verrà anche ricordato per il fallito blitz
militare per liberare gli ostaggi dell'ambasciata americana a Teheran.
8) Ronald
Reagan, 20 gennaio 1981 - 10 gennaio 1989 (Repubblicano). E' il presidente che
ha chiuso (e vinto) la Guerra Fredda con l'Unione Sovietica. Durante il suo
quasi decennio di permanenza alla Casa Bianca, l'ex governatore della California
è stato il protagonista di altre due azioni militari: La prima fu l'invasione di
Grenada nel 1983, decisa per paura che un regime lo marxista si affiancasse a
quello di cubano in quell'area. Le truppe furono inviate per ristabilire un
ordine costituzionale dopo che un colpo di stato militare aveva eliminato il
governo eletto nel 1979 nell’isola caraibica. La seconda, invece, fu il
bombardamento di Tripoli nel 1986 con l'obiettivo di colpire Muhammar Gheddafi
dopo che un attentato in una discoteca di Berlino aveva provocato una vittima
americana e numerosi feriti. Inoltre, Ronald Reagan era alla Casa Bianca quando
nell'ottobre del 1983, 241 soldati americani vennero uccisi in un attentato con
un camion bomba a Beirut. Un anno dopo, il presidente ordinò il graduale ritiro
dei marines che facevano parte della forza multinazionale di pace in Libano.
9) George H.
W. Bush, 20 gennaio 1989 - 20 gennaio 1993 (Repubblicano). Il successore di
Reagan fu il presidente che combattè e vinse la prima guerra del Golfo. Dopo
l'invasione da parte di Saddam Hussein del Kuwait, Washington lanciò un
ultimatum al dittatore iracheno. Una forza multinazionale di 500.000 soldati
venne dispiegata in Arabia Saudita per ristabilire il legittimo governo nel
piccolo paese del Golfo. Il 16 gennaio del 1991 iniziarono i bombardamenti su
Bagdad, sulle altre città irachene e sulle trincee dell'esercito di Saddam In
Kuwait. Un mese dopo, gli iracheni si ritirarono dal paese invaso. Ma quella del
Golfo non fu l'unica guerra di G.H. Bush. Il Numero 41 diede anche l'ordine di
invadere Panama: nel dicembre del 1989, 24.000 soldati americani sbarcarono nel
piccolo, ma importantissimo stato del Centroamerica per abbattere il dittatore
Manuel Noriega, una volta amico degli Usa. Infine, durante il suo mandato ci fu
il crollo del Muro di Berlino, atto finale (e non solo simbolico) della Guerra
Fredda.
10) Bill
Clinton, 20 gennaio 1993 - 20 gennaio 2001 (Democratico). L'ex governatore
dell'Arkansas è il presidente che ha inviato (ma la decisione di partecipare
alla missione era stata del suo predecessore) e ha poi ritirato le truppe dalla
Somalia. Impiegati nel 1993 in missione di peacekeeping, i soldati americani
vennero coinvolti nella battaglia di Mogadiscio, subendo numerose perdite. Fu
quell’episodio che convinse Clinton a lasciare il paese africano al suo destino.
Due anni dopo, Bill Clinton ordinò i raid aerei contro i serbi di Bosnia per
costringerli a sedersi al tavolo delle trattative e poi, dopo gli accordi di
Dayton dispiegò una forza di pace nei Balcani. Nel 1998, in risposta agli
attentati di Al Qaeda contro le ambasciate Usa in Tanzania e Keyna, il
presidente, per ritorsione, fece bombardare obiettivi in Afghanistan e in Sudan.
Un anno dopo, il teatro di guerra tornò ad essere i Balcani. Gli Usa di Bill
Clinton furono i protagonisti della Guerra del Kosovo e della conseguente caduta
di Slobodan Milosevic.
11) George W.
Bush, 20 gennaio 2001 - 20 gennaio 2009 (Repubblicano). E' il presidente delle (pen)ultime,
due guerre americane: Afghanistan e Iraq. E' stata questa la sua risposta
all'attacco delle Torri Gemelle. E, se la prima ha avuto l'appoggio di quasi la
totalità degli americani, la seconda, invece, è stata largamente contestata
dall'opinione pubblica statunitense e mondiale. Tra coloro che manifestavano il
loro dissenso all'invasione di Bagdad del 2003 c'era anche Barack Obama.
I Presidenti
USA e le loro guerre. Da Agerecontra.it il 10 giugno 2020 da Staff "Christus
Rex".
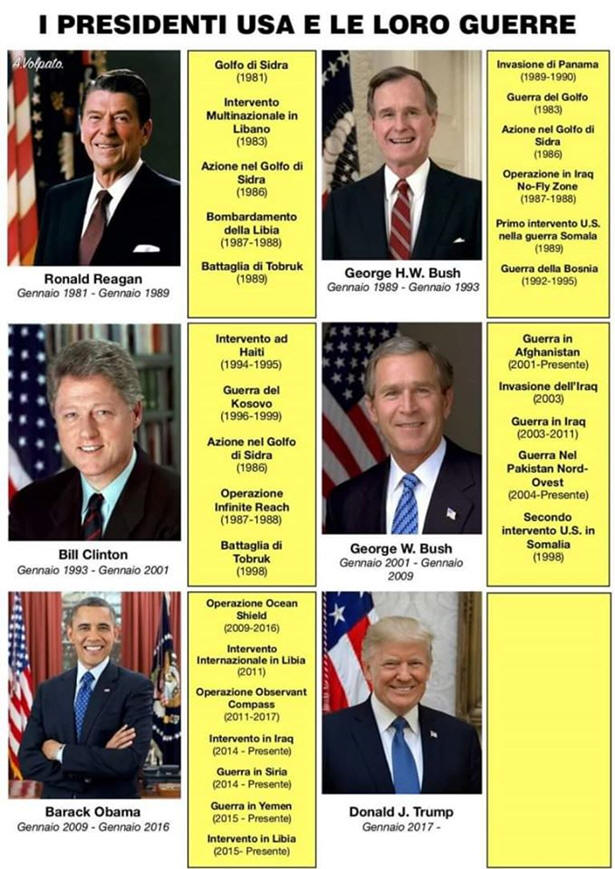
Dalla guerra contro lo straniero ai dipinti sui migranti: La
redenzione del compagno Bush. Vittorio Ferla su Il
Riformista il 12 Agosto 2020. L’ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush pubblicherà
a marzo, per l’editore Crown, un libro che conterrà 43 ritratti di immigrati, da
lui stesso dipinti. Il libro – i cui proventi saranno donati alle organizzazioni
che favoriscono l’inserimento degli immigrati – uscirà in concomitanza con la
mostra sul valore dell’immigrazione americana ospitata dal George W. Bush
Presidential Center, sito a Dallas, in Texas: qui – dove il Presidente si è
ritirato al termine del secondo mandato nel 2009 – sarà possibile visionare le
sue opere.
I dipinti di George W. Bush? Il presidente che, dopo l’attacco
alle Torri gemelle, diede il via alla guerra in Afghanistan, nel nome della
lotta al terrorismo, con l’obiettivo di rovesciare il regime talebano,
distruggere Al Qaida e catturare Osama Bin Laden? Lo stesso che poi, nel 2003,
non contento, avviò la guerra contro l’Iraq allo scopo di deporre il dittatore
locale Saddam Hussein, per una serie di ragioni tra le quali una – la detenzione
di armi di distruzione di massa – che si rivelò completamente infondata? Colui
che inventò la dottrina Bush – appunto – una sorta di diritto militare di
intervento in qualsiasi parte del mondo in cui uno “Stato canaglia” minacciasse
di attentare alla libertà e alla democrazia? Lo stesso leader che, nel nome
della guerra contro il terrorismo, adottò lo Usa Patriot Act con il quale, in
situazioni particolari (vedi Baia di Guntanamo), potevano essere sospesi
i diritti civili? Sì, esatto, proprio lui. George W. Bush, l’ultimo presidente
guerrafondaio della storia americana è diventato un pacifico pittore amatoriale.
Dopo aver lasciato l’incarico nel 2009, Bush inizia a dipingere, mantenendo
segreto il suo nuovo hobby. Ispirato dal primo ministro britannico Winston
Churchill, Bush scopre il potere rilassante della pittura e prende lezioni da un
insegnante d’arte, alla ricerca del suo “Rembrandt interiore”. Ma i dipinti
dell’ex presidente sono diventati pubblici nel 2013, quando l’hacker Guccifer violò
l’account di posta elettronica di sua sorella Dorothy Bush. Molti dei suoi
ritratti – inclusi quelli di suoi autorevoli colleghi: da Vladimir Putin al Dalai
Lama, da suo padre, l’ex presidente George H.W. Bush fino a Silvio Berlusconi
– sono esposti nella biblioteca presidenziale a Dallas. Nell’ottobre scorso, il Kennedy
Center di Washington ha ospitato una mostra intitolata “Ritratti di coraggio”:
uomini e donne – dipinti da Bush – che hanno prestato servizio nelle forze
armate statunitensi dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001.
Sbaglieremmo, però, ad archiviare la pubblicazione di questo libro tra le pagine
culturali. Basta leggere il titolo: Out of Many, One, traduzione del sacro motto
E Pluribus Unum, quello che ispira gli americani dai tempi della Dichiarazione
di Indipendenza. Gli Usa sono un paese mosaico fatto di immigrati, una
composizione di tessere diverse – più o meno riuscita – provenienti
dall’Europa, dall’Africa e dall’America del Sud. Proprio a partire da questo
miscuglio di origini, il senso di unità ha un valore e una potenza quasi
religiosi. D’altro canto, come potrebbe sopravvivere un paese originato dalle
diversità se non attribuendo all’unità il senso di una religione costituzionale?
Anche Bush, conservatore e repubblicano, è fortemente intriso di questa cultura.
Nella presentazione del suo prossimo volume si legge: “Attraverso potenti
ritratti a quattro colori e le loro storie di accompagnamento, Out of Many, One
ci ricorda gli innumerevoli modi in cui l’America è stata rafforzata dagli
individui che sono venuti qui in cerca di una vita migliore”. Nell’introduzione
del libro, Bush esprime la speranza che le sue opere potranno aiutare a fare
dell’immigrazione una questione unificante ed edificante. “Riconosco che
l’immigrazione può scatenare reazioni emotive, ma rifiuto la premessa che sia
una questione di parte. È forse la più americana delle questioni, e dovrebbe
essere quella che ci unisce”, scrive Bush. “La mia speranza – aggiunge – è che
questo libro aiuterà a focalizzare la nostra attenzione collettiva sull’impatto
positivo che gli immigrati producono sul nostro Paese”. Pronunciate nel Paese
di Martin Luther King, John Lewis, Malcom X e tanti altri, queste parole sono la
dimostrazione che i valori dell’unità e del rispetto delle diversità non sono
solo il patrimonio della sinistra liberal, ma sono un pilastro fondamentale
della stessa identità americana. In più, pronunciate nel paese di George Floyd,
dopo che un presidente ha minacciato di mandare l’esercito contro i manifestanti
del movimento Black Lives Matter, queste parole rivelano che, perfino
nell’America più tradizionale e conservatrice, i messaggi di divisione interna e
di astio contro le minoranze sono mal sopportate. Nei mesi scorsi, Bush non ha
mancato di esporre critiche (velate) alla Casa Bianca. Già nel 2018, il giorno
dopo l’emissione da parte di Trump linee guida restrittive contro i richiedenti
asilo al confine Bush dichiarò di essere “turbato” dal dibattito
sull’immigrazione in corso negli Stati Uniti. Viceversa, elogiò la storia degli
immigrati in America, definendola “una benedizione” per la nazione. In occasione
dei funerali di John Lewis, rappresentante democratico al Congresso e storico
leader dei diritti civili degli afroamericani, George Bush era presente accanto
agli ex presidenti democratici come Barack Obama e Bill Clinton. Così, l’assenza
di Donald Trump è stata ancora più evidente e imbarazzante. Molta parte
dell’establishment repubblicano vive con lo stesso enorme imbarazzo la
leadership dell’attuale inquilino della Casa Bianca. Forse a novembre prevarrà
la realpolitik di chi cerca la riconferma del seggio al Congresso. Ma qualcosa
sta cambiando. Anche nel Texas della famiglia Bush. Qui – dove Trump aveva vinto
con 9 punti di vantaggio sulla Clinton e, prima, Romney con 15 punti di
vantaggio su Obama – i sondaggi danno un pareggio tra il presidente in carica e
il candidato democratico, Joe Biden. Nel libro Dio salvi il Texas, lo scrittore Lawrence
Wright segnala un paradosso: quello di uno Stato che, da un lato, si sposta
ancora più a destra, con il rischio di trascinare con sé l’intero Paese, ma che,
dall’altro, mostra evidenti segnali di cambiamento del suo corpo elettorale,
grazie al ruolo sempre più incisivo giocato dalle minoranze ispaniche, al punto
da ipotizzare, in un futuro non troppo lontano, una riscossa democratica. In
pratica, se gli ispanici votassero in Texas al ritmo in cui votano
in California, spiega Wright, lo Stato sarebbe già democratico. Chissà se –
armato stavolta di tela e pennelli come George W. – il Texas della famiglia Bush,
il Texas fondato su petrolio, cotone e bestiame, il Texas dominato da cowboy,
pistoleros e petrolieri, il Texas di film come Il Gigante o di telefilm come
Dallas non ci dia qualche grossa sorpresa alle elezioni presidenziali di
novembre.
L’Esercito statunitense mira a guardare attraverso i muri.
Matteo Acciaccarelli su Inside Over il 10 febbraio
2020. the world. Nel prossimo futuro i soldati dell’Esercito
statunitense potrebbero avere una conoscenza piena di tutto ciò che avviene nel
campo di battaglia, riuscendo a osservare la situazione anche “oltre ai muri”.
Questo è ciò che emerge dalla recente richiesta di informazioni (Rfi, Request
for Information) pubblicata dal Pentagono, nel quale viene avanzata la
possibilità alle aziende interessate di presentare dei progetti di visori di
nuova generazione (Sttw, Sense Through the Wall) Una tecnologia considerata
fondamentale per aumentare il livello di sicurezza dei soldati impegnati nei
teatri operativi, ma anche importante per assicurarsi una maggiore velocità e
precisione nelle missioni.
Come sarà il visore. Vedere attraverso un muro, infatti,
assicurerebbe la piena conoscenza della situazione prima di
intervenire, minimizzando i rischi e massimizzando i risultati sapendo già dove
colpire per neutralizzare le potenziali minacce. L’obiettivo del programma
dell’Esercito statunitense è proprio “di rilevare, identificare e monitorare
personale e materiali dietro qualsiasi ostacolo”. Un progetto complicato da
portare a termine, soprattutto perché nonostante i diversi tentativi già messi
in atto non sono stati ancora sviluppati dei sensori capaci di ciò. Non solo
vedere attraverso i muri, ma il visore ottico di nuova generazione –secondo le
aspettative del Pentagono– dovrà avere anche la capacità di mappare tutta la
struttura in esame, rilevando eventuali stanze o passaggi nascosti o
sotterranei. Nella richiesta viene sottolineato come l’Sttw, qualora dovesse
essere prodotto, sarebbe inizialmente ad uso esclusivo delle forze speciali
dell’Esercito; ma non è da escludere che se dovesse essere veramente efficiente
il suo impiego sarebbe esteso a tutte le divisioni impegnate nei teatri
operativi. Per essere utilizzabile, i tecnici dell’Esercito e del Pentagono
hanno posto alcuni requisiti minimi tra cui la possibilità di utilizzarlo
per lunghi periodi di tempo e in qualsiasi luogo e condizione atmosferica, otre
che indifferentemente di giorno e di notte. Inoltre, i sensori alla base del
visore dovrebbero essere capaci di identificare tra amico e nemico (Iff;
Identification friend or foe) e distinguere gli uomini dagli animali, in modo
tale da limitare possibili errori.
Quali le alternative? Questo, però, non è il primo tentativo da
parte del Pentagono di richiedere alle aziende di sviluppare un sistema capace
di vedere “oltre i muri”, ma nonostante gli sforzi non è stato ancora presentato
un prototipo effettivamente impiegabile in teatro operativo. L’Esercito, però,
per scongiurare questa evenienza ha messo in campo non solo il comando delle
forze speciali, ma anche quelli destinati allo sviluppo delle
capacità C5ISR (Comando, controllo, comunicazioni, cyber, sistemi di
combattimento, intelligence, sorveglianza e ricognizione) di nuova generazione.
Difficilmente, però, si arriverà alla realizzazione di visori a raggi
x collegati a dei sensori che trasmettono –in tempo reale– una mappa dettagliata
del luogo in questione con l’esatta localizzazione di ogni potenziale bersaglio.
Più probabilmente per riuscire in ciò si farà utilizzo di velivoli a guida
remota terrestri (Ugv, Unmanned ground vehicles) e volanti (Uav, Unmanned aerial
vehicle) di ridotte dimensioni che, grazie ai sensori e alle telecamere
presenti, potrebbero ritrasmettere su un tablet ciò che avviene dentro un luogo
chiuso, assicurando la piena –o quasi– consapevolezza operativa ai soldati. Un
progetto, questo, per certi versi più semplice da realizzare, anche se non
sarebbe risolutivo per assicurare la massima sicurezza dei soldati, che
rischierebbero di rilevare la loro posizione o di essere scoperti. Le altre
soluzioni potrebbero arrivare tramite il potenziamento dei sensori termici già
in uso alle forze speciali, come il Range-R che indica la presenza umana dietro
un qualsiasi ostacolo in muratura tramite il rilevamento della temperatura
corporea. Oltre ai sensori termici, anche l’utilizzo e lo sfruttamento dei
ripetitori e dei modem Wi-Fi da modo di individuare corpi umani da dietro un
muro. Entrambi questi sistemi, però, hanno dei limiti fisici impossibili da
superare e che creano dei punti deboli potenzialmente pericolosi. Proprio per
questo motivo, forse, l’utilizzo di droni terrestri e volanti di ridottissime
dimensioni potrebbe essere l’unica soluzione percorribile per l’Esercito
statunitense. Di certo c’è che il soldato del futuro sarà dotato anche di questa
importante capacità.
La guerra fantasma degli Usa in Africa tra forze speciali e
basi nel deserto. Alberto Bellotto il 10 agosto 2020
su Inside Over. Tenere traccia delle operazioni americane in Africa non è
semplice. Ufficialmente il Pentagono smentisce un coinvolgimento massiccio. Si
limita a timide considerazioni e conferma che la sola base a stelle e strisce
attiva nel continente è quella di Camp Lemonnier, in Gibuti. In realtà uomini e
mezzi americani sono presenti in quantità sul suolo africano. Grazie a una
richiesta di accesso agli atti, il sito The Intercept è riuscito a mettere le
mani su alcuni documenti dell’Africom, che certificano come l’impronta
statunitense sia molto più estesa. Nei documenti si scopre che gli avamposti
sono ben 27 distribuiti in 15 Paesi. Molti di questi sono concentrati tra Africa
Occidentale e Corno d’Africa. Le autorità hanno poi stilato una sorta di
classificazione distinguendo le strutture in “Enduring” e “Non-Enduring”. Nella
prima categoria, nella quale ricadono 15 strutture, ci sono tutte quelle basi
che forniscono “un accesso strategico per supportare gli interessi di sicurezza
degli Stati Uniti.” Le seconde, denominate anche “posizioni di emergenza” sono
invece dei punti di appoggio per operazioni di contingenza o limitate. Però
anche qui non è chiaro quanto siano attive dato che possono essere a loro volta
classificate come semi permanenti. Rispetto ai dati del 2018, fa notare The
Intercept, il numero di avamposti è diminuito di circa sette unità. Due anni fa,
infatti. la posizioni identificate erano state 34. Il problema è che non è stato
semplice identificare quelle chiuse. Facendo un confronto tra i documenti
ottenuti dal portale in due anni diversi si scopre che una delle strutture in
chiusura è la base di Gaborone, in Botswana; mentre altre quattro sono
classificate come strutture secondarie, in particolare Faya Largeau in Ciad,
Lakipia in Kenya, Benina in Libia e Gao in Mali. Non è però stato possibile
individuare le altre due strutture chiuse, ma il dipartimento della Difesa ha
ribadito che non si tratta di altre strutture chiuse in Libia, già smantellate
per la forte instabilità nel Paese.
L’ambiguità del Pentagono. Nonostante i documenti, il
dipartimento della Difesa continua a mantenere una certa ambiguità.
Pubblicamente i portavoce affermano che l’impegno americano nel continente è
molto limitato. Ma nelle audizioni alle commissioni Difesa di Camera e Senato
ufficiali e comandanti dell’Africom continuano a sostenere la necessità di una
presenza costante e strutturata. A inizio maggio il magazine d’inchiesta
sudafricano Mail & Guardian è entrato in possesso di alcuni leak dell’Africom
che rivelano un piano strutturato per rinforzare l’attuale network di basi, con
strutture snelle e di basso profilo. Nei documenti si legge di un progetto da
330 milioni con una lista di strutture prioritarie da sviluppare tra il 2021 e
2025. Negli stessi documenti, continua il magazine, è scritto che il piano
potrebbe essere esteso e ampliato con un arco di circa 20 anni. Tra i dettagli
del dossier ben 12 progetti da realizzare in tre Paesi: Niger, Gibuti e Kenya.
Ma gli americani non si muovono solo attraverso strutture proprietarie. In molti
casi si appoggiano a basi dei paesi ospitanti. E qui risulta molto difficile
mapparne la presenza. Due esempi di questa presenza ombra sono le strutture di
Theis, in Senegal e Singo, in Uganda. Ufficialmente controllate dai governi
locali, ma usate anche da personale americano. Questo rende molto difficile
anche sapere quante sono le truppe stanziate. Una stima parla di circa 6 mila
uomini sparsi dal Sahel fino al Corno d’Africa. Molti di questi, circa 4 mila,
si trovano a Camp Lemonnier, altri 500 sarebbero invece quelli delle forze
speciali in Somalia e 1200 circa quelli impegnati in West Africa.
Niger: la frontiera della lotta al jihadismo. Negli ultimi anni
uno degli scenari in cui gli americani si sono mossi di più è stato il Niger.
Nel Paese, che ospita almeno sei basi, ci sarebbero circa 800 uomini. La luce
sulle operazioni americane nel Paese si è accesa nell’ottobre del 2017 quando
quattro soldati americani sono rimasti uccisi in un’imboscata jihadista nel
cuore del deserto nigerino. Il commando stava lavando con le forze di sicurezza
del Paese nel centro di Oullam nell’ambito di un’operazione antiterrorismo in
Africa Occidentale denominata Juniper Shield. Ma il coinvolgimento non si ferma
qui. Nell’avamposto di Diffa nel Sud-Est del Paese le unità speciali si occupano
dell’addestramento delle forze di intervento del Niger che operano nell’area del
Lago Ciad, mentre in un altro distaccamento, ad Arlit, svolgono operazioni e
addestramenti per l’antiterrorismo. Ma il Niger è uno snodo chiave anche per la
base aerea da 110 milioni di dollari realizzata ad Agadez e costruita per
ospitare droni americani che operano in tutto il Sahel e nel Nord Africa. I
progetti dell’Africom prevedono anche l’estensione di questa base con nuove
strutture da realizzare nel 2021 e 2022 per migliorare le operazioni di
sorveglianza. Nei leek di Mail & Guardian si legge che per il comando americano
in Africa il Niger è centrale nelle operazioni antiterrorismo per almeno i
prossimi 10-20 anni.
Corno d’Africa: l’avamposto per la lotta ad Al-Shabaab. Il
secondo punto caldo per gli americani è rappresentato dal Corno d’Africa. Oltre
alla già citata Camp Lemonnier e alla base di Manda Bay in Kenya – assaltata in
gennaio da miliziani di Al-Shabaab – gli americani hanno almeno cinque avamposti
in Somalia e programmano di ampliare le operazioni con almeno altre tre
strutture “non-enduring” nelle zone meridionali del Paese. L’altro grande
investimento nella zona riguarda il Gibuti. Oltre all’allargamento della
capienza di Lemonnier fino a 5 mila uomini entro il 2025, il programma è quello
di creare altri punti di appoggio nel piccolo paese affacciato sullo stretto di
Bab el-Mandeb. Gia nel 2015 Washington aveva messo le mani sul campo di volo di
Chabelley trasformandolo in un punto di partenza per missioni coi droni in
Africa, Yemen, Iraq e Siria. I diritti di sfruttamento per la base, usata anche
per operazioni della Delta Force in Somalia, scadranno nel 2024, ma potranno
essere rinnovati fino al 2034. Per questo motivo sono pronti altri investimenti
per ampliare e fortificare la struttura. Persino la base di Manda Bay otterrà
nuovi fondi, circa 34 milioni di dollari, per migliorare il sito e renderlo più
resistente agli attacchi dei qaedisti di Al-Shabaab. Sul piatto ci sarebbe
l’allungamento della pista di volo, un miglioramento degli alloggi per portare
nel centro altre 325 unità di personale.
Le operazioni fantasma con gli “127-echo programs”. Rispetto ad
altri scenari dove è forte la contrapposizione tra potenze, come quella con la
Russia in Europa e quella contro la Cina in Asia orientale, il fronte africano
resta legato alla lotta al terrorismo. E in questo gli Usa restano ampiamente
coinvolti. Il generale di brigata in pensione Don Bolduc, che ha servito
nell’Africom fino al 2015, ha raccontato che tra il 2013 e 20107 le forze
speciali americane sono entrate in azione in 13 Paesi africani. Un’inchiesta di
Yahoo News pubblicata circa un anno fa ha rilevato che sono state almeno 36 le
operazioni compiute da soldati americani sul suolo africano. A queste vanno
contate anche otto incursioni denominate “127-echo programs”. Le 127-echo sono
dei dispositivi che danno mandato alla forze speciali di utilizzare unità
militari locali come proxy in missioni legate alla lotta ai gruppi terroristici,
le cosiddette VEO. Queste unità vengono gestite dalla Joint Special Command che
controlla la Seal Team 6 della Marina e la Delta force dell’esercito. Le
127-echo sono composte da 80-120 uomini e operano con l’assistenza dei comandi
americani. Questo tipo di operazioni non occupano direttamente forza combattente
americana ma restano sotto il controllo dagli Stati Uniti, pagati sempre dal
Pentagono, ma allo stesso tempo nell’ombra. Sono difficili da individuare e
confermano ancora una volta che il coinvolgimento di Washington è tutt’altro che
superficiale e limitato. Questo è il quinto e ultimo episodio di una serie di
approfondimenti sulla presenza militare americana nel mondo. L’episodio pilota
si può leggere qui. Il secondo episodio riguardava il deflusso europeo, dalla
ritirata in Germania alla presenza flessibile nell’Est Europa. Il terzo si
soffermava invece sul lungo ritiro dallo scenario Mediorientale. Il quarto,
invece ha raccontato la nuova frontiera asiatica e il contenimento della Cina.
La “sorpresa” di Donald Trump è un’arma ipersonica?
Andrea Muratore il 14 settembre 2020 su Inside Over. “Un’arma che nessuno ha mai
avuto prima”, qualcosa di “incredibile” e “nucleare”. È una delle rivelazioni
che Donald Trump avrebbe fatto al giornalista Bob Woodward, emersa dalle
anticipazioni sul libro Rage dedicato alla presidenza del tycoon newyorkese. La
rivelazione ha animato la discussione tra gli addetti ai lavori e gli esperti,
consci che nella fase attuale numerosi sono i terreni in cui la ricerca militare
di frontiera ha portato e porterà a profonde innovazioni e altrettanti quelli in
cui la competizione di Washington con i maggiori rivali, Cina e Russia in testa,
è serrata. L’amministrazione Trump, ad esempio, aggiornando nel 2018 la dottrina
di utilizzo delle armi nucleari (Nuclear Posture Review) ha aperto la strada
allo sviluppo della nuova testata nucleare, W76-2 è una variante dell’arma usata
sui missili Trident dai sottomarini nucleari americani; la W76-2, in ogni caso,
non rappresenta necessariamente una novità assoluta, ma l’ampliamento di un
programma già esistente. Per capire quale arma possa essere davvero
un game-changer nella competizione militare globale sono altri i terreni su cui
l’analisi deve concentrarsi. Per Marcello Spagnulo, ingegnere aerospaziale con
decenni di esperienza nel settore, presidente del Mars Center e autore del
saggio Geopolitica dell’esplorazione spaziale, il terreno da tenere d’occhio è
quello delle armi ipersoniche e della partita per il controllo dello spazio.
Spagnulo, in un articolo pubblicato su Formiche traccia in particolar modo il
percorso della graduale crescita di influenza dell’ex sottosegretario per
Ricerca e sviluppo del Pentagono, Michael Griffin, in carica dal 2018 fino allo
scorso mese di giugno, che negli ultimi anni ha fortemente spinto per mettere in
campo tutta la potenza industriale e tecnologica degli Stati Uniti al servizio
dello sviluppo delle nuove armi ipersoniche. Ricordando l’intervento di
Griffin, oggi 71enne, forte di cinque lauree e di un’esperienza alla guida
della Nasa, a un convegno a Washington nel marzo 2018 Spagnulo sottolinea che
allora l’ingegnere “fece esplicito riferimento a un nuovo tipo di arma
rivoluzionaria capace di volare manovrando a più di 15 volte la velocità del
suono e in grado di colpire quasi tutti i bersagli al mondo in pochi minuti. I
missili ipersonici appunto, che piombano sugli obiettivi in un lampo accecante e
distruttivo prima di qualsiasi boom sonico e sono troppo veloci per le
contromisure radar”. Un campo in cui è oggi la Russia, secondo le notizie più
affidabili, ad essere saldamente in testa e in cui altre potenze nucleari, come
la Cina e l’India, partecipano attivamente. Al 2020, gli Stati Uniti sono
ancora, ufficialmente, in ritardo nella corsa all’arma ipersonica e viene da
pensare come potrebbe essere stata la partita senza l’entrata a gamba tesa di
Girffin, il cui dipartimento ha maneggiato fondi per 17 miliardi di dollari e
accelerato la svolta legislativa per la ricerca ipersonica: “nel 2018, il
Congresso approvò una legge che richiedeva la disponibilità di un’arma
ipersonica operativa dal 2022 e, infatti, l’anno seguente il budget per la
Difesa proposto dall’amministrazione Trump comprendeva 2,6 miliardi di dollari
il primo anno per questi sistemi d’arma e 5 miliardi per il seguente”. Si
trattava di dare organicità industriale e programmare strategicamente sul
medio-lungo periodo la partita ipersonica, che Griffin comprese avere dirette
implicazioni anche sulla corsa al controllo dello spazio, tanto che sotto l’ala
del Pentagono l’ex capo della Nasa costruì un’agenzia ad hoc per promuovere la
ricerca e le politiche per il controllo dello spazio, ora con ogni probabilità
confluita nelle nuove Space Forces. A fine marzo il Pentagono ha affermato di
aver superato con successo il test di volo del suo vettore, che gli sviluppi
militari e industriali, concentrati principalmente nella filiera di aziende che
fa capo a Lockheed Martin. Un vettore – considerazione importante – che sarà
unico per l’Us Army e l’Us Navy. Come ha ricordato su InsideOver, il prototipo a
stelle e strisce potrà toccare la velocità di punta di Mach-20, venti volte la
velocità del suono, trasportando dunque testate anche nucleari con una rapidità
superiore a qualsiasi difesa anti-missile nemica, e per l’impiego finale
dell’arma si stanno considerando, come mezzi da armare, le navi della Marina
classe Arleigh Burke e Zummwalt o i sottomarini classe Virginia. A questi
programmi il Pentagono lavora da tempo, ma gradualmente il cono d’ombra su di
essi si sta diradando e l’attenzione di opinione pubblica e studiosi sta
crescendo. Donald Trump potrebbe in fin dei conti aver anticipato a Woodward
questo sentore. L’uscita di Mike Griffin dall’amministrazione per entrare
nell’azienda del settore aerospaziale Rocket Lab, in questo contesto, aumenta il
presidio di uomini dell’apparato di potere americano ne complesso
militar-industriale, e non è un segno dei ritardi ma dell’effettivo avvio di un
programma capace di marciare e oramai strutturato per esser portato avanti dai
militari. Non a caso da oltre cinque anni Lockheed Martin, azienda centrale del
programma ipersonico C-Hgb, è diventato un investitore strategico di Rocket Lab:
Griffin, il principale ispiratore del programma, è a maggior ragione ancora al
suo interno. Pronto – con le competenze di Rocket Lab, specializzata nel lancio
in orbita di vettori di piccola dimensione – a sviluppare quello che potrebbe
essere il vero vantaggio competitivo del programma ipersonico Usa: una rete di
satelliti capaci di tracciare dallo spazio i missili amici e nemici. L’ipotesi
più concreta per una nuova arma, dunque, porta nella direzione del missile
ipersonico. La dichiarazione roboante di Trump che Woodward attribuisce al
Presidente, dunque, può avere numerosi riscontri concreti: gli Usa sono tornati
in partita nella corsa ipersonica, e nei prossimi anni anche il loro arsenale
potrà, di questo passo, allinearsi a quello di Cina e Usa.
I veicoli
autonomi “multi-missione” Usa.
Marco Pizzorno
su Inside Over il 14 ottobre 2020. Le innumerevoli diversificazioni delle
strategie di guerra costringono le forze armate a coprire settori nelle aree più
impensabili. La competizione per gli armamenti e i nuovi obbiettivi geopolitici
stanno incrementando la corsa tra le società dedicate alla fornitura di
tecnologia bellica, impegnandole in una gara all’ultima “micidiale creazione”.
Su questa riga, la Marina degli Stati Uniti ha effettuato investimenti in armi
modulari e flessibili per far fronte alle nuove necessità “multi-missione”,
dettate dalle nuove tipologie di conflitto. Per soddisfare tali esigenze, la
Navy si è dotata del nuovo sistema Iver 4 Autonomous Underwater Vehicle,
progettato dalla L3 Harris Technologies. Le caratteristiche dell’Auv, sono
focalizzate su alta tecnologia dedicata alla sorveglianza, ricognizione, guerra
anti-sottomarino, mine e soprattutto “intelligence”. Infatti, per queste
tipologie di missioni, l’armamento è dotato di capacità “mission-critical”, che
consente ai sensori di bordo di poter scaricare i dati raccolti dall’Iver4 a
velocità detta di gigabit-ethernet. Questo consente di velocizzare le azioni,
sebbene il veicolo sia già in grado di viaggiare ad una velocità di quattro
nodi.
Autonomus
underwater vehicle. La L3 Harris Technologies, ha progettato un vero e proprio
gioiello tecnologico. Esso è infatti dotato di un’alimentazione alternativa con
capacità di ricarica di 4 kilowattora agli ioni di litio, con durata stimata di
circa 40 ore, ma può essere anche alimentata ad alluminio con un modulo speciale
che le consente ben 80 ore di autonomia. Come si apprende dalla scheda tecnica
dell’azienda, l’armamento riporta un magnetometro trainato, un ecoscandaglio in
modalità di radar, utile al riconoscimento degli ostacoli così da poterli
evitare ed un sonar a scansione. La capacità d’immersione consente alla
tecnologia d’immergersi a una profondità stimata di 300 metri. Come
riferisce Defensenews, l’Iver 4 è stato ideato proprio per operazioni marittime
multi-missione, in special modo quelle anti-accesso, in quanto l’architettura
consente basse interferenze elettromagnetiche utili alla geolocalizzazione e al
rilevamento di quei fondali classificati come “complessi”. La macchina, a
missione compiuta, è programmata per muoversi sotto-superficie sino a quando un
sistema di richiamo acustico non detti le coordinate per il ritorno. Infine per
ciò che concerne le operazioni d’intelligence, l’Iver è formattato per il
trasporto dei dati crittografati, gestiti da un sistema di comando e controllo,
impiegati sia in missioni inquadrate come “non-Itar” che per altre tipologie di
operazioni. L’estrazione e sostituzione dei dati avvengono in maniera
istantanea, consentendo all’apparecchio di ripristinarsi per essere velocemente
operativo per un nuovo impiego.
Cosa è la L3
Harris Technologies. Sul sito ufficiale della compagnia, la descrizione cita che
la L3 Harris soddisfa le esigenze mission-critical dei clienti. Ha un fatturato
stimato di circa 18 miliardi di dollari e 48000 dipendenti, oltre ad un
portafoglio clienti che copre ben 100 paesi. La storia della compagnia vede la
“Harris Automatic Press Company” fondata da Alfred S. Harris in Ohio, nel 1895.
Ha prodotto per oltre 60 anni macchine da stampa e prodotti litografici prima di
acquisire la Intertype Corpordtion, per poi fondersi con la Radiation Inc. La
competenza di quest’ultima permise alla Harris di espandersi nei circuiti
integrati e tecnologie modem oltre alle antenne. La L3 Communications, invece,
avendo una diversa organica ben strutturata, ha orientato la sua espansione
nell’acquisizione di unità industriali che permettessero all’azienda di avere i
“numeri”. Così avvenne con la Lockeheed Martin divenendo un dei maggiori
appaltatori del governo americano, cambiando il nome della società da L3
Communication Holdings a L3 Technologies Inc. La fusione finale tra la Harris e
L3 avvenne il 29 giugno del 2019, creando la L3 Harris con sede a Melbourne
Florida. Attualmente l’azienda è uno dei colossi dell’industria bellica, ed i
contribuenti americani si apprestano a verificare la reale operatività di questo
gioiello in missione, soprattutto nel mar cinese meridionale, dove quest’ultimo
è considerato “una speranza” per eludere le zone anti-accesso create ad hoc da
Pechino.
Gli Usa
mettono in campo una nuova testata nucleare.
Andrea Massardo su Inside Over the world il 5 febbraio 2020. Il governo
degli Stati Uniti d’America ha deciso di fornire la propria marina militare di
una nuova testata nucleare a basso rendimento (ossia, inferiore ai 20 chilotoni)
per rinnovare il proprio comparto balistico. Le testate verrebbero utilizzate
dai sottomarini americani e la prima imbarcazione che sarà equipaggiata con la
nuova arma, stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Reuters, sarà la
Uss Tennessee, operativa nelle acque dell’Atlantico. Secondo quanto dichiarato
dai portavoce dell’esecutivo statunitense, il dispiego di una nuova testata a
basso rendimento servirebbe a scoraggiare i propri rivali (in particolar modo la
Russia) dall’utilizzare il proprio arsenale nucleare. Avendo a disposizione
infatti un armamento a basso rendimento i cui esiti sarebbero molto meno
devastanti di una normale arma non convenzionale, le possibilità che venga
utilizzato sono più elevate anche a causa del minore impatto che ne deriverebbe.
In questo modo la possibilità che nei prossimi anni la terra sia teatro di un
conflitto atomico sarà più remota. Tuttavia, il fatto che gli Usa siano dotati
di un’arma non convenzionale utilizzabile anche in situazioni meno estreme
significa al tempo stesso che una detonazione nucleare potrebbe avvenire per
mano Usa anche in condizioni in cui precedentemente non sarebbero state usate.
In sintesi, potrebbe essere utilizzata come normale ordigno militare, non
causando lo scenario di distruzione di massa e di danni ambientali come le
versioni più potenti degli arsenali atomici, mantenendo però la sua potenza
distruttiva sull’obiettivo. Proprio questa possibilità ha messo sull’allerta il
Partito democratico americano, che non ha esitato nel sottolineare come tale
strumento, più che un deterrente, possa significare una nuova corsa agli
armamenti da parte degli avversari degli Stati Uniti d’America. Oltre alla
Russia, soprattutto Paesi come Corea del Nord e forse nel futuro l’Iran potranno
optare per la stessa scelta, con la differenza di possedere notoriamente un
temperamento differente rispetto a quello del ceto politico moscovita. Il
governo degli Stati Uniti ha però precisato come la mossa sia stata effettuata
semplicemente per un discorso difensivo e legato alla psicologia della guerra,
proprio per evitare il verificarsi di un conflitto nucleare nei prossimi anni.
Tuttavia, gli enormi interrogativi lasciati aperti dalla questione evidenziano
come, nonostante i punti di forza sottolineati dall’esecutivo americano, la
mossa Usa possa essere reputata ambigua, mettendo sulla difensiva gli stessi
massimi avversari mondiali. In questo scenario, la possibilità che nei prossimi
mesi e nei prossimi anni si assista effettivamente ad una nuova corsa agli
armamenti nucleari – questa volta di ridotta potenza – è più reale che mai, date
soprattutto le tante questioni irrisolte a livello mondiale e che dall’inizio
del 2020 hanno subito una nuova impennata. Con Washington che anche questa volta
ha deciso di giocare d’anticipo, scoprendo però le carte per evitare che la
mossa potesse essere identificata come possibilmente ostile; nonostante la
conseguenza di eventi che necessariamente provocherà negli ambienti militari
mondiali.
IL SUPERCANNONE (ELETTROMAGNETICO) ECCOLO QUA.
Da it.businessinsider.com il 31 luglio 2020.
In dotazione, per la prima fase di test, alla Marina sparano
proiettili che viaggiano a 7mila km all’ora grazie “alla spinta” di campi
elettromagnetici: ma hanno un punto debole. L’energia.
Da marinecue.it. Gli USA non smettono mai di stupirci nell’ambito
della ricerca tecnologica, in particolare nel loro tanto amato campo militare.
Ebbene, presso la base navale di Dahlgren, in Virginia, l’ufficio americano per
le ricerche navali destinato alla promozione dei programmi scientifici e
tecnologici della marina (ONR), ha presentato un nuovo cannone a impulsi
elettrici, di uso prettamente navale. I proiettili di questo supercannone
sarebbero in grado di superare i 7000 mila chilometri orari, arrivando a coprire
una distanza di 100 miglia nautiche, (circa 185,2 chilometri). Il cannone lavora
accumulando energia generata da una fonte esterna, a bordo nave, per alcuni
secondi. In seguito, dopo aver caricato i suoi condensatori di circa 32 MJ di
energia, invia un impulso elettrico attraverso due lunghi binari, uno caricato
positivamente e l’altro negativamente, generando così un campo elettromagnetico
che spara il proiettile lungo gli stessi binari. Il colpo è un proiettile non
esplosivo, con all’interno pallottole di tungsteno contenute in un casing di
lega d’alluminio, che vengono rilasciate nel momento in cui il proiettile lascia
la canna. La US Navy, sta anche sviluppando un dispositivo da inserire
all’interno del proiettile, al fine di permettere il puntamento attraverso il
sistema GPS. In questo modo essa potrà essere utilizzata come arma
antimissilistica. Sfortunatamente, come già accennato, l’energia richiesta per
il funzionamento del cannone è di circa 25 MW (energia capace di alimentare
circa 19000 case), e l’unica classe di navi capace di fornire tale energia è
quella dei cacciatorpedinieri Zumwalt, che utilizzano turbo-generatori
Rolls-Royce (capaci di fornire 78 MW di potenza alla nave). Il problema della
potenza da fornire quindi è considerata una sorta di “barriera tecnologica”. La
Raytheon Integrated Defense Systems è quindi alla ricerca di nuove tecnologie
nel campo dei materiali (sempre più resistenti date le altre velocità del
proiettile e le alte temperature raggiunte), dei condensatori (sempre più
capienti e capaci di immagazzinare energia in breve tempo) tali da rendere l’EM
railgun sempre più efficiente. Il video che riportiamo di seguito, caricato sul
canale YouTube dell’ente governativo, mostra tutta la potenza della nuova arma,
messa alla prova durante alcune dimostrazioni effettuate presso la stessa base
navale in Virginia. A giudicare dalle immagini, l’arma si prospetta come uno
strumento dal grandissimo potere distruttivo.
Cos’è e come funziona la Mop, la bomba americana distruggi
bunker. Paolo Mauri su Inside Over il 28 ottobre 2020.
Si chiama Mop, acronimo che sta per Massive Ordnance Penetrator. È una delle più
potenti bombe che ci siano al mondo insieme alla Moab (Massive Ordnance Air
Blast), la “mother of all bombs” usata per la prima volta in azione in
Afghanistan ad aprile del 2017 sganciata da un MC-130 “Combat Talon II” o
“Slick” C-130, l’unico velivolo in grado di trasportarla date le sue imponenti
dimensioni, e la Foab, una bomba termobarica russa che, che con le sue 44
tonnellate di Tnt equivalente sembra essere la più potente bomba convenzionale
del mondo (a detta di Mosca). Sebbene la Mop sia più piccola della Moab, ha
delle dimensioni e dei pesi di tutto rispetto: la bomba, denominata
ufficialmente Gbu-57, è lunga infatti 6,2 metri con un diametro di 80 centimetri
e ha una massa complessiva di 13,6 tonnellate di cui 2,4 sono rappresentate
dalla carica esplosiva. Per fare un paragone la Moab ha un peso di 10 tonnellate
ma ha una carica esplosiva di 8,4 rappresentata da H6, una mistura di Rdx
(Ciclotrimetilenetrinitroammina), Tnt e alluminio. La Moab, infatti, non è
progettata per penetrare bersagli corazzati, ma per colpire obiettivi d’area che
distrugge tramite la sovrappressione ed il calore. La Mop, invece, nasce
esplicitamente per colpire obiettivi corazzati, o induriti come si dice in gergo
militare: risulta che possa penetrare 60 metri di cemento armato in grado di
resistere alla sovrappressione di 5mila Psi (circa 350 chilogrammi per
centimetro quadrato). Ad oggi il bombardiere stealth B-2 Spirit è l’unico aereo
in grado di utilizzare la Gbu-57 a livello operativo, sebbene i
bombardieri B-52H abbiano sganciato alcune di queste armi durante passati test.
Anche il futuro bombardiere stealth B-21 Raider sarà probabilmente in grado di
trasportare le Mop, in quanto rientrano nella dottrina statunitense del Prompt
Global Strike, ovvero la capacità di effettuare un attacco convenzionale in
breve tempo in qualsiasi parte del mondo. La Mop deriva dal progetto di un’altra
bomba, la Big BLU, proposto dalla Northrop-Grumman e Lockheed-Martin nel 2002 e
presto abbandonato. L’invasione dell’Iraq del 2003, però, mise l’Usaf davanti
alla necessità di avere ordigni in grado di penetrare efficacemente i bunker
nemici, così la Boeing l’anno successivo riesumò il progetto e sviluppò la
Gbu-57, che effettuò il suo primo test nel 2007. Il primo ordine per 8 di questi
ordigni arriva a febbraio del 2011, ma attualmente non si sa esattamente il
numero di Gbu-57, nelle sue varie versioni, presenti nell’arsenale dell’Usaf,
sebbene già a settembre del 2011 risulta fossero circa 20. Sappiamo, come
riporta The Drive, che ci sono stati ordini successivi e che da quella data un
certo numero di ordigni è stato usato in vari test. È probabile che il numero
totale di armi disponibili sia aumentato negli ultimi anni. Nel febbraio 2018,
l’Usaf aveva annunciato che stava acquistando un numero imprecisato di Mop dalla
Boeing, che probabilmente sarebbero stati anche nella configurazione Gbu-57E/B.
Il mese prima, Bloomberg aveva riferito che un programma di “quarto
aggiornamento” per gli ordigni era stato completato e che anche le bombe
esistenti nelle scorte erano state modificate. La Mop è stata pensata
appositamente per colpire, con un attacco di precisione, gli spessi bunker
utilizzati dall’Iran per la sua ricerca nucleare oppure utilizzati dalla Corea
del Nord per celare sia le sue infrastrutture nucleari sia i veicoli di lancio
per i missili balistici. Lo sviluppo della bomba è stato infatti accelerato di
pari passo con il peggiorare della crisi per il nucleare iraniano, ed è tornata
utile anche come strumento di deterrenza per la successiva crisi nordcoreana. La
Mop venendo trasportata dal B-2 è un efficace mezzo di primo colpo: il
bombardiere, infatti, si avvicina al bersaglio eludendo i radar avversari e
sgancia l’ordigno restando invisibile sino al momento dello scoppio. In effetti
un tale sistema è efficace anche contro i siti corazzati di comando,
comunicazione e controllo: un obiettivo primario che verrebbe colpito
immediatamente all’inizio di possibili ostilità per creare confusione e
“accecare” il nemico. La Mop, con la sua alta capacità di penetrazione data
dalla sua massa, riuscirebbe a penetrare uno spesso strato di cemento armato per
poi esplodere: la sua spoletta a scoppio ritardato, montata sulla coda della
bomba per proteggerla, la farebbe detonare nel cuore dell’obiettivo. Grazie al
suo carico bellico, e alla guida Gps della bomba, un B-2 potrebbe bersagliare
con due ordigni un obiettivo particolarmente indurito: il primo colpo servirebbe
per “ammorbidirlo”, mentre il successivo servirebbe a distruggerlo
completamente. Il B-2, come accennato, è l’unico velivolo che ha visto un
aggiornamento mirante a migliorare le capacità convenzionali di “bunker
busting”: il programma dell’Air Force noto come Hdbtds (Hard and Deeply Buried
Target Defeat System). Secondo il bilancio del budget dell’Usaf per l’anno
fiscale 2020, questi aggiornamenti includono una modifica non specificata
“principalmente basata sul software” per la Mop che mira a migliorare la
capacità Hard and Deeply Buried Target Defeat System, ovvero del sistema di
bordo per colpire bersagli induriti o sepolti in profondità.
La portaerei Uss Gerald R. Ford.
Paolo Mauri su Inside Over il 3 marzo 2020. La Uss Gerald R. Ford (Cvn-78) è la
portaerei capoclasse di una nuova serie di unità della Us Navy che dovranno
sostituire le precedenti della classe Nimitz.
Il vascello prende il nome dal 38esimo presidente degli Stati
Uniti, noto soprattutto per essere succeduto a Richard Nixon a seguito delle sue
dimissioni per lo scandalo del “Watergate”, restando in carica per 895 giorni,
dal 9 agosto 1974 sino al 20 gennaio 1977. Il suo motto è “Integrity at the
helm”. La Ford, momentaneamente basata a Norfolk (Virginia), sta attualmente
terminando la fase di certificazione dei sistemi di bordo e del gruppo di volo.
Le caratteristiche.
Lunghezza: fuori tutto 337 metri alla linea di galleggiamento 317
metri
Larghezza: massima 78 metri alla linea di galleggiamento 41 metri
Pescaggio:7,8 metri in condizioni standard (max 12,4 metri)
Velocità massima: più di 30 nodi (56 km/h)
Autonomia: illimitata, il combustibile nucleare ha una durata di
circa 20/25 anni e la vita operativa della nave è stimata in circa 50 anni.
Dislocamento: 112mila tonnellate a pieno carico.
Equipaggio: 4660 uomini compreso il personale del gruppo di volo
composto da circa 2480 unità.
Descrizione: Come tutte le portaerei maggiori americane anche la
Gerald Ford presenta una sovrastruttura ad isola sul lato di dritta del ponte di
volo angolato sede dei ponti di comando della nave e del gruppo di volo oltre
che della maggior parte dei sistemi radar, di comunicazione e delle altre
dotazioni elettroniche. La portaerei ha tre ascensori posti due sul lato di
dritta ed uno a sinistra che collegano i due hangar al ponte di volo che ha una
superficie di 25974 metri quadri (333×78). La portaerei Ford è dotata di 4
catapulte di nuova concezione che utilizzano la forza elettromagnetica invece
del vapore (Emals – Electromagnetic Aircraft Launch System) ed ha un sistema
avanzo di arresto dei velivoli a 3 cavi Aag (Advanced Arresting Gear). L’unità è
propulsa da due reattori nucleari tipo A1B da 100 Mw complessivi, evoluzione
rispetto a quelli in dotazione alle classe Nimitz, che azionano ciascuno due
gruppi di turbine, turboriduttori e assi su cui sono montate in totale quattro
eliche pesanti 30 tonnellate. La portaerei, la prima di quattro previste, nasce
dall’esigenza di dotare la Us Navy di nuove unità in grado di effettuare più
sortite dei velivoli al giorno, di avere più potenza elettrica per i sistemi di
bordo, e di imbarcare meno uomini rispetto a quelle della classe Nimitz
precedente, riducendo nel contempo i costi del servizio spalmati su 50 anni di
vita stimata delle unità di questo tipo (meno 4 miliardi di dollari nei piani
della Marina Usa). La costruzione della Ford ha richiesto un investimento
complessivo di 13,084 miliardi di dollari (valuta del 2008) a cui si sono
aggiunti 1,3 miliardi nel periodo 2014-2018. Le portaerei della classe Ford sono
le più grandi mai costruite fin’ora e le più grosse navi militari in termini di
dislocamento.
I sistemi elettronici: La portaerei Ford è dotata di sistemi
radar e svariati sensori elettronici per effettuare le operazioni navali, di
volo, per la comunicazione e l’autodifesa che fanno parte del Ship Self Defense
System (Ssds), il sistema integrato per la difesa della nave. In particolare
quelli conosciuti sono:
Il radar dual band (Dbr) a scansione elettronica active array che
opera combinando il sistema AN/SPY-3 lavorante in banda X col Vsr (Volume Search
Radar) lavorante in banda S.
Il sistema da guerra elettronica SLQ-32(V)6
I sistemi d'arma: La portaerei Ford dispone di due lanciatori per
missili superficie aria tipo Rim-162 Essm, due per Rim-116 Ram, nonché di tre
sistemi Mk15 Phalanx da 20 millimetri per la difesa di punto (Ciws – Close-in
Weapon System). L’unità può trasportare sino a 90 velivoli per il suo gruppo di
volo che comprendono F-35C Lightning II, F/A-18E ed F Super Hornet, E-2D
Advanced Hawkeye, EA-18G Growler ed elicotteri tipo MH-60R e S nonché Uav e Ucav
di vario tipo.
La storia della Ford: La portaerei Ford è stata impostata il 13
novembre del 2009 presso i cantieri Huntington Ingalls di Newport News
(Virginia). Varata il 31 maggio del 2017 è entrata nei registri della Us Navy il
22 luglio dello stesso anno. Ad agosto del 2011 la Ford era stata costruita per
metà della sua struttura, l’isola è stata posizionata il 26 gennaio del 2013 con
qualche mese di ritardo rispetto a quanto preventivato. Il ponte di volo è stato
completato il 9 aprile del 2013 ed il 3 ottobre è iniziata l’installazione delle
4 eliche da 30 tonnellate che ha richiesto più di 10 mesi di lavoro. Il 9
novembre del 2013 avviene il battesimo ufficiale della portaerei alla presenza
della madrina, la figlia del presidente Ford, Susan Bales Ford. Ritardi dovuti a
difficoltà tecniche posticipano il varo della nave ed il suo ingresso in
servizio, originariamente previsti per il 2015, all’anno successivo. A questo
punto la nave è completa al 95%. A luglio del 2016 un rapporto del Dipartimento
della Difesa ammette che alcuni problemi gravi ritarderanno ulteriormente il
varo della nave. In dettaglio le catapulte Emals, il sistema di arresto Aag, il
radar Dbr e l’Awe (Advanced Weapon Elevator) della Ford risultano poco
affidabili e, come si legge, si crede che possano ulteriormente prolungare la
IOT&E (Initial Operational Test and Evaluation). A gennaio del 2018, durante
delle prove in mare, la Ford subisce un’avaria importante al sistema di
propulsione ed è costretta a rientrare in porto. Ad un anno dal varo della nave
i giorni che ha trascorso in mare ammontano a 81. Dopo 15 mesi di cantiere,
il 25 ottobre del 2019 la Ford riprende il mare per circa 3 settimane di prove.
Il 16 gennaio del 2020 la portaerei ha cominciato in Oceano Atlantico i test per
l’Act (Air Compatibility Test) della durata di 16 giorni che hanno certificato
l’affidabilità dei sistemi Emals e Aag con 211 lanci e appontaggi di vari
velivoli tra cui T-45, F/A-18 E/F, E/A-18G, E-2D e C-2A.
Doris Miller, intitolata all’eroe afroamericano di Pearl
Harbor la portaerei Usa. Pubblicato domenica, 26
gennaio 2020 su Corriere.it da Silvia Morosi. Non solo i nomi di battaglie
famose o presidenti americani. Gli Stati Uniti hanno deciso di intitolare una
delle navi della nuova serie di portaerei classe Ford a — che entrerà in
servizio tra sette-otto anni — a Doris Miller, il primo afroamericano a ottenere
il prestigioso riconoscimento della «Navy Cross», all’epoca la terza più alta
decorazione militare statunitense.. Nipote di schiavi neri e figlio di mezzadri,
come si legge sulla Bbc, si distinse durante l’attacco a Pearl Harbor, a bordo
della corazzata «West Virginia» nelle prime ore del 7 dicembre 1941 quando
apparvero gli aerei giapponesi sopra le Hawaii. Nato a Waco, in Texas, nel 1919,
terzo di quattro figli, venne chiamato Doris perché sua madre si aspettava una
femmina. Dopo aver abbandonato la scuola superiore e aver lottato per trovare
lavoro, Miller si unì alla Marina nel 1939 all’età di 20 anni. «Scegliendo il
suo nome, onoriamo i contributi di quanti, uomini e donne, di ogni razza,
religione, hanno onorato il nostro Paese», ha detto il segretario della Marina
Thomas B. Modly : «Nessuno capisce l’importanza e il vero significato del
servizio rispetto a coloro che si sono offerti volontari, mettendo i bisogni
degli altri al di sopra di loro», si legge su UsaToday. Impiegato come cuoco
sulla nave (erano ancora in vigore le «leggi Jim Crow», che di gatto servirono a
creare e mantenere la segregazione razziale in tutti i servizi pubblici, ndr),
stava riordinando il bucato sulla nave quando, quel 7 dicembre 1941, un siluro
giapponese si schiantò contro la «West Virginia». Il primo dei nove siluri che
colpì e affondò la nave. L’attacco giapponese a Pearl Harbor uccise più di 2.300
persone e portò gli Stati Uniti nella Seconda guerra mondiale. Miller corse
subito ad aiutare i suoi compagni marinai e il capitano, Mervyn Bennion, ferito
a morte. Prese posto su una mitragliatrice e sparò contro il nemico, nonostante
non avesse mai ricevuto l’addestramento necessario per il suo utilizzo. Rimase
poi a bordo fino a quando non esaurì i colpi e venne dato l’ordine di
abbandonare la nave, aiutando a evacuare la corazzata. «Non fu difficile»,
raccontò in seguito. Nel gennaio del 1942, la Marina degli Stati Uniti —non
senza polemiche, dato il colore della sua pelle — lo premiò insieme ad altri
soldati che si erano distinti nel combattimento. All’inizio il suo nome non
venne svelato, ma un paio di mesi dopo il Corriere di Pittsburgh rivelò
l’identità del marinaio Doris Miller. Tornò in mare a bordo della portaerei
Liscombe Bay e venne ucciso quando questa venne affondata da un sottomarino
giapponese nella Battaglia di Makin nel novembre 1943. La sua eredità è
sopravvissuta anche nella cultura popolare, tra libri, pellicole e monumenti:
nel 1942 le azioni di Miller furono raccontate nella serie «Esse Live Forever»
su CBS Radio; nel film «Tora! Tora! Tora!» (1970), anche se non identificato per
nome, il ruolo di Miller era interpretato da Elven Haward e, infine, nel più
celebre «Pearl Harbor» del 2001, Miller fu interpretato da Cuba Gooding Jr.
All’alba del 7 dicembre 1941 — lo abbiamo ricordato sopra — le forze giapponesi
attaccarono a sorpresa la base aeronavale statunitense di Pearl Harbor, nelle
Hawaii. L’attacco produsse l’affondamento di tre portaerei, un posamine, e il
danneggiamento di portaerei, cacciatorpedinieri, aerei. Da quel giorno gli Stati
Uniti entrarono ufficialmente nella Seconda guerra mondiale e Italia e Germania
dichiararono guerra agli Usa pochi giorni dopo, appoggiando la causa del
Giappone, già membro del «patto tripartito». Quel 7 dicembre fa sarebbe passato
alla storia come «giorno dell’infamia». A definirlo così fu Franklin Delano
Roosevelt, il Presidente Usa in carica, nel suo primo discorso di guerra al
Congresso in seduta plenaria: «Ieri, 7 Dicembre 1941, una data segnata
dall’infamia, gli Stati Uniti d’America sono stati improvvisamente ed
intenzionalmente attaccati dalle forze aeree e navali dell’Impero del Giappone.
Gli Stati Uniti erano in pace con questo paese (...) Non importa quanto tempo
occorrerà per riprenderci da questa invasione premeditata, il popolo americano
con tutta la sua forza riuscirà ad assicurarsi una vittoria schiacciante». Gli
Stati Uniti hanno previsto la realizzazione di dieci esemplari della serie che
andranno a sostituire progressivamente le unità della classe «Nimitz», in
servizio da oltre 40 anni. La classe «Gerald R. Ford» (Cvn 78) è stata
progettata con una serie di miglioramenti anche per la qualità della vita per i
marinai e per ridurre i costi di manutenzione per la Marina.
Nelle mani di Joe Quattrone, il barbiere del Congresso.
Pubblicato sabato, 25 gennaio 2020 su Corriere.it da Giuseppe Sarcina. La
bottega di Joe Quattrone potrebbe essere tranquillamente inserita nel giro per i
turisti organizzato ogni giorno dal «visitor center» di Capitol Hill. Da
cinquant’anni è il barbiere del Congresso. Ha regolato le sfumature di tre
presidenti, da George Henry Bush a Gerald Ford, fino a Barack Obama, quando era
un giovane senatore dell’Illinois; sistemato la capigliatura di tre futuri vice
presidenti; quella folta di Al Gore, quella più rada di Dick Cheney e Joe Biden.
Perché Joe Quattrone non fa differenza tra democratici e repubblicani, iper
conservatori e liberal, falchi e colombe, star e peones, generali e capi di
stato. È una zona franca nella politica di Washington, anche ora, nei giorni
laceranti dell’impeachment di Donald Trump. La piccola insegna si affaccia
sull’enorme corridoio in marmo al piano terra del Rayburn House Office Building,
uno dei satelliti di Capitol Hill, dove sono alloggiati gli uffici di 169
deputati e le aule di nove Commissioni. La prima pietra fu posata nel 1962, con
un discorso di John Kennedy. Joe ci è arrivato nel 1970, a 35 anni. Era partito
con la famiglia da Reggio Calabria, nel 1947. Destinazione Ohio. Racconta che
frequentò poco le scuole e molto di più le officine e i cantieri. Come molte
famiglie di immigrati italiani anche i Quattrone provarono a metter su un
ristorante dai sapori tradizionali. Ma non funzionò. Nel frattempo il ragazzino
aveva imparato un mestiere. Pettini, forbici e rasoio. L’America di quegli anni
era un mare sempre in movimento. Un’onda anomala e Joe si ritrovò nella
capitale, al Congresso. Oggi, a 85 anni, è ancora lì, a capo di un piccolo team.
Tre mini box per barba e capelli, 17 dollari per il taglio semplice; più una
specie di sedia gestatoria per gli habitué di Al, un anziano afroamericano di
New York, che lucida le scarpe per 10 dollari. Sulle pareti almeno un centinaio
di foto incorniciate, alcune in bianco e nero, qualche disegno, molte dediche. È
la storia personale di «Joe Q.» e anche, un po’, di questo Paese. Lo hanno
cercato da Fox news; il magazine del Washington Post gli ha dedicato un lungo
servizio. «Ma per contratto non posso parlare con i i giornalisti, altrimenti mi
licenziano». Allora stabiliamo di lasciare fuori la politica americana. Tanto è
sufficiente guardarsi intorno. Ecco il ritratto di Mark Kennedy Shriver, nipote
di John, Robert e Ted, deputato per due legislature, dal 1995 al 2003. C’è una
scritta a pennarello: «Joe, grazie per avermi tenuto sempre vigile». A fianco un
più formale «grazie per la tua opera», firmato da Eric Cantor, ex leader dei
deputati repubblicani. E poi «All the best» di Obama e la «simpatia» di una
giovane Nancy Pelosi, di Hillary Clinton, a testimoniare di quanto la popolarità
di «Joe Q.» non sia ristretta al club per soli uomini.
Sarebbe sbagliato, però, pensare di venire qui e scoprire chissà
quali segreti. Ed è solo una caricatura immaginare, come ha scritto in passato
qualche giornale americano, che davvero Joe si metta a parlare di soppressate e
polpette. Circondato dai suoi ricordi personali, condivisi da almeno tre-quattro
generazioni, Quattrone sforbicia e chiacchiera con una nota nostalgica. Tutto è
cambiato «a metà degli anni Novanta». Prima di allora la vita era certamente più
dura, ma «eravamo anche più liberi», con meno complicazioni. Nella sua memoria,
nelle sue parole affiora tanta Italia. «Su questa poltrona», dice, sono passati
Giulio Andreotti, il presidente Giovanni Leone, accompagnato «dalla sua moglie
meravigliosa», donna Vittoria. L’ultimo cliente? «Bettino Craxi, passava ogni
volta che veniva a Washington. Da allora non ho visto più nessuno».
DAGONEWS il 25
febbraio 2020. Per uno che faceva il medico della Casa Bianca e che nel
frattempo si è candidato per un seggio al Congresso col partito repubblicano,
questi racconti sono piuttosto bizzarri dal punto di vista deontologico, ma
fanno molto ridere: lo staff medico di Trump ''nascondeva'' le verdure nel purée
del presidente per migliorare la sua alimentazione. Ronny Jackson, come scrive
il Daily Beast, ha raccontato al New York Times di non esser mai riuscito a far
perdere al commander-in-chief quei 5-7 chili che avrebbe voluto, né a portare
nella residenza della Casa Bianca un attrezzo ginnico, cosa che aveva annunciato
nella conferenza stampa del 2018 in cui strombazzava ''il fantastico corredo
genetico'' di Trump. Purtroppo però alla visita medica dell'anno successivo il
presidente aveva preso altri due chili, ''la storia degli esercizi non è mai
decollata come avrei sperato'', ha detto al giornale. ''Ma ci eravamo
concentrati sulla dieta: avevamo reso i gelati meno accessibili, ''tagliato'' il
puré con i cavolfiori''. Jackson ha lasciato l'amministrazione Trump quattro
mesi dopo la conferenza stampa, dopo che il suo nome era stato rimosso dalla
rosa per il vertice del Dipartimento degli Affari dei Veterani. Ha detto
al Times che uno dei suoi maggiori rimpianti è il non essere riuscito a mettere
a dieta il presidente.
Barbara Costa per Dagospia il 13 aprile 2020.
“Meglio un presidente che fotte le donne di uno che fotte il Paese”, l’ha detto
l’attrice Shirley MacLaine e si riferiva a John F. Kennedy e a tutti i gossip
sulla vivace vita sessuale del presidente assassinato a Dallas.
Biografie pettegole parlano di un John Kennedy
sex-addicted, un uomo fissato col sesso, che soffriva di violente emicranie se
non lo faceva ogni due giorni con una donna diversa e che litigava con Jackie
perché lei non amava fargli pompini né sperimentare altre posizioni oltre il
classico missionario. Kennedy scopava con la stessa amante poche volte perché si
stufava subito. Gli piaceva cambiare. Le donne troppo giovani non lo eccitavano
perché a letto le voleva esperte e spregiudicate. Nel 1962 incaricò suo fratello
Robert di dire addio a Marilyn Monroe al posto suo: Robert lo fece e la consolò
portandosela a letto per tre mesi. J
ohn Kennedy non è stato l’unico presidente
americano ad amare il sesso fuori dal matrimonio: si racconta di un George
Washington sessualmente impotente, ma un altro Padre Fondatore, Alexander
Hamilton, era pieno di amanti.
Thomas Jefferson si portava a letto Sally
Hemings, la sua schiava mulatta nonché semi-cognata, ed è provato che fu il
padre di uno dei sei figli di lei.
Abraham Lincoln forse era bisessuale e c’è chi
ipotizza che il suo omicida, John Wilkes Booth, fosse in realtà un suo
innamorato respinto.
L’amante di Andrew Jackson si chiamava Peggy
Eaton ed era una donna bella quanto ambiziosa: una volta metà dei ministri di
Jackson si dimisero perché non ne potevano più delle ingerenze di Peggy negli
affari di governo.
Grover Cleveland ebbe un figlio illegittimo
prima di diventare presidente.
Warren Harding scriveva infuocate lettere
d’amore a Carrie Phillips, moglie di un suo caro amico.
Woodrow Wilson sposò la sua amante appena la
moglie morì, James Buchanan fu l’unico presidente scapolo e forse l’unico
presidente asessuale.
Franklin Delano Roosevelt ebbe molte amanti
prima e dopo essere colpito dalla poliomielite. La sua storia con Lucy Mercer
durò più di vent’anni: facevano l’amore sullo yacht di lei o alla Casa Bianca,
potendo contare sulla complicità di Anna, la figlia di Roosevelt, che taceva i
loro roventi incontri alla madre Eleanor. C’era Lucy e non Eleanor quando
Roosevelt ebbe l’emorragia cerebrale, come c’era Lucy e non Eleanor accanto a
lui quando morì. Eleanor badava poco alle infedeltà del marito: lei era lesbica
e faceva l’amore con Lorena Hickok, una giornalista dell’Associated Press. Le
due trascorrevano momenti bollenti negli hotel o in campeggio nei posti più
sperduti d’America: l’FBI le spiava e registrava i loro orgasmi clandestini. A
proposito di FBI: J. Edgar Hoover l’ha guidata per quasi 40 anni, ricattando
tutti gli uomini di potere possibili.
Hoover era gay ed ebbe un solo uomo per tutta
la vita, Clyde Tolson, suo vice all’FBI. La sera, a casa, Hoover si vestiva da
donna indossando gli abiti di sua madre, oppure si metteva un tutù e faceva
piroette in salotto. Robert Kennedy lo sapeva: la volta che Hoover tentò di
ricattarlo con le registrazioni delle scopate di suo fratello John, Robert gli
servì un contro-ricatto coi fiocchi.
Richard Nixon aprì alla Cina e si trovò
un’amante cinese, anche se alcuni biografi dicono che era omosessuale e
innamorato di Charles “Bebe” Rebozo, un banchiere amico di mafiosi. Nelle sue
memorie, Nixon ricorda Bebe come “il mio compagno di partite a golf”, tutte
partite giocate sempre da soli, nella villa di Bebe a Miami. Hoover naturalmente
sapeva tutto, ma morì nel 1972 e Nixon in privato ne gioì. Henry Kissinger, suo
consigliere per la sicurezza nazionale e segretario di Stato, considerava le
donne un amabile passatempo: finché fu al potere ebbe storie con attrici,
modelle, aristocratiche. Il potere può far diventare sexy anche un uomo brutto,
tarchiato e noioso come lui che, intervistato da Oriana Fallaci, si vantò con
lei della sua fama di frivolo playboy. Una giornalista francese, Danielle
Hunebelle, s’innamorò di lui, ma non fu ricambiata: scrisse della sua folle
passione per Kissinger in un libro, “Dear Henry”, dove il caro Henry è
irresistibile preda di morbose attenzioni.
Gerald Ford fu un presidente troppo tranquillo
e ingenuo per avere un’amante, ma il suo vice, Nelson Rockefeller, morì
d’infarto mentre era a letto con una procace ventenne.
Ronald Reagan ha avuto più di 50 amanti, tra
cui Marilyn Monroe, Liz Taylor, Doris Day e Lana Turner: le amò tutte quando
faceva l’attore a Hollywood, e non era ancora entrato in politica. Quando suo
marito era lontano dalla Casa Bianca, Nancy Reagan invitava a colazione Frank
Sinatra, suo grande amico e (ex?) amante. George Bush Sr. è andato a letto per
10 anni con Jennifer Fitzgerald, la sua segretaria, e si dice che il suo vice
Dan Quayle abbia avuto una relazione con Paula Parkinson, una lobbista che,
oltre a Quayle, si portava a letto molti altri politici.
Bill Clinton nel 1995 aveva la malattia di
Peyronie, cioè il suo pene aveva un’erezione ricurva e un pochino fastidiosa. Ce
lo dice Monica Lewinsky, la stagista con cui Clinton fece sesso orale per 9
volte alla Casa Bianca, in un ufficio adiacente allo Studio Ovale, dove Monica
si faceva spogliare e toccare da tutte le parti, raggiungevano entrambi orgasmi
pazzeschi solo sfregandosi, e lui si eccitava introducendo un sigaro nella
vagina di lei. Una volta Monica gli ha fatto un pompino mentre lui era al
telefono con un senatore, altre volte hanno fatto sesso telefonico (“Fammi
venire lì”, lo stuzzicava lei, “mi tolgo i vestiti e comincio a fare quello che
sai”). Chissà se Monica Lewinsky conserva ancora l’abito blu che il presidente
le macchiò di sperma e che fu la prova regina della loro relazione illecita.
Alla fine solo sei voti salvarono Bill Clinton dall’impeachment per spergiuro.
Il suo successore, George Bush Jr., non ha mai
combinato molto tra le lenzuola: sua moglie Laura si lamentò pubblicamente di
tutte le sere passate a letto, a guardare la televisione, con lui che le dormiva
accanto. Le loro due figlie, Jenna e Barbara, hanno trascorso allegre serate ad
alto tasso alcolico alla Casa Bianca. Si è sempre favoleggiato di un sex tape
girato da Barbara al college, ma nessuno l’ha mai visto.
Dicono che Michelle Obama sia stufa delle
continue “distrazioni” di Barack, che il loro matrimonio sia solo di facciata e
che, appena lui non sarà più in carica, lei chiederà il divorzio. In questi otto
anni le voci sulle infedeltà di Obama sono state tante, ma mai provate. Molti
falchi repubblicani però ripetono all’infinito che Obama, oltre ad essere un
musulmano mai nato in America, è di sicuro gay.
Donald Trump si dichiara un vincente anche
perché ha avuto le donne tra più belle al mondo, tra cui Carla Bruni quando era
ancora sposato con Ivana. E Hillary Clinton? Ha mai tradito Bill? C’è chi giura
di sì, ma solo una volta, tanti anni fa, con Webster Hubbell, un suo collega
avvocato. Bill diceva a Monica che sua moglie a letto era un pesce freddo, ma
forse a Hillary gli uomini non interessano più: in questi mesi si è speculato
molto sul suo rapporto con Huma Abedin, sua assistente personale. Quando si è
scoperto che il marito di Huma, Anthony Weiner, faceva il porco via chat con le
ragazzine, lei lo ha lasciato. Per dedicarsi completamente a Hillary?
(ANSA il 2 marzo 2020) - Anche Pete Buttigieg getta la spugna
dopo il quarto turno di primarie in South Carolina, dove è arrivato quarto con
l'8,2%. Una decisione che segue quella del miliardario Tom Steyer. Ora alla
vigilia del Super Tuesday restano in corsa sei candidati, che potranno ambire a
raccogliere i loro voti. Il ritiro di Mayor Pete sembra prematuro considerando
la vittoria in Iowa e il secondo posto in New Hampshire, che gli hanno regalato
la terza posizione come numero di delegati (25), dietro solo a Joe Biden (48) e
Bernie Sanders (56). Ma poi è arrivata la frenata in Nevada con i latinos e il
flop in South Carolina con i neri, che hanno premiato l'ex vicepresidente
spianandogli la strada verso la leadership dei moderati: la stessa cui ambiva
l'ex sindaco di South Bend. La campagna sentirà la mancanza di questo giovane
outsider rivelatosi come una vera sorpresa e probabilmente destinato a rimanere
un astro nascente del partito democratico. Il suo era un profilo di tutto
rispetto: studente modello e poliglotta prima ad Harvard e poi ad Oxford,
veterano decorato in Afghanistan come ufficiale dell'intelligence, ex consulente
della multinazionale McKinsey, sindaco fino a poco tempo di South Bend
(Indiana), gay dichiarato e sposato con un insegnante che lo accompagna in
campagna elettorale. Con i suoi 38 anni era il più giovane candidato
presidenziale dem. Qualcuno aveva anche cominciato a paragonarlo a Barack Obama.
Nonostante la sua scarsa esperienza politica, Pete resta un fenomeno. Appare
intelligente, brillante, preparato, incisivo. Ma sa integrare la sua lucidità
raziocinante con l'empatia, la capacità di scherzare. Parla e pensa come la
giovane generazione cui appartiene, ha cultura digital dei millennials. La sua
era un'agenda riformista progressiva, ma senza i radicalismi ideologici di
Sanders e Warren, i loro toni anti capitalisti, i piani per una università e una
sanità gratis per tutti. Su altri temi però aveva posizioni comuni o molto
vicine a loro, come sull'ambiente, o i temi sociali. Sara' interessante vedere
se darà il suo endorsement a qualcuno. O se verrà scelto come vice nella corsa
alla Casa Bianca. "Pete Buttigieg è fuori. Tutti i suoi voti del Super Tuesday
andranno al sonnolento Joe Biden. Grande tempismo. Questo è il vero momento in
cui i dem iniziano a mettere Bernie fuori gioco. Nessuna nomination, di nuovo!":
lo ha twittato Donald Trump dopo il ritiro dalla corsa dell'ex sindaco di South
Bend.
Bufera su
Sanders: «Fidel era un dittatore, ma ha fatto anche cose buone».
Il Dubbio il 24 febbraio 2020. Il senatore dem, lanciatissimo nelle primarie, al
centro delle polemiche per le sue frasi sull’ex leader cubano. Ma lui non ci
sta: «Non mi scrivo lettere d’amore con i tiranni come Kim Jong un». Stanno
provocando roventi polemiche le dichiarazioni di Bernie Sanders, il senatore che
si definisce “socialista” che sta al momento guidando le primarie democratiche,
riguardo al fatto che non tutto quello che ha fatto Fidel Castro a Cuba sia da
considerarsi negativo. «Noi ci opponiamo con forza alla natura autoritaria di
Cuba – ha detto Sanders in un’intervista a 60 Minutes andata in onda ieri sera –
ma è ingiusto dire che tutto sia negativo». «Quando Fidel Castro è andato al
potere sapete cosa ha fatto? Ha condotto un massiccio programma di
alfabetizzazione. Questa è una cosa negativa? Anche se l’ha fatta Fidel Castro»,
ha detto il 78 enne senatore rispondendo all’intervistatore che ricordava negli
ottanta disse che i cubani non si ribellavano alla dittatura perché Castro aveva
«trasformato la società». Sanders ha comunque poi ribadito la condanna per la
detenzione dei dissidenti a Cuba, affermando di non avere nessuna simpatia per i
dittatori. «A differenza di Donald Trump, voglio essere chiaro, io non penso che
Kim Jong Un sia una buon amico – ha poi aggiunto – non mi scambio lettere
d’amore con dittatori assassini. Vladimir Putin – ha continuato – non è un mio
grande amico». Le parole di Sanders su Fidel hanno provocato immediatamente la
reazione sui social media, con diversi commentatori che hanno detto che queste
potrebbero creare dei problemi ai democratici in Florida, dove vive una grande
comunità di cubano americani in fuga dal regime castrista.«Spero che in futuro
il senatore Sanders abbia tempo di parlare con qualcuno dei miei elettori prima
di decidere di tessere le lodi di un tiranno assassino come Fidel Castro», ha
twittato la deputata democratica, eletta in Florida, Donna Shalala.
(ANSA il 26
febbraio 2020) - Bernie Sanders sotto assedio nell'ultima sfida tv tra i
candidati democratici alla Casa Bianca prima delle primarie in South Carolina
(sabato) e del Super Tuesday (il 3 marzo). E non poteva essere diversamente, con
i moderati sul palco che hanno tentato in tutti i modi di mettere in difficoltà
il senatore socialista, attuale frontrunner e più che mai lanciato nella corsa
alla nomination. Mentre Elizabeth Warren, l'altra candidata progressista, non
potendo colpire Sanders per l'agenda simile alla sua è tornata a sferzare
Michael Bloomberg, con l'ex sindaco di New York che ha dovuto nuovamente
incassare le accuse di sessismo e discriminazione sul luogo di lavoro. Ma anche
quelle di aver fatto affari con la Cina e di non voler svelare le sue
dichiarazioni fiscali. Il risultato è stata una serata caotica, di cui a tratti
i moderatori hanno rischiato di perdere il controllo. Con la gioia del
presidente Donald Trump e dei molti repubblicani che su Twitter hanno esultato
per le divisioni all'interno del fronte avversario. Divisioni - e questa è anche
la preoccupazione dell'establishment del partito democratico - che alla fine
rischiano di avvantaggiare proprio il tycoon e la sua rielezione il prossimo 3
novembre. E con Trump è andato in scena anche un duello a distanza sulla vicenda
del coronavirus, dopo che le autorità sanitarie federali hanno messo in guardia
da un'impennata dei casi quasi certa anche negli Usa. E se i candidati dem - uno
dei pochi punti su cui si sono mostrati d'accordo - hanno attaccato la gestione
dell'emergenza da parte dell'amministrazione Trump, accusandola anche di aver
tagliato i fondi alla sanità, il presidente non ci ha pensato due volte e ha
risposto in diretta su Twitter: "La mia amministrazione sta facendo un grande
lavoro, compresa l'immediata chiusura dei nostri confini a certe aree del mondo.
Una misura a cui i democratici erano contrari". Il risultato, ha aggiunto, è che
finora negli Usa non c'è stata alcuna vittima. Sanders si è dovuto difendere
dalle accuse di essere aiutato dalla Russia ("non è vero") e di aver difeso la
Cuba di Fidel Castro ("ho detto le stesse cose di Obama"), ma soprattutto dal
portare avanti un'agenda progressista che rischia di far vincere nuovamente
Donald Trump. "Putin vuole la rielezione di Trump ed è per questo la Russia ti
sta aiutando", ha attaccato un Bloomberg leggermente più efficace e a suo agio
rispetto al precedente dibattito televisivo. "Vi immaginate - ha aggiunto - i
repubblicani moderati che votano per Sanders? E se non succede questo non si
vince contro Trump". Sulla stessa linea d'onda Pete Buttigieg: "Se la nomination
andrà a Sanders avremo altri quattro anni di Donald Trump, lo speaker della
Camera sarà repubblicano e i democratici non riusciranno a riconquistare il
Senato. Non è solo la presidenza che conta". In soccorso del senatore è arrivata
la collega Warren: "L'agenda progressista è molto popolare. Noi parliamo di come
costruire il futuro. E' questo quello che conta". Più vivace del solito anche
l'ex vicepresidente Joe Biden, che in South Carolina e' ancora in testa ai
sondaggi e si gioca già gran parte delle sue chance di proseguire la corsa. La
sfida a Sanders è lanciata: "Sabato vincerò io, e conquisterò il voto degli
afroamericani", ha detto, nella speranza di ricompattare la grande alleanza che
portò al trionfo di Barack Obama. Ma nei sondaggi Sanders, che già lo sovrasta a
livello nazionale, è in gran rimonta e fa paura.
Ritratto di Bernie Sanders, il più populista dei candidati
anti Trump. Vittorio Ferla de Il Riformista il 28
Febbraio 2020. Ognuno ha il virus populista che si merita. In Italia ha molte
facce: le norme sulla prescrizione e le intercettazioni, le scoordinate misure
per fronteggiare il Covid-19, l’isteria collettiva provocata dai media. Ma in
America non stanno meglio. Alla Casa Bianca c’è un certo Donald Trump. E i
democratici, finora, non trovano nulla di meglio da opporgli se non un populista
eguale e contrario: Bernie Sanders. Martedì notte si è svolto l’ultimo dibattito
televisivo prima delle primarie in South Carolina e prima del Super Tuesday del
3 marzo. Ognuno ha fatto la sua parte, ma nessuno ha fatto una gran
figura. Elizabeth Warren, senatrice del Massachussetts, è tornata a martellare
Bloomberg sul sessismo. Tattica ossessiva ma inefficace: ricordate lo stile di
Trump con le donne? Sempre la Warren ha promesso di attuare la proposta clou di
Sanders – la sanità pubblica aperta a tutti – meglio di Sanders. Ma perché, alle
urne, gli elettori dovrebbero scegliere lei e non l’originale? Joe Biden, ex
vicepresidente in grande affanno, e Tom Steyer, un miliardario mica da ridere,
si sono litigati i voti degli afroamericani in South Carolina. Quasi una lite da
cortile tra ragazzini. Amy Klobuchar, senatrice del Minnesota, è la più garbata.
Ha cercato di spostare il confronto sul piano della ragione. Teme, non ha torto,
l’autodistruzione dei Dem. Ma tra i giganti dell’estremismo bipartisan – Sanders
e Trump – è destinata a sparire. Poi c’è Michael Bloomberg: nei match televisivi
l’ex sindaco di New York risulta goffo e impacciato. Con tutti i soldi che
spende per la campagna non potrebbe pagare qualcuno per prepararsi meglio a
questi appuntamenti? Di lui si ricorda soprattutto questa frase rivolta a
Sanders: «Vladimir Putin pensa che Donald Trump dovrebbe essere il presidente
degli Stati Uniti. Ed è per questo che la Russia ti sta aiutando a essere
eletto». Un esplicito richiamo alle rivelazioni del Washington Post di qualche
giorno fa che segnalano le interferenze russe nelle primarie. E al rischio che
Sanders sia il miglior avversario per Trump. Ovviamente l’interessato ha
respinto le illazioni. Pete Buttigieg, che ha capito dove si sposta il vento, si
è concentrato nell’attacco a Sanders. Lo ha fatto con una certa efficacia, ma
quel viso acerbo da bravo ragazzo, sconosciuto ai più, non basterà. Alla fine il
senatore del Vermont prende qualche sberla, ma resta in piedi. Bontà sua, ha
pure una parola buona per Fidel Castro e l’amministrazione cubana. Chissà se
in Florida saranno d’accordo con lui. E chissà come si divertirà Donald Trump
tra qualche mese. Pur essendo un politico di carriera, Sanders si presenta come
un ribelle contro le élite, sia repubblicana che democratica, in perfetto stile
populista. Promette una rivoluzione che affascina soprattutto i giovani, anche
se non spiega con quali soldi potrà sostenerla. Ha una capacità enorme di
raccogliere denaro. La sua falange di seguaci è pronta a tutto. Anche a sparare
senza pietà contro chiunque lo ostacoli. Guardate che combinano i Bernie Bros,
un gruppo di trolls che ha intossicato il dibattito politico sui social media.
Ne sanno qualcosa Hillary Clinton e la Culinary Union, il sindacato dei
lavoratori alberghieri che ha osato negargli l’endorsement. In più, il suo côté
madurista fa breccia tra i latinoamericani: per loro è lo “tío Bernie”. Per
queste e altre ragioni molti osservatori – come, per esempio, John Freedland del
Guardian – vedono in lui il Corbyn americano. Il paragone non è di buon
auspicio. Ma la lezione resta valida per tutti i democratici. Anche per quelli
italiani che civettano con il grillismo. Paralizzati in una lotta fratricida,
nel Super Tuesday ci saranno ancora troppi candidati che si rubano i voti tra
loro: forse perché un candidato con un messaggio forte e lo standing adeguato
questa volta non c’è. Un eccesso di frammentazione che favorisce il leader più
populista. Secondo Fivethirtyeight, il sito di matematica elettorale fondato da
Nate Silver, giornalista e statistico che ha previsto i risultati delle
presidenziali del 2008 e del 2012, Sanders ha il 43% di possibilità di ottenere
la nomination (nessuno degli altri candidati esprime percentuali significative).
La stessa percentuale è attribuita all’ipotesi in cui nessun candidato riesca a
conquistare la nomination. In entrambi i casi diventerebbe necessaria la
mediazione tra le parti alla Convention di luglio. Stando così le cose, c’è un
solo pronostico possibile oggi: la vittoria di Trump.
Tutti i dem
contro Sanders.
Orlando Sacchelli su Il Giornale il 27 febbraio 2020. Chi avesse dato
un’occhiata o letto qualcosa sull’ultimo confronto in diretta tv tra i candidati
democratici alle primarie degli Stati Uniti, trasmesso da Charleston (South
Carolina), saprà già che è stato uno scontro dai toni molto accesi. Più che un
dibattito una gazzarra, dove tutti alzavano la voce ed era difficile seguire un
ragionamento senza interruzioni. La posta in gioco, del resto, era (ed è) molto
alta. Oltre al voto in South Carolina c’è l’appuntamento del 3 marzo, il Super
Tuesday, quando si assegneranno moltissimi delegati (1.338) e la corsa,
inevitabilmente, vivrà una forte scrematura. Probabilmente dopo resteranno in
corsa solo 3 candidati, forse 4. Quindi, avranno pensato, è bene darci dentro
ora per cercare di spostare voti. Dopo il dibattito quasi tutti i commentatori
sono d’accordo su una cosa. Bloomberg non sfonda. Si dà da fare, per carità,
mettendocela tutta, però fatica a divincolarsi dagli attacchi degli avversari.
La senatrice Elizabeth Warren l’ha accusato di essere, proprio come Trump, un
sessista con alle spalle accordi extragiudiziali con ex dipendenti vincolate al
silenzio. L’ha accusato di aver esortato una dipendente ad abortire, avendo
saputo della sua gravidanza. L’ex sindaco di New York ha negato tutto. Molto
piccata la replica della Warren: “Non mi importa di quanti soldi abbia il
sindaco Bloomberg. Il cuore del partito democratico non si fiderà mai di lui.
Non si è guadagnato la loro fiducia, io lo farò”. Warren se l’è presa anche con
Sanders, dicendo che su di lei ha lanciato “spazzatura”. Se c’è un filo
conduttore, in questo dibattito, è stato l’attacco contro Sanders. Eppure, in
questo schema, peraltro abbastanza scontato, alla fine il vincitore può essere
considerato proprio lui, l’anziano senatore del Vermont. Che risponde a tutti
con veemenza senza farsi mettere all’angolo da nessuno. L’attacco più forte gli
è arrivato da Michael Bloomberg, che dopo aver sottolineato che ha nostalgia
per Fidel Castro ha insinuato che Putin punta su di lui: “Putin pensa che Trump
debba essere eletto presidente degli Stati Uniti ed è per questo che ti sta
aiutando ad essere eletto candidato, così perderai con Trump”. Poi ha giocato
la carta dell’appello al voto moderato: “Vi immaginate un solo repubblicano
moderato che a novembre potrebbe votare un socialista? Presentando lui andremo
incontro ad una catastrofe, perché garantiremo altri quattro anni a Trump”.
Sanders ha replicato negando ogni legame con Putin, ma al contempo ha voluto
rinfacciare a Bloomberg la sua stima/simpatia per il presidente cinese Xi
Jinping: “Non sono io il grande amico del presidente Xi della Cina, credo che il
presidente Xi sia un leader autoritario e lasciatemi dire che a Mister Putin,
che ha cercato di interferire nelle elezioni del 2016 e di mettere gli americani
gli uni contro gli altri: Hey Mister Putin, se io sarò presidente, fidatevi, non
interferirà più con le nostre elezioni“. Piccola (o grande) gaffe di Bloomberg,
al quale è scappato detto, a un certo punto, di aver “comprato” il Congresso che
ha messo sotto impeachment Trump, con una campagna elettorale da 100 milioni di
dollari che ha aiutato “ventuno democratici a essere eletti”, tra i quali la
Speaker della Camera, Nancy Pelosi. Non ha pronunciato completamente la parola
“comprato”, si è corretto subito usando l’espressione “portati dentro”. Ma molti
sui social hanno sottolineato lo scivolone. Nel corso dell’infuocato dibattito
la senatrice del Minnesota Amy Klobuchar, considerata una centrista, ha avvisato
i democratici del grave rischio che starebbero correndo: “Se passiamo i prossimi
quattro mesi a distruggerci tra i noi, vedremo Trump trascorrere i prossimi
quattro anni a distruggere il nostro Paese”. E Joe Biden come se l’è cavata? Non
male. Anche lui ha attaccato per evitare di finire nell’angolo. In particolare
Sanders, accusato di aver votato contro le “leggi per i controlli sulle armi” e
aver lavorato per “indebolire Obama”. Su certi temi (come ad esempio il sostegno
alla comunità afroamericana) è stato l’unico che si è speso direttamente,
promettendo la nomina di un giudice alla Corte Suprema. Biden punta molto su di
loro per cercare di ottenere la prima vittoria in South Carolina, o comunque un
risultato di grande rilievo (magari un testa a testa), per poter dimostrare a
tutti i democratici di essere nelle condizioni di strappare la nomination dalle
mani del favorito Bernie.
(ANSA il 27
febbraio 2020) - Bernie Sanders potrebbe essere il primo nominee ebreo per la
Casa Bianca ma boicotterà la conferenza della American Israele Public Affair
Commission (Aipac) che inizia domenica accusando i suoi leader di accogliere
persone intolleranti. "Il popolo di Israele ha il diritto di vivere in pace e in
sicurezza. Così pure il popolo palestinese", ha twittato. "Resto preoccupato
dalla piattaforma che l'Aipac fornisce a leader che esprimono intolleranza e si
oppongono ai diritti dei palestinesi. Per questo motivo non parteciperò", ha
spiegato il senatore, che ha conservato l' accento degli ebrei di Brooklyn e che
ha vissuto per un breve periodo in un kibbutz. L'Aipac è un gruppo che promuove
politiche pro Israele presso il Congresso e l'amministrazione Usa.
Bloomberg è
l’unico che può battere Trump ma i dem pensano al “suicidio”.
Vittorio
Ferla de Il Riformista il 22 Febbraio 2020. Con il dibattito televisivo di
mercoledì a Las Vegas, organizzato in vista dei caucus del Nevada di questa
notte, le primarie democratiche salutano un nuovo protagonista: Michael
Bloomberg. È stato il primo confronto pubblico con i suoi concorrenti. Ma non è
stato un bell’esordio. I cinque rivali – Joe Biden, Bernie Sanders, Amy
Klobuchar, Elizabeth Warren e Pete Buttigieg – lo hanno martellato senza pietà,
esaltando le sue debolezze. Joe Biden gli ha rinfacciato performance modeste da
sindaco di New York. La Warren lo ha accusato di sessismo nei confronti delle
donne e delle persone Lgbt e gli ha chiesto di rivelare il contenuto dei
patteggiamenti riservati (e profumatamente pagati) per mettere a tacere le donne
che, lavorando con lui, sono state vittime di comportamenti “inappropriati”.
Sanders gli ha chiesto di mostrare la sua dichiarazione dei redditi, non ancora
pubblicata, per verificare il rispetto delle norme fiscali federali. Tutti i
rivali, ovviamente, hanno cannoneggiato una campagna fondata sulla convinzione
di essere l’unico in grado di battere Trump e di farlo a suon di miliardi di
dollari. “Davvero abbiamo bisogno di un altro riccone alla Casa Bianca dopo
Donald Trump?”, ha chiesto Amy Klobuchar in favore di telecamere. Sanders
sostiene da settimane che Bloomberg vuol comprarsi la presidenza degli Stati
Uniti a suon di quattrini. Questo fuoco incrociato è, per il miliardario, il
primo momento di difficoltà di una campagna elettorale finora condotta (quasi)
esclusivamente nell’etere. Dalla pubblicità nel Super Bowl ai meme su internet,
dai video contro Trump agli spot nei casi più diversi: da mesi, televisioni e
social media sono saturi di Bloomberg. In sostanza, “non puoi cambiare un canale
del televisore o scorrere un feed di Facebook senza vedere un suo annuncio”,
avverte Justin Peters del magazine Slate. “Un ex repubblicano che una volta
sosteneva politiche di sicurezza brutali, che raccoglieva capitale a spese dei
poveri, e che dice regolarmente cose stupide nelle conferenze dei ricchi sembra
essere il candidato emergente per le nomination del Partito Democratico”. Di
recente, su Twitter, la social strategist democratica Elizabeth Spiers, che vive
a Brooklyn e si definisce “Obama native”, descrive così la campagna di
Bloomberg: “messaggi mediocri su vasta scala”. Tuttavia il ritmo e l’estensione
di questa raffica pubblicitaria potrebbero fare storia. Sebbene abbia saltato i
primi round elettorali in Iowa, New Hampshire e Nevada, l’ex sindaco ha speso
finora più di 300 milioni di dollari e prevede di raddoppiare l’importo in vista
del Super Tuesday del 3 marzo. Secondo Nbc News, nelle ultime settimane la sua
campagna ha registrato una spesa media di un milione di dollari al giorno sugli
annunci di Facebook, cinque volte di più rispetto alla celebre campagna di Trump
nel 2016. Curioso di verificare l’impatto di questa valanga mediatica, per circa
due settimane Justin Peters ha condotto un esperimento, divorando per giorni
ogni singolo annuncio e contenuto video pubblicati da Bloomberg sui profili
ufficiali di YouTube, Facebook e Twitter. “Guardare quasi 200 messaggi in un
breve periodo – spiega Peters – è come sottoporsi al lavaggio del cervello, che,
suppongo, sia l’obiettivo di tutta la pubblicità. Molti annunci sono molto
buoni. Molti altri non lo sono. La qualità di ogni singolo contenuto, tuttavia,
è in definitiva meno importante dell’ampiezza dell’insieme. Non è che Bloomberg
non abbia delle buone idee – ne ha pure di buone – o che non sarebbe un leader
più competente dell’attuale presidente in carica”. Il punto è che, conclude
Peters, “l’obiettivo della campagna è raggiungere rapidamente la saturazione per
supplire al gioco democratico che per mesi Bloomberg ha evitato. Odio dirlo, ma
funziona!” Eppure Bloomberg non è soltanto un meme. “In meno di 12 settimane –
racconta Rebecca Ruiz del New York Times – Bloomberg ha messo in piedi uno staff
di migliaia di persone, con oltre 125 uffici in tutto il paese e un elenco di
eventi speciali con tanto di festoni, bevande e tartine”. La campagna “Mike
2020” conta sui servizi della sua società privata: diversi suoi dipendenti sono
stati assegnati alle attività elettorali e altri nuovi sono stati reclutati con
potenti incentivi, inclusi benefici e stipendi ben al di sopra della media degli
altri candidati. Gli addetti (di primo livello) all’organizzazione sul campo
della campagna, per esempio, ricevono un compenso di 72 mila dollari all’anno:
quasi il doppio di quello che offrono le altre campagne. Ai membri dello staff
di Bloomberg sono stati assegnati anche dispositivi elettronici di proprietà
della campagna, inclusi i laptop Apple e gli iPhone di ultima generazione. Anche
per pagare gli affitti – dal quartier generale della campagna di Times Square
agli appartamenti nell’East Side di Manhattan, dove vivono i manager dello staff
– servono milioni di dollari. Altri sono impiegati per pagare una fitta rete di
consulenti, avvocati e membri del team. E gli stipendi sono del tutto fuori
mercato. “Tutti sanno che la campagna è un duro lavoro, lunghe ore e pessime
retribuzioni”, spiega Stu Loeser, portavoce della campagna di Bloomberg. “Non
possiamo cambiare i primi due, ma possiamo fare qualcosa per il terzo”. Per i
dipendenti che lavorano nella sede di New York, racconta ancora Ruiz, “la
campagna offre anche tre pasti al giorno e snack illimitati in un bar che
funziona da centro dell’ufficio. Solo alla fine di dicembre, secondo i dati
raccolti dalla Federal Election Commission, ha pagato oltre 16 mila dollari a un
ristorante di sushi a Manhattan e circa 200 mila dollari a Flik Hospitality, una
società di catering”. Per James A. Thurber, docente di Scienze del governo e
fondatore del Campaign Management Institute presso la American University di
Washington, si tratta di spese assolutamente necessarie: “Partendo così tardi,
Bloomberg deve pagare stipendi superiori al mercato per convincere le persone
migliori a fare i salti mortali”. In più, il bombardamento mediatico non basta:
“Non puoi vincere una campagna elettorale soltanto con una ‘guerra aerea’. Devi
fare anche una ‘guerra di terra’. Bloomberg lo sa, e spende tanto proprio per
preparare la guerra di terra”. La domanda è: ce la farà? Più delle dimensioni
della paga mensile dei collaboratori colpisce la durata degli incarichi: tutti
di lungo periodo visto che coprono tutto l’anno. Il che significa una cosa sola:
nonostante la confusione del campo democratico (o proprio grazie a questa),
Bloomberg è certo di farcela e di essere lui il futuro antagonista di Donald
Trump.
Così Bloomberg ha speso mezzo miliardo in spot per comprarsi
la Casa Bianca. Pubblicato martedì, 03 marzo 2020
su Corriere.it da Milena Gabanelli. Nato in Massachusetts, Bloomberg ha ottenuto
un Mba ad Harvard. Dopo aver lavorato per 15 anni nella banca d’investimento
Solomon Brothers, oggi parte di Citigroup, con i 10 milioni di dollari ricevuti
come buonuscita ha fondato nel 1981 una società di informazione finanziaria: la
Bloomberg LP, che ad oggi ha venduto circa 325 mila abbonamenti in tutto il
mondo e ha ricavi per 10 miliardi di dollari. Ha circa 20 mila dipendenti e
pubblica anche un sito di news generalista e una rivista, Bloomberg
Businessweek, entrambi molto influenti. Dal 2002 al 2013 è stato sindaco di New
York: in quei dodici anni aveva lasciato l’incarico in azienda, e se venisse
eletto presidente sostiene che la venderà.Oggi Bloomberg, 78 anni, è il nono
uomo più ricco del mondo e ha un patrimonio netto di 61,9 miliardi di dollari,
che sta usando per finanziarie da solo la sua campagna elettorale. Secondo i
dati della Federal Election Commission, fino al 31 gennaio ha versato al suo
comitato elettorale 464 milioni e ne ha spesi 409. Per farci un’idea, Trump nel
2016 investì di tasca propria 66 milioni e con le donazioni arrivò a un totale
di 333 milioni per tutta la campagna elettorale, mentre Hillary Clinton raccolse
563 milioni. Le intere presidenziali, secondo un’analisi del Center for
Responsive Politics, costarono a tutti i candidati 1,5 miliardi. Gran parte dei
409 milioni li ha investiti in pubblicità e in uno staff da oltre 2.000 persone,
il più ampio fra i candidati. Secondo i dati raccolti dalla società Kantar
Media, che traccia le spese pubblicitarie, a metà febbraio Bloomberg aveva speso
254 milioni in spot televisivi e radiofonici – di cui 156 solo negli Stati in
gara al Super Tuesday – e 47 su Facebook e Google. Proprio su Facebook, nelle
prime sei settimane del 2020, i suoi spot sono comparsi 1,6 miliardi di volte
nei newsfeed degli utenti sulle 2,4 miliardi totali di tutti i candidati:
insomma, si è comprato il 69% dello spazio.La sua capacità di spesa limita anche
il ruolo dei Super Pac, i controversi comitati di azione politica nati dopo una
sentenza della Corte Suprema del 2010, e che possono finanziare senza limiti i
candidati a patto che non siano coordinati con le campagne elettorali. Gran
parte dei candidati ha rifiutato apertamente l’aiuto dei Super Pac e delle
grandi corporation per motivi etici: in particolare Bernie Sanders ed Elizabeth
Warren, che hanno fatto campagna per limitare l’influenza dei grandi donatori
sulla politica e promesso di affidarsi alle piccole donazioni degli elettori.
Finora gli unici ad aver ricevuto l’aiuto di alcuni Super Pac erano Joe Biden e
Pete Buttigieg: il primo ha ricevuto a gennaio il sostegno finanziario del Super
Pac United the Country, che ha raccolto (e speso) 4 milioni per la sua campagna;
il secondo ha potuto contare sul supporto di VoteVets, che ha mandato in onda
spot per 2,1 milioni di dollari. A febbraio, però, Warren ci ha ripensato,
accettando l’aiuto di Persist Pac, che ha speso 1 milioni di dollari in spot
televisivi in Nevada.Sanders, al momento il grande favorito, ha ricevuto
donazioni da 1,4 milioni di persone nel 2019. Secondo i dati della Federal
Election Commission, dall’inizio della campagna al 31 gennaio ha raccolto 134
milioni e ne ha spesi 121. Altri 46 li ha raccolti a febbraio. Elizabeth Warren
ne ha messi insieme 93 milioni da 892 mila donatori, di cui 90 già spesi e ha
dovuto chiedere un prestito per proseguire la campagna, poi a febbraio ha
raccolto altri 29 milioni. Pete Buttigieg — che domenica si è ritirato — ha
ricevuto 82 milioni da 741 mila persone e ne ha spesi 76; Joe Biden è a 69, di
cui 62 spesi, da 451 mila finanziatori e a febbraio ha ricevuto 18 milioni. Amy
Klobuchar era a 34 milioni da 227 mila donatori, di cui 31 già spesi, ma lunedì
sera si è ritirata anche lei. A parte Bloomberg e l’altro miliardario Tom Steyer
— che ha pagato 193,6 milioni di tasca propria, di cui 37 milioni andati in spot
per il Super Tuesday, finendo per ritirarsi senza aver ottenuto risultati —
tutti i candidati hanno speso parecchi soldi nei primi quattro Stati e sono
rimasti a corto per affrontare i costosi mercati pubblicitari del Super Tuesday:
mandare un’onda una settimana di spot a Los Angeles costa circa 3 milioni di
dollari. Al 31 gennaio Sanders aveva in banca 16,8 milioni, Biden 7,11 milioni,
Buttigieg 6,6 milioni, Klobuchar 2,8 e Warren 2,3. Bloomberg invece aveva ancora
55 milioni, e potrebbe facilmente versarne di più.Secondo i dati di OpenSecret —
che tiene il conto dei soldi ricevuti da ogni candidato — i principali
finanziatori di Sanders e Warren sono i dipendenti della University of
California, di Alphabet (che vuol dire Google), poi Amazon, Microsoft, Apple, la
compagnia telefonica At&T, Walmart. Poi ci sono Buttigieg, che prima di
ritirarsi domenica sera ha raccolto fondi nei grandi studi di avvocati, nel
mondo dell’istruzione e nei settori finanziario e sanitario; Biden, anche lui
finanziato da avvocati e dal settore finanziario, ma anche dagli imprenditori
immobiliari e dai Vigili del Fuoco; e infine Amy Klobuchar, che andava forte fra
gli avvocati e ha ricevuto donazioni dai dipendenti dell’università del suo
Stato, il Minnesota.Finora, i principali candidati hanno speso in pubblicità
meno di un decimo di Bloomberg: secondo gli ultimi dati di Kantar Media,
Bloomberg ha speso 501 milioni di dollari al 28 febbraio, mentre Sanders 50,
Buttigieg 35, Warren 24, Klobuchar 16 e Biden 14. Quest’ultimo però ha raccolto
10 milioni in 48 ore dopo la vittoria in South Carolina di sabato e li sta
investendo in spot per il Super Tuesday. La differenza è che ognuno di loro deve
raccogliere donazioni, mentre Bloomberg paga tutto di tasca propria. E — come ha
raccontato l’ex candidato Andrew Yang citando un suo finanziatore, e come hanno
confermato anche diversi media — chiede ai donatori degli avversari di non dare
più soldi ai candidati, ma di spenderli contro Trump. Insomma, cerca di
togliergli l’ossigeno.Il risultato si vede nei sondaggi. Se fino a dicembre
Bloomberg non veniva neanche rilevato, con la spesa sono cresciuti anche i suoi
numeri: in California l’ex sindaco newyorkese è quarto; in Texas è terzo e
continua a crescere. Come dimostra il ritiro di Steyer, però, i soldi aiutano ma
non bastano a giustificarne i sondaggi. La crescita di Bloomberg, infatti, è
cominciata dopo il fiasco di Biden in Iowa e New Hampshire: in una corsa in cui
i moderati sono deboli, l’ex sindaco si sta pagando la propria scalata. Resta da
vedere se bastano i soldi per fermare la corsa di Sanders e «comprarsi» la
presidenza.
Monica Monnis
per elle.it il 21 febbraio 2020. "Non posso cambiare la storia. Ma si impara dai
propri errori". Michael Bloomberg pochi giorni fa a Houston ha annunciato il suo
sostegno alla comunità afro lanciando la sua campagna Mike for black America e
scusandosi ufficialmente e pubblicamente per quando, da sindaco di New York,
approvò la prassi dello stop and frisk (ferma e perquisisci) ovvero le
perquisizioni senza mandato che colpivano soprattutto le minoranze e i giovani
afroamericani (e per cui Trump lo ha definito su twitter "un razzista totale",
salvo poi cancellare il post ndr). E questo è solo l'inizio, e Bloomberg, 78
anni e da tempo nell'olimpo degli imprenditori più influenti del pianeta
(secondo Forbes, è il 12esimo uomo più ricco al mondo ndr), lo sa benissimo. La
scalata alla Casa Bianca è una gara ad ostacoli (e le elezioni USA 2020 non
saranno l'eccezione) e gli scheletri dell'armadio pronti a essere riesumati da
stampa e avversari (per lui ma come per tutti i candidati alle primarie dei
Democratici in programma il prossimo 3 marzo, nel cosiddetto Super Tuesday ndr).
Uno dei temi più spinosi a cui l'ex Sindaco di New York (dal 2001 al 2013) è
invitato a rispondere, riguarda il trattamento delle donne nella sua azienda, la
celebre Bloomberg LP, società di servizi finanziari, software e mass media nata
nel 1981 che porta il suo nome (e lo ha reso milionario). Come si legge su The
Cut, negli ultimi 20 anni, l'omonima società di informazioni commerciali di
Bloomberg è stata citata in giudizio con quasi 40 cause di discriminazione e
molestie da parte di 64 dipendenti. A condividere l'agghiacciante statistica,
un'indagine del Washington Post, secondo cui l'ambiente della Bloomberg LP
sarebbe "tossico e fortemente sessista". Dunque, mentre il candidato dem sui
social si difende dalle dure accuse della testata sottolineando che "non sarebbe
dove [è] oggi senza le donne di talento che lo circondano", e di essere grato
"della loro leadership, i loro consigli e il loro contributo", sono in molti a
puntare il dito sul tycoon di Boston e ad essere scettici sui suoi speech
incentrati su tolleranza e inclusione. Secondo il WP, quando Bloomberg venne a
sapere della gravidanza della sua dipendente Sekiko Sakai Garrison (che ha fatto
causa al miliardario alla fine degli anni '90) nel 1995, le avrebbe chiesto di
interrompere la gravidanza per preservare il posto di lavoro ("Kill it", le
parole precise). Frasi negate con insistenza dall'imprenditore ma fortemente
ribadite dalla Garrison, che in ogni caso venne licenziata pochi mesi dopo.
Sempre nella stessa causa, l'ex impiegata ricorda poi di aver sentito
pronunciare questa frese a Bloomberg nei confronti di una collega alla ricerca
di una tata: "È un fottuto bambino! ... Tutto ciò di cui hai bisogno è un nero
che non deve per forza parlare inglese che sappia salvarlo da un edificio in
fiamme". Nelle deposizioni dal caso, che si concluse con un risarcimento
privato, Bloomberg però negò ripetutamente le affermazioni definendole "ridicole
e scandaloso". Nel 2001, invece, è il The New York Magazine a pubblicare alcuni
estratti di un opuscolo compilato da Elisabeth DeMarse, una dirigente di
Bloomberg negli anni 90, in cui venivano catalogate alcune delle presunte
osservazioni sessiste e fortemente discriminanti di Bloomberg (definito dalla
DeMarse "senza censure" e spesso sopra le righe) tra cui "Se le donne volessero
essere apprezzate per il loro cervello, andrebbero in biblioteca invece che a
Bloomingdale", oppure "so per certo che ogni donna che si rispetti che passa
accanto a dei lavori in corso e non riceve un fischio si girerà e passerà più
volte fino a quando non ne avrà uno". Le frasi imbarazzanti e misogine non
finirebbero qui. Sempre secondo la denuncia di Garrison, Bloomberg avrebbe
manifestato in più occasioni l'interesse di fare sesso con lei, oltre a
sminuirla in continuazione con frasi altamente inappropriate ("Sei ancora
fidanzata? Cos'è, è così bravo a letto, o tuo padre lo ha pagato per sbarazzarsi
di te?"). Anche un'altra dipendente, Mary Ann Olszewski, ha accusato nel 1996 la
Bloomberg LP per essere una società non propensa a "prevenire o ridurre le
molestie sessuali" operando invece sul "degrado sessuale per le donne". Proprio
a causa di questo ambiente "che permetteva alle molestie di prosperare", la
Olszewski ha raccontato (e poi denunciato) di essere stata violentata dal suo
supervisore. Dunque, Bloomberg ha definito Trump "una minaccia esistenziale per
il nostro Paese e i nostri valori", ma adesso spetta anche a lui fare
immediatamente chiarezza.
Claudio
Salvalaggio per l'ANSA il 20 febbraio 2020. I candidati democratici per la Casa
Bianca si tolgono i guanti nella nona sfida tv a Las Vegas e si attaccano
reciprocamente alla vigilia dei caucus di sabato in Nevada, terza tappa di
primarie ancora troppo affollate. Ma il bersaglio grosso per tutti è l'ultimo
arrivato, il miliardario Michael Bloomberg, che sta scalando i sondaggi con una
campagna di spot pubblicitari da 400 milioni di dollari, la più costosa della
storia americana, insidiando sia il frontrunner socialista Bernie Sanders sia la
pattuglia dei moderati. Per l'ex sindaco di New York, che non partecipa ad un
dibattito politico da oltre 10 anni e che finora si è sottratto al confronto, è
un nuovo debutto ma molto amaro. I suoi rivali lo aggrediscono uno dopo l'altro,
trasformando subito il palco un ring di wrestling a tratti brutale. A dare il la
è Sanders, che accusa Bloomberg di aver sostenuto quando governava la Grande
Mela lo "stop and frisk", la "vergognosa" prassi di fermare e perquisire i
sospetti che discriminava le minoranze nere e ispaniche. Il miliardario ricorda
di aver chiesto scusa e afferma di aver ridotto quella politica quando finì
fuori controllo ma viene smentito da Elizabeth Warren. Ed è proprio la senatrice
che sferra l'attacco successivo, forse il più letale della serata, quando
rinfaccia a Bloomberg i suoi commenti sessisti sulle donne e gli accordi di
riservatezza per sistemare le accuse di molestie sessuali nell'ambiente di
lavoro. "Vorrei parlare di una persona contro cui corriamo: un miliardario che
chiama le donne ciccione e lesbiche con la faccia da cavallo. No, non sto
parlando di Trump, ma di Bloomberg", ha incalzato, ammonendo che " i democratici
si prendono un grosso rischio se sostituiscono un miliardario arrogante con un
altro". Il magnate è rimasto visibilmente imbarazzato ma ha tentato di
difendersi assicurando che nella sua società le donne hanno un ruolo importante
e che non è tollerato nessuno dei comportamenti denunciati dal movimento #Metoo.
Ma quando si è rifiutato di mettere fine agli accordi di riservatezza,
precisando che nessuno lo ha accusato di aver fatto nulla di male anche se forse
qualche sua battuta non è piaciuta, si è beccato i buu del pubblico. Legnate
anche dagli altri concorrenti. Amy Klobuchar lo ha accusato di nascondersi
dietro i suoi spot tv, mentre Joe Biden gli ha rimproverato le sue critiche
all'Obamacare. Pete Buttigieg ne ha approfittato per colpire anche Sanders,
avvisando che i dem "non dovrebbero scegliere tra un candidato che vuole
bruciare il suo partito e uno che lo vuole comprare", tra "un socialista che
ritiene il capitalismo la radice di tutti i mali e un miliardario che considera
il denaro la radice di tutto il potere". Ma Bloomberg non ha dubbi: "solo io
posso battere Donald Trump e ho l'esperienza per fare il presidente, perchè sono
stato sindaco della città con più diversità, imprenditore, manager, filantropo.
Sanders non ha alcuna chance di riprendere la Casa Bianca, avremo Trump per
altri quattro anni". Il senatore del Vermont, in testa a tutti i sondaggi, è
stato il secondo candidato più attaccato: sulla mancata ulteriore documentazione
medica dopo il suo attacco di cuore, sugli aggressivi attacchi social dei suoi
fan, e sulla sua piattaforma socialista. Il colpo più basso glielo ha rifilato
proprio Bloomberg, accusandolo di essere un socialista con tre case diventato
milionario. Il siparietto più divertente è stato tra il giovane Buttigieg e Amy
Klobuchar, che aveva criticato l'ex sindaco per la sua inesperienza ma si è
sentita rimproverare di non aver saputo dire il nome del presidente messicano.
"Un lapsus", si è giustificata. Pete ha infierito e lei gli ha risposto: "Mi
stai dando della stupida? Ti stai prendendo gioco di me?". Nel complesso tutti
possono rivendicare una buona performance, tranne Bloomberg, che esce dal
dibattito con le ossa rotte.
DAGONOTA il 29 febbraio 2020. - Democratici americani a pezzi. Le
grandi speranze riposte in Bloomberg dai ''big donor'' (soprattutto nella
Silicon Valley) e dei media liberal si sono sbriciolate durante il primo
dibattito in cui è apparso l'ex sindaco di New York, che è stato letteralmente
tranciato dagli avversari. D'altronde ciascuno di loro ha vissuto un momento
simile, da Biden a Sanders, dalla Warren a Buttigieg hanno avuto la fase in cui
sono stati presi d'assalto dagli altri candidati, magari perché appena entrati
nella corsa, magari perché in testa nei sondaggi in un determinato momento. Ma
il gruppo di testa è sceso in campo da un anno, c'è chi come Biden e Sanders
tenta la strada della Casa Bianca da lustri, quindi se sono ancora in corsa è
perché hanno avuto il tempo e la capacità di riprendersi dalle botte prese
durante la campagna, sono stati prepped, addestrati, sui loro punti deboli e
dove non potevano dare risposte chiare hanno imparato a prendere colpi, cercando
di schivarne e di restituirne il più possibile. Invece il miliardario Mike è
l'ultimo arrivato, finora aveva fatto campagna solo attraverso pubblicità in tv
e sui social che gli sono costate centinaia di milioni di dollari, e ha deciso
di sottoporsi alla prova del dibattito a soli dieci giorni dal Super Tuesday,
quando per la prima volta il suo nome apparirà sulle schede degli elettori
democratici. Troppo tardi, troppo poco prepped, è andato giù su critiche che si
sarebbe dovuto aspettare. Non è bastato l'aver preso uno degli studi della sua
Bloomberg TV per simulare un dibattito con la sua squadra di comunicazione e un
famoso anchorman. Adesso l'establishment liberal non sa più come fare per
fermare il socialista, inizia a pensare a un ticket Buttigieg-Klobuchar,
mettendo in mezzo i due più ''nuovi'' e moderati per allargare a una base
elettorale meno trumpiana (donne-lgbt-giovani). Ma il clima è piuttosto
disperato, tanto che Obama starebbe cercando di convincere Clinton (Bill, non
Hillary, che ormai quando appare fa solo perdere voti) a fare qualcosa insieme
per dare una spinta ai candidati democratici più centristi. Già nei mesi scorsi
l'ex presidente aveva di fatto bocciato Warren e Sanders, consigliando alla base
dem di puntare su candidati con proposte meno radicali, convinto com'è che Trump
pattinerebbe verso un secondo mandato se dovesse trovarsi contro Sanders.
L'unica buona notizia per i dem è il Coronavirus: Trump punta su una vittoria
trainata dai mercati e dall'economia galoppante, mentre questa settimana a Wall
street è stata la peggiore dai tempi della crisi del 2008. Un tonfo causato
dalla paura degli effetti che una pandemia potrebbe avere in America e nel
mondo. E la borsa non fa piangere solo i ricchi investitori, ma pure i fondi
pensione della classe media: da quando i titoli di stato offrono rendimenti
microscopici, i risparmiatori si sono spostati in massa sul mercato azionario.
Quindi se s'impoverisce il mercato azionario, si impoverisce pure la classe
media. Bisogna capire però se il virus, pur danneggiando Trump, non aiuti ancor
più Sanders, uno che promette protezionismo e sanità gratis a tutti…
Ugo Caltagirone per l'ANSA il 29 febbraio 2020. C'è una data,
martedì 3 marzo, che potrebbe segnare una prima svolta nella campagna elettorale
per le elezioni presidenziali americane: è quella del Super Tuesday, nella quale
si svolgeranno le primarie democratiche in 14 stati, tra cui il Texas e la
California. Ed è l'appuntamento in cui il senatore socialista Bernie Sanders,
già saldamente in testa ai sondaggi nazionali, sogna di iniziare la fuga verso
la nomination, da conquistare nella convention di Milwaukee di metà luglio. Un
sogno rafforzato dopo l'ultima caotica sfida tv in cui Sanders è arrivato da
chiaro frontrunner, e per questo messo letteralmente sotto assedio dagli
avversari. Ma nonostante ciò il 78enne senatore è riuscito a venirne fuori
indenne, mostrando la solita grinta e una energia da far invidia ai più giovani
sul palco. Mentre il fronte moderato dei vari Biden, Buttigieg, Bloomberg,
Klobuchar è apparso più che mai diviso, ma soprattutto incapace di mettere
davvero in difficoltà il vecchio Bernie, accusato di essere troppo radicale e di
avere un'agenda troppo progressista per poter battere Donald Trump nell'Election
Day del 3 novembre. Un modo di vedere le cose che Sanders ha respinto
categoricamente, spalleggiato anche dall'altra candidata della sinistra dem,
Elisabeth Warren: "L'agenda progressista è molto popolare. Noi parliamo di come
costruire il futuro. E' questo quello che conta". Ed è per questo che il popolo
di Sanders è un popolo soprattutto di giovani e giovanissimi. Il confronto si è
svolto nel corso di un dibattito indisciplinato e confuso, caratterizzato da un
sovrapporsi di voci concitate e di braccia sventolate freneticamente per
accaparrarsi la parola. Uno spettacolo che da' l'immagine di un partito
democratico disunito e che permette a Donald Trump di affondare la sua lama nel
fianco degli avversari, per giunta con ironia: "Che caos su quel palco. Datemi
un avversario per favore!". E poi giù con le impietose pagelle dei suoi
potenziali sfidanti, da Sleepy Joe a Mini Mike, passando per Pochaontas Warren,
i suoi ormai popolari e irriverenti soprannomi. E se Bloomberg, il più attaccato
dopo Sanders, guadagna appena la sufficienza, se non altro per essersi mostrato
un po' più deciso e a suo agio rispetto al suo primo dibattito in Nevada, l'ex
vicepresidente Joe Biden ha forse perso l'ennesima occasione di guadagnare il
centro della scena. Anche se nelle primarie di sabato in South Carolina, il
primo stato del sud a votare, i sondaggi lo danno ancora in testa, seppur di
poco. Sanders è in rimonta, anche all'interno dell'elettorato afroamericano,
quello su cui sono riposte quasi tutte le speranze dell'ex numero due di Barack
Obama. Biden ha comunque incassato nelle ultime ore un endorsement chiave in
South Carolina, quello del deputato Jim Clyburn, il membro nero di più alto
livello al Congresso e quello più influente nel mondo democratico di questo
Stato del sud. Se questo basterà per vincere lo si vedrà sabato. Ma anche per
l'ex vicepresidente, così come per le aspirazioni di Bloomberg, l'ora della
verità scatterà nel super martedì.
Giuseppe Sarcina per il “Corriere della Sera” il 29 febbraio
2020. «Questa elezione sarà la più importante di qualsiasi altra nella nostra
vita. E lo dico avendo corso due volte per la presidenza... Dobbiamo compattarci
per portare un democratico alla Casa Bianca... Impegnarsi per l' unità del
partito non è sempre facile... Ma la posta in gioco è troppo alta per consentire
alle divisioni e all' odio di vincere. P.s. Più andremo avanti nel cammino delle
primarie e più ci saranno delle forze che cercheranno di dividerci. Non dobbiamo
consentire che questo accada. Grazie per la vostra partecipazione». Firmato:
Barack Obama. Questo è un estratto della mail che l' ex presidente ha mandato ai
militanti democratici, giovedì 27 febbraio. Due giorni prima delle primarie in
South Carolina e del Super martedì, il 3 marzo, con 14 Stati chiamati alle urne,
compresi California e Texas. Da mesi Obama sfugge ai radar dei media americani.
Si muove nelle retrovie, mettendosi a disposizione dell' organismo centrale del
partito, il Democratic National Committee, promuovendo la raccolta di piccole
donazioni, da 7 a 100 dollari. Oppure concentrandosi su temi di struttura, come
il cosiddetto «gerrymandering», il contestato sistema per disegnare i collegi
elettorali favorendo candidati altrimenti minoritari sul territorio. Una
tecnica, sostengono i democratici, usata storicamente dalle amministrazioni
repubblicane locali. Nonostante il basso profilo, però, Barack spunta un po' da
tutte le parti nello scontro tra i pretendenti. Il suo vice di allora, Joe
Biden, lo evoca continuamente nei dibattiti televisivi e nei comizi. All' inizio
lo citava per condividerne l' eredità politica: l' Obamacare, la lotta al
climate change, la protezione dei dreamers , i figli dei migranti irregolari, e
così via. Ma da ultimo Biden lo usa come una specie di amuleto per bloccare gli
avversari. Innanzitutto contro Bernie Sanders, accusato di aver tramato nel
2011-2012 per sabotarne la rielezione. Certo, secondo le stime la comunità black
vale circa la metà della base democratica in South Carolina. Obama resta la
figura più popolare tra gli afroamericani e non solo. Ecco allora che tutti i
concorrenti si sono dovuti adeguare alla linea: «Perché non possiamo non dirci
obamiani». Lo ha fatto Michael Bloomberg alluvionando le tv con spot in cui si
vede mentre parla con Barack, stringe la mano a Barack e così via. Lo stesso
Sanders ha smentito di aver mai voluto danneggiare la riconferma del primo
presidente afroamericano, anche se i filmati dell' epoca lo smentiscono con
chiarezza. Persino Pete Buttigieg, pur presentandosi con una proposta «che deve
guardare avanti e non indietro», si è allineato. L' ex sindaco di South Bend ha
scritto ai suoi supporter: «Domani (oggi per chi legge ndr ) ospiteremo una town
hall virtuale con Ryann Richardson, Miss Black America, e Reggie Love, ex
assistente speciale del presidente Barack Obama».
A Washington si discute da mesi sul «fattore Obama». Nell'
autunno scorso il leader virtuale del partito aveva dato un' indicazione
precisa: «L' americano medio non pensa che noi dobbiamo smantellare
completamente il sistema e rifarlo da capo. Questo è ancora un Paese che è poco
rivoluzionario ed è invece attratto dal miglioramento progressivo». Era,
ovviamente, uno stop a Sanders. Ma non ha funzionato. E ora che sono concrete le
possibilità che il senatore «socialista democratico» possa conquistare la
nomination, Obama cerca di salvare «l' unità» della base. Anche se non sarà
«facile».
Da “la Stampa” il 29 febbraio 2020. Le signore della «Reckoning
Crew» non hanno dubbi: o Biden, o niente. «Il sostegno di Joe tra gli
afroamericani - spiega Bernice Scott, leader di questo gruppo di attiviste nere
- è innegabile e incrollabile. Durante la campagna ha ricevuto colpi da tutte le
parti, eppure ha resistito e ne è uscito più forte. Ha dimostrato che è
esattamente ciò di cui abbiamo bisogno, per battere Trump a novembre». Quindi
Bernice aggiunge: «In precedenza noi avevamo appoggiato Kamala Harris, perché
credevamo fosse importante avere la sua voce in questa corsa. Quando lei si è
ritirata, ci siamo convinte che era venuto il momento di unire le nostre forze
per sostenere l' unico candidato che può sconfiggere Trump, e aggiustare tutto
ciò che lui ha rotto dal primo giorno di servizio nella Casa Bianca. Joe saprà
costruire sulla storia che aveva già fatto con Barack Obama, quando era il suo
vice». Reckoning significa la resa dei conti, in termini biblici è il momento in
cui Dio chiede agli esseri umani di dimostrare come hanno seguito i suoi
precetti sulla Terra. È una buona metafora per spiegare cosa c' è in gioco nelle
primarie di oggi in South Carolina, ultima occasione per Biden di sopravvivere e
sperare di ottenere la nomination democratica. La «Reckoning Crew» raccoglie
attiviste nere della Richland County, la contea della capitale dello stato
Columbia, che era stata determinante per le vittorie di Obama nel 2008 e Hillary
nel 2016. Lo sarà ancora oggi, non solo per assegnare il primo stato del sud, ma
anche per dare un segnale concreto sulle intenzioni degli afroamericani, che a
novembre saranno decisivi per il candidato democratico. Nel 2016 il 61% dell'
elettorato della South Carolina era nero, e alle primarie l' 86% scelse Clinton,
contro il 16% di Sanders. Fu l' inizio della netta scelta di campo degli
afroamericani, che aiutarono Hillary ad ottenere la nomination, ma non a battere
Trump, perché a novembre non andarono a votare con la stessa determinazione per
lei. Nel 2008 l' elettorato afroamericano rappresentava il 19% dei votanti
democratici nelle primarie a livello nazionale, mentre quest' anno salirà a
circa il 25%. Il dato aiuta a capire il loro peso determinante non solo per la
scelta del candidato, ma anche per la possibilità di sconfiggere il capo della
Casa Bianca. Biden conta di vincere grazie al rapporto con la comunità nera
coltivato nella sua carriera, e rivendicando di essere stato per otto anni il
vice di Obama. In più ha ottenuto l' appoggio del deputato locale Jim Clyburn,
che è il nero più alto in grado al Congresso e ha la forza di muovere l'
elettorato afroamericano nel proprio stato. Ha bisogno del successo per
sopravvivere, e anche per ricevere una spinta in vista del Super Martedì del 3
marzo. Le sconfitte in Iowa e New Hampshire lo hanno danneggiato tra i bianchi,
mentre in Nevada ha dimostrato di non aver la maggioranza tra gli ispanici.
Queste sconfitte hanno fatto sorgere dubbi sulla sua eleggibilità a novembre
anche tra gli afroamericani. Perciò è sceso nei sondaggi, mentre tra i suoi
avversari sono saliti Tom Steyer e Sanders. Il primo perché ha speso parecchi
milioni di dollari per farsi pubblicità in South Carolina. Il secondo perché le
vittorie nelle primarie iniziali gli hanno dato spinta, stavolta ha curato
meglio il rapporto con le minoranze, e alcuni aspetti del suo programma come la
sanità pubblica e l' accesso all' istruzione interessano anche agli
afroamericani. Nelle ultime settimane, diversi sondaggi hanno suonato campanelli
d' allarme per Biden. Un rilevamento nazionale fatto dalla Reuters dopo il New
Hampshire ha notato una diminuzione del 10% della popolarità dell' ex vice
presidente tra i neri, e un aumento del 7% per Sanders, passato così avanti con
il 26% dei consensi contro il 23%. L' ultimo sondaggio, pubblicato giovedì dalla
Monmouth University, ha riacceso l' animo dell' ex vice presidente. Secondo
questo rilevamento, in South Carolina Joe ha accumulato 20 punti di vantaggio su
Sanders, 36% a 16%, mentre tra i neri ha il 45%, contro il 17% di Steyer e il
13% di Bernie. Biden ha assolutamente bisogno che le cose stiano davvero così,
tra le signore della «Reckoning Crew» nella Richland County, in South Carolina,
e in generale tra gli afroamericani, se vuole conservare qualche speranza di
conquistare la Casa Bianca.
Dagonota il 3 marzo 2020. - Obama e il partito democratico hanno
suonato la fine della ricreazione: la corsa dei moderati Buttigieg e Klobuchar
finisce alla vigilia del SuperTuesday: Sanders è più forte del previsto e non è
più tempo di scherzare con candidature che non hanno un clear path, un percorso
chiaro, verso la nomination. È una corsa a due, Biden vs Bernie, e il partito ha
scelto, da quel dì che ha scelto, di fermare il socialista con tutti i mezzi. Lo
fece nel 2016, costringendo gli elettori a sorbirsi Hillary e impedendo la corsa
di chiunque altro, e lo farà anche stavolta. Non solo perché il senatore del
Vermont ha idee radicali, non è iscritto al partito e vuole conquistarlo
dall'esterno, cambiandone per sempre identità e obiettivi – esattamente come
Trump coi repubblicani –. Il problema vero si chiama down-ballot, ovvero ''più
giù sulla scheda elettorale'', e sono tutti quei candidati (435 per la Camera e
33 per il Senato) che dovranno farsi eleggere a novembre insieme al presidente.
Per molti politici dem, soprattutto in collegi contendibili, essere associati a
Sanders viene visto come una iattura, un fatto che spingerebbe moderati e
indipendenti tra le braccia dei candidati repubblicani, facendo perdere ai
democratici il controllo della Camera conquistato nel 2018 e che permette loro
di mettere i bastoni tra le ruote di Trump. Lo scenario-horror
dell'establishment liberal vede la perdita doppia in parlamento e alla Casa
Bianca. I Sanderistas fanno invece notare che lo scenario è esattamente identico
a quello di 4 anni fa: i repubblicani #NeverTrump erano convinti che il puzzone
li avrebbe ammazzati, e invece conquistò sia la presidenza che la maggioranza al
Congresso. Ma l'establishment democratico, come quello del GOP, non guarda tanto
alla vittoria quanto alla propria sopravvivenza. Per questo alla fine si è
ritrovato a puntare su un candidato, Biden, non per la sua forza ma per la
debolezza degli altri, incluso l'ultimo arrivato Bloomberg, che si è schiantato
alla prima curva (il primo dibattito dal vivo). Ora Mike, a differenza di
Buttigieg e Klobuchar, resta in campo per salvare la faccia e prendere almeno il
15% (e dunque qualche decina o centinaio di delegati) in più stati possibile,
per poi consegnare i suoi voti e i suoi miliardi a Biden se l'ex vicepresidente
da qui alla convention non dovesse raggiungere il 50+1 ma solo una plurality (la
maggioranza relativa). L'unica wild card resta Elizabeth Warren. Le sue
prospettive di oggi sono da una parte migliorate, perché due candidati in meno
vuol dire più possibilità di superare la soglia del 15%, dall'altra peggiorate:
è ormai chiaro che siamo davanti a una corsa a due, e scatta dunque la mentalità
del voto utile con la tendenza a scegliere tra i due cavalli principali. A chi
darebbe i suoi delegati? La senatrice per anni è stata molto vicina a Bernie in
termini di idee e proposte, sebbene nell'ultimo anno non abbia risparmiato
attacchi feroci (tra tutti, quello di essere un sessista) anche per
differenziarsi da lui e offrire quello che secondo lei è il giusto mix di
populismo e capitalismo. I suoi fan sono più affini al socialista, ma non è
sicuro che sia pronta a consegnarglieli.
(ANSA il 3 marzo 2020) - "Non credo che sconfiggeremo Donald
Trump con un candidato come Joe Biden": lo scrive Bernie Sanders su Twitter alla
vigilia del Supertuesday in cui si voterà in 14 stati Usa per le primarie
democratiche. Il senatore ricorda come Biden votò per la guerra in Iraq e si
complimenta poi per la corsa compiuta da Amy Klobuchar che ha annunciato il suo
ritiro: "Spero ce i suoi sostenitori si uniscano a noi per sconfiggere Trump a
novembre e vincere un cambiamento reale". Amy Klobuchar e Beto O'Rourke
appoggiano Joe Biden. Nel corso di un comizio dell'ex vice presidente a Dallas,
in Texas, Klobuchar prende la parola e scende in campo per Biden, un candidato
che "può unire l'America". O'Rourke, parlando in inglese e spagnolo, si rivolge
agli elettori texani e li invita a votare Biden. "Stanno effettuando un altro
golpe contro Bernie!" dopo quello del 2016 che favorì Hillary Clinton: così su
Twitter Donald Trump commenta gli ultimi sviluppi sul fronte delle primarie
democratiche alla vigilia del Supertuesday. Il riferimento del tycoon è al
ritiro dalla corsa alla nomination di Pete Buttigieg ed Amy Klobuchar, entrambe
intenzionati a dare l'endorsement al moderato Joe Biden ai danni del socialista
Bernie Sanders. Pete Buttigieg, l'ex sindaco di South Bend ritiratosi dalla
corsa alla nomination democratica per la Casa Bianca, ha ufficialmente dato il
suo endorsement all'ex vicepresidente Joe Biden. "Lui è il leader che può
battere Donald Trump", ha detto parlando a Dallas, in Texas, uno degli stati in
cui si voterà nelle prossime ore per il Super Tuesday. Al suo fianco proprio
Biden.
Ugo Caltagirone per l'ANSA il 3 marzo 2020. Frenare la corsa di
Bernie Sanders prima che sia troppo tardi. Questa la missione di Joe Biden e
Michael Bloomberg che nel Supertuesday non possono fallire se ancora vogliono
sperare di sfidare Donald Trump. E' il tema del supermartedì delle primarie
democratiche americane, la tornata più importante della stagione elettorale che
porterà alle elezioni presidenziali del 3 novembre. Si vota in 14 Stati e in
palio c'e un bottino di 1.357 delegati sui 1.991 necessari per conquistare la
nomination nella convention di metà luglio a Milwaukee. Il 78enne senatore
socialista è in testa un po' ovunque, come confermano i sondaggi dell'ultim'ora:
dalla California al Texas, passando per la Virginia. Quanto basta per
assicurarsi un vantaggio difficile da colmare nei mesi a seguire. Così Sanders
già sogna la fuga incontrastata verso la nomination, quella che gli sfuggì per
un soffio nel 2016 contro Hillary Clinton. Ma tutto dipenderà da come andranno
l'ex vicepresidente, resuscitato sabato dopo la vittoria boom in South Carolina,
e il miliardario ex sindaco di New York, al suo debutto assoluto nelle primarie
dopo aver speso di tasca propria una vera e propria fortuna per la campagna
elettorale. Gli sviluppi delle ultime ore, pero', sembrerebbero far pendere
l'ago della bilancia dalla parte di Biden, destinato a beneficiare dell'addio
alla corsa dei moderati Pete Buttigieg ed Amy Klobuchar, entrambe intenzionati a
dare l'endorsement all'ex braccio destro di Barack Obama. Proprio l'ex
presidente - che avrebbe anche chiamato Buttigieg - in queste ore sarebbe molto
attivo dietro le quinte, nel tentativo di indirizzare la corsa. Intanto Biden ha
reso omaggio a 'Mayor Pete', non escludendo di inserirlo in una futura squadra
di governo: "La sua uscita dalla corsa facilita la mia nomination", ha ammesso
l'ex vicepresidente. La regola elettorale vuole che, Stato per Stato, per
aggiudicarsi dei delegati ogni candidato deve superare una soglia di voti del
15%. E' da questo che dipenderà l'entità della vittoria di Sanders, con Biden e
Bloomberg chiamati a fare il meglio possibile in California e Texas, dove la
posta in gioco è rispettivamente di 415 e 228 delegati. Biden poi spera di
vincere in North Carolina, dove si assegnano 110 delegati. E dopo l'exploit
della South Carolina, punta a sfondare negli Stati del sud come il Tennessee e
l'Alabama, grazie alla spinta dell'elettorato afroamericano che finora sembra
non averlo tradito. A dargli fastidio c'è però Bloomberg, che punta in
particolare sull'Arkansas, lo Stato di Bill Clinton, dove ha investito
moltissimo. Nubi all'orizzonte, infine, per le donne rimaste in gara. Secondo
gli ultimi sondaggi la senatrice Elizabeth Warren rischia di perdere anche nel
suo Massachusetts.
DAGONEWS il 14
febbraio 2020. Il 12 febbraio 2018, i ritratti di Barack e Michelle Obama sono
stati svelati alla National Portrait Gallery (NPG) di Washington. Da quel
momento per la galleria e gli artisti nulla è stato uguale. Kehinde Wiley e Amy
Sherald hanno conosciuto la celebrità e il museo è diventato meta di
pellegrinaggio di migliaia di persone che vogliono vedere i due quadri. Una
fascinazione descritta anche Kim Sajet, direttore del museo che ha raccontato di
aver visto una donna inginocchiarsi davanti al ritratto di Obama per pregare.
L’ex presidente e la first lady sono stati in grado di richiamare migliaia di
persone a tal punto che gli ingressi al museo sono triplicati. «Come direttore
della National Portrait Gallery, avevo un posto in prima fila per assistere a
questo "effetto Obama" – ha detto Sajet - Vedevo migliaia di visitatori che si
riversavano nel museo realizzando quello che per me era un sogno. Ma mi sono
posto una domanda: dato che abbiamo in mostra centinaia di ritratti di famosi
americani, da George Washington a Beyoncé, perché Obama aveva questa capacità di
attrazione? Cosa stava succedendo per davvero? La verità è che per le persone
vedere quei dipinti si stava trasformando in una forma di pellegrinaggio e il
museo stava diventando un luogo di ritrovo. Come ha osservato Michael Dyson
della Georgetown University, Barack Obama, come primo presidente afroamericano,
“ha scioccato il sistema simbolico della politica americana”. L’impatto
culturale ci costringe a considerare l'effetto "Obama" in relazione ai 50 anni
di storia della National Portrait Gallery e, più in generale, della storia degli
Stati Uniti. Dato il "peccato originale" americano della schiavitù è
significativo il fatto che ci sono voluti i ritratti del primo presidente e
della first lady neri per riaccendere un faro sul problema all'interno di uno
spazio originariamente destinato a elevare l’America. Oggi abbiamo ancora le
file di persone. La verità è che oggi la galleria offre qualcosa in più: un sito
in cui i visitatori possono sentire uno speciale legame sociale».
Carlo Nicolato
per "liberoquotidiano.it" il 14 febbraio 2020. La coppia presidenziale più cool
dai tempi di J. F. Kennedy e Jacqueline è ancora più cool da che ha lasciato la
Casa Bianca. Basti pensare che, quando Barack Obama fu eletto per la prima volta
alla fine del 2008, il suo patrimonio sommato a quello della moglie Michelle
ammontava ufficialmente a qualcosa attorno al milione di dollari. Non è che se
la passassero male, ma niente di che a confronto dei 240 milioni di dollari
stimati a fine 2019. Non è una novità che gli ex presidenti Usa traggano
profitto dalla loro esperienza alla Casa Bianca, specie quelli del partito
Democratico, ma la loro performance supera perfino quella della coppia Bill e
Hillary Clinton, fino ad ora la first family più ricca di sempre, se si
escludono Trump e moglie. Il patrimonio dei Clinton, prima della presidenza di
Bill, si aggirava attorno ai 1,5 milioni di dollari, qualche anno fa, prima
della corsa di Hillary alla Casa Bianca veniva stimato 240 milioni. La stessa
cifra degli Obama, i quali però l' avrebbero raggiunta in soli tre anni, con
buone prospettive di moltiplicarla in breve tempo.
CONSORTERIE
ARTISTICHE. Quell'Oscar appena ottenuto per il documentario "American Factory" è
il migliore degli indizi. La pellicola infatti è stata prodotta dalla Higher
Ground Productions, la casa cinematografica fondata dagli Obama nel 2018 in
partnership con Netflix con l'esplicito intento di raccontare progetti che
tocchino temi come diritti civili, differenze etniche, sociali, sessuali ecc. Un
accordo da 50 milioni di dollari quello con la piattaforma cinematografica che
ha già dato i suoi scontatissimi frutti: chi mai avrebbe dubitato che un
documentario prodotto dal Dem dei Dem Obama non vincesse almeno un Oscar in quel
covo di Dem chiamato Hollywood? Ma la famiglia Obama non vanta solo la statuetta
d' oro dell' Accademy Award, ma anche un Grammy vinto stavolta da Michelle per
il più ruffiano dei motivi, cioè per l' audiolibro del suo bestseller Becoming.
Ma che c'entra l'audiolibro con la musica? C' entra in quanto l' audiolibro ha
una colonna sonora, ma soprattutto c' entra eccome quando ci sono di mezzo gli
Obama e premi che rappresentano l' eccellenza dell' omologazione. Di Grammy
peraltro il marito Barack ne aveva vinto uno tutto suo, prima di diventare
presidente, con l' audiolibro di Dreams from My Father. Poi da presidente arrivò
il Nobel per la Pace. Oscar, 2 Grammy e Nobel, non male se si pensa che del Bush
figlio post presidenza si ricordano a malapena i quadri da dilettante allo
sbaraglio. Ma se ancora vi chiedete da dove arrivino quei presunti 240 milioni
di dollari sappiate che il libro di cui sopra, quello che racconta di come
Michelle ha passato il tempo alla Casa Bianca, ha venduto oltre 10 milioni di
copie nel mondo e che è stato il più venduto negli Usa nel 2018, primato
raggiunto in soli 15 giorni. Becoming è anche il libro rimasto più a lungo al
primo posto di vendite su Amazon, record prima detenuto da un' altra mediocrità,
50 sfumature di grigio di E. L. James. Con le autobiografie il marito si era già
messo in pace scrivendo appunto Dreams from My Father: Era il 1995 e Barack
aveva 34 anni, da allora di cose ne sono passate sotto i ponti ed è quindi
lecito immaginare che prima o poi arrivi un' altra autobiografia, quella vera.
Con le registrazioni audio gli Obama faranno tanti bei soldi anche su Spotify
con il quale hanno appena firmato un contratto per dei podcast. Senza
dimenticare i sei episodi dal titolo A Year First che Michelle ha appena
concordato con Instagram Television per raccontare storie di studenti
appartenenti a minoranze etniche.
MATTONE
DEMOCRATICO. Gli Obama poi hanno investito bene anche nel mondo del mattone con
l' acquisto prima della magione di Kalorama a Washington DC, dove si sono
trasferiti dopo aver lasciato la Casa Bianca e poi della spettacolare villa
estiva a Martha' s Vineyard. La prima è costata 8 milioni di dollari, la seconda
12, ma il loro valore è già quasi raddoppiato. Ovviamente non bisogna
dimenticare la più classica delle attività post-presidenziali, le conferenze,
con le quali Barack incassa svariate centinaia di migliaia di dollari a botta.
Problemi? Finché non divorzieranno saranno rose e fiori.
Quel suicidio inaspettato del più grande critico di Obama.
Emanuel Pietrobon su Inside Over il 28 febbraio 2020.
Julian Assange, Chelsea Manning ed Edward Snowden, sono questi i nomi di coloro
che, durante l’epoca di Barack Obama, hanno dato luogo, in episodi distinti,
alla fuga di notizie sensibili e riservate più grave della storia degli Stati
Uniti. Alla lista andrebbe però aggiunto Philip Haney, sebbene la sua popolarità
sia più bassa in Italia. Haney era stato uno dei critici più feroci dell’ex
presidente e aveva condensato le sue accuse, corroborate da prove, in un
libro, See Something, Say Nothing: A Homeland Security Officer Exposes the
Government’s Submission to Jihad, pubblicato nel 2016. Secondo Haney, Obama
stava vanificando gli sforzi dell’antiterrorismo imponendo agli operatori di
seguire una nuova linea d’azione intrisa di politicamente corretto, aiutando
implicitamente la causa jihadista e rendendo possibile che alcuni sanguinosi
attentati avessero avuto luogo, dalla maratona di Boston alla strage di San
Bernardino.
Un suicidio inaspettato. Haney, 66 anni, è stato ritrovato senza
vita a Plymouth, in California, nella giornata di venerdì, con un “singolo colpo
di pistola, auto-inferto” nel petto. Non si avevano più sue notizie da
mercoledì, ma i suoi conoscenti e parenti non erano in allerta perché era
sereno, in procinto di sposarsi, stava lavorando al seguito di See Something,
Say Nothing, e i suoi comportamenti non suscitavano preoccupazione.
Insomma, niente lasciava presagire che Haney si sarebbe suicidato. Non è un
caso, quindi, che nelle ore successive al ritrovamento del corpo si sia
rapidamente diffusa la tesi cospirazionista. La giornalista investigativa Sara
Carter, di Fox News, che era un’amica di Haney, ha scritto su Twitter che è
stato “apparentemente ucciso” e che sta pregando affinché la polizia “trovi chi
lo ha assassinato”. Sembra anche che Haney avesse realizzato un archivio, ricco
di informazioni compromettenti che avrebbero potuto incriminare gli alti vertici
delle due amministrazioni Obama, dando istruzione che fosse aperto nel caso di
una sua morte prematura. Adesso potrebbe essere giunta l’ora della verità.
Chi era Haney. Haney, in quanto profondo conoscitore della realtà
mediorientale ed esperto di islam radicale, era stato scelto da George Bush Jr
per lavorare in prima fila nella guerra al terrore. Quando nel 2002 fu fondato
il Dipartimento per la sicurezza interna (Dhs), Haney vi entrò automaticamente
con un posto già riservato. Le sue indagini hanno portato alla cattura di oltre
300 jihadisti e hanno permesso di sventare decine di attentati sul suolo
statunitense nell’arco di 13 anni. Poi, il 2 dicembre 2015, avviene la svolta:
San Bernardino è colpita da un grave attentato jihadista, muoiono 14 persone e
22 vengono ferite. Haney si dimette dal servizio e un anno dopo pubblica See
Something, Say Nothing, un durissimo j’accuse nei confronti dell’allora
presidente Obama che, a suo dire, stava intralciando le importanti attività del
Dhs, e quindi minacciando la sicurezza nazionale, a causa dell’imposizione di un
nuovo codice di condotta e d’azione, plasmato dal politicamente corretto, nel
trattamento e nel monitoraggio di radicalizzati e jihadisti, noti o presunti. La
goccia che avrebbe fatto traboccare il viso, spingendo Haney a dimettersi e a
denunciare pubblicamente il presidente, fu proprio la strage di San Bernardino.
L’attentatore, infatti, non era sconosciuto all’antiterrorismo, in quanto
soggetto radicalizzato, ma al Dhs dovette cessare le attività di sorveglianza
nei suoi confronti. Era dal 2009 che a Haney e ai suoi colleghi veniva ordinato
di cancellare o alterare le schede dei terroristi e dei radicalizzati contenute
negli archivi digitali del Dhs: lo fece più di 800 volte, fino al
2015. Testimoniò anche davanti al Congresso, nel giugno 2016, confermando quanto
scritto nel libro. Stando alle accuse di Haney, se la presidenza non avesse
imposto agli agenti di lavorare secondo un approccio progressista, orbo e
buonista, il Dhs avrebbe potuto prevenire una serie di attacchi, fra i quali la
strage della maratona di Boston e il massacro di Orlando. In numerosi casi,
però, Haney e la sua squadra furono accusati di portare avanti inchieste
“ingiuste”, giustificate soltanto dalla loro presunta ostilità nei confronti dei
musulmani, oppure offensive, e quindi obbligati a chiuderle.
Super Tuesday, Biden vince in 8 Stati ed è avanti in Texas.
Sanders tiene in California. Pubblicato mercoledì, 04
marzo 2020 su Corriere.it da Massimo Gaggi, Andrea Marinelli , Viviana Mazza,
Marisa Palumbo, Giuseppe Sarcina. Probabilmente sarà la California a salvare la
campagna di Bernie Sanders. Ma il Super Martedì dà slancio a Joe Biden. L’ex
vice presidente vince in otto Stati sui 14 chiamati al voto. E con lo spoglio
ancora in corso è in testa anche in Texas, sia pure di poco sul leader
«socialista democratico». Nelle prossime ore si faranno i conti sui delegati: ce
n’erano 1.357 in palio. Secondo le stime del New York Times, Biden salirebbe a
647 delegati scavalcando Sanders (580). Il debuttante Michael Bloomberg si
fermerebbe a 127 ed Elizabeth Warren a 102. Ma in ogni caso alcuni risultati
politici sono chiari. Innanzitutto il flop di Bloomberg. L’imprenditore
miliardario pensava di poter seppellire gli avversari con il peso della sua
esperienza di manager e dei suoi 500 milioni di dollari investiti in
un’operazione faraonica. Bloomberg, nella nottata italiana, ha fatto sapere che
oggi mercoledì 4 marzo, valuterà con i suoi consiglieri «come proseguire».
Sconfitta rovinosa per Elizabeth Warren, solo terza addirittura nello Stato che
rappresenta in Senato, il Massachusetts e tagliata fuori praticamente ovunque,
coast to coast. Ha funzionato, invece, il ricompattamento dell’area moderata. Lo
stesso Biden ha riconosciuto di aver vinto in Minnesota, grazie ad Amy
Klobuchar. La senatrice di questo Stato del midwest si è ritirata dalla corsa e
ha appoggiato l’ex numero due di Barack Obama alla vigilia del Super Tuesday.
Più difficile, al momento, misurare il travaso dei consensi di Pete Buttigieg,
anche lui uscito dalla gara per convergere sul nuovo front-runner. Questa
tornata cruciale ci consegna una mappa geopolitica spaccata in due dal fiume
Mississippi. Ad est ci sono le terre di Biden. Il filotto del Sud, Virginia,
North Carolina, Tennessee, Alabama: gli afroamericani sono andati alle urne e
hanno fatto lievitare le percentuali di «Joe». Sulla costa Est, la sorpresa del
Massachusetts, a Nord quella del Minnesota. E poi la striscia centrale, dove è
consistente il peso dei bianchi: Arkansas, l’Oklahoma (dove Sanders aveva vinto
contro Hillary Clinton nel 2016). E infine la grande sorpresa del Texas, in
bilico fino all’ultimo. Ad ovest ecco i presidi di Sanders: Colorado, Utah e il
pezzo più pregiato: la California. Sull’altra costa ha piantato una sola
bandierina, nel suo cortile di casa, il Vermont. C’è un’America spaccata anche
in verticale, per generazioni. I giovani tra i 18 e 29 stanno con Bernie, e
questo si era capito. Ma il Senatore del Vermont, 78 anni, praticamente rimbalza
tra gli anziani. Il profilo di Biden è speculare: inesistente tra i ragazzi e le
ragazze; leader assoluto per la terza età. In ogni caso lo scontro non è
risolutivo. Ma le posizioni si sono capovolte. Nel giro di dieci giorni Biden
passa dalla periferia al centro della scena. Si ritrova alla testa di una
coalizione geografica e alla guida di un blocco sociale che al momento appaiono
più ampi rispetto a quelli del suo avversario. Sanders, in sostanza, si aggrappa
alla California e deve ringraziare il voto anticipato. Circa 4 milioni di
cittadini del Golden State si erano espressi nei giorni scorsi. L’11%, per
esempio, aveva scelto Buttigieg: schede che sarebbero potute andare a Biden e
che, invece, non saranno conteggiate. «Bernie» non è riuscito a convincere
«Elizabeth» a farsi da parte, stringendo un’alleanza per non disperdere le
potenzialità dell’area radical. La senatrice ha fatto sapere ai suoi supporter
di guardare avanti e pensare alle prossime primarie. Vedremo se oggi cambierà
idea. I risultati mostrano che Biden ha ulteriori margini di miglioramento.
Nelle prossime settimane lo aspettano le prove di New York e della Florida. Le
sue performance in Massachusetts e nel Maine (dove contende il primato a
Sanders) dimostrano che ha fatto breccia anche tra i liberal. E’ importante
anche aver messo un piede nel Nord industriale, nel Minnesota, dove quattro anni
fa Sanders stracciò Hillary. Ma Nevada e ora California hanno messo in luce le
difficoltà di Biden con i latinos. Nei prossimi giorni avrà la possibilità di
radicare in modo più capillare la rete territoriale, specie se Bloomberg si farà
da parte e lo finanzierà.
Bloomberg, un flop da mezzo miliardo. Resterà in corsa o
appoggerà Biden? Pubblicato mercoledì, 04 marzo 2020
su Corriere.it i da Massimo Gaggi. Da aspirante presidente ad aspirante
kingmaker. La parabola di Mike Bloomberg si consuma in una notte: ha investito
più di mezzo miliardo di dollari nella sua campagna elettorale sperando in un
blitz col quale avrebbe dovuto vincere in Stati importanti come la California.
Ha vinto solo a Samoa, isolette del Pacifico, mentre in alcuni Stati non è
arrivato nemmeno al 15 per cento necessario per partecipare alla spartizione dei
delgati che alla convention di luglio incoroneranno lo sfidante di Donald Trump.
Più ancora dell’errata valutazione dell’efficacia della sua campagna condotta
inondando tv e reti digitali di pubblicità elettorale, Bloomberg paga un altro
sbaglio: aver dato prematuramente per morta la candidatura di Joe Biden. Un anno
fa l’ex sindaco di New York aveva scelto di non candidarsi dando per scontato
che le sue istanze, quelle di un democratico moderato, sarebbero state portate
avanti dall’ex vicepresidente, allora frontrunner della sinistra. Ma dopo
l’estate, davanti al crollo di Biden nei sondaggi, Bloomberg aveva deciso di
uscire allo scoperto proponendo sé stesso, al posto del vecchio braccio destro
di Obama, come alternativa a Sanders. La sua tardiva campagna che, pure, era
partita bene, ha subito, però, un primo infarto col dibattito televisivo in
Nevada: gli attacchi durissimi e concentrici degli altri candidati lo hanno
trovato impreparato, incapace di reagire in modo convincente. Il secondo
infarto, quello decisivo, è arrivato alla vigilia del Super Martedì, con
l’improvvisa resurrezione di Biden. Gli altri candidati scesi dalla giostra
dalle primarie si sono riaccasati, ma alla tenda superaccessoriata di Bloomberg
hanno preferito quella di Joe Biden. E’ vecchia e un po’ lisa, ma rappresenta la
cultura e la tradizione democratica e, probabilmente, gode della benedizione di
Obama. Ora gli strateghi di Bloomberg parlano di una «revisione» della campagna.
Forse un ritiro dalla corsa per la nomination ma non dalla battaglia elettorale
democratica della quale il miliardario ex sindaco di New York vuole diventare il
principale organizzatore e finanziatore rimpiazzando, in questo ruolo, lo stesso
Dnc: la struttura del partito democratico che negli ultimi anni si è dimostrata
sempre più inefficiente e fragile. Adesso Bloomberg diventerà inevitabilmente il
bersaglio del sarcasmo di Trump: già ieri la Fox, la rete televisiva
conservatrice, lo accusava di essere un imprenditore che investe in modo poco
lungimirante, visto che ha speso decine di milioni per ogni delegato
conquistato. La risposta di Bloomberg non può che essere quella di ribadire il
suo impegno prioritario: battere Trump che lui considera una minaccia mortale
per la democrazia americana. Batterlo in prima persona o attraverso un altro
candidato. Al quale il miliardario può offire una machina elettorale molto
potente. Sicuramente più efficiente e meglio finanziata di quella del partito
democratico. Questo per lui significa, ovviamente, tornare in campo per
appoggiare Biden, visto che ha mostrato più volte di considerare Sanders una
sorta di nemico pubblico. Del resto Bloomberg era stato ripagato con la stessa
moneta dal senatore del Vermont che, avendo demonizzato il miliardario sceso in
politica, non potrebbe accettare il suo aiuto anche se l’ex sindaco volesse
darglielo.
DAGONEWS il 2 aprile 2020. Sono almeno 50 gli ex membri dello
staff di Mike Bloomberg che hanno intentato una causa contro il miliardario dopo
la decisione di abbandonare la corsa alla candidatura democratica in vista delle
lezioni alla Casa Bianca. Il personale accusa l’ex sindaco di New York non solo
di aver promesso loro lavoro fino a novembre, ma di aver detratto dal loro
ultimo stipendio l’attrezzatura tecnologica usata durante la campagna. I membri
dello staff hanno anche riferito a NBC News di aver visto detratto almeno 400
dollari per tasse sui iPhone 11 e MacBook che sono stati dati loro durante la
campagna. Un portavoce della campagna ha affermato che il personale era stato
informato durante il processo di off-boarding che avrebbe dovuto pagare le tasse
sugli articoli, ma molti hanno detto alla NBC che non sapevano che l'importo
sarebbe stato automaticamente detratto dalla loro busta paga. Più di 2.400
persone che lavorano per la campagna di Bloomberg sono state licenziate dopo che
lui ha deciso di abbandonare la corsa: i membri del personale licenziato sono
stati invitati a fare domanda per un lavoro presso il Comitato nazionale
democratico. Tutte queste persone perderanno la loro assicurazione sanitaria
alla fine di aprile e molti insistono sul fatto di aver lasciato lavori
redditizi con una promessa di un impiego fino a novembre. A fine marzo lo staff
di Bloomberg ha rilasciato una dichiarazione: «Questa campagna ha pagato salari
e benefit al personale come nessun altro ha fatto».
Il Super Tuesday travolto dallo tsunami Joe Biden: "Siamo più
vivi che mai". Le primarie Usa cambiano volto. Anna
Lombardi su L'Ansa il 3 marzo 2020. L'ex vice di Obama, dato da tutti per
spacciato, rinasce nel super martedì grazie all'endorsement di Pete Buttigieg e
Amy Klobuchar. «È una notte straordinaria, siamo più vivi che mai». È un Joe
Biden raggiante quello che appare sul palco del Baldwin Hills Recreation
Center di Los Angeles quando in California sono passate da poco le sette di sera
e le urne sono ancora aperte, ultimo Stato dove a causa del fuso orario si vota
ancora. Nel resto d’America i giochi sono fatti. E l’ex vice di Barack Obama,
fino a pochi giorni dato da tutti per spacciato, sa di essere tornato in gara.
Con mezza America a fare il tifo per lui: «La nostra campagna sta decollando.
Unitevi a noi per cambiare le cose» dice: brevemente interrotto dall’attacco di
due fanatiche animaliste, lanciatesi sul palco cartelli anti-latte alla mano, e
subito portate via di peso dai bodyguard. E pazienza se proprio la California,
lo stato più popoloso d’America e dunque quello dov’erano in palio il maggior
numero di delegati, 415 – non solo gli volta le spalle preferendogli il
rivale Bernie Sanders, vittorioso con quasi il 30 per cento dei voti, come
d’altronde ampiamente annunciato dai sondaggi. Ma lo relega addirittura al terzo
posto, dopo Michael Bloomberg che qui ottiene il suo miglior risultato. A dirla
tutta, Biden non sfonda nemmeno in Texas, secondo premio più ambito della
giornata, dove è testa a testa col rivale. Ma che importa: con un bottino di
almeno 339 delegati torna prepotentemente in gara, frenando l’ascesa del
candidato “socialista” che lo segue con 287.
Super Tuesday delle primarie Usa: è il giorno di Biden ma la
California va a Sanders. Texas in bilico. Male Bloomberg:
pensa al ritiro. Alessio Sgherza il 3 marzo 2020 su La
Repubblica. Primarie Usa, i dem ricompattati per il Super Tuesday. «Non siamo la
faccia dell’establishment. Vogliamo tutti la stessa cosa, una politica decente:
e la gente lo ha capito». Al solito, è la senatrice del Minnesota Amy Klobucher
a spiegare nel modo più semplice e diretto cosa ha scatenato in meno di 24 ore
quello che già tutte le televisioni chiamano “lo tsunami Joe Biden”. È bastato
il ricompattamento del partito democratico intorno ad un unico candidato, l’ex
vice di Obama appunto, appunto, per ribaltare le sorti della campagna
elettorale. Imponendo sul podio della raccolta dei delegati proprio colui
chiamato spregevolmente “Sleepy Joe”, Joe l’addormentato, da Donald Trump. Ma
che tutti sanno essere il rivale finora più temuto dal presidente degli Stati
Uniti, pronto a congelare gli aiuti ad un’intera nazione, l’Ucraina, pur di
trascinarlo nel fango. E invece. Nonostante l’età, le gaffe e lo scandalo del
Kievgate - che lo ha comunque colpito, rischiando di affossarne la corsa - Biden
è davvero l’araba fenice del Super Tuesday. Tornato prepotentemente in gara dopo
aver incassato nelle ultime ore gli endorsement più diversi: non solo quelli
degli ex rivali Amy Klobucher e Pete Buttigieg - quasi certamente con lo zampino
di Barack Obama - ma anche quello dell’ex consigliera alla sicurezza
nazionale Susan Rice, l’attivista del movimento #MeToo Alyssa Milano, la vedova
del senatore Ted Kennedy, Victoria: e tanti altri. Tanto da aggiudicarsi almeno
8 Stati su 14: Virgina, Alabama, Carolina del Nord, Tennessee, Arkansas,
Massachusetts, Minnesota, e perfino l’Oklahoma che nel 2016 era stata vinta da
Sanders. Mentre Sanders ottiene l’ambita California e poi Colorado, Utah e il
suo Vermont: quasi sempre con percentuali inferiori a quelle di 4 anni fa.
Bloomberg e Warren gli sconfitti del Super Tuesday. Nella
giornata del suo grande esordio, il miliardario Michael Bloomberg, che pure
aveva aspettato il Super Tuesday per scendere in gara sperando nell’uscita di
scena di Biden, non sfonda: e nonostante un investimento di 50 milioni di
dollari in spot elettorali, primeggia in una sola gara, quella delle Samoa
americane, imponendosi solo in California e in Utah, secondo a Sanders,
però. Elizabeth Warren, invece, non vola nemmeno nel suo Massachusetts: dove è
terza con poco più del 20 per cento, dietro a Biden che vince e Sanders.
Usa 2020,
Warren si ritira: «Biden o Sanders? Speravo in una terza via».
Pubblicato giovedì, 05 marzo 2020 da Corriere.it. Ci ha pensato per un giorno,
ma dopo i risultati del Super Martedì oggettivamente non c’era altra scelta
possibile. «La mia campagna finisce qui, ho creduto potesse esserci una terza
corsia tra quella moderata di Joe Biden e quella progressista di Bernie Sanders.
Mi ero sbagliata». All’ora di pranzo Elizabeth Warren si presenta ai giornalisti
che l’aspettano sotto casa, a Cambridge, Massachusetts. Contiene l’emozione. È
senatrice di questo Stato dal 2013. Eppure anche i suoi concittadini l’hanno
relegata al terzo posto, nelle primarie democratiche del 3 marzo. L’annuncio,
dunque, era nell’aria. Che cosa farà adesso? Secondo logica politica dovrebbe
appoggiare Sanders. Come fece, per altro, senza alcun tentennamento, nel 2016,
preferendolo a Hillary Clinton. Ma la risposta di ieri è sorprendente: «Non ho
deciso, adesso voglio prendere un lungo respiro. Voglio capire qual è lo
schieramento migliore in cui far avanzare le mie proposte». Biden e Sanders si
sono subito fatti vivi. Nulla di segreto, «ci sono state delle telefonate»,
fanno sapere gli staff dei due concorrenti rimasti in gara. È iniziata, dunque,
una vera trattativa e l’esito non sembra scontato. Warren, 70 anni, giurista e
docente a Harvard, è stata molto chiara. Non si è mai considerata una copia
sbiadita del radicalismo di Bernie, ma la promotrice di una specie di terza via,
«per costruire una piattaforma di riforme strutturali». In tutti questi mesi, in
realtà, la percezione era stata diversa. Warren si è candidata ufficialmente il
9 febbraio 2019, con un comizio nella antica città operaia di Lawrence, nel
Massachusetts. La sua visione è simile a quella di Sanders: viviamo in un
sistema economico e politico corrotto e al servizio dell’1% più ricco della
popolazione. Nei dibattiti televisivi ha sempre attaccato duramente tutti gli
altri concorrenti, risparmiando solo «Bernie». Fino a metà gennaio, quando in
diretta tv, la senatrice gli rinfaccia di averle detto in privato che una donna
non potrà mai vincere le presidenziali. In quel momento, forse, tra i due si è
rotto qualcosa. Nelle ultime settimane frange di sandersiani hanno scorticato la
senatrice sui social. Lo scenario, però, potrebbe essere un altro. Al di là dei
rapporti personali, Warren sta valutando se non sia meglio un compromesso con
Biden, in questa fase il favorito nella corsa, piuttosto che imbarcarsi in «un
movimento» completamente dominato dalla figura del leader «socialista
democratico». Sulla carta la scelta di Elizabeth può spostare gli equilibri,
almeno in alcuni Stati. Lo ha fatto notare anche Donald Trump, spettatore
interessato, con un ruvido tweet: «Elizabeth “Pocahontas” Warren, non stava
andando da nessuna parte, se non nella testa di Mini Mike (Bloomberg ndr). Si è
ritirata con tre giorni di ritardo. La sua presenza è costata al “pazzo” Bernie,
almeno, il Massachusetts, il Minnesota e il Texas». Martedì 10 marzo saranno
chiamati alle urne altri sei Stati. Il pacchetto di voti della Warren farebbe
comodo in particolare nel nord industriale del Michigan o nel territorio di
Washington sulla costa ovest. In queste zone i sondaggi attribuivano alla
senatrice circa il 10-11%. Biden proverà a reclutarla, come ha già fatto con
Pete Buttigieg e Amy Klobuchar. L’ex vice presidente si richiamerà, come fa
sempre, «all’età dell’oro di Barack». Probabilmente ricorderà che Elizabeth
lavorò per l’amministrazione Obama dal 2010 al 2011, ideando l’istituzione di
un’Authority per la difesa degli utenti di banche e finanziarie. Come dire:
abbiamo un terreno comune, possiamo trovare un accordo.
Primarie Usa, il Super Tuesday nero di Bloomberg: "Non so se
mi ritiro, vedremo. Ma sono pronto a tutto pur di battere Trump".
Claudi Tito il 3 marzo 2020 su la Repubblica. Al 4926 di Cesar Chavez Street,
nel quartier generale dei fedelissimi di Sanders qui a Austin, la rinascita di
Joe Biden deprime profondamente i fedelissimi di Bernie. Un testa a testa che
vuol dire che si spartiranno in parti quasi uguali il bottino di 228 delegati.
Ad accorciare le distanze, dicono i commentatori, è stato il comizio di Dallas
di lunedì sera, dove Biden è apparso con Klobucher, Buttigieg e Beto O’Rourke al
suo fianco. E infatti poco più in là, al 2922 dello stesso stradone punteggiato
di capannoni industriali ad est della capitale del Texas, i tanti che si sono
riuniti nella sede locale della campagna di Biden esultano, sindaco della
città Steve Adler – il veterano amico di Buttigieg anche lui unitosi all’ex vice
di Obama nelle ultime ore – in testa. «Sanders ha ancora il suo movimento» dice
Ken Herman, editorialista politico del giornale locale Austin
American-Statesman, anche lui alla festa. «Ma Biden ha decisamente il suo
momento».
Paolo
Valentino per il “Corriere della Sera” il 26 febbraio 2020. «L' imperativo è
mandare Trump via dalla Casa Bianca: sosterrò qualunque candidato democratico e
se vince, sosterrò il presidente democratico». Hillary Clinton gioca la carta
della lealtà, anche se probabilmente di Bernie Sanders, attuale battistrada dei
democratici nella corsa alla nomination, pensa tutto il male possibile. «È stato
al Congresso per anni: non piace a nessuno, nessuno vuole lavorare con lui, non
ha mai concluso nulla. È un politico di carriera», dice di lui Madame Secretary
nel documentario dedicato alla sua vita, pubblica e privata il che è la stessa
cosa, realizzato da Nanette Burstein e presentato ieri al Festival del Cinema di
Berlino. Quattro puntate di un' ora ciascuna, per uno straordinario viaggio
attraverso più di mezzo secolo di storia degli Stati Uniti. Ma soprattutto il
ritratto senza filtri e senza calcoli, genuino e a volte perfino disarmante, di
una donna che come nessuno ha definito la politica americana, ma che come
nessuno è stata sempre a torto o a ragione percepita come carrierista,
calcolatrice, manipolatrice e insincera. L' ho intervistata insieme a un gruppo
di giornalisti di testate internazionali.
Perché ha
accettato di fare un film, nel quale parla anche di episodi dolorosi della sua
vita?
«Sono stata
nella vita politica per un tempo molto lungo e ho visto così tante idee
sbagliate e storie non vere su di me. C' è un momento nel quale vuoi mettere le
cose in chiaro. Mi sono detta: vi posso piacere o meno, ma guardatemi con
qualche elemento di autenticità e verità su chi sono sempre stata e chi sono.
Credo che questo documentario lo dica bene».
Torniamo alle
sue riserve su Sanders.
«Riguardano
non solo lui personalmente, ma la cultura della sua campagna, del suo team e dei
suoi principali sostenitori. Penso al sito Bernie Bros e ai continui attacchi
contro gli avversari democratici, in particolare le donne. È molto preoccupante
che Sanders non solo permetta, ma incoraggi questa campagna denigratoria. Spero
che le persone ne tengano conto al momento di prendere la loro decisione».
Avendo perso
contro Donald Trump, quale consiglio gli darebbe per batterlo?
«Ho avuto 3
milioni di voti in più di Trump. E nell' elezione del 2016 ci furono aspetti
senza precedenti. Alcuni, come l' interferenza russa, sembrano ripetersi anche
questa volta. Ho detto a tutti i candidati che dobbiamo battere Donald Trump, ma
che dobbiamo vincere anche contro l' interferenza straniera, la propaganda sui
social media, gli ostacoli insormontabili a votare posti contro le minoranze che
sono la specialità repubblicana. È una sfida difficile. Credo che possiamo e
dobbiamo farcela e farò di tutto perché questo succeda».
C' è una scena
a casa di Tim Kaine, il suo candidato vice-presidente nel 2016, in cui lei
descrive Trump come un Manchurian candidate, anche se non usa questa
espressione, uno che «ha l' agenda politica di qualcun altro». In pratica, un
agente di Putin. Ora Trump è il presidente. Lo pensa ancora?
«Non mi spingo
così lontano a dire che è un Manchurian candidate, ma dico che ammira Putin e si
è dimostrato straordinariamente disponibile a sposarne le posizioni. La scena
cui si riferisce, comincia con Tim che dice: "Ho parlato con il presidente Obama
e mi ha detto: andate là fuori e sconfiggete il fascista". Eravamo molto
preoccupati, anche se non pensavamo che Trump potesse vincere».
Neppure Trump.
«Forse no. Ma
la gente che era intorno a lui e stava manipolando il processo elettorale ha
investito molti soldi per farlo vincere. Nonostante le idee sbagliate sul mio
conto, credo che alcuni dei miei avversari mi capiscano perfettamente. Anche
Putin aveva capito bene il mio impegno a difendere la libertà, il rapporto
transatlantico, la Nato e l' Europa, quando ha deciso di far di tutto perché
perdessi. Trump è un presidente innamorato dei leader autoritari, al quale
piacerebbe poter mandare i suoi oppositori in galera e poter fare qualunque cosa
a prescindere dai limiti della legge. Ancora più importante, è cos' ha fatto:
indebolire la Nato, attaccare la Ue, denunciare l' accordo con l' Iran,
screditare la lotta contro i cambiamenti climatici, minare il nostro ruolo nel
mondo. Tutte cose che vanno a favore di Putin. E non sappiamo tutto. Quando
Trump parla a tu per tu con Putin, e parlano molto spesso non si sa nulla, non
c' è nessuno che prenda appunti . Il presidente Obama e io stessa abbiamo
incontrato centinaia di leader, compreso Putin, ma c' era sempre un note taker .
Non volevamo fraintendimenti. Trovo molto grave che leader autocrati vengano
incoraggiati dal presidente americano».
Vedendo qual è
la situazione, pensa ancora che fu giusto intervenire in Libia?
«Penso di sì,
ma non ci fu il seguito che era necessario. Guardi alla Siria oggi, dove non
siamo intervenuti. Quattrocentomila morti, milioni di profughi, un regime
criminale sostenuto dall' Iran sul terreno e dalla Russia dall' aria. In Libia
le persone si rivoltarono per le stesse ragioni contro un tiranno. Gheddafi
aveva detto che li avrebbe uccisi come scarafaggi e lo avrebbe fatto. Il mondo
arabo e gli alleati europei ci chiedevano di intervenire. Era uno sforzo
internazionale e quella missione fu portata a termine. Poi non è successo nulla.
I libici che lottavano per la libertà non avevano alcuna idea della politica,
erano accademici, imprenditori, avevano bisogno di aiuto e noi, gli Stati Uniti
e l' Europa, non abbiamo dato loro il tipo di sostegno che avrebbe potuto
normalizzare il Paese. Oggi c' è una sanguinosa guerra per procura per spartirsi
le risorse energetiche e il territorio libico».
Super Tuesday, Biden il vincitore L’amicizia di Obama, l’odore
di establishment. Pubblicato mercoledì, 04 marzo 2020
su Corriere.it da Massimo Gaggi. Il cuore e il cervello. Il cuore del vecchio
Sleepy Joe, come lo apostrofa Trump, che ha ripreso a battere forte. E il
cervello freddo di Barack Obama, umanamente vicinissimo al veterano suo vice per
8 anni, ma che poi lo aveva dissuaso dal correre per la Casa Bianca nel 2016,
lasciando via libera a Hillary Clinton. Un Obama che anche nella campagna
attuale, non era mai sceso in campo in suo favore invocando, semmai, «sangue
nuovo» per le presidenziali 2020. Fino alla svolta maturata in appena 72 ore. È
questo lo sfondo del ritorno di Joe Biden, la rinascita politica più
sorprendente e clamorosa delle recente storia politica americana. Assorto,
smarrito, a volte balbettante, Biden sembrava già un capitolo archiviato dopo le
prime tre votazioni del grande circo delle primarie. Fino alla riscossa di
sabato scorso in South Carolina e all’incredibile vigilia del Super Martedì
quando il rischio di una vittoria a valanga di Bernie Sanders — un leader
considerato troppo radicale ed estraneo alla storia del partito democratico per
essere il perno di una coalizione capace di battere Donald Trump — ha spinto
l’ex presidente a mettere la corsa per la Casa Bianca su nuovi binari. Per mesi
Barack si è mantenuto sopra le parti parlando di unità del partito e ha
incontrato i giovani candidati centristi che sfidavano il suo vicepresidente,
alimentandone le frustrazioni. Biden, che non è mai riuscito a trasformare
un’amicizia profonda — cementata da otto anni di gioie e dolori vissuti insieme
a cominciare dalla tragedia della morte di suo figlio Beau — in una vera
alleanza politica, aveva addirittura raccontato la sua delusione per il mancato
appoggio di Barack nel 2016 in Promise me, dad, il suo libro di memorie
politiche. Ma quando il rischio di una vittoria a valanga di Sanders è diventato
concreto, Obama ha rotto gli indugi esercitando una pressione discreta ma nitida
dietro le quinte per convincere gli altri candidati centristi che non erano
riusciti a sfondare nelle sfide iniziali delle primarie a ritirarsi dalla corsa.
Non solo: nell’arco di poche ore Pete Buttigieg e Amy Klobuchar sono passati dal
ruolo di sfidanti di Biden a quello di suoi alleati entusiasti, decisi a
trainarlo verso la vittoria contro Sanders prima e contro Trump a novembre.Il
ritorno di Biden galvanizza i democratici riformisti, da tempo smarriti, ma
approfondisce il solco che spacca la sinistra: gli attacchi durissimi lanciati
ieri sera contro Biden da un Sanders deluso, lasciano spazio a un possibile
remake del 2016, con i fan del candidato socialista scatenati contro Hillary
Clinton durante le primarie e poi non disposti a votarla a novembre anche a
costo di dare via libera a Trump. Sembrava che, dopo quattro anni di «The
Donald», uno scenario simile fosse impensabile. Anche perché Joe non è l’algida
Hillary: nonostante le accuse di Trump al figlio Hunter per i suoi affari in
Ucraina e Cina, Biden ha un’immagine di onestà e di vicinanza empatica al mondo
del lavoro che mancava alla ex first lady. Ma le chat dei sostenitori di Bernie
sono già piene di invettive contro Biden e di spiegazioni del perché non
voteranno mai per lui: il leader più radicato in quell’establishment democratico
che la nuova guardia della sinistra radicale ha deciso di abbattere a tutti i
costi. Ma andare avanti con uno scontro all’ultimo sangue tra i due può essere
un grosso regalo a Trump. Che già dipinge Sanders come la vittima di una
congiura democratica. Bernie continuerà a combattere ma sa che, se non la spunta
su Biden, lo manderà indebolito al confronto con un presidente che anche lui
considera un pericolo mortale per l’America. Ieri Sanders ha dovuto prendere
atto che il suo momento migliore è passato e che riempire le piazze non basta:
ha conquistato la California, ma non è riuscito a prendere né il Texas, né i due
Stati sui quali aveva investito maggiormente: il Massachusetts liberal e il
Minnesota che aveva strappato a Hillary 4 anni fa. Sabato a Boston erano in 13
mila a osannarlo in un Stato nel quale Biden non è andato quasi mai. Ma alla
fine ha vinto lui.
Dagospia il 4 marzo 2020. Da Circo Massimo - Radio Capital. Il
Super Tuesday consacra la rinascita di Joe Biden. Dato da tutti per spacciato,
l’ex vice di Obama ha confermato il suo ritorno in pista, vincendo in nove stati
e candidandosi ora nel ruolo di anti-Trump. Una scalata che rappresenta “una
clamorosa sorpresa - spiega il corrispondente di Repubblica negli States
Federico Rampini a Circo Massimo, su Radio Capital - era dato per defunto, dopo
una serie di performance disastrose nei dibattiti televisivi e un inizio pessimo
nelle primarie. La sua rinascita ha del miracoloso”. Un miracolo dovuto anche ai
ritiri di Pete Buttgieg e Amy Klobuchar. “Il partito democratico ha avuto la
capacità di imporre una disciplina e di far convergere i voti su Biden”
aggiunge il giornalista, intervistato da Massimo Giannini e Jean Paul Bellotto,
che ora rende “molto complicata la rincorsa di Bernie Sanders, perché la
maggioranza del partito è moderata e c'è una gran voglia di ritorno alla
normalità”. Secondo Rampini, “Biden non è uno che fa sognare, non è carismatico
ma rappresenta un vecchio modo di fare politica, basato sul buonsenso e
sull'esperienza e conoscenza dei dossier". Al contrario di Sanders: "Fa sognare,
promette la socialdemocrazia, ma parte dei democratici teme che le riforme
radicali da lui proposte (sanità pubblica, università gratuita, super tasse sui
ricchi) possano portare alla sconfitta contro Trump”, fa notare il
corrispondente di Repubblica. Anche perché, continua Rampini, “Biden è un po’
diverso da Hillary Clinton, ha una storia da famiglia operaia. Per i colletti
blu del Midwest, decisivi nell’elezione di Trump nel 2016, è più semplice
identificarsi con lui rispetto alla Clinton. Sulla carta Biden è il candidato
giusto per sconfiggere Trump ma una sfida così polarizzata porta il rischio che
una parte dei seguaci di Sanders non vada a votare, soprattutto i giovani. Per
loro avere Biden è come avere Trump". Fra le prossime tappe "la più importante
di tutte è il 28 aprile, quando si voterà a New York e in una serie di stati nel
nordest", spiega Rampini, "Prima, a metà strada, c'è il voto in Midwest, che
sarà ocmunque molto importante. Ma ce ne sarà una a settimana".
Flavio Pompetti per “il Messaggero” il 4 marzo 2020. Il più
giovane tra tutti è il presidente in carica: Donald Trump, che dall'alto delle
sue 73 primavere guarda con un certo disdegno il resto del plotone. Tra i
democratici che gli contendono la rielezione il prossimo novembre - nel partito
che fu dei quarantenni Kennedy, Clinton e Obama - c'è un solo 77enne: il canuto
Joe Biden che Trump ha già ribattezzato Joe il lento, proprio a causa dell'età
che gli ha corroso parte dei riflessi. Sopra di lui in ordine gerontologico c'è
poi la coppia degli splendidi 78enni Bernie Sanders e Michael Bloomberg. Quella
che una volta si chiamava la giovane democrazia statunitense è oggi dominio di
una classe di veterani, che per una serie di concomitanze si trovano a
progettare il futuro del paese. Il dato è ancora più stridente se si pensa che
le tappe delle primarie finora celebrate sono state dominate, almeno dal punto
di vista dei rilevatori di opinione e degli statistici, dall'ossessione di
interpretare il voto dei giovani che per la prima o la seconda volta stanno
andando alle urne per selezionare il prossimo presidente. Le elezioni di metà
mandato del 2018 avevano portato al congresso un contingente di politici in
erba, determinati e combattivi. Eppure al momento di incanalare tale forza di
rinnovamento nella strettoia del voto presidenziale, il gruppo di elettori che
sta alla base di tale fenomeno non ha trovato di meglio che cementarsi intorno a
Bernie Sanders, un settuagenario legato ad una retorica da guerra fredda e a
concetti che altrove nel mondo venivano dibattuti quaranta, e forse più anni fa.
Meno sorprendente è la presenza di Bloomberg e di Trump tra le file di questa
gerontocrazia politica. I due non sono stati scelti per acclamazione popolare,
ma hanno usato rispettivamente la propria ricchezza e la propria celebrità come
grimaldello per entrare nei salotti della politica. Sia il mogul dei media
finanziari, che l'imprenditore-uomo di spettacolo, hanno passato gli anni
migliori della loro vita a costruire il trampolino dal quale si sono poi
lanciati nella mischia elettorale. Biden avrebbe potuto farlo prima, al culmine
di una carriera interamente dedicata alla politica, ma la meteora Obama prima e
il lutto per il secondogenito poi lo hanno frenato. Sanders è di per sé un
relitto del passato: ha trascorso l'intera carriera congressuale in altero
isolamento dichiarandosi indipendente, e ha scelto il campo democratico solo in
chiave elettorale quattro anni fa. Questo fenomeno non è senza conseguenze. Da
tre anni gli Usa stanno rincorrendo la visione retrotopica del presidente Trump,
ispirata a un nostalgico quanto irreale ritorno ad un passato di isolamento
insulare e di mantenimento di privilegi. Una vittoria dell'attuale capofila dei
democratici Bernie Sanders rischia di dirigere la rotta verso obiettivi
altrettanto utopici e idealisti che hanno poco a che vedere con la realtà.
Massimo Gaggi
per il “Corriere della Sera” il 5 marzo 2020. Il cuore e il cervello. Il cuore
del vecchio Sleepy Joe, come lo apostrofa Trump, che ha ripreso a battere forte.
E il cervello freddo di Barack Obama, umanamente vicinissimo al veterano suo
vice per 8 anni, ma che poi lo aveva dissuaso dal correre per la Casa Bianca nel
2016, lasciando via libera a Hillary Clinton. Un Obama che anche nella campagna
attuale, non era mai sceso in campo in suo favore invocando, semmai, «sangue
nuovo» per le presidenziali 2020. Fino alla svolta maturata in appena 72 ore. È
questo lo sfondo del ritorno di Joe Biden, la rinascita politica più
sorprendente e clamorosa delle recente storia politica americana. Assorto,
smarrito, a volte balbettante, Biden sembrava già un capitolo archiviato dopo le
prime tre votazioni del grande circo delle primarie. Fino alla riscossa di
sabato scorso in South Carolina e all' incredibile vigilia del Super Martedì
quando il rischio di una vittoria a valanga di Bernie Sanders - un leader
considerato troppo radicale ed estraneo alla storia del partito democratico per
essere il perno di una coalizione capace di battere Donald Trump - ha spinto l'
ex presidente a mettere la corsa per la Casa Bianca su nuovi binari. Per mesi
Barack si è mantenuto sopra le parti parlando di unità del partito e ha
incontrato i giovani candidati centristi che sfidavano il suo vicepresidente,
alimentandone le frustrazioni. Biden, che non è mai riuscito a trasformare un'
amicizia profonda - cementata da otto anni di gioie e dolori vissuti insieme a
cominciare dalla tragedia della morte di suo figlio Beau - in una vera alleanza
politica, aveva addirittura raccontato la sua delusione per il mancato appoggio
di Barack nel 2016 in Promise me, dad , il suo libro di memorie politiche. Ma
quando il rischio di una vittoria a valanga di Sanders è diventato concreto,
Obama ha rotto gli indugi esercitando una pressione discreta ma nitida dietro le
quinte per convincere gli altri candidati centristi che non erano riusciti a
sfondare nelle sfide iniziali delle primarie a ritirarsi dalla corsa. Non solo:
nell' arco di poche ore Pete Buttigieg e Amy Klobuchar sono passati dal ruolo di
sfidanti di Biden a quello di suoi alleati entusiasti, decisi a trainarlo verso
la vittoria contro Sanders prima e contro Trump a novembre. Il ritorno di Biden
galvanizza i democratici riformisti, da tempo smarriti, ma approfondisce il
solco che spacca la sinistra: gli attacchi durissimi lanciati ieri sera contro
Biden da un Sanders deluso, lasciano spazio a un possibile remake del 2016, con
i fan del candidato socialista scatenati contro Hillary Clinton durante le
primarie e poi non disposti a votarla a novembre anche a costo di dare via
libera a Trump. Sembrava che, dopo quattro anni di «The Donald», uno scenario
simile fosse impensabile. Anche perché Joe non è l' algida Hillary: nonostante
le accuse di Trump al figlio Hunter per i suoi affari in Ucraina e Cina, Biden
ha un' immagine di onestà e di vicinanza empatica al mondo del lavoro che
mancava alla ex first lady. Ma le chat dei sostenitori di Bernie sono già piene
di invettive contro Biden e di spiegazioni del perché non voteranno mai per lui:
il leader più radicato in quell' establishment democratico che la nuova guardia
della sinistra radicale ha deciso di abbattere a tutti i costi. Ma andare avanti
con uno scontro all' ultimo sangue tra i due può essere un grosso regalo a
Trump. Che già dipinge Sanders come la vittima di una congiura democratica.
Bernie continuerà a combattere ma sa che, se non la spunta su Biden, lo manderà
indebolito al confronto con un presidente che anche lui considera un pericolo
mortale per l' America. Ieri ha dovuto prendere atto che il suo momento migliore
è passato e che riempire le piazze non basta: ha conquistato la California, ma
non è riuscito a prendere né il Texas, né i due Stati sui quali aveva investito
maggiormente: il Massachusetts liberal e il Minnesota che aveva strappato a
Hillary 4 anni fa. Sabato a Boston erano in 13 mila a osannarlo in un Stato nel
quale Biden non è andato quasi mai. Ma alla fine ha vinto lui.
Alberto Flores
d' Arcais per “la Stampa” il 5 marzo 2020. L' ultimo cinguettio di Bernie è
arrivato su Twitter quando sulla East Coast erano le 6:57 del mattino. La lunga
nottata del Super Tuesday più sorprendente di sempre si era appena conclusa, l'
Associated Press lo dava vincitore nel Golden State: «Grazie California! Hai
dimostrato che gli americani sono pronti per un governo e un' economia che
funzioni per tutti, non solo per l' 1%. Andiamo avanti insieme». Chiuso con i
suoi più stretti collaboratori, il campaign manager americano-pachistano Faiz
Shakir, l' imprenditore-filantropo Ben Cohen (quello dei gelati Ben&Jerry) e la
fida Arianna Jones (direttrice della comunicazione), stava analizzando quella
che sui media i era già raccontata come una preoccupante battuta d' arresto del
candidato «socialista». Solo poche ore prima, parlando ai suoi sostenitori in
Vermont, Sanders si era mostrato ottimista («Quando abbiamo cominciato questa
corsa tutti dicevano che non era possibile, ma stasera vi dico con fiducia
assoluta che conquisteremo la nomination e sconfiggeremo il presidente più
pericoloso della storia») ma quando ha lasciato il palco è sembrato un po'
amareggiato. La sorpresa c' è stata, ma non nel senso che auspicava lui e adesso
la strada di «zio Bernie» verso la nomination diventa tutta in salita. Diciotto
Stati hanno già votato, altri ne seguiranno i due prossimi martedì e fra
quindici giorni il suo destino potrebbe già essere segnato. Se con la vittoria
in California riuscirà a contenere e forse a colmare la distanza che lo separa
da Biden , altri dati ci dicono che le difficoltà per lui iniziano ora. Il suo
messaggio per il Super Tuesday era chiaro. Dimostrare di essere in grado di
cambiare l' elettorato democratico, portando alle urne chi non vota, dimostrare
ai democratici scettici che così facendo sarebbe veramente in grado di battere
Trump il prossimo 3 novembre. Dalla Virginia arriva il primo campanello d'
allarme: l' affluenza è quasi raddoppiata rispetto al 2016, ma lui non ha
costruito alcuna coalizione e Biden lo ha stracciato. E nei caucus del Colorado,
dove aveva avuto il 60% quattro anni fa è sceso al 40. Ha un altro punto debole,
quello di apparire come un candidato di minoranza. Vince in Vermont con il 51%
(ma 4 anni fa aveva l' 85), vince in Nevada con il 40% ma in tutti gli altri
Stati - anche dove è primo - si ferma sempre attorno al 30%. Nel giro di una
settimana è passato da front runner, il favorito, a inseguitore; invece di
crescere il suo slancio è diventato statico. Dire che è quasi fuori gara sarebbe
del tutto sbagliato, ma fra due settimane potrebbe essere più vero. Martedì 10
si vota in sei Stati (Idaho, Missouri, North Dakota, Mississippi, Washington e
Michigan) e con i risultati simili a quelli del Super Tuesday rischierebbe di
vincerne solo uno (Washington). Il colpo peggiore potrebbe arrivare da una
sconfitta in Michigan, Stato dei «blue collar» che Sanders ha già conquistato
nel 2016 (contro tutti i sondaggi che lo davano perdente contro Hillary). Se la
settimana successiva (17 marzo) non sfonda quando andranno alle urne Illinois
Ohio, Florida e Arizona difficilmente arriverà alla Convention di Milwaukee con
un pacchetto di delegati in grado di garantirgli la nomination. Dalla sua ha
ancora la forza della mobilitazione e l' entusiasmo giovanile. Proprio i giovani
potrebbero essere però il suo tallone di Achille. Perché è vero che applaudono
il suo messaggio anti-istituzione e diventano folle ai suoi raduni. Ma tutto ciò
non si trasforma in quella affluenza di cui Sanders avrebbe avuto bisogno il
Super Martedì. I numeri ci dicono che nei cinque Stati sudisti vinti da Biden
(North Carolina, Virginia, Tennessee, Arkansas e Alabama) i giovani hanno
disertato le urne in modo ancora più massiccio di quanto non fecero nel 2016.
Da lastampa.it
l'11 marzo 2020. A questo punto manca solo la certezza matematica, ma sul piano
politico non restano più dubbi che Joe Biden sarà il candidato del Partito
democratico per sfidare il presidente Trump a dicembre. La netta vittoria nelle
primarie di ieri in Michigan, Mississippi, Missouri e anche Idaho, ha confermato
che l’ex presidente è l’unico a guidare una coalizione di elettori che lo
sostiene in tutto il paese, in grado di contrastare il capo della Casa Bianca.
Biden non ha ancora la maggioranza di 1.991 delegati alla convention di
Milwaukee, necessaria per rendere definitiva la sua candidatura, ma ha ormai un
solido vantaggio che Bernie Sanders non può colmare. L’ex vice presidente, oltre
a vincere in Michigan, Mississippi, Missouri e Idaho, è praticamente alla pari
col senatore del Vermont nello stato di Washington, una regione liberal nella
quale Sanders avrebbe dovuto surclassarlo. Bernie invece si è imposto solo in
North Dakota, troppo poco per coltivare ancora la speranza di ottenere la
nomination. Molto significativo è anche il modo in cui Biden ha vinto, non solo
per il forte distacco percentuale, ma anche perché sta riuscendo ad aumentare
l’affluenza alle urne, riportando nel Partito democratico gruppi di elettori che
lo avevano abbandonato nel 2016. Joe infatti è forte non solo tra gli afro
americani, ma anche tra i colletti blu, i bianchi della classe media e bassa, le
donne, e le famiglie delle zone suburbane. Da questo punto di vista, guardando a
novembre, è particolarmente importante il risultato ottenuto in Michigan, che
con Pennsylvania e Wisconsin era stato decisivo nel 2016 per la vittoria di
Trump contro Hillary Clinton. Nel discorso tenuto ieri sera a Philadelphia, dopo
aver annullato un comizio in Ohio a causa del coronavirus, l’ex vice presidente
non ha tanto celebrato la sua vittoria, quanto lanciato un appello all’unità dei
democratici, a Sanders, e ai suoi sostenitori, affinché adesso si concentrino
sull’obiettivo comune di battere Trump. Bernie non ha dato segnali di volersi
ritirare, e domenica ha forse un’ultima occasione di rilanciare la propria
candidatura, nel dibattito a due con Biden. Martedì prossimo però voteranno
altri quattro stati importanti, cioè Florida, Ohio, Illinois e Arizona, e il
loro verdetto sarà probabilmente definitivo.
(ANSA il 18
marzo 2020) Uno, due e tre. Florida, Illinois e Arizona. Nell'ennesimo
supermartedì delle primarie democratiche americane Joe Biden fa tris e spazza
via il povero Bernie Sanders, soprattutto con una vittoria a valanga nel
Sunshine State. Si fosse votato anche in Ohio (ma il voto è stato rinviato per
l'emergenza coronavirus) sarebbe stato un trionfo completo per l'ex
vicepresidente americano che - salvo clamorose sorprese - ha ormai vanificato
qualunque chance di rimonta dell'avversario, con 18 stati conquistati e almeno
1.400 delegati agguantati sui 1.991 necessari per la nomination. Donald Trump,
se ce n'era bisogno, adesso sa che nelle urne il 3 novembre prossimo sfiderà
quello contro cui ha combattuto in questi anni: l'eredità di Barack Obama che in
tutti i modi ha tentato di rottamare. Il tycoon, vincendo anch'egli nelle
primarie senza rivali in Florida e Illinois, si è assicurato un numero di
delegati ormai sufficiente per conquistare la nomination repubblicana. Verrà
incoronato nella convention di Charlotte a fine agosto, ma l'emergenza del
presente, quella dell'incubo coronavirus, rende il futuro più che mai incerto.
Senza un'azione decisa - ha avvertito senza mezze parole il segretario al tesoro
Steve Mnuchin - si rischia una disoccupazione al 20%, altro che crisi del 2008.
Lo spettro della recessione agita i sonni di un presidente che si gioca la
rielezione sul terreno dell'economia. Del resto gli ultimissimi dati sulla
diffusione del contagio non lasciano presagire nulla di buono. Anzi, fanno
tremare i polsi: oltre 6.000 in tutto il Paese ed almeno 118 morti. Una
progressione impressionante in poche ore, e l'incubo degli incubi: il lockdown
di New York dopo quello di San Francisco. Da questo scenario nasce l'appello di
Biden, che tende la mano a Sanders nella speranza che il senatore molli e i
democratici si possano concentrare unicamente sull'emergenza e sul bersaglio
grosso, Donald Trump. "Il mio obiettivo è quello di unire il partito democratico
e di unite il nostro Paese in questo momento difficile e per battere insieme
Trump", ha affermato l'ex vicepresidente americano: "Quello che serve ora è la
speranza contro la paura, l'unità contro le divisioni, la verità contro le
menzogne e la scienza contro la finzione". Saranno le prossime ore a dire se
Sanders raccoglierà l'invito. Anna Wintour, la direttrice di Vogue, si schiera
con Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca individuando nella sua esperienza
politica un asset cruciale per battere Donald Trump. «Ha molte qualità di cui
abbiamo disperatamente bisogno a Washington: la decenza, l'onore, la
comprensione, l'affidabilità e soprattutto l'esperienza», dice Wintour che nel
2016 aveva appoggiato Hillary Clinton e che non ha mai nascosto la sua antipatia
per Donald Trump. Un’antipatia emersa anche nelle ultime ore quando la
direttrice si è scagliata contro il tycoon per la cattiva gestione
dell’emergenza coronavirus, criticando l'amministrazione di Trump per i test
"imperdonabilmente" lenti e le misure prese in risposta al contagio. Nelle
scorse ore la Wintour è stata costretta anche ad annunciare il rinvio del Met
gala: una scelta definita «inevitabile e responsabile». La regina della moda ha
promesso anticipazioni della mostra «About Time» sul numero di maggio di Vogue
(e ha usato l'opportunità per offrire il suo appoggio al candidato alla
nomination democratica Joe Biden).
Giuseppe Sarcina per il “Corriere della Sera” il 2 aprile 2020.
L' ultima foto con Bernie Sanders pubblicata sul profilo Instagram di Alexandria
Ocasio-Cortez (4,2 milioni di follower) risale al 3 dicembre 2018: seduti
insieme intorno a un tavolo rotondo, in occasione di un dibattito sul «climate
change». Tutto il resto è sparito. Non c' è neanche una delle decine di immagini
con «Bernie» sul palco. Lui che le solleva il braccio in segno di vittoria e di
unità. Sorridenti. La rottura tra i due è netta e traumatica per la sinistra
americana. La giovane deputata ha abbandonato il suo «mentore», come lo ha
chiamato per anni, subito dopo il comizio nell' Università del Michigan, ad Ann
Arbor, l' 8 marzo scorso. Gli organizzatori sandersiani avevano dovuto pregarla,
perché i contrasti tra i due erano già acuti. Un mese prima il 10 febbraio nel
palazzetto dello sport a Durham nel New Hampshire, Ocasio-Cortez aveva
entusiasmato almeno cinquemila persone. Era il momento migliore per il Senatore
del Vermont: l' America stava considerando l' idea che il leader «democratico
socialista» potesse conquistare la nomination democratica e persino battere
Donald Trump a novembre. Che cosa è successo allora di tanto grave tra
Alexandria e Bernie? Ci sono stati diversi passaggi. Il 8 febbraio, in una town
hall con la Cnn , Sanders criticò la deputata che aveva ipotizzato una versione
ridotta del «Medicare for all», la sanità gratuita per tutti. Il 13 marzo la
deputata fece sapere ai dirigenti della campagna di Sanders che avrebbero dovuto
rifiutare l' endorsement di Joe Rogan. Il comico e conduttore radiofonico aveva
stroncato l' uso di terapie per bloccare la pubertà dei ragazzi transgender.
Seguirono altri screzi e polemiche soffocate, fino ad arrivare al 30 marzo,
quando si è saputo che Ocasio-Cortez non avrebbe appoggiato, come invece aveva
fatto nel 2018, la candidatura alla Camera di Cory Bush (Missouri) sostenuta in
pieno da Sanders e dal gruppo radical Justice Democrats . Il sito Politico
sostiene che la nuova star della sinistra americana, 30 anni, abbia maturato una
svolta ideologica negli ultimi mesi. L' esperienza del lavoro parlamentare l'
avrebbe convinta ad abbandonare il massimalismo sandersiano. Può darsi. Anche
se, nel merito, Alexandria mantiene una linea oltranzista. È stata tra le poche
a criticare le misure di soccorso economico da 2.200 miliardi, perché
«insufficienti». E ieri ha attaccato duramente il governatore democratico di New
York, Andrew Cuomo, perché ha sospeso i pagamenti delle rate del mutuo, ma non
degli affitti. Aoc, a torto o a ragione, lavora politicamente sui limiti delle
proposte. Vede sempre il bicchiere mezzo vuoto. Il Senatore del Vermont, invece,
quel «bicchiere» non lo vede proprio: l' intero sistema è da rifondare
completamente. Neanche l' emergenza coronavirus l' ha convinto a scendere dal
bulldozer. Vuole andare avanti con le primarie, nonostante il calendario delle
elezioni si stia dissolvendo giorno dopo giorno e ora sia in dubbio perfino la
Convention di luglio. Troppo anche per Alexandria Ocasio-Cortez.
(ANSA l'8 aprile 2020) - Un Bernie Sanders
visibilmente commosso ha ringraziato in tv tutti quelli che lo hanno sostenuto
nelle sue campagne elettorali del 2016 e del 2020. Il senatore socialista ha
confermato il suo ritiro dalla corsa per le presidenziali del 2020. "Una
decisione dolorosa": così Bernie Sanders ha definito la scelta di sospendere la
sua campana elettorale. "Ma se la nostra campagna è giunta al termine, il nostro
movimento no", ha aggiunto, "il nostro movimento ha vinto la lotta ideologica
nel partito anche se non ha conquistato la nomination". "Bernie Sanders è fuori!
La sua gente dovrebbe venire nel partito repubblicano": lo twitta Donald Trump
cha accusa il partito democratico di aver fatto fuori il candidato socialista.
"Sanders e' fuori grazie a Elizabeth Warren. Se non fosse stato per lei, Bernie
avrebbe vinto quasi ogni stato nel Supertuesday! E' finita esattamente come il
partito democratico voleva".
Primarie Usa, Bernie Sanders sospende la sua campagna
elettorale e si commuove in tv. La Repubblica l'8
aprile 2020. Prima che la pandemia di coronavirus bloccasse il processo delle
primarie democratiche, il vantaggio di Joe Biden sul senatore del Vermont era
aumentato in modo significativo. La lunga marcia di Bernie Sanders è finita. Il
senatore del Vermont cede alle pressioni che ormai facevano su di lui perfino i
suoi sostenitori, Alexandria Ocasio Cortez in testa. E si ritira dalle primarie
democratiche, abbandonando - per la seconda (e a 78 anni suonati, ultima volta)
– quel sogno della presidenza, già sfumato nel 2016. Quando, dopo un’aspra
battaglia, cedette il podio a Hillary Clinton, dopo aver tirato così tanto la
corda da venir poi additato da tutti come il motore della sua sconfitta. Sarà
dunque Joe Biden, 77 anni, a sfidare Donald Trump, 73 anni, come frontrunner del
partito democratico. È stato lo stesso Sanders ad annunciarlo ai suoi
sostenitori. Prima, nel corso di una conference call con il suo staff, dove si è
detto: «Fiero delle nostre conquiste. Quattro anni fa nessuno parlava di
stipendio minimo garantito, sanità per tutti e spese universitarie gratuite. Ora
sono entrate nel programma di molti». Poi, con un video messaggio trasmesso
sempre da casa sua, a Burlington in Vermont, dove si è rivolto direttamente ai
suoi fan: «È una scelta dolorosa. Ma se la campagna è finita, il movimento vive
ancora». Per poi concludere: «Mi congratulo con Biden. Combatteremo insieme
contro Donald Trump». A patto, certo, di convincere la sua base: che di votare
per l’ex vice di Barack Obama, fin qui ha sempre detto di non volerne sapere.
Per qualche settimana il candidato “socialista” ci aveva davvero creduto di
potercela fare. Tanto più che a inizio primarie, quando la corsa era ancora
affollata da 20 candidati in gara, si era aggiudicato New Hampshire e Nevada.
Scegliendo di resistere pure alla debacle del Super Tuesday: quando gli altri
candidati avevano mollato, endorsando Biden, e permettendogli così di vincere in
quasi tutti gli Stati. Quella notte il senatore aveva però incassato il premio
in palio più grosso: la California col suo pacchetto ghiotto di delegati. E
tanto gli era bastato per spingersi ancora più in là. Ma a un certo punto il
divario si era fatto incolmabile. Nonostante gli sforzi aveva perso il Michigan
operaio, e poi la Florida, l’Illinois, l’Arizona. E quasi certamente quel
Wisconsin dove si è votato ieri, fra mille problemi per via del lockdown dovuto
al coronavirus: i risultati arriveranno venerdì, ma secondo i sondaggi Biden era
avanti di 28 punti. Da tempo ci si chiedeva perché, nonostante la disparità di
delegati evidente, Bernie non si decidesse a mollare. Col timore che, proprio
come nel 2016, fosse intenzionato a dar battaglia fino all’ultimo, per spingere
il più possibile a sinistra la piattaforma del partito. Nel pieno dell’emergenza
Covid-19 quel piano è sembrato sciagurato perfino ai suoi alleati. Tanto più che
pure la convention di Milwaukee è in forse. Dovrebbe tenersi questa estate ma è
già stata posticipata da metà luglio a metà agosto. E chissà come andrà a
finire. Con le primarie di almeno 16 Stati slittate a fine giugno, l’incertezza
non poteva durare. Senza il ritiro di Sanders, la candidatura di Biden alla
nomination democratica sarebbe rimasta formalmente in forse ancora per mesi: e
non c’è più tempo. Novembre è dietro l’angolo, bisogna organizzare la campagna,
mobilitare fondi, trovare donatori. E se la convention non si riuscirà a
organizzare e sarà soltanto virtuale, bisognerà renderla più semplice che mai.
«Aiuterò Biden a sconfiggere Trump» promette ora Bernie. E chissà che questa
volta non ci riesca davvero.
Bernie Sanders si ritira, tramonta il sogno socialista
americano. Paolo Guzzanti su Il Riformista il 10
Aprile 2020. Per amore del paradosso e della simmetria, in fondo ci speravamo:
che nascesse l’Ussa, Unione degli Stati Socialisti Americani, contrapposti
alla Federazione Capitalista Russa, una nuova guerra fredda già pronta, a ruoli
invertiti. Invece, niente. Non si farà più, perché Bernie Sanders, il candidato
apertamente socialista con ampie nostalgie per il mondo sovietico e castrista ha
gettato la spugna, ritirandosi dalla competizione per le elezioni presidenziali
di novembre, annunciando di concedere i suoi trecento delegati al quieto e
istituzionale Joe Biden, ex vice di Obama sostenuto dal clan dei clintoniani. Il
paradosso, sarebbe stato quello di vedere correre per la Casa Bianca non già un
semplice candidato un po’ più a sinistra degli altri, ma proprio un socialista
in un Paese in cui quell’aggettivo è ancora una parolaccia. Sanders ha 78 anni e
al prossimo turno non potrà più correre per motivi d’età e dunque Trump dovrà
vedersela proprio con lo stesso Biden per cui ha subito un processo di
impeachment, avendo provato in tutti i modi a far uscire prove delle ipotizzate
malefatte affaristiche in Ucraina del suo avversario. Bernie Sanders, che era
partito a razzo nello sbalordimento generale – si era fatto strada anche il
giovane Buttigieg, buono per la prossima corsa – si è poi afflosciato. Perché?
Perché lo hanno mollato le due forze su cui contava: gli afroamericani che hanno
seguitato a votare Biden alle primarie e i giovanissimi, su cui il vecchio leone
contava per un patto generazionale. Il Covid 19 ha fatto il resto e l’anziano
rivoluzionario ha visto che non c’era più carne da mettere al fuoco e ha
mollato. Molti si chiedono quanto questo elegante e vecchio ebreo sia di
sinistra. Nei programmi era soltanto molto socialdemocratico, di stampo
nord-europeo: sanità gratuita per tutti, diritti civili per tutti, grandi
programmi di riforma sociale. Ma intorno a lui si erano radunati dei veri
rivoluzionari di cui il più in vista, Kyle Jurek, lo ha messo più volte in
imbarazzo per i fuori onda in cui diceva che una volta preso il potere sarà
necessario fucilare un po’ di gente come fece Fidel e che occorrerebbe aprire
dei Gulag americani come campi di rieducazione, sostenendo che la Cia avesse
riscritto la storia della Rivoluzione sovietica. Queste sparate diventate virali
su YouTube e non hanno fatto bene a Sanders. Che ha cercato di tenere a bada il
suo gruppo di teste calde secondo cui se Trump venisse rieletto si dovrebbero
mettere a fuoco le città. Trump non è stato contento della sconfitta di Bernie
e, dando prova della solita sfacciataggine, ha invitato l’elettorato della
sinistra orfana a votare per lui. Trump ovviamente non si sente più sulla cresta
dell’onda dopo il disastro dell’epidemia che aveva imprudentemente negato. E se
la disoccupazione tornerà ai livelli del 2008 per lui sarà la fine. Ma la
parabola Sanders riapre la questione: quanto a sinistra può spingersi la
sinistra americana? E poi: che genere di sinistra è? Oltre un secolo fa
gli Stati Uniti, e New York in particolare, erano pieni di movimenti anarchici e
socialisti, poi di comunisti romantici e di rivoluzionari detestati
dall’establishment. Gli anarchici italiani Sacco e Vanzetti finirono sulla sedia
elettrica vent’anni prima di Julius e Ethel Rosenberg in piena Guerra fredda,
accusati di essere spie sovietiche e di aver dato ai russi l’accesso ai segreti
atomici. I due erano effettivamente comunisti iscritti al partito comunista
americano (Communist Party Usa) che era una organizzazione totalmente
filosovietica e talmente chiusa da opporsi alle novità introdotte da Michail
Gorbaciov – glasnost e perestrojka – il quale fece tagliare i fondi di
mantenimento costringendo il partito alla chiusura e alla clandestinità. Ma il
partito comunista americano era stato molto potente nei sindacati e presso gli
intellettuali e aveva eseguito con estrema diligenza le direttive di Mosca
durante l’alleanza nazi-sovietica del 1939-41, opponendosi con scioperi e
manifestazioni al vagheggiato intervento americano al fianco della Gran
Bretagna, disperatamente richiesto da Churchill. Franklin Delano
Roosevelt malgrado le promesse non dichiarò mai guerra alla Germania e fu Hitler
a dichiarare guerra agli Stati Uniti, con grande sdegno degli inglesi. E dopo la
guerra ci fu il “maccartismo”, cioè la famosa “caccia alle streghe” come la
chiamò il commediografo Arthur Miller (secondo marito di Marilyn Monroe la quale
diventò poi l’amante di John Fitzgerald Kennedy), lanciata dal senatore Joseph
McCarthy per stroncare le “attività antiamericane”. Una caccia cominciata a
partire dagli intellettuali che tenevano in vita la produzione cinematografica
di Hollywood e che avevano in gran maggioranza sentimenti fortemente
simpatizzanti per il comunismo sovietico e che avevano fatto la loro parte
durante il conflitto contro la Germania nazista. L’opinione pubblica americana,
appena uscita dalla tremenda depressione iniziata alla fine del 1929 che gettò
milioni di americani nella miseria, era stata totalmente ostile all’entrata in
guerra contro la Germania nazista, ricordando il costo dell’intervento in Europa
nel 1918 (durante il quale i soldati americani del Kansas portarono
inconsapevolmente il virus dell’influenza poi detta “Spagnola” che causò fra i
50 e i 100 milioni di morti). Le minoranze americane di origine tedesca erano
filonaziste come quelle italiane erano filofasciste, ma l’attacco giapponese
di Pearl Harbor nel dicembre del 1941 schierò di nuovo il patriottismo americano
a fianco del Presidente. Le sinistre americane furono entusiaste di fare la loro
parte quando l’Unione Sovietica fu invasa da Hitler nel giugno del 1941, ma
l’inizio della Guerra Fredda con il discorso di Winston Churchill a Fulton negli
Stati Uniti, quello in cui fu varata l’espressione “iron courtain”, la cortina
di ferro, spaccò il Paese. Il servizio segreto Oss, pieno di agenti reclutati in
campo repubblicano nella Lincoln Brigade durante la guerra civile spagnola,
tutti molto vicini alle posizioni comuniste, fu chiuso dal presidente Truman che
inaugurò nel 1947 la Cia, organizzata per combattere i comunisti esterni, mentre
l’Fbi di J. Edgar Hoover si dava alla caccia dei comunisti interni. Chi ha visto
la stupenda serie The Americans (vincitrice assoluta di Emmy Awards) ha un’idea
di come funzionavano in Usa le reti sovietiche e con quale potente appoggio
interno. L’arrivo di JFK alla Casa Bianca, figlio di un ambasciatore americano
irlandese che si era arricchito con il contrabbando di whisky, dette al mondo la
sensazione del tutto nuova di una sinistra elegante, riformista e potente, che
però fu costretta ad affrontare la crisi dei missili cubani che portò il mondo
sul ciglio della catastrofe nucleare e poi all’assassinio dello stesso John
Kennedy a Dallas, che diventò il giallo del secolo. Robert “Bob”
Kennedy, fratello del presidente ucciso e suo ministro della Giustizia
come General Attorney (e che su preghiera del padre aveva allentato la presa
sulla mafia guidata da Sam Giancana affinché questi portasse a John i voti del
sindacato, e con cui divideva il letto di Marilyn insieme al fratello) fu subito
il nuovo divo delle sinistre americane e mondiali. Nel frattempo, il presidente
Johnson, succeduto a John come suo vice, si era impantanato nella guerra
del Vietnam iniziata proprio da John, ma aveva compiuto la grande operazione
della restituzione dei diritti civili alle minoranze nere del Sud. Bob era il
darling mondiale della speranza di pace negli Stati Uniti, ma fece la stessa
fine del fratello, ucciso a revolverate il 6 giugno del ’68 durante un comizio.
Oggi si è persa la memoria di che cosa fosse e quanto dividesse l’intero mondo
la guerra del Vietnam, che sarebbe stata chiusa dal detestato Richard Nixon, il
presidente repubblicano costretto alle dimissioni per lo
scandalo Watergate. L’Europa, la sinistra italiana e in particolare Walter
Veltroni che giocò la carta del “Kennedy italiano”, aveva puntato tutte le
fiches sul riformismo kennediano e per un lungo periodo l’immagine dei due
fratelli assassinati fu collegata con quella dei due Gracchi nella storia
romana. Fu poi la volta dell’eroe di guerra e storico accademico George
McGovern (pilota di bombardieri B-24 Liberator sulla Germania) che prese il
posto dell’assassinato Bob Kennedy nel 1968 e poi combatté
contro Nixon perdendo, poi in Senato fu il campione della nuova politica “Food
for Peace”, cibo per la pace, sempre perdendo e sempre frustrando lo spirito
delle sinistre riformiste europee rimaste senza eroi di riferimento e che
attingevano ormai a piene mani dalla caotica ma generosa fucina americana. Ma la
fucina americana non fu in grado di sfornare nulla sia pur vagamente “di
sinistra” fino all’arrivo della coppia formata da Bill e Hillary Clinton,
entrambi provenienti dal più sperduto e depresso angolo degli Stati Uniti:
Little Rock, Arkansas (da pronunciare rigorosamente Arkansò) dove formarono un
team familiare e politico. Quando andai a Little Rock per la prima elezione di
Bill, conobbi sua madre, una sciroccata sciampista dai capelli color vinaccia
che mi tirò per la giacca e mi chiese in gran segreto: «Ma è sicuro che il mio
Bill ce la può fare? Ma è vero che è diventato such a big shot, un vero pezzo
grosso?». Confermai con spudorata sicurezza e poi ballammo tutti insieme con
Bill, Hillary, Al Gore che sarebbe diventato vicepresidente e sua moglie Tippy
che era un bel peperino. Bill fece molti casini: mentì davanti al popolo
americano negando i pompini di Monica Lewinsky facendosi incriminare per
spergiuro e poi bombardò la Serbia facendosi prestare dall’Italia governata
da Massimo D’Alema le basi aeree. No bueno, come sinistra. Però i due erano
glamour, carini con tutti, tanto con D’Alema quanto con Berlusconi. Se non
ricordiamo male, non c’è gran che d’altro nella sinistra americana recente. E di
sicuro nessuno dei suoi epigoni si era dichiarato socialista o marxista.
Ammiratore dichiarato del regime dei Castro. O con qualche nostalgia per la
Repubblica dei Soviet che in fondo non era così male. Era nata una nuova
generazione, i Millennial, i nipoti dei baby boomers (i pupi nati dopo il
ritorno dei soldati della Seconda Guerra Mondiale) che non sanno niente del
Sessantotto, sono indifferenti ai Kennedy e alle loro bravate o bravure, tutti
impegnati nella nuova ideologia ecologica e del riscaldamento globale. Tutta
un’altra storia. E forse Bernie ha fallito proprio perché non ha saputo fino in
fondo diventare protagonista dell’altra storia, quella dei nuovi americani senza
un genere predefinito, senza un colore di pelle predefinito, di orientamenti
fluidi e nuovi, gente che vive su un nuovo pianeta e che cerca un altro tipo di
leadership. Bernie è stato generoso e ha dato tutto se stesso con due campagne
entusiasmanti: nella prima si era battuto come un leone contro la nomination di
Hillary Clinton che odia a morte. Fallì allora e ha fallito la sua ultima
battaglia, ma ha vinto l’Oscar alla carriera e quello per la novità, di una
rivoluzione socialista nella patria del capitalismo e dello stock exchange,
persa mentre un virus attacca più efficacemente di lui, più di quanto posa fare
Biden, lo zazzeruto presidente Trump. L’America è così un nuovo uovo di Pasqua
dalla sorpresa a sorpresa.
Il Primo maggio del Vietnam: dallo scoppio della guerra alla
sconfitta degli americani. Paolo Guzzanti su Il
Riformista l'1 Maggio 2020. Esattamente 45 anni fa, il primo maggio, l’America
fuggiva da Saigon mentre entravano le truppe comuniste dopo dodici anni di
guerra. Gli elicotteri sul terrazzo dell’ambasciata erano presi d’assalto dai
funzionari della Repubblica del Sud Vietnam, abbandonata al suo destino. Fuga:
gli americani in fuga, sconfitti. Quarantacinque anni fa come oggi l’America
fuggiva da Saigon mentre entravano le truppe comuniste dopo dodici anni di
guerra. Gli elicotteri sul terrazzo dell’ambasciata erano presi d’assalto dai
funzionari della Repubblica del Sud Vietnam, abbandonata al suo destino. Fuga:
gli americani in fuga, sconfitti militarmente sul più diabolico e sottovalutato
campo di battaglia dopo la Seconda guerra mondiale e l’infausta guerra di Corea.
Nelle foreste e sulle alture del Vietnam si è giocata la politica delle nazioni
e la “meglio gioventù” della sinistra europea e americana si scontrava ogni
giorno con i governi, la polizia e anche con le forze democratiche
filoamericane, specialmente dal 1967 in poi, quando la guerra diventò un
massacro e un palcoscenico di doppiogiochismi, tradimenti e bassezze. Mia figlia
Sabina aveva tre anni, poi quattro e cinque e mi chiedeva: «Andiamo a giù le
mani dal Vietnam?». E andavamo. A Roma come a Milano a Parigi e New York e
a Ottawa (molti adolescenti americani si rifugiarono in Canada e furono
incriminati). L’America protestava con le canzoni di Joan Baez e Bob Dylan, We
shall overcome one day, from the deep of my heart. E ci sentivamo, noi
antiamericani di allora, molto americani perché quella guerra, fino al magnifico
film Il grande Lebowski dei fratelli Cohen, fu anche una guerra civile americana
con i giovani di leva (leva reintrodotta da Lindon Johnson, successore di
Kennedy che quella guerra aveva cominciato mandando i primi berretti verdi), che
scappavano e le famiglie potenti che pagavano l’esenzione dei figli cercando di
mandare i ragazzi neri a fare la loro guerra. Gli americani alla fine persero
meno di ottantamila uomini, oggi il Covid ha battuto quelle cifre, ma il Nord e
il Sud Vietnam persero nel complesso più di tre milioni di uomini e donne. A
chiuderla, la guerra, fu il cattivo Richard Nixon del Watergate, detto Tricky
Dixie, il furbastro, ma che fu nella disgrazia uno dei più grandi e realistici
presidenti e che più tardi, lo scoprii a New York negli anni Novanta, andava a
tenere lezioni private segrete al giovane Bill Clinton, di cui detestava la
moglie Hillary che considerava una strega. Ma questo fu uno dei tanti
paradossi: John Fitzgerald Kennedy e la sua corte detta Camelot come quella di
Re Artù, l’elegante democratico cattolico, speranza delle sinistre mondiali,
autorizzò la fallita invasione della Baia dei Porci cubana preparata sotto
Eisenhower, che fu un vergognoso disastro; portò il mondo sull’orlo della guerra
atomica con la crisi dei missili sovietici a Cuba (fece bene, vinse, ma giocò
alla roulette le vite di tutti, noi compresi) e iniziò la guerra del Vietnam, in
sordina, piccoli aiuti, qualche istruttore, dei mercenari senza distintivo, i
berretti verdi alla John Wayne (che fece un film, ma che era riformato e non
vestì mai l’uniforme). Bisognerà aspettare l’arrivo di Marlon Brando in
Apocalypse Now di Francis Ford Coppola – uno che si era filmato la Seconda
guerra mondiale in prima linea con la camera a spalle – anche se prima c’era
stato un film supremo per sincerità: Il Cacciatore di un altro italo americano,
Michael Cimino con Robert De Niro e John Cazale. Io stesso – il lettore mi
scuserà se per praticità uso me stesso come metro di misura, ma è l’unico di cui
dispongo – non ebbi dubbi sulla assoluta malvagità americana nella guerra del
Vietnam, finché non conobbi l’America e la sua natura interna, proletaria,
campagnola, patriottica, legatissima a modi di fare e di essere che noi europei
non conosciamo, anche perché quando andiamo in America di solito ci fermiamo a
Manhattan. Scoprii quest’America dei red neck, la gente di campagna e dei blue
collar, i nostri Cipputi, ed erano tutti reduci. Veterani. In America si onorano
i veterani di tutte le guerre e sono sempre più giovani, ecco un panorama poco
italiano, per fortuna. Poi, sperimentai una reazione emotiva quando visitai, più
d’una volta. Il Vietnam Veteran Memorial, costruito nel 1982, da una architetta
asiatica, Maya Lin. È una trincea fatta di curve tortuose, le cui pareti sono
coperte di un marmo scuro e lucido, con incisi tutti i nomi dei soldati caduti
nel ‘Nam. E fui impressionato dall’enorme numero di nomi italiani, tutti nomi
del Sud, accentati sulla finale, o che finiscono per “o” e “u”. La stessa
sensazione che provai vedendo l’elenco dei giganteschi eroici vigili del fuoco
che morirono l’11 Settembre dopo l’attacco alle Twin Towers, molti di quei
giganteschi statunitensi erano paesani discendenti di nonni curti e niri.
Torniamo a quella guerra terribile e moderna, da cui vennero le droghe, l’uso
pacifista di indossare mimetiche militari, l’uso di massa di marijuana ed eroina
(le fumerie d’oppio di Saigon che ha ricordato anche Bernardo Valli che combatté
la prima di quelle guerre in uniforme francese), lo sfondamento del turpiloquio
sessuale come arredo accettato del comune parlare, ad imitazione
dell’intraducibile fuck e fucking del soldato americano che si sente screwed up,
fottuto dai Charlies, come chiamavano i Vietcong , dalle iniziali “V” e
“C”, Viktor Charlie. Fu la guerra che persero gli americani e che certamente
vinsero i russi e i cinesi, ma più che altro i vietnamiti che poi dovettero
vedersela in armi proprio con i cinesi e che oggi vanno d’amore e d’accordo con
gli antichi nemici americani che stravedono per loro e viceversa. Il consiglio
che mi permetto di dare a tutti è di guardare, se non l’avete fatto, lo
splendido documentario in sei o sette ore di cinema, su Netflix, o anche quelli
della Bbc. Lì si capisce tutto. Ho Chi-Minh. il leggendario Ho Chi Minh dalla
lunga barbetta, da giovane faceva il cameriere a New York, adorava Lincoln e
giurava che gli americani avrebbero aiutato l’Indocina francese a liberarsi dal
giogo colonialista. E questa era l’intenzione di Roosevelt, che fece sputare
l’India e l’intero British Empire a Winston Churchill in cambio della
liberazione dalla morsa tedesca. I giapponesi avevano spazzato via le potenze
coloniali francese, inglese, olandese dall’Oriente, ma con la sconfitta del
Giappone i colonialisti erano tornati e l’Indocina francese -Vietnam, Laos e
Cambogia – era di nuovo sotto la mano di Parigi. La cantante esistenzialista
francese Juliette Gréco, amica di Jean Paul Sartre, di Brassens e
di Brel, cantava le pene d’amore della Pétite tonquinoise. Il movimento
indipendentista e comunista vietnamita era guidato da rivoluzionari tutti di
cultura francese passati per l’università della Sorbonne, il Partito comunista
francese, e dunque attraverso la Rivoluzione francese. Ma la Francia
sottovalutò, come poi fecero testardamente gli americani, la potenza militare
convenzionale e corazzata dell’esercito vietnamita. A Diem Bien Phu, il 13 marzo
del 1954, l’Armée Francaise schierò la sua migliore artiglieria, le migliori
truppe e la fanteria, accusata di ridicola esagerazione per combattere un pugno
di sporchi ribelli comunisti. Ma gli sporchi ribelli comunisti erano prima di
tutto dei patrioti nazionalisti, avevano chiamato alle armi anche le donne,
trasportavano a spalla per le foreste e le colline i pezzi d’artiglieria come
formiche e inflissero all’esercito francese una umiliazione militare bruciante e
definitiva. L’esercito guidato dal “Bismark vietnamita” Vo Nguyen Giàp aveva
divisioni, cannoni, fanteria, truppe corazzate, ogni ben di dio fornito sia
dall’Unione Sovietica che dalla Cina. Questa la situazione che trovarono gli
americani, che furono ben felici della rotta francese. Kennedy, contro il parere
del Congresso, cominciò a inviare aiuti, mercenari nelle vesti di consiglieri e
truppe, finché (poco dopo la sua morte) fu creato un falso (o ingigantito)
incidente navale nelle acque del Tonchino, che fornì il casus belli e in forza
del quale l’America si trasferì in Vietnam. “Good morning Vietnam!”, prima di
diventare un film scomodo e divertente era una realtà radiofonica mattutina per
l’America che prima di salire in elicottero voleva il suo breakfast di uova
strapazzate e caffè, ascoltando i risultati delle partite di baseball e
basketball. E gli americani, come potete vedere dai documentari, non vollero
sentir ragione: seguitarono a combattere una guerra contro i “guerriglieri” Viet
Cong, ignorando il gigantesco esercito nordvietnamita di Giap ed Ho Ci Min. Le
cui tattiche erano nuovissime: interi tratti di foresta venivano scavati con
gallerie enormi riempite di truppe e postazioni d’artiglieria su cui veniva
rimessa come un coperchio bonsai, l’intera foresta. E così, quando gli allegri
americani andavano a sorvolare e sbarcare truppe, armati di mitragliatrici
elicotteri e chitarre, scoprivano che una voragine si apriva sotto le loro
scarpe da cui partiva all’attacco un esercito in grado di annientarli. Quando
arrivavano i bombardieri, l’esercito fantasma era già sparito sotto altre
gallerie. Fu un lento sanguinoso declino di bordelli e divisioni
aerotrasportate, fame e sacrifici umani, incomprensioni e amori perduti,
attentati e disperazioni. Richard Nixon, dopo un ultimo costoso impegno in
bombardamenti inutili e terrificanti che misero in fiamme le foreste, gettò la
spugna e trattò a Parigi un laborioso accordo che fu firmato il 27 gennaio del
1973 ma che avrebbe definito soltanto due anni dopo la forza delle armi. Gli
americani se ne erano andati, lasciando ai Sud Vietnamiti, con grande ipocrisia,
una enorme quantità di armamenti privi di pezzi di ricambio e di munizioni
sufficienti per un lungo tempo. Saigon cadde il 30 aprile del 1975, la bandiera
americana ammainata in fretta e furia dai marines in fuga dal terrazzo
dell’ambasciata buttando giù a calci i vietnamiti attaccati alle funi. I
comunisti avevano vinto. Ma l’effetto domino non ci fu: il Vietnam difese con le
armi la sua indipendenza dalla troppo fraterna Cina e nel giro di una decina
d’anni, tutti dimenticarono tutto.
Ritratto di Bernie Sanders, il più populista dei candidati
anti Trump. Vittorio Ferla su Il Riformista il 28
Febbraio 2020. Ognuno ha il virus populista che si merita. In Italia ha molte
facce: le norme sulla prescrizione e le intercettazioni, le scoordinate misure
per fronteggiare il Covid-19, l’isteria collettiva provocata dai media. Ma in
America non stanno meglio. Alla Casa Bianca c’è un certo Donald Trump. E i
democratici, finora, non trovano nulla di meglio da opporgli se non un populista
eguale e contrario: Bernie Sanders. Martedì notte si è svolto l’ultimo dibattito
televisivo prima delle primarie in South Carolina e prima del Super Tuesday del
3 marzo. Ognuno ha fatto la sua parte, ma nessuno ha fatto una gran
figura. Elizabeth Warren, senatrice del Massachussetts, è tornata a martellare
Bloomberg sul sessismo. Tattica ossessiva ma inefficace: ricordate lo stile di
Trump con le donne? Sempre la Warren ha promesso di attuare la proposta clou di
Sanders – la sanità pubblica aperta a tutti – meglio di Sanders. Ma perché, alle
urne, gli elettori dovrebbero scegliere lei e non l’originale? Joe Biden, ex
vicepresidente in grande affanno, e Tom Steyer, un miliardario mica da ridere,
si sono litigati i voti degli afroamericani in South Carolina. Quasi una lite da
cortile tra ragazzini. Amy Klobuchar, senatrice del Minnesota, è la più garbata.
Ha cercato di spostare il confronto sul piano della ragione. Teme, non ha torto,
l’autodistruzione dei Dem. Ma tra i giganti dell’estremismo bipartisan – Sanders
e Trump – è destinata a sparire. Poi c’è Michael Bloomberg: nei match televisivi
l’ex sindaco di New York risulta goffo e impacciato. Con tutti i soldi che
spende per la campagna non potrebbe pagare qualcuno per prepararsi meglio a
questi appuntamenti? Di lui si ricorda soprattutto questa frase rivolta a
Sanders: «Vladimir Putin pensa che Donald Trump dovrebbe essere il presidente
degli Stati Uniti. Ed è per questo che la Russia ti sta aiutando a essere
eletto». Un esplicito richiamo alle rivelazioni del Washington Post di qualche
giorno fa che segnalano le interferenze russe nelle primarie. E al rischio che
Sanders sia il miglior avversario per Trump. Ovviamente l’interessato ha
respinto le illazioni. Pete Buttigieg, che ha capito dove si sposta il vento, si
è concentrato nell’attacco a Sanders. Lo ha fatto con una certa efficacia, ma
quel viso acerbo da bravo ragazzo, sconosciuto ai più, non basterà. Alla fine il
senatore del Vermont prende qualche sberla, ma resta in piedi. Bontà sua, ha
pure una parola buona per Fidel Castro e l’amministrazione cubana. Chissà se
in Florida saranno d’accordo con lui. E chissà come si divertirà Donald Trump
tra qualche mese. Pur essendo un politico di carriera, Sanders si presenta come
un ribelle contro le élite, sia repubblicana che democratica, in perfetto stile
populista. Promette una rivoluzione che affascina soprattutto i giovani, anche
se non spiega con quali soldi potrà sostenerla. Ha una capacità enorme di
raccogliere denaro. La sua falange di seguaci è pronta a tutto. Anche a sparare
senza pietà contro chiunque lo ostacoli. Guardate che combinano i Bernie Bros,
un gruppo di trolls che ha intossicato il dibattito politico sui social media.
Ne sanno qualcosa Hillary Clinton e la Culinary Union, il sindacato dei
lavoratori alberghieri che ha osato negargli l’endorsement. In più, il suo côté
madurista fa breccia tra i latinoamericani: per loro è lo “tío Bernie”. Per
queste e altre ragioni molti osservatori – come, per esempio, John Freedland del
Guardian – vedono in lui il Corbyn americano. Il paragone non è di buon
auspicio. Ma la lezione resta valida per tutti i democratici. Anche per quelli
italiani che civettano con il grillismo. Paralizzati in una lotta fratricida,
nel Super Tuesday ci saranno ancora troppi candidati che si rubano i voti tra
loro: forse perché un candidato con un messaggio forte e lo standing adeguato
questa volta non c’è. Un eccesso di frammentazione che favorisce il leader più
populista. Secondo Fivethirtyeight, il sito di matematica elettorale fondato da
Nate Silver, giornalista e statistico che ha previsto i risultati delle
presidenziali del 2008 e del 2012, Sanders ha il 43% di possibilità di ottenere
la nomination (nessuno degli altri candidati esprime percentuali significative).
La stessa percentuale è attribuita all’ipotesi in cui nessun candidato riesca a
conquistare la nomination. In entrambi i casi diventerebbe necessaria la
mediazione tra le parti alla Convention di luglio. Stando così le cose, c’è un
solo pronostico possibile oggi: la vittoria di Trump.
Elezioni
Usa 2020, Obama sostiene Biden: “Ha l’esperienza per guidarci nei momenti bui”.
Redazione de Il Riformista il 15 Aprile 2020. “Scegliere Joe come
mio vicepresidente è stata una delle migliori decisioni che abbia mai preso. Ha
il carattere e l’esperienza per guidarci in uno dei nostri momenti più bui e
curarci attraverso una lunga ripresa. Ecco perché sono così orgogliosa di
sostenere Joe Biden come presidente degli Stati Uniti.” Così, in un video
postato sui social, l’ex presidente della Casa Bianca Barack Obama dà il suo
endorsement al candidato democratico, Joe Biden, suo ex vicepresidente. “Se c’è
una cosa che abbiamo imparato come Paese da momenti di grande crisi, è che
lo spirito americano di prendersi cura l’uno dell’altro non può essere limitato
alle nostre case, né ai nostri posti di lavoro, né ai nostri quartieri, o alle
nostre case di culto. Deve riflettersi anche nel nostro governo nazionale. Il
tipo di leadership guidata dalla conoscenza e dall’esperienza; dall’onestà e
dall’umiltà; dall’empatia e dalla grazia – quel tipo di leadership che non
appartiene solo alla nostra amministrazione. Appartiene alla Casa Bianca”. L’ex
inquilino della Casa Bianca ricorda l’impegno di medici e infermieri nella dura
battaglia contro il coronavirus e assicura che, ad ogni livello, Biden saprà
scegliere di chi fidarsi: “Si circonderà di brave persone
– esperti, scienziati e funzionari militari che sanno gestire il governo,
lavorare con i nostri alleati e mettere sempre gli interessi del popolo
americano al di sopra dei propri”. Obama non rinuncia a un passaggio critico
sull’attuale amministrazione americana, quella guidata da Donald Trump: “In
questo momento, abbiamo bisogno di americani di buona volontà per unirsi in un
grande risveglio contro una politica che troppo spesso è stata caratterizzata
da corruzione, indifferenza, autoreferenzialità, disinformazione,
ignoranza e cattiveria. E per cambiarlo, abbiamo bisogno di americani di tutte
le appartenenze politiche per farsi coinvolgere nella nostra politica e nella
vita pubblica come mai prima d’ora”. Una politica basata sui grandi valori della
tradizione democratica americana: “Per quelli di noi che credono nella
costruzione di un’America più giusta, più generosa, più democratica, dove tutti
hanno una giusta occasione, che credono in un governo che tiene a cuore i tanti,
e non solo i pochi, che amano questo paese e sono disposti a fare la loro parte
per assicurarci che sia all’altezza dei suoi ideali più alti”. E conclude:”Ora è
il momento di lottare per ciò in cui crediamo”.
Da ilfattoquotidiano.it il 14 aprile 2020. Un’accusa di abusi sessuali rischia
di compromettere la corsa alla Casa Bianca di Joe Biden. Diventato da pochi
giorni ufficialmente il candidato dei Democratici alle prossime Presidenziali
contro Donald Trump, dopo il ritiro di Bernie Sanders, Biden dovrà subito
rispondere alle accuse mosse contro di lui da Tara Reade, sua ex aiutante negli
anni 90, che già in passato aveva dichiarato di aver subito molestie dall’ex
vicepresidente. Ma in un’intervista rilasciata al New York Times, la donna, che
secondo quanto riporta Nbc News ha anche presentato una denuncia
ufficiale alla polizia di Washington giovedì, parla di veri e propri abusi.
L’anno scorso, Reade aveva dichiarato che il suo ex capo le aveva toccato in
modo inappropriato collo e capelli, ma in questa nuova intervista sostiene che
nella primavera del 1993, quando lavorava come assistente nel suo ufficio
a Capitol Hill, l’attuale candidato democratico la spinse contro un muro, le
mise la mano sotto la gonna e la penetrò. La denuncia sporta da Reade, aggiunge
l’emittente tv americana, parla di un assalto avvenuto tra il primo marzo e il
31 maggio 1993 e, pur se nel rapporto non si nomina direttamente Biden, lei ha
confermato che quello che viene indicato come ‘soggetto 2’ nella denuncia è l’ex
vice presidente. I responsabili della campagna elettorale di Biden parlano
di accuse false, affermando che il presunto abuso “non è assolutamente
accaduto”.
Tara Reade e
Michael Cohen. Sono i due scheletri nell’armadio che minacciano di deragliare le
campagne presidenziali di Joe Biden e Donald Trump. Tara era un’assistente del
candidato democratico che lavorava per lui quando era senatore, e lo ha accusato
di averla aggredita sessualmente nel 1993, cercando di penetrarla con le dita.
All’epoca lei non aveva sporto denuncia, ma lo ha fatto il 9 aprile scorso,
anche se i termini ormai sono scaduti, per affermare la disponibilità ad essere
interrogata dalla polizia. Nel 1993 Reade aveva discusso l’episodio con poche
persone, senza scendere nei dettagli. Ora è stato pubblicato l’audio di una
telefonata che sua madre aveva fatto al giornalista della Cnn Larry King, per
chiedere come denunciare un abuso subito dalla figlia. I dubbi sulla denuncia
riguardano le diverse versioni, i pochi testimoni, e il fatto che Tara potrebbe
avere motivazioni politiche, perché era una sostenitrice di Sanders e appoggia
le politiche di Putin. Biden finora ha ignorato l’accusa, riportata dai grandi
giornali come il New York Times e il Washington Post, ma la pressione sale.
Chris Cillizza della Cnn ha detto che deve rispondere di persona, mentre l’ex
consigliere di Hillary Clinton Peter Daou ha usato l’hashtag #DropOutBiden per
chiedere di cambiare il candidato presidenziale democratico. C’è il sospetto che
la campagna condotta con questi hashtag sia stata lanciata dall’apparato di
disinformazione russa, ma per il movimento #MeToo e i democratici è difficile
sostenere che le denunce delle donne sugli abusi vanno sempre ascoltate, e poi
ignorarle nel caso di Biden. Nello stesso tempo Trump è preoccupato perché il
suo ex avvocato Michael Cohen è uscito dal carcere e sta scrivendo un libro che
dovrebbe uscire prima delle elezioni. Cohen è stato condannato per i pagamenti
fatti alla pornostar Stormy Daniels e alla coniglietta di Playboy Karen
McDougal, allo scopo di nascondere le loro relazioni con il presidente. Secondo
indiscrezioni nel libro racconterà questi, ed altri episodi imbarazzanti, e il
capo della Casa Bianca ha chiesto ai legali di bloccarlo. La differenza rispetto
a Biden è che queste storie sono già note e Trump è sopravvissuto, quindi
serviranno dettagli nuovi e significativi per avere un impatto.
Andrea Salvadore per americanatvblog.com l'1 maggio 2020. MSNBC è
la televisione di news e talk shows che sveglia gli americani ogni mattina e li
accompagna nel corso della giornata, con CNN e FoxNews. FoxNews ha un
telespettatore fedele nella Casa Bianca, Trump. MSNBC è la televisione che
guardano quelli che tifano per Biden, candidato democratico nelle prossime
elezioni di novembre. In estrema e rozza sintesi. Il programma che apre le
mattine di MSNBC è Morning Joe, dal nome del conduttore Joe Scarborough, con un
passato repubblicano. Con lui conduce Mika Brzezinski, figlia di Zbigniew, che
ha lavorato nelle amministrazioni Johnson e Carter. Lo show parte ogni mattina
alle 6 e termina alle 9. Per me appuntamento fisso, quando possibile. Oggi,
l’annunciata intervista a Joe Biden, 77 anni, sul caso Tara Reade, la donna che
accusa il candidato democratico di molestia sessuale. La storia risalirebbe al
1993, quando lei lavorava per lui al Senato ed aveva 27 anni. L’intervista di
oggi è stata fatta precedere dalle immagini di tutte le donne che hanno accusato
Trump di molestie. Non è stata fatta menzione (potrei essermi distratto) alla
vicenda Clinton-Monica Levinski. Roba che se provi a Google ancora oggi Monica
Le…salta subito fuori. Come è andata? Beh, prima cosa da dire è che l’intervista
sull’accusa della Reade è stata condotta da una donna e basta, Mika Brzezinski.
E questa scelta me la segnerei. La Brzezinski, democratica e potenziale
elettrice di Biden, è stata molto dura. Ha ripetuto le domande quando la
risposta le è sembrata non esauriente. L’ha riformulata in un altro modo. Biden
ha detto all’infinito “Non è mai accaduto”. E la Brzezinski “Lei ha dichiarato
in passato che le donne devono essere sempre credute quando denunciano molestie.
Ora ?”. “Ha mai cercato una mediazione con un avvocato?”. “Ha mai provato lei o
qualcuno del suo staff a parlare con la Reade?”. ” La cerchera’?”. “È d’accordo
con la visione dei materiali contenuti negli archivi nazionali e quelli
dell’università del Delaware per rintracciare una denuncia della Reade di cui
potrebbe esserci traccia”. Biden ha ripetuto “Non so cosa ci sia dietro a lei.
Ma irrilevante perché nulla è accaduto”. Molto tesa la conversazione che si è
trasformata in un dialogo più rilassato quando è entrato il conduttore Joe
Scarborough (marito della Brzezinski) a parlare di pandemia e provvedimenti da
prendere. Conclusione, stiamo a vedere. Certamente la storia non finisce oggi. È
annunciata un’intervista alla Reade che potrebbe andare in onda su una
televisione nazionale già domenica. Ventisette anni dopo.
Una storia che potrebbe rimanere nel ciclo elettorale o chiudersi
rapidamente?
Una storia che potrebbe minare la candidatura Biden fino a farla
cadere?
Una storia arma di distrazione di massa dalla pandemia?
Giuseppe Sarcina per il “Corriere della Sera” il 4 maggio 2020.
Perché le accuse di Tara Reade contro Joe Biden valgono meno di quelle avanzate
da Christine Blasey Ford contro il giudice Brett Kavanaugh? È la domanda che
divide e imbarazza le donne impegnate nel movimento MeToo. Il candidato
democratico ha risposto solo il primo maggio, in un' intervista televisiva con
la Msnbc, alla versione di Tara Reade, registrata in un podcast a fine marzo. La
donna, 56 anni, ha raccontato che nel 1993 lavorava come assistente nell'
ufficio dell' allora senatore Biden. Un giorno il suo boss la spinse contro il
muro, tentò di baciarla e le infilò le dita sotto la gonna, toccandole gli
organi genitali. Tara, all' epoca aveva 29 anni, Biden 49 ed era già un
parlamentare in vista nel Congresso americano. Ora l' ex numero due di Barack
Obama smentisce «categoricamente» di aver molestato l' ex collaboratrice e
chiama in causa lo schema più collaudato: è una manovra politica, «perché esce
solo ora una storia di 27 anni fa?». È lo stesso argomento che i repubblicani
usarono nel 2018 per respingere l' assalto alla conferma di Kavanaugh come
giudice della Corte Suprema. In quelle settimane ci furono manifestazioni
davanti a Capitol Hill, si mobilitarono le personalità più in vista del MeToo,
nato nell' ottobre 2017 sull' onda del caso Weinstein. Nel Paese, sui media si
sviluppò un grande dibattito. La vicenda di Biden, invece, per settimane è
passata sotto silenzio. Non solo per il coronavirus. Le donne democratiche «si
sono trovate come intrappolate», per citare Tina Tchen, leader di Times Up Now,
associazione contro le molestie sui luoghi di lavoro. La candidatura di Joe
fatica a consolidarsi. Le diverse anime del partito stanno cercando di
puntellarla, in vista della sfida con Trump. Molte delle figure più
rappresentative hanno deciso di accordare comunque piena fiducia all' ex
vicepresidente, liquidando come infondate le rimostranze di Tara Reade. Ecco
allora la senatrice di New York Kirsten Gillibrand dichiarare martedì 28 aprile:
«Quando noi diciamo che dobbiamo credere alle donne, significa che va garantito
il diritto a tutte di parlare e di essere ascoltate. Tutto ciò è successo con le
accuse di Tara Reade. C' è stata un' indagine su diversi giornali. Il vice
presidente Biden ha negato con veemenza e io mi schiero con lui». Avevamo
lasciato Gillibrand sul palco montato nella Mall di Washington, il 21 gennaio
2017, giorno della prima Marcia delle donne. I suoi argomenti e toni erano
completamente diversi. Biden ha già incassato l' appoggio «sulla fiducia» della
Speaker Nancy Pelosi, di Hillary Clinton e di Stacey Abrams, la democratica
georgiana che si sta agitando per diventare la vice di Joe. La spinta del MeToo
stavolta si è rivelata fiacca. Non c' è stata una vera indagine. Gli organi del
partito democratico hanno ignorato il problema. Abbiamo solo la versione di Tara
e quella di Joe.
Irene Soave per "corriere.it" il 16 giugno 2020. Uscirà questo
agosto per la casa editrice Simon & Schuster e si intitolerà «Too Much and Never
Enough»: «troppo e mai abbastanza». L’autrice è Mary Trump, psicologa, 55
anni: nipote del presidente degli Stati Uniti, cioè figlia di quel fratello
alcolizzato, Fred Trump Jr., che Donald Trump ha a volte citato come ragione
della sua scelta di essere astemio. Il libro è un memoir, scritto in prima
persona e dunque autobiografico: ma è già annunciato che conterrà molti
dettagli «inquietanti e volgari», così scrive il sito che per primo ha dato la
notizia, il Daily Beast, sulla vita del presidente. Un capitolo decisivo sarà
dedicato a quando Mary, nipote informatissima, fu la «talpa» che nel 2018
permise al New York Times di svelare nei dettagli vari espedienti fiscali messi
in atto da Trump, e anche di provare che la sua corsa alla Casa Bianca era stata
finanziata da 400 milioni di dollari direttamente dal padre, Fred Trump Sr...È
la prima volta che Mary racconta chiaramente questa vicenda e il suo ruolo di
fonte riservata. Un altro «dettaglio di famiglia» che, secondo quanto trapela,
sarà presente nel libro, sono conversazioni con la sorella di Donald Trump, la
zia di Mary Maryanne Trump Barry,una carriera da giudice federale, in privato
molto critica con la figura pubblica del fratello. Ma le parti più dolorose e
forse più destinate a mettere in difficoltà il presidente Usa potrebbero essere
le pagine dedicate a Fred Jr., primogenito debole e morto a 42 anni nel 1981 per
un attacco cardiaco attribuito dai medici al suo alcolismo. Dell’alcolismo di
Fred Trump il memoir parla estesamente; e secondo le fonti della notizia
trapelata ieri le accuse a Fred Sr. e Donald di non averlo aiutato a lungo, e
avere contribuito alla sua morte, sarebbero chiare e dirette. Lo stesso Donald
Trump, in un’intervista del 2019 al Washington Post, ammette di aver messo molta
pressione al fratello perché portasse avanti le imprese di famiglia, pur non
avendone né voglia né inclinazione. Insomma, tra affari di famiglia, ricevute
fiscali e panni sporchi lavati in pubblico — «Mio zio dovrebbe vergognarsi» è
stata finora l’unica frase detta da Mary Trump in un’intervista a proposito di
Donald, e sembra dare un chiaro anticipo di quale sarà il tono del memoir — «Too
Much, Never Enough» sembra destinato a sollevare molta polvere a Washington. A
partire dalla data di uscita: sarà in libreria l’11 agosto, alla vigilia della
convention nazionale dei repubblicani.
Massimo Gaggi per il ''Corriere della Sera'' il 16 giugno 2020.
Difficile dire se abbiano varcato il confine tra elusione ed evasione fiscale.
Ma certamente Donald Trump e papà Fred varcarono quello del cinismo quando,
negli anni Novanta, usarono finti acquisti di materiali per la manutenzione dei
loro palazzi - caldaie, infissi, motori degli ascensori e altro ancora - da
parte di una loro società, la All Country Buildings Supply & Maintenance, non
solo per trasferire soldi da padre a figlio evitando di pagare le tasse, ma
anche per giustificare l'aumento dell'affitto imposto agli inquilini. L'episodio
è uno dei tanti narrati in una sterminata inchiesta sui cento modi usati da
Trump per aggirare il Fisco pubblicata dal New York Times nell'ottobre del 2018:
un'indagine assai dettagliata (secondo il quotidiano, «The Donald» in realtà
nell'arco di 50 anni ha usato ben 295 canali per trasferire fondi evitando
prelievi fiscali) che per la prima volta dimostrò la falsità della storia del
self made man. Trump ha sempre sostenuto di aver avuto dal padre solo un milione
di dollari, poi restituito con gli interessi: invece ricevette da Fred un
patrimonio del valore di 413 milioni di dollari. Notizie clamorose, ottenute due
anni fa dai giornalisti investigativi del quotidiano da una fonte segreta.
Segreta fino a oggi perché Mary Trump, figlia di Fred Jr, fratello maggiore di
Donald, morto a soli 42 anni per un infarto nel 1981, ora ha deciso di
raccontare di essere stata lei la «gola profonda» della famiglia in un libro che
promette di essere un altro colpo per l'immagine del presidente, che già aspetta
con ansia quello del suo ex assistente John Bolton (verrà pubblicato la prossima
settimana). Le memorie di Mary Trump arriveranno in libreria l'11 agosto, alla
vigilia della convention repubblicana che darà al presidente la nomina per un
secondo mandato alla Casa Bianca. L'intento della nipotina col dente avvelenato
traspare già dal titolo del libro che verrà pubblicato da grande editore Simon &
Shuster: Too Much and Never Enough (Troppo e mai abbastanza). La miniera alla
quale attinge Mary - che è anche la ragione principale del suo risentimento - è
quella delle controversie che circa vent' anni fa segnarono la distribuzione
dell'eredità del capostipite, Fred, morto nel giugno del 1999 (la moglie, Mary,
scomparve pochi mesi dopo). Per ora non ci sono anticipazioni: probabilmente
Mary tornerà a raccontare, stavolta in prima persona, come papà Fred abbia
trasferito soldi per decenni ai figli in modo occulto. Soprattutto a Donald,
finito più volte in bancarotta nella sua attività imprenditoriale. Il futuro
presidente già all'età di tre anni riceveva un salario di 200 mila dollari come
consulente. A otto anni era milionario. A diciassette era proprietario di un
edificio con 52 appartamenti. Ma Mary stavolta andrà oltre gli aneddoti
contabili: si sa, ad esempio, che il libro conterrà anche le confidenze di un
altro personaggio fin qui silenzioso della famiglia: Maryanne Trump Barry,
sorella di Donald, un giudice federale in pensione.
Albachiara Re per "wired.it" il 17 giugno 2020. Mancano poche
settimane all’uscita di due libri che promettono di creare più di un problema al
presidente Donald Trump. La nipote Mary Trump pubblicherà il 28 luglio una
biografia familiare edita da Simon & Schuster dal titolo Too much and never
enough nella quale – secondo la sinossi – verranno descritta con “particolari
drammatici e piccanti” i Trump, in particolare il rapporto di Donald con il
fratello maggiore Fred (scomparso ancora giovane nei primi anni ’80). Le vere
rivelazioni del libro sono però quelle legate alle dichiarazioni fiscali
fraudolente di Fred Trump Sr, magnate dell’immobiliare e padre del presidente,
nonché primo artefice della sua fortuna. Mary, infatti, sarebbe la fonte del New
York Times per l’inchiesta sulle magagne fiscali di Donald che è valsa alla
testata il premio Pulitzer. A una scadenza molto più ravvicinata, il 23 giugno,
invece sarà disponibile il libro di un personaggio già molto discusso in
relazione a Trump: John Bolton, ex consigliere per la sicurezza nazionale. The
Room where it happened: a White House memoir, sempre edito da Simon & Schuster,
racconterà del suo anno alla Casa Bianca, affrontando temi di politica estera
spinosi come Nord Corea, Iran, Afghanistan e Ucraina. Quest’ultima vicenda, in
particolare, è costata a Trump un processo di impeachment da cui è uscito
assolto. Il presidente, con il proprio staff di avvocati, sta valutando tutte
le misure legali necessarie per impedire l’uscita dei libri che teme possano
danneggiare la sua immagine dal punto di vista personale e politico.
Le azioni legali. “Secondo la mia esperienza, se mi chiedete
quale libro preoccupa più Trump direi decisamente quello di Mary”, ha spiegato
al Daily Beast Sam Nunberg, ex consigliere politico del presidente. “Perché
riguarda la famiglia e lo considera una sorta di tradimento personale”. Tra le
misure prese in considerazione dal presidente c’è quella di impedire
l’uscita della biografia di sua nipote, minacciando azioni che potrebbero
portare a un ordine restrittivo alla pubblicazione fino a un sequestro degli
eventuali guadagni. Fonti vicine alla Casa Bianca hanno spiegato al giornale che
Trump vorrebbe rivalersi attraverso un accordo di non divulgazione firmato da
Mary nel 2001, in cui la donna prometteva di non rivelare nulla di riguardante
il patrimonio immobiliare del patriarca Fred Sr. e del rapporto dell’attuale
presidente con il fratello Fred Jr, Robert e sua sorella Maryanne. Più complessa
è, invece, la faccenda riguardante le memorie di Bolton, che contengono
anche informazioni delicate riguardanti materie di sicurezza nazionale.
Soprattutto in relazione alla questione ucraina, l’ex consigliere non ha avuto
mai modo di dare la sua versione dei fatti perché la sua richiesta di audizione
è stata bloccata con un voto contrario dei repubblicani vicini al presidente,
sia al Congresso che in Senato. Visti gli argomenti del libro, lo scritto
avrebbe dovuto passare la revisione dell’amministrazione e del Dipartimento di
Giustizia volta a verificare che non vengano divulgate informazioni sensibili o
pericolose. In effetti, come riporta il New York Times, una revisione c’è stata
e Bolton ha modificato alcuni parti del libro, ma la Casa Bianca ha preso tempo
e non ha mai confermato all’ex consigliere di aver completato il processo di
revisione. Il Dipartimento di Giustizia e Trump hanno accusato Bolton di voler
far trapelare informazioni segrete, senza approvazione, commettendo quindi
un crimine federale. I legali dell’ex consigliere, invece, hanno spiegato che
l’amministrazione sta abusando del proprio potere per impedire che il libro
venga pubblicato. Intanto l’editore Simon & Schuster ha già stampato la prima
edizione e le prevendite su Amazon, in pochi giorni, sono schizzate alle stelle.
Ora Trump sta valutando come muoversi. Anche in questo caso le misure prese in
considerazione sono le stesse del libro di Mary: impedire l’uscita, o almeno
rimandarla di qualche mese, e provare ad avere un risarcimento con i proventi
ricavati dalla vendita del libro.
Trump chiede aiuto a Cina per le elezioni: l’attacco nel libro
di Bolton. Notizie.it il 18/06/2020. Proseguono le
accuse contro Trump: è il nuovo libro di Bolton a preoccupare il presidente
degli Stati Uniti, che è già pronto a bloccarne la vendita. Mentre i sondaggi
parlano di un brusco calo dei consensi e preoccupano le rivelazioni della nipote
Mary, Donald Trump riceve altre accuse: nel suo nuovo libro,
infatti, Bolton sostiene che il presidente degli Usa abbia chiesto aiuto alla
Cina per essere rieletto. Stando a quanto dichiarato dall’ex consigliere per la
sicurezza nazionale John Bolton, Trump avrebbe chiesto al presidente cinese Xi
Jinping di aiutarlo a vincere la rielezione. Inoltre, stando a quanto riportato
nel nuovo libro “The Room Where it Happened: A White House Memoir”, il
presidente americano avrebbe incoraggiato la realizzazione di campi di
concentramento per gli uiguri, la minoranza musulmana in Cina. La proposta
sarebbe arrivata dal presidente cinese, ma Trump si sarebbe mostrato favorevole
all’iniziativa, esortandolo ad andare avanti con la sua politica di
internamento. Per il presidente degli Stati Uniti sarebbe “la cosa giusta da
fare”, rivela Bolton. Mentre si consumava la guerra dei dazi, Trump pare si sia
rivolto a Xi definendolo “il più grande leader cinese degli ultimi 300 anni”. Si
tratta solo di alcune delle più sconvolgenti rivelazioni fatte da Bolton. Il suo
testo sarà in libreria dal 23 giugno, ma non mancano le anticipazioni. Il libro
esce nove mesi dopo l’addio di Bolton alla Casa Bianca ed è già in vetta alla
classifica dei best seller di Amazon. L’amministrazione Trump replica alle
accuse, ritenendo false le notizie riportate e criticandolo per divulgare
informazioni classificate, è ricorsa in tribunale. Trump “chiese al presidente
cinese Xi Jinping di aiutarlo a vincere le elezioni Usa del 2020”, scrive
chiaramente Bolton nel suo nuovo volume. Quindi fa sapere: “Durante una cena
estiva lo scorso anno, spiegò a Xi che aumentare gli acquisti di Pechino di
prodotti agricoli americani avrebbe migliorato le sue prospettive elettorali”.
Si tratterebbe di un colloquio avvenuto a margine del G20 in Giappone nel giugno
del 2019.
(ANSA il 18 giugno 2020) - ROMA, 18 GIU - L'amministrazione Trump
chiede un ordine restrittivo di emergenza per bloccare la pubblicazione del
libro dell'ex consigliere alla sicurezza di Donald Trump, John Bolton. Il
governo chiede un'udienza per il 19 giugno considerato che il libro dovrebbe
uscire il 23 giugno. "ha infranto la legge", sostiene il presidente. "E' un
bugiardo - sottolinea -. Alla Casa Bianca non lo sopportava nessuno".
Giuseppe Sarcina per il “Corriere della Sera” il 18 giugno 2020.
Mescolare interessi politici personali e relazioni internazionali. «Uno schema
consueto per Donald Trump». Non solo con l' Ucraina: anche con la Cina e la
Turchia. Tutti dossier «che avrebbero potuto avere una maggiore probabilità di
convincere altri (parlamentari ndr) che erano stati commessi "crimini gravi e
misfatti"», punibili con l' impeachment. Il libro di John Bolton, The Room where
it happened (592 pagine, Simon & Schuster editore) uscirà il 23 giugno. Ma di
fatto, con le anticipazioni filtrate ieri, è già entrato nel dibattito
nazionale. L' ex consigliere per la Sicurezza nazionale, in carica dal 9 aprile
2018 al 9 settembre 2019, racconta, per esempio, il dietro le quinte del G20 di
Osaka, in Giappone, il 28 e il 29 giugno scorsi. Trump disse al presidente
cinese Xi Jinping che negli Stati Uniti c' era chi spingeva per scatenare «una
guerra fredda» con la Cina. «Trump capì immediatamente che Xi pensava si
riferisse ai democratici. E quindi, incredibilmente, spostò la conversazione
sulle imminenti elezioni presidenziali, chiedendo a Xi un aiuto per vincerle».
Il leader americano, allora, «domandò con insistenza a Xi Jinping di comprare
soia e grano, in modo da favorire i farmer americani». Vale a dire una parte
della sua base elettorale. Bolton sostiene che il presidente abbia cercato
sistematicamente di agevolare «i dittatori che gli piacevano». Cita l'
interferenza della Casa Bianca nelle indagini sulla turca Halkbank, «per rendere
un favore» a Recep Tayyip Erdogan. Oppure le pressioni sugli accertamenti che
toccavano la multinazionale cinese delle telecomunicazioni, la Zte, «per
compiacere», ancora una volta, Xi Jinping. Nel volume vengono anche descritte le
relazioni interne all' amministrazione. Bolton scrive che anche i consiglieri
apparentemente più fedeli, come il segretario di Stato, Mike Pompeo, in realtà
«prendevano in giro il presidente». Durante lo storico vertice del 2018 tra
Trump e Kim Jong-un, «Pompeo mi passò un bigliettino in cui era scritto: "è così
pieno di m."». Seguono altri particolari, che ricordano l' atmosfera raccontata
nei libri di Bob Woodward ( Paura ) e di Michael Wolff ( Assedio ). Trump arrivò
a un passo da annunciare il ritiro dalla Nato; non sapeva che il Regno Unito
fosse una potenza nucleare; pensava che la Finlandia facesse parte della Russia.
E così via. Un capitolo fondamentale riguarda l' Ucraina, le manovre contro il
candidato democratico Joe Biden, le accuse che hanno condotto all' impeachment
del presidente. Il 31 gennaio scorso i senatori repubblicani riuscirono
veramente per un soffio a impedire che Bolton fosse ascoltato in aula. Tuttavia
in quei giorni a Washington circolava «il manoscritto», cioè la bozza di quello
che ora è il libro più atteso dell' anno. In quegli appunti il consigliere
riferisce che nell' agosto del 2019 il presidente gli disse: bloccherò gli aiuti
militari per 391 milioni di dollari già promessi a Kiev, fino a quando il neo
leader ucraino Volodymyr Zelensky non riaprirà l' indagine per corruzione a
carico della Burisma. Nel consiglio di amministrazione di quella società del gas
era presente anche Hunter Biden, figlio dell' ex vice presidente Joe Biden. La
versione di Bolton chiama in causa anche Pompeo, che si sarebbe prima lamentato
per l' anomalo attivismo di Rudy Giuliani in Ucraina, ma poi avrebbe di fatto
avallato le manovre messe in campo dall' ex sindaco di New York per fare
pressioni su Zelensky. Il 21 novembre 2019, in un' audizione alla Camera, la
consigliera Fiona Hill aveva rivelato come Bolton, all' epoca suo diretto
superiore, le avesse ordinato di consultare l' ufficio legale perché non voleva
avere nulla a che fare con il dossier «Ucraina-Biden-Burisma», considerato «un
traffico di droga». Gli avvocati dell' amministrazione hanno chiesto alla
magistratura di bloccare le memorie di Bolton, perché diffondono «informazioni
classificate» che mettono a rischio la sicurezza del Paese. Ma ormai è tardi.
Trump, il New York Times pubblica le sue dichiarazioni dei
redditi: «Per anni non ha pagato le tasse». Giuseppe
Sarcina su Il Corriere della Sera il 28 settembre 2020. Il presidente
miliardario ha pagato 750 dollari di imposte nel 2016, l’anno della sua
elezione, e altri 750 nel 2017. Per dieci anni su quindici precedenti non ha
versato neanche un centesimo al fisco. In media ha corrisposto 1,4 milioni di
dollari all’anno, rispetto ai 25 milioni di dollari liquidati dalla sua
categoria di ricchi contribuenti. Sono i dati shock che emergono dai documenti
tributari della «Trump Organization» pubblicati ieri dal «New York Times». Il
quotidiano è riuscito, quindi, ad aggirare la difesa allestita dal gruppo
imprenditoriale di Trump, procurandosi le dichiarazioni dei redditi dal 2000 al
2017. A differenza degli altri leader della Casa Bianca, l’ex costruttore
newyorkese si è rifiutato di pubblicare i suoi rendiconti personali e quelli
della sua holding cui fanno capo imprese immobiliari, alberghi, club di golf e
altre attività. Secondo la ricostruzione del giornale, Trump e i suoi
commercialisti sono riusciti ad abbattere se non a eludere completamente le
imposte, chiedendo e ottenendo un gigantesco rimborso fiscale pari a 72,9
milioni di dollari, probabilmente per compensare il fallimento dei casino ad
Atlantic City. Gli ispettori dell’Internal Revenue Office (Irs) stanno ancora
accertando se non siano state commesse irregolarità. È questo il famoso «audit»,
iniziato nel 2011, cui Trump ha fatto spesso riferimento per giustificare la
decisione di non fare luce sui suoi rapporti con l’erario. La «Trump
Organization» avrebbe compilato i bilanci in modo da denunciare perdite in tutti
i settori, dagli hotel, ai club esclusivi. Il «New York Times» calcola che
grazie a queste manovre contabili Trump avrebbe versato 400 milioni di dollari
in meno, tra prelievi statali e federali, rispetto a una stima plausibile del
dovuto, considerando il prelievo su patrimoni analoghi di altri businessmen.
Nella conferenza stampa di ieri il presidente ha accusato il giornale newyorkese
di «aver inventato completamente la storia»: «è una fake news». Trump, però,
forse involontariamente, ha fornito una pista interessante: «Se voi guardate i
“files” che ciascuna delle mie aziende compila ogni anno, vedrete che vanno
tutte bene. Appena l’Irs avrà completato la revisione, renderò tutto pubblico».
In effetti, analizzando le 92 pagine sulle proprietà consegnate da Trump alla
«Federal Electoral Commission» nel maggio del 2016, si scoprono informazioni che
contraddicono quanto «The Donald» ha, invece, comunicato al fisco. La «Trump
Organization» è divisa in cinque settori: gli hotel, 24 torri con appartamenti
in vendita e in affitto negli Stati Unit e altre otto sparse nel mondo; le vigne
e altro ancora. Ma i soldi veri arrivano dai 18 campi da golf. Il «Trump
National Golf di Jupiter», in Florida è iscritto a bilancio per 50 milioni e
frutta ricavi prima delle tasse per 12,5 milioni. Oppure Mar-a-Lago, la Casa
Bianca d’inverno, rende 15,56 milioni. Ora il formidabile lavoro del «New York
Times» ci aiuta a chiudere l’equazione rimasta finora in sospeso. Se le
proprietà di Trump, come dice lo stesso presidente, continuano a dare gettito,
come è possibile che il suo contributo alle casse pubbliche sia praticamente
nullo? Le tecniche del cosiddetto «tax planning» sono numerose e molto
sofisticate. Ma dal brogliaccio delle carte emergono anche particolari
grotteschi. I legali di Trump avrebbero scontato, giusto per fare qualche
esempio, spese per 75 mila dollari, sostenute dal tycoon per farsi sistemare i
capelli negli anni in cui conduceva lo show tv «The Apprentice». Poi c’è il
capitolo Ivanka. Anche la figlia prediletta di «The Donald» ha scaricato
scontrini per 100 mila dollari, rilasciati dal suo parrucchiere e dal «makeup
artist» di fiducia. Tutte uscite che i contabili hanno classificato come costi
aziendali deducibili. Stesso discorso per le commissioni collegate alle
operazioni di «real estate». Trump ha messo a verbale 747.622 dollari come
onorari per un consulente anonimo che ha sviluppato il progetto di alcuni hotel
nelle Hawaii e a Vancouver, in Canada. Adesso viene fuori che esattamente la
stessa cifra compare nel modulo consegnato da Ivanka Trump nel 2017, quando fu
nominata dal padre consigliera della Casa Bianca.
(ANSA il 28 settembre 2020) - Donald Trump non ha pagato tasse
federali sul reddito per almeno 10 degli ultimi 15 anni, e nel 2016 e 2017 ha
sborsato solo 750 dollari per ciascun anno. E' lo scoop del New York Times, che
ha ottenuto informazioni sulle dichiarazioni fiscali fatte negli ultimi 20 anni
dal presidente americano. Uno scoop che rovina la festa al presidente il giorno
dopo la controversa nomina della giudice Amy Coney Barrett alla Corte Suprema e
alla vigilia del primo duello tv con Joe Biden. La notizia bomba è stata
pubblicata proprio nel momento in cui Trump stava per iniziare una conferenza
stampa convocata per attaccare i media, rei di criticare la scelta della giudice
Barrett solo - ha detto - perchè è cattolica. Ma la questione è passata subito
in secondo piano, con il presidente costretto a difendersi dalle domande dei
giornalisti e che ha liquidato le rivelazioni del Nyt come "assolute fake news".
Secondo le carte di cui il Nyt è venuto in possesso, Trump avrebbe pagato appena
750 dollari di tasse federali sul reddito sia l'anno in cui ha vinto la
presidenza sia il suo primo anno alla Casa Bianca. Avrebbe invece pagato "zero
dollari" in dieci degli ultimi 15 anni, soprattutto - si spiega - grazie
all'escamotage di riportare molte più perdite rispetto alle somme guadagnate. Le
finanze del presidente - racconta sempre il Nyt - sarebbero poi sotto stress,
con centinaia di milioni di debiti legati in gran parte alla gestione delle
proprietà della Trump Organization, l'impero di famiglia. In particolare Trump
sarebbe personalmente responsabile di prestiti e altri debiti per 421 milioni di
dollari la cui gran parte sarebbero da rimborsare entro quattro anni. C'è di
più: a complicare la situazione, spiega il Nyt, ci sarebbe anche un'annosa
controversia con l'Irs, il fisco americano, per un rimborso fiscale di 72,9
milioni di dollari entrati che si sospetta Trump abbia richiesto e ottenuto
dichiarando enormi perdite. Una controversia che se dovesse vedere Trump
perdente potrebbe costare al presidente oltre 100 milioni di dollari. Il
direttore esecutivo del Nyt, Dean Baquet, ha spiegato così la decisione di
pubblicare le carte: "Crediamo che i cittadini debbano sapere il più possibile
dei loro leader e rappresentanti, le loro priorità, le loro esperienze e anche
le loro finanze". Trump, si ricorda, finora si è sempre rifiutato di rendere
pubbliche le proprie dichiarazioni fiscali, nonostante le richieste anche da
parte del Congresso e della magistratura. "Ogni presidente dalla metà degli anni
'70 ha pubblicato le proprie informazioni fiscali - ricorda Baquet - e Trump,
uno dei presidenti più ricchi della nostra storia, ha rotto con questa
tradizione". Per i legali della Trump Organization lo scoop del Nyt è
"inaccurato": negli ultimi decenni - si spiega - il presidente ha pagato decine
di milioni di dollari in tasse personali al governo federale, compresi milioni
di dollari da quando ha annunciato la sua candidatura nel 2015.
Ansa il 27
ottobre 2020. Vittoria di Trump a una settimana dal voto negli Stati Uniti: dopo
l'approvazione del Senato, ha giurato come nuovo giudice della Corte suprema la
conservatrice Amy Coney Barrett. "E' un giorno storico per l'America", ha
commentato il presidente. "Dobbiamo avere il risultato finale la notte del 3
novembre", ha twittato il presidente, lanciando l'ennesimo sospetto sul voto per
posta. Ma Twitter ha censurato il post, definendolo "controverso" e
possibilmente "fuorviante in merito alle modalità di partecipazione alle
elezioni". I risultati ufficiali del voto Usa, spiegano alcuni osservatori, non
sono mai calcolati nella notte elettorale. "E' un privilegio essere stata
chiamata a servire il mio Paese", sono state le prime parole della Barrett dopo
il giuramento. "Ricoprirò il mio incarico in maniera indipendente dalla politica
e dalle mie preferenze", ha aggiunto. "Saluto la prima mamma di bambini in età
scolastica a diventare giudice della Corte suprema", ha sottolineato Trump.
Stavolta tutti con le mascherina e rispetto del distanziamento sul prato davanti
la Casa Bianca. Diversamente era andata durante la cerimonia per la nomina di
Barrett, divenuta un evento superdiffusore del contagio da Covid-19, con decine
di persone in seguito risultate positive compreso Trump.
(ANSA il 27
ottobre 2020) - Donald Trump non vuole perdere nemmeno un minuto di tempo e
fissa la cerimonia del giuramento di Amy Coney Barrett alle nove di sera. A una
settimana dal voto il presidente americano, sempre indietro nei sondaggi, non
può permettersi neanche un istante di pausa, anche dopo una lunga giornata che
lo ha visto impegnato in ben tre comizi nello stato chiave della Pennsylvania.
Così la giudice scelta dal presidente americano per la Corte Suprema ha appena
il tempo di cambiarsi dopo il voto finale da parte dell'aula del Senato e
correre alla Casa Bianca. La sua nomina per Trump è una grande vittoria
politica, forse l'unico vero colpo del presidente in questi tormentati mesi di
campagna elettorale. E sicuramente, se dovesse perdere le elezioni, il vero
segno lasciato dopo quattro anni di presidenza, la sua eredità principale.
L'unica cosa che potrebbe rimanere davvero in mano ai repubblicani se dovessero
perdere come temono anche il Senato. The Donald consegna alla storia un'Alta
Corte mai così conservatrice negli ultimi 90 anni, da quegli anni '30 che
precedono l'era del New Deal di Franklin Delano Roosevelt: sei toghe di nomina
repubblicana e appena tre di nomina democratica. Una svolta che potrebbe
incidere sul sistema giudiziario e sulla vita sociale degli americani per
decenni, visto che i giudici della Corte Suprema non hanno una scadenza. E' una
svolta a cui Trump ha contribuito enormemente, avendo avuto la possibilità di
nominare, prima della ultracattolica Barrett, altri due magistrati di estrazione
conservatrice: Neil Gorsuch e Brett Kavanaugh. A questo punto potrebbe essere
vanificato anche il ruolo di ago della bilancia spesso svolto dal presidente
della Corte John Roberts, che in più casi ha votato con i colleghi liberal
nonostante sia stato nominato dal repubblicano George W.Bush. E, con la nomina
di Amy Barrett, Trump potrebbe aver aperto la strada non solo per l'abolizione
dell'Obamacare, l'odiata riforma sanitaria di Barack Obama, ma addirittura per
rimettere in discussione la storica sentenza Roe vs Wade che nel 1973 ha
legalizzato l'aborto, nonchè quella più recente che ha riconosciuto il diritto
alle nozze gay, e tante altre conquiste sul fronte dei diritti civili. Per
questo i democratici fino all'ultimo hanno provato a fermare in ogni modo i
repubblicani in Senato. Barrett, 48 anni, di South Bend Indiana, è proprio la
figura che più temono: giovane, cattolica conservatrice, figura distante anni
luce dall'icona liberal Ruth Bader Ginsburg di cui prenderà il posto nel massimo
organo istituzionale. E il suo peso potrebbe essere messo subito alla prova, ben
prima del previsto, se il risultato delle elezioni dovesse essere contestato e
finire proprio davanti alla Corte Suprema. Mentre i democratici, fallito
l'ostruzionismo, tirano fuori dal cassetto il piano B: quello del cosiddetto
“court packing”, vale a dire allargare la composizione dell'Alta Corte con nuove
nomine democratiche in caso di vittoria di Joe Biden. Una strada in passato
criticata dall'ex vicepresidente quando a proporla erano i repubblicani. Ma ora
è decisamente un'atra storia.
Donald Trump e il caso tasse: oltre 70mila dollari dedotti per
il parrucchiere. Redazione su Il Riformista il 29
Settembre 2020. Donald Trump l’ha bollata come “fake news”, ma l’inchiesta del
New York Times sulle dichiarazioni dei redditi del tycoon e presidente Usa
rischia di provocare un terremoto politico in vista delle elezioni del 3
novembre. Trump, secondo l’indagine del NYT, avrebbe pagato nel 2016 e nel 2017,
primi due anni della presidenza, solo 750 dollari di tasse, cifra “notevolmente
inferiore alla maggior parte degli americani che lavorano”. Inoltre, non avrebbe
pagato nulla per dieci degli ultimi 15 anni.
UN IMPERO A RISCHIO FALLIMENTO – Non solo. Altri dettagli fanno
emergere chiaramente come l’immagine dell’imprenditore di successo sia in realtà
molto più controversa: l’impero economico costruito dal padre del presidente,
riunito nella Trump Organization, è pericolosamente a rischio. In particolare
tutte le attività, che vanno dagli hotel al ramo immobiliare, sono in rosso e
pericolosamente a rischio fallimento: il solo Trump Hotel di Washington,
acquistato nel 2015, perde 55 milioni.
SPESE PERSONALI ‘PAZZE’ – Il New York Times inoltre ha rivelato
come il tycoon abbia classificato come “spese aziendali” molte delle sue spese
personali, beneficiando di un numero vastissimo di deduzioni, che il fisco
statunitense chiede siano “ordinarie” e “necessarie”. Tra queste spuntano quelle
per il suo aereo privato, quelle per i campi da golf, anche 70mila dollari per
il suo parrucchiere personale per lo show "The Apprentice", i quasi 100mila per
il make-up artisti di Ivanka Trump. Oltre due milioni di dollari sono stati
dedotti in tasse per la casa di Seven Springs, a nord di New York, un castello
classificato da "The Donald" come sede di lavoro.
Trump come Al Capone, nei guai per aver evaso le tasse.
Vittorio Ferla su Il Riformista il 29 Settembre 2020. Donald
Trump non paga tasse federali sul reddito in 10 anni su 15 a partire dal 2000.
Questa la bomba pubblicata dal rapporto del New York Times di domenica scorsa.
Il motivo? Ha perso molto più di quanto ha guadagnato. Sia nell’anno in cui ha
vinto la presidenza (2016) che nel suo primo anno alla Casa Bianca (2017), Trump
ha pagato la miseria di 750 dollari. Se il quadro dei pagamenti di Trump
delineato dal NYT risultasse confermato il presidente americano potrebbe dire
addio alla speranza di riconquistare la Casa Bianca. Il rapporto, infatti,
racconta anni di enormi perdite finanziarie e di elusione fiscale che danno un
duro colpo all’epica del re degli affari su cui Trump ha costruito la
sua carriera politica. Delle due l’una: o Trump ha nascosto al fisco le sue
enormi ricchezze, oppure il racconto dei suoi successi imprenditoriali è
soltanto una grande bugia. «Pago molto in tasse statali sul reddito», ha
dichiarato Trump in sua difesa. Bisogna ricordare che, sul piano legale, il
presidente non ha l’obbligo di rendere pubblica la propria dichiarazione dei
redditi, ma negli anni la prassi dei presidenti americani è sempre stata quella
di comunicare i propri redditi, proprio nel rispetto del principio di
trasparenza. L’inchiesta giornalistica, firmata da Russ Buettner, Susanne
Craig e Mike McIntire, rivela che Trump «ha evitato di pagare le tasse pur
facendo una vita da miliardario – cosa che lui rivendica di essere – mentre le
sue compagnie hanno pagato i costi di quelle che molti considererebbero spese
personali». Negli ultimi due decenni, Trump avrebbe pagato circa 400 milioni di
dollari in meno in tasse federali sul reddito rispetto a quello che avrebbe
dovuto fare per legge. Basti ricordare che, negli anni in cui erano in carica, i
due presidenti che lo hanno preceduto – Barack Obama e George W. Bush –
versavano ogni anno più di 100mila dollari di tasse federali. Secondo il
giornale, Trump ha utilizzato i 427 milioni di dollari che gli erano stati
pagati per le puntate di The Apprentice per finanziare le altre sue attività,
principalmente i suoi campi da golf, e che il denaro investito nei suoi affari
era superiore a quello che stava perdendo. Le informazioni fiscali ottenute dal
Times rivelano inoltre che per anni Trump ha sostenuto un conflitto legale con
l’International Revenue Service (Irs), l’ente statunitense che corrisponde alla
nostra Agenzia delle Entrate, per decidere se le sue perdite avrebbero dovuto
comportare un rimborso di quasi 73 milioni di dollari. Trump ha ottenuto di
pagare poche tasse anche perché la sua azienda – la Trump Organization – ha
dichiarato enormi perdite nel corso degli anni: dal 2000, per esempio, il
magnate ha dichiarato di aver perso più di 315 milioni di dollari dalle attività
derivanti dai suoi campi da golf, che descriveva però, allo stesso tempo, come
il cuore del suo impero economico. Nel corso degli anni, secondo il NYT, Trump
avrebbe scaricato la gran parte delle sue spese personali sulle sue aziende,
riducendo così ulteriormente le imposte: viaggi, residenze, campi da golf, e
perfino i tagli dei capelli sono tutti finiti nei bilanci aziendali. A ridurre
le imposte hanno contribuito anche le numerose consulenze – che il New York
Times definisce “inspiegabili” – come quelle di cui ha goduto per esempio
Ivanka, la figlia del tycoon e una dei dirigenti più importanti della Trump
Organization. Alan Garten, avvocato dell’azienda di famiglia, ha cercato di
mettere qualche toppa dichiarando che “la maggior parte dei fatti, se non tutti,
sembrano essere inesatti”. Ma le tasse di Trump sono un mistero fin dalla sua
candidatura. Già durante la campagna del 2016, l’allora aspirante presidente si
è rifiutato di presentare le sue dichiarazioni dei redditi per la revisione
pubblica. Stavolta, il polverone sui guai fiscali dell’inquilino della Casa
Bianca, vittima delle sue stesse menzogne populiste, arriva poche ore dal primo
dibattito presidenziale di martedì notte, proprio mentre il rivale Joe Biden lo
distanzia nei sondaggi. Una vera e propria spada di Damocle per un presidente in
ostaggio dei suoi creditori, in attesa di centinaia di milioni di dollari di
prestiti in scadenza. Come ricorda Stephen Collinson della Cnn, «il magnate
miliardario spaccone, panacea populista per gli americani dimenticati, si rivela
quello che è sempre stato: una finzione».
Il report (a orologeria) del Nyt: "Trump non ha pagato le
tasse". Donald Trump ha reagito all’inchiesta del New York Times sulle
proprie dichiarazioni dei redditi bollandola come un mucchio di falsità. Gerry
Freda, Lunedì 28/09/2020 su Il Giornale. Negli Usa sono state appena pubblicate
recenti dichiarazioni dei redditi di Donald Trump, da cui risulta che il magnate
avrebbe, negli ultimi anni, accumulato più perdite che guadagni nel mondo degli
affari. A divulgare i dati tributari, a meno di 48 ore dal primo dibattito in tv
tra lo stesso Trump e il rivale dem Joe Biden, è stato il sito del New York
Times, testata dichiaratamente ostile al miliardario. Proprio sulla
pubblicazione delle proprie dichiarazioni dei redditi, l’attuale presidente
americano ha finora sostenuto un duro braccio di ferro sia con l’opposizione
liberal sia con diverse Corti statali e federali, rifiutandosi costantemente di
diffondere autonomamente le cifre del suo patrimonio e delle sue finanze.
L’inchiesta del giornale della Grande Mela è stata firmata a sei mani da Russ
Buettner, Susan Craig e Mike McIntir, che accusano in coro l’inquilino della
Casa Bianca di "infedeltà fiscale". Nel dettaglio, le carte ottenute e
pubblicate dal quotidiano attestano che nel 2016, ossia l’anno in cui Trump è
stato incoronato presidente dagli elettori, l’esponente repubblicano avrebbe
versato al fisco statunitense appena 750 dollari di tasse federali, la stessa
cifra da lui pagata anche l’anno successivo. I documenti svelati dal New York
Times dichiarano inoltre che il magnate, per dieci dei quindici anni precedenti,
non avrebbe sborsato neanche un dollaro di tributi. Tra le carte diffuse dal
giornale mancano però quelle relative agli anni 2018 e 2019. Il materiale alla
base dell’inchiesta dell’organo di stampa, oltre a portare alla luce i minimi o
nulli versamenti fiscali di Trump, denuncia anche che quest’ultimo avrebbe sul
groppone debiti per centinaia di milioni, nonché molti problemi legati alle
proprietà della sua Trump Organization, derivanti da una serie di operazioni di
storno fatte con l’intento deliberato di aggirare il fisco. Un altro scottante
dato contenuto nelle carte citate sempre in merito all’apparente fallimentare
gestione finanziaria dell’attuale presidente attiene alla cifra di 100 milioni
di dollari che il miliardario newyorchese sarebbe stato condannato di recente a
pagare da una sentenza a lui negativa. Tale verdetto sfavorevole, affermano i
documenti pubblicati dal giornale, sarebbe stato conseguente a una causa
temeraria intentata dallo stesso Trump per ottenere dal fisco federale un
rimborso tributario di 72,9 milioni di dollari. Dalla pubblicazione dei
documenti fiscali incriminati, l’inquilino della Casa Bianca ne esce come un
uomo d’affari per niente di successo, infedele con l’amministrazione finanziaria
nazionale, pieno di debiti e che dipende sempre più da guadagni fatti con
aziende che lo mettono in costante conflitto d'interesse con il suo ruolo di
Capo dello Stato. Le notizie appena diffuse dalla testata sulle dichiarazioni
dei redditi del magnate, pur esplosive, sono però parziali, come specificato
dalla stessa inchiesta: “Le informazioni di cui siamo a conoscenza sono quelle
date dallo stesso Trump al fisco, non il frutto di un'indagine indipendente. A
quanto davvero ammonti il suo patrimonio nessuno lo sa”. Dean Baquet, direttore
del New York Times, ha giustificato con le seguenti parole la scelta di
diffondere dettagli potenzialmente lesivi sulla campagna presidenziale di Trump
nel pieno dello scontro elettorale tra l’esponente repubblicano e Biden: “I
cittadini devono sapere il più possibile dei loro leader. Conoscere le loro
priorità, le loro esperienze e sì: pure le loro finanze”, ricordando inoltre che
fin dagli anni Settanta "tutti i presidenti hanno pubblicato le loro
dichiarazioni dei redditi. Secondo tradizione, chi fa politica non deve cercare
con le sue azioni benefici finanziari. Trump ha rotto questa consuetudine”. Non
si è fatta attendere la dura risposta dell’inquilino della Casa Bianca alle
pesanti insinuazioni fatte su di lui dal quotidiano della Grande Mela. Egli ha
appunto bollato come falsità i particolari portati alla luce dall’inchiesta
citata: “È una notizia falsa, totalmente inventata. Ho sempre pagato le tasse.
Il fisco ce l'ha con me: da tempo mi trattano molto male”. Lo stesso ha infine
tuonato: “Sapevo che stavano preparando una storia negativa su di me. Eccola.
Era prevedibile. Ed è falsa”.
Così Biden ha usato le scappatoie fiscali per pagare meno
tasse. Alberto Bellotto su Inside Over il 6 ottobre
2020. Mentre i media si concentravano sull’inchiesta del New York
Times incentrata sui redditi di Donald Trump, il rivale democratico nella corsa
alle presidenziali del 3 novembre, Joe Biden, ha rilasciato la propria
dichiarazione dei redditi. Leggendola attentamente ci sono una serie di
indicazioni interessanti non solo su come funziona il sistema fiscale americano,
ma anche su come si possano usare forme societarie, e meccanismi vari, per
ridurre il carico fiscale colpendo indirettamente anche l’Obamacare. Ben inteso,
non si sta parlando di evasioni, illeciti o operazioni fraudolente, ma di un
recinto molto elastico, usato da milioni di americani, deputati e senatori
compresi.
Cosa c’è nella dichiarazione. Prima una premessa. La
dichiarazione dei redditi è congiunta e contiene non solo le attività di Biden,
ma anche quelle della moglie Jill. Partiamo ora dai numeri. Nel 2019 l’ex vice
di Barack Obama ha pagato 299.346 dollari di tasse sul reddito, il 31,7%
rispetto al reddito imponibile di 944 mila dollari. Scendendo più nel dettaglio
si scopre che lo scorso anno la coppia ha incassato stipendi pari a 517 mila
dollari. Di questi 135 mila sono arrivati dall’impiego di Biden come professore
all’Università della Pennsylvania, 73 mila dal lavoro della moglie come docente
del Northern Virginia Community College. A questi si aggiungono anche altri
introiti. Circa 33 mila dollari di pensione dallo Stato del Delaware più altri
160 mila dollari dal governo federale per il lavoro che Biden ha fatto negli
anni come senatore. Joe e Jill hanno però incassato altri due stipendi, due voci
da 112 mila e 196 mila dollari arrivati altrettante società: la CelticCapri
Corp. e la Giacoppa Corp, entrambe nelle mani dei Biden.
L’azionariato gestito dai coniugi Biden. Secondo i dati della
camera di commercio del Delaware le due corporation sono state registrate
entrambe nel 2017, una il 30 gennaio e una il 15 marzo. L’agente che si è
occupato della registrazione è lo studio legale Monzack Mersky McLaughlin and
Browder, PA. Una realtà legale di Wilmington che tra i fondatori ha Melvyn
Monzack in passato tesoriere sia della campagna per la rielezione al Senato di
Biden nel 2002, che della campagna elettorale del 2008.
I dati delle due S-Corp. dei Biden disponibili sul sito della
camera di commercio del Delaware. Ufficialmente queste due aziende si occupano
di amministrare tutte le attività dei Biden al di là dell’attività politica e
accademica. Stiamo quindi parlando delle royalties derivate dalla vendita di
libri e dai compensi incassati per prendere parte ad eventi come speaker. Per
avere un’idea a gennaio 2019 l’ex senatore del Delaware ha incassato 134 mila
dollari dalla Performing Arts Center Authority per un discorso tenuto a Fort
Lauderdale, in Florida. Queste due società sono registrate come S-Corporation.
Semplificando molto si tratta di società per azioni di piccole dimensioni che
per legge non possono avere più di 100 azionisti ma che soprattutto non pagano
imposte sul reddito. Secondo le norme infatti redditi e perdite vanno
distribuiti agli azionisti in proporzione alla loro quota. Qui ora c’è il primo
passaggio da tenere bene a mente per capire i flussi di denaro dei Biden. I
singoli azionisti di una S-corp pagano le tasse sulla quota di profitti che gli
spetta in base alle quote, e lo fanno indipendentemente dal fatto che ritirino o
meno queste queste di profitti della società. Ogni anno la S-corp fornisce un
rapporto, denominato K-1, a ciascun azionista in cui si evidenziano introiti e
perdite. L’azionista poi paga le tasse sulla sua quota direttamente dalla sua
dichiarazione dei redditi personale.
Quanto fruttano le corporation. Secondo la stampa americana i
Biden sono azionisti di maggioranza di entrambe le corporation. Quindi
giocoforza sono i destinatari di gran parte dei dividendi. Nella dichiarazione
di Biden del 2019 si legge che le due società gli hanno corrisposto profitti per
228 dollari, 53 mila la CelticCapri e 175 mila la Giacoppa. Le cifre salgono di
molto se si considerano i primi due anni di attività delle corporation. Nel 2018
l’importo complessivo delle due ammontava a 3,2 milioni di dollari, mentre nel
2017 la CelticCapri segnava nel modulo K-1 9,4 milioni e la Giacoppa 557 mila
dollari. In quelli stessi anni le aziende corrispondevano ai Biden degli
stipendi, 245 mila nel 2017 e 500 mila nel 2018. Quello che non sappiamo è se i
Biden hanno incassato i fondi o li hanno lasciati nelle aziende. L’unico
elemento che abbiamo è un passaggio su un articolo di Bloomberg che riporta come
nel 2019 Biden abbia preso da CelticCapri una quota netta di 50 mila dollari.
La dichiarazione dei redditi di Biden del 2017, primo anno di
attività delle due corporation. Come abbiamo detto all’inizio, tutte queste
pratiche non sono illegali. Diversi membri del congresso hanno partecipazioni in
corporation e usano le forme societarie per ridurre al minimo l’impatto delle
tasse. Lo stesso Biden poteva dirottare parte dei fonti nei cosiddetti
donor-advised fund (daf), uno strumento finanziario amatissimo da molti big
della Silicon Valley che li utilizzano come strumento la beneficenza, almeno
appartenente. I daf permettono infatti di stanziare cifre enormi sui quali
automaticamente viene eliminata ogni tassa, ma senza che queste cifre siano poi
effettivamente versate a progetti o istituzioni caritatevoli. Ecco Biden non ha
assolutamente optato per una soluzione così radicale, ma i flussi di denaro
dalle sue controllate gli hanno permesso di limitare alcuni tipi di tasse, come
ad esempio quelle sulla previdenza sociale e quelle previste sulla sanità come
il programma Medicare e l’Affordable Care Act, meglio nota come Obamacare. Il
consulente finanziario Christopher Jacobs, in un editoriale sul Wall Street
Journal, ha provato a fare alcuni conteggi sui flussi di denaro raccolti nelle
dichiarazioni dei redditi dei coniugi Biden negli ultimi tre anni. Secondo
Jacobs il fatto di aver incassato 13,5 milioni di dollari di proventi attraverso
le società ha permesso all’ex coppia vicepresidenziale di risparmiare 513 mila
dollari di tasse sui salari. Le due tasse che regolano i programmi sanitari sono
così composte. L’imposta Medicare del 2,9% si applica a tutti i redditi, mentre
l’imposta sugli “alti redditi” dello 0,9% creata dall’Obamacare si applica a
tutti i redditi da salario superiori a $ 200.000 per un individuo o $ 250.000
per una famiglia. Trasformando quindi una grossa fetta degli incassi delle
attività in profitti di una S-corp, l’intera tassazione risulta ridimensionata.
Obama voleva limitare le S-Corp. Il meccanismo negli anni è stato
ribattezzato “scappatoia Gingrich-Edwards”, dal nome di due politici, il primo
repubblicano e il secondo democratico, che usavano una tecnica simile. Negli
ultimi anni il mondo fiscale americano ha discusso molto sulle S-Corp. Molti
fiscalisti sostegno che soprattutto in quelle realtà con pochi soci servirebbe
un certo equilibrio tra il salario e i dividendi dei profitti. Secondo l’Irs
(Internal Revenue Service), l’agenzia federale Usa che si occupa della
riscossione dei tributi, la scappatoia Gingrich-Edwards deve essere
controbilanciata dalla cosiddetta “reasonable compensation”, compensazione
ragionevole, cioè un’equa distribuzione tra dividendi, spari ed eventuali spese,
dividendo idealmente in profitti in tre parti. Come a dire che ai 13,5 milioni
di profitti delle due aziende dei Biden dovevano corrispondere a salari molto
più alti e quindi tasse più alte. Al momento il punto più che fiscale è politico
dato che negli anni Biden si è sempre schierato contro i vasti privilegi del
famoso 1% ricco d’America. E in caso di elezione promette anche un allargamento
dell’Obamacare. Altro aspetto fondamentale è che nell’ultimo anno di presidenza
Barack Obama aveva provato a frenare questi meccanismi fiscali, introducendo un
prelievo fiscale del 3,8% col quale finanziare il Medicare Hospital Insurance
Trust Fund, il fondo che gestisce il programma Medicare. Il pacchetto che
conteneva la norma non passò mai al Congresso è rimase lettera morta. Nei giorni
di indignazione per i leaks del Times la posizione di Biden rimane sullo sfondo.
Eppure gran parte dei politici più in vista del partito dell’asinello non hanno
mai approfittato delle S-Corp. Lo stesso Obama, l’ex segretaria di Stato Hillary
Clinton, ma anche gli sfidanti alle primarie Elizabeth Warren e Bernie Sanders
hanno sempre dichiarato i loro redditi da libri e discorsi attraverso i moduli
per il lavoro autonomo. Ci si aspetterebbe qualche voce contro soprattutto
dell’area più liberal dello schieramento dem, ma per il momento i mugugni non
vengono espressi pubblicamente.
Trump nominato per il Nobel per la Pace 2021.
(ANSA il 9 settembre 2020) Il Nobel per la Pace 2021 a Donald
Trump? Qualcuno ci ha pensato, in particolare un parlamentare norvegese, che ha
formalmente nominato il presidente americano per il ruolo di mediazione svolto
nell'accordo di pace tra Israele e Emirati Arabi Uniti. "Penso che Trump abbia
compiuto più sforzi di qualunque altro candidato per creare pace tra le
nazioni", ha detto il norvegese Christian Tybring-Gjedde parlando alla Fox News,
la tv più amata proprio da Trump.
Trump ritwitta post con sua nomina per il Nobel per la pace.
Donald Trump ha ritwittato diversi post con la sua nomina al Nobel per la pace
come 'broker' dell'accordo Israele-Emirati Arabi. Un riconoscimento che ha
sempre agognato, soprattutto dopo che è stato assegnato al suo odiato
predecessore Barack Obama.
Ferdinando Fedi per opinione.it. Nonostante i reiterati tentativi
di delegittimazione, tra cui l’ultima balla della dichiarazione sui militari
americani morti in Normandia da considerare dei perdenti, Trump continua la sua
azione di riappacificazione mondiale nel contesto di una politica estera che da
anni non si vedeva negli Stati Uniti. È sempre bene ricordare che durante il suo
mandato non è sorto un solo conflitto nel pianeta e che solo poche settimane fa
sotto la sua egida è stato sottoscritto un accordo bilaterale tra Israele e
Stati Uniti che consente tra l’altro il sorvolo dei velivoli della El Al anche
su Arabia Saudita e Bahrein. Ora è la volta del teatro balcanico con la firma di
una storica intesa tra la Serbia e il Kossovo sotto gli auspici e l’impegno
della Casa Bianca. L’accordo, soprattutto di natura economica, prevede la
realizzazione di un’autostrada e di un collegamento ferroviario tra Belgrado e
Pristina, la realizzazione di un valico di frontiera congiunto e il
riconoscimento reciproco dei diplomi e dei certificati professionali. Altro
punto strategico è l’impegno a condividere il lago artificiale di
Gazivode-Ujmani, importante riserva idrica ed energetica nel nord del Kosovo a
cui la Serbia vorrebbe accedere. Altra questione bilaterale, ma di natura in un
certo senso interlocutoria, è la moratoria reciproca di un anno sul
riconoscimento internazionale del Kosovo. Ulteriori clausole riconducono alla
matrice statunitense del documento: le infrastrutture previste dall’accordo
verranno realizzate con l’assistenza delle statunitensi International
Development Finance Corporation ed Export-Import Bank e le parti si impegnano
poi a proibire l’acquisto e l’uso di apparecchiature 5G provenienti da
“venditori inaffidabili” – il riferimento alla Cina sembra ovvio – ed
acconsentiranno alla condivisione di informazioni con i sistemi di monitoraggio
Usa. Infine l’intenzione di Serbia e Kosovo di designare Hezbollah come
organizzazione terroristica “nella sua interezza” e non solo nella sua sola
accezione militare, come fa l’Unione europea. Infine un punto apparentemente
estraneo all’accordo: la Serbia si impegna a spostare la propria ambasciata da
Tel Aviv a Gerusalemme entro il prossimo luglio, mentre il Kosovo e Israele si
riconosceranno impegnandosi a stabilire relazioni diplomatiche. L’accordo,
pertanto, rientra nello schema di Donald Trump volto a normalizzare i rapporti
tra Israele e i Paesi arabi, il cui prodromo sono stati i ricchi Emirati.
Infatti il Kossovo, a maggioranza mussulmana da quando i ricchi possidenti della
regione ai margini della ex Jugoslavia agevolarono l’immigrazione di massa dalla
vicina Albania per avere manovalanza a basso costo, si andrà ad aggiungere al
numero di paesi islamici che stanno riconoscendo Israele. L’Europa che in
Kossovo è presente con numerosi contingenti militari e agenzie preposte al
mentoring and training delle principali istituzioni di Pristina sta a guardare
forse stupita del successo dei negoziati Usa. Trump, oltre ad aver conseguito
l’obiettivo di stabilizzare la regione, ha quindi aggiunto un ulteriore tassello
al suo disegno di far accettare Israele ai paesi arabi. Che abbia in testa di
ispirare un potentato economico che unendo tecnologia ebrea e ricchezza araba
diventerebbe tra i più rilevanti al mondo? Ma chissà! Figurarsi se quel parvenu,
antipatico e un po’ gaffeur può avere progetti di così raffinata strategia e
riuscire in un obiettivo che nessuno dei suoi blasonati predecessori si è mai
sognato.
Massimo Gaggi per il ''Corriere della Sera'' l'11 settembre 2020.
L'arma nucleare segreta della quale il presidente non avrebbe mai dovuto
parlare, la necessità di impegnarsi contro il razzismo liquidata da Trump con
una battuta, i servizi segreti per i quali Vladimir Putin potrebbe avere in mano
qualcosa per condizionare il leader americano, i suoi giudizi sprezzanti sui
generali «fighette» che si preoccupano più del rispetto delle alleanze che delle
relazioni commerciali, con l' ex ministro della Difesa, James Mattis, che lo
liquida con un giudizio perentorio: «Trump è inadatto al ruolo che ricopre e non
ha una bussola morale». Rage, il nuovo libro di Bob Woodward sulla Casa Bianca
anticipato due giorni fa alla stampa Usa, sta mettendo in seria difficoltà un
presidente che, pure, ha collaborato al lavoro del giornalista del Watergate,
dandogli ben 18 interviste dal dicembre 2019 al giugno scorso. La questione più
rilevante, quella riferita ieri dal Corriere , riguarda l' ammissione di Trump
di aver saputo fin dalla fine di gennaio della gravità dell' epidemia e di aver
tenuto all' oscuro gli americani, anzi minimizzando, «per non creare panico». Le
registrazioni dei colloqui, soprattutto quello del 7 febbraio, inchiodano Trump
alle sue responsabilità: avesse agito con più vigore per tempo mettendo in
guardia i cittadini e imponendo l' uso delle mascherine, ci sarebbero state meno
vittime. Ma anche l'«eroe» della storia, il giornalista che l' ha stanato, non
vive giorni da marcia trionfale. Anzi, la pubblicazione delle anticipazioni gli
ha procurato qualche livido: molti, soprattutto suoi colleghi, gli hanno chiesto
perché, se già sei mesi fa sapeva che Trump stava mentendo su «questioni di vita
e di morte», non ha denunciato la cosa subito.
Non sono solo mugugni di colleghi più o meno invidiosi: a
considerare discutibile sul piano etico il comportamento di Woodward ci sono
anche autorità come David Boardman, preside della facoltà di giornalismo della
Temple University, mentre la discussione sul caso è viva anche sulle pagine del
suo giornale, il Washington Post. Il reporter che quasi mezzo secolo fa
costrinse alle dimissioni il presidente Nixon con l' inchiesta (realizzata
insieme a Carl Bernstein) sul Watergate, si difende sostenendo che solo a maggio
si è reso conto delle gravità delle cose che Trump gli aveva confessato a
febbraio: in inverno Bob, abituato a un Trump che straparla, non aveva capito
che stavolta il presidente aveva informazioni di fonti certe e autorevoli. Ma,
soprattutto, Woodward rivendica il suo diritto di «scrivere la storia». Non
partecipa più alla produzione dell' informazione quotidiana, ma vuole offrire ai
lettori «il quadro più completo possibile della realtà. E glielo dò molto prima
delle elezioni in modo da dare loro il tempo di farsi un giudizio: è il meglio
che mi sento di fare». Il ragionamento non è infondato, ma non convince molti
sul fronte progressista: Woodward doveva denunciare quando ha saputo.
Paradossalmente questo ritardo viene sfruttato anche da Trump per cercare di
uscire dall' angolo nel quale il libro l' ha cacciato: «Se avevo detto cose così
gravi perché non farlo venire fuori subito?».
Guido Olimpio per corriere.it il 10 settembre 2020. Sono la sua
passione, ma non solo. Mezzi eccezionali che possono cambiare gli equilibri.
Donald Trump, nei lunghi colloqui con Bob Woodward per il libro «Rage», ha
indicato l’esistenza di un nuovo sistema nucleare del quale nessuno ha mai
sentito parlare. «Ho costruito un sistema nucleare... un’arma che nessuno ha mai
avuto prima in questo Paese. Abbiamo qualcosa che non si è mai visto e sentito.
Abbiamo qualcosa di cui Putin e Xi non hanno mai saputo. Non c’è nessuno...
quello che abbiamo è incredibile» ha rivelato Trump al giornalista. E il
reporter, attraverso le sue fonti, ha avuto un paio di conferme. Il «segreto» ha
subito messo in moto la catena delle interpretazioni, gli specialisti hanno
formulato delle ipotesi. Interessanti quelle apparse sul blog «The War Zone»,
dove hanno provato a rispondere agli interrogativi. Al primo posto — scrivono
Joseph Trevithick e Tyler Rogoway — c’è la testata W93 che dovrebbe dotare il
missile intercontinentale Trident D5, ospitato sui sommergibili, una delle
componenti fondamentali dell’arsenale. La pensa così anche un altro esperto che
tuttavia ritiene sia stato sviluppato nel periodo 2018-2019. Poi ci sono
progetti per il bombardiere con caratteristiche Stealth B 21 Raider, l’ordigno
nucleare B61-12, un nuovo vettore a lungo raggio installato nei silos e un’arma
– sempre atomica – ipersonica. I «candidati» non mancano, così come abbondano i
fondi per accrescere il potenziale in teatri sempre più complessi, da Occidente
a Oriente. C’è anche la possibilità di qualcosa di davvero top secret, anche se
a questo punto c’è stata una piccola breccia. Una super arma sconosciuta,
qualcosa passato sotto pochi «occhi», tra questi quelli del presidente, magari
in termini generici. Forse si è fatto sfuggire il dettaglio oppure ha voluto
farlo in modo deliberato per rafforzare un messaggio abituale della sua
comunicazione: con me l’America sarà di nuovo grande ed avrà apparati sempre più
poderosi. Nelle sue schermaglie pubbliche, con gli interventi su twitter, The
Donald ha spesso esaltato le capacità del Pentagono e messo in guardia gli
avversari sulle conseguenze. Gli esempi sono numerosi. Ha citato l’enorme
potenziale per ammonire il nord coreano Kim, leader con il quale ha un rapporto
fatto di tensioni e di gesti amichevoli. Ha postato foto dopo un fallito test
iraniano non escludendo che all’origine ci fosse un sabotaggio, magari un atto
di guerra cyber dell’intelligence statunitense. Ha avvertito, sempre con foto,
il generale iraniano Qasem Soleimani poi ucciso da un raid di un drone americano
a Bagdad. Show verbali – però collegati a fatti reali – che si sono specchiati
in quelli dei concorrenti. Vladimir Putin non è stato da meno, con i riferimenti
ad una mezza dozzina di progetti: il super drone, il missile da crociera
Burevestnik, la testata Avangard, un nuovo sottomarino ed altro ancora. I
cinesi, invece, hanno insistito sulle contromisure per spazzare via le portaerei
e proprio il leader di Pyongyang fa sfilare ad ogni parata le sue produzioni
belliche ed ha condotto un’infinita serie di test. Provocazioni alla quale una
volta il capo della Casa Bianca ha risposto con la celebre frase: «Il mio
bottone nucleare è più grande del tuo». Un’ultima annotazione riguarda Woodward.
Nella biografia dedicata a George Bush jr raccontò di un altro piano segreto, un
sofisticato sistema integrato di intelligence/forze speciali/velivoli per dare
la caccia ai militanti in Iraq e portato avanti dalla Task Force 77.
L'annuncio di Trump. Super arma di Trump, quali sono i segreti
che nessuno sa. Vittorio Ferla su Il Riformista l'11
Settembre 2020. Più di 190 mila americani sono morti a causa dell’infezione
da Coronavirus. L’emergenza sanitaria ha provocato la distruzione di milioni di
posti di lavoro. Oggi sappiamo che il presidente Donald Trump – nonostante
sapesse che il coronavirus fosse «altamente pericoloso» «brutalmente contagioso»
e «peggiore perfino dell’influenza più grave» – ha ritardato l’intervento del
governo. Peggio ancora: si è rifiutato di condividere pubblicamente le
informazioni che aveva e non ha messo in guardia il popolo americano,
assicurando che tutto sarebbe andato bene. Tutto questo è registrato su nastro.
E, tra una settimana, sarà pubblicato nel libro del leggendario Bob
Woodward, probabilmente il reporter americano più famoso nel mondo dopo la
famigerata vicenda del Watergate. Il libro è intitolato Rage – che significa
“rabbia” – e sta provocando un esplosivo coro di condanne dal mondo liberal
americano: per molti commentatori democratici le rivelazioni mettono a nudo
«l’atto di negligenza presidenziale più sconcertante dei tempi moderni». Roba
molto diversa dagli scandali che in passato colpirono i presidenti Richard
Nixon e Bill Clinton. In quei casi, la corruzione politica e gli inciampi etici
furono coperti dagli insabbiamenti e dagli abusi di potere. Questa volta, il
comportamento di Trump viene stigmatizzato come il tradimento del dovere più
basilare di un presidente: quello di salvaguardare la salute e la sicurezza
degli americani. La strategia adottata da Trump fin dall’inizio è stata chiara:
negare pubblicamente la potenza del virus e minimizzarne l’impatto. Ma
sentirglielo dire nelle registrazioni audio fatte da Woodward è tutta un’altra
cosa. E tra otto settimane arrivano le elezioni. Nel libro, Bob Woodward
squaderna una serie di interviste private col presidente sugli argomenti più
vari. Ma le rivelazioni più imbarazzanti riguardano il coronavirus. In una
conversazione di febbraio, Trump definisce il virus una «roba mortale, più
mortale anche della tua forte influenza» ma in pubblico diceva esattamente il
contrario. Il 19 marzo scorso, giorni dopo che le raccomandazioni dei Centers
for Disease Control and Prevention contro i grandi raduni avevano provocato
il lockdown a livello nazionale, Trump confessa nelle interviste a Woodward di
aver minimizzato l’impatto del virus nonostante l’evidenza delle prove. «Volevo
sempre sdrammatizzare» dice Trump a Woodward. E ancora: «Preferisco ancora
sdrammatizzare, perché non voglio creare panico». Inevitabile la reazione
di Biden. Nel corso di una visita in Michigan per annunciare un piano per
l’occupazione, il candidato democratico ha accusato il presidente in carica «di
non aver saputo fare bene il suo lavoro». «Trump sapeva e ha minimizzato di
proposito», ha detto. E poi ha aggiunto: «Peggio ancora, ha mentito al popolo
americano». It’s disgusting sembra ormai da mesi il ritornello dell’ex vice
di Obama per commentare ogni uscita dell’avversario. Ma la verità è che, ogni
volta che Trump apre bocca il povero “Sleepy Joe” schizza sulle montagne russe.
Gli echi della stampa liberal non sono meno teneri. Milioni di vite e mezzi di
sussistenza dipendono dal carattere, dalla competenza, dall’altruismo e
dall’integrità della persona nello Studio Ovale, qualunque sia il suo partito o
ideologia. Ma il presidente Donald Trump – come ha rivelato in modo devastante
con la sua stessa voce a Bob Woodward – ha affrontato la grande crisi della sua
epoca con inettitudine, disonestà e un epico abbandono del “dovere”,
dice Stephen Collinson della Cnn. «Nel corso della storia – continua Collinson –
i presidenti hanno risposto a momenti di grande prova livellando con il popolo
americano le sfide spesso terribili, ma hanno anche evocato un senso collettivo
di missione verso una destinazione meno pericolosa». E cita i casi di un
democratico, Franklin Roosevelt, e di un repubblicano, George W. Bush. Il primo
per ben due volte – in occasione della Grande Depressione degli anni ‘30 e
dell’attacco a Pearl Harbor nel 1941 – disse la verità al paese. Che lo ascoltò
e lo seguì. Il secondo consolò e unì il popolo americano scioccato
dall’attentato terroristico dell’11 settembre. Viceversa, Trump ha
deliberatamente ingannato gli americani e non è riuscito a preparare il governo
per una adeguata iniziativa nazionale adeguato. Peggio ancora, per settimane ha
continuato a disinformare il paese sulla gravità dell’agente patogeno che ha
causato la peggiore pandemia globale degli ultimi 100 anni. «Un approccio più
onesto di Trump – ammette Collinson – non avrebbe salvato tutte le vite
americane. Ma il suo deliberato inganno e la mancanza di serietà in un grave
momento nazionale hanno trasformato la risposta degli Stati Uniti in una delle
peggiori del mondo». A queste critiche feroci Trump ha risposto al suo solito.
Rivolto ai giornalisti, non ha contestato i rapporti di Woodward, ma ha ammesso
candidamente: «Il fatto è che sono una cheerleader per questo paese. E poi ha
aggiunto di aver salvato vite umane imponendo il divieto di viaggiare dalla
Cina. In un primo tweet, Trump ha affermato che il suo «successo politico sta
facendo sbiadire rapidamente rapidamente Bob Woodward e il suo libro noioso». In
un altro tweet ha domandato: «Woodward ha conservato queste mie dichiarazioni
per mesi. Se le riteneva pericolose avrebbe potuto diffonderle prima per salvare
delle vite umane. Non avrebbe avuto l’obbligo morale di farlo? No, non lo ha
fatto perché sapeva che le mie risposte erano giuste e appropriate». E la sua
difesa di non voler creare panico è stata ripresa anche dalla sua
portavoce, Kayleigh McEnany, che ha detto: «I leader fanno così». Ma le
rivelazioni del libro di Woodward non si fermano qui. Il giornalista racconta
che i massimi funzionari della sicurezza degli Stati Uniti hanno temuto
l’esplosione di una guerra nucleare con la Corea del Nord nel 2017. Tuttavia,
Woodward riporta anche il clima idilliaco creatosi tra il presidente americano e
il tiranno nordcoreano Kim Jong. Quest’ultimo avrebbe lusingato Trump in quelle
che il presidente ha chiamato «lettere d’amore». Sempre Trump ha descritto un
loro incontro come una scena di «un film fantasy» e la loro relazione come una
«forza magica». La speciale chimica con mister Kim, Trump la spiega così:
«Incontri una donna. In un secondo, sai se accadrà o meno». L’ultima rivelazione
ha qualcosa di assai inquietante. Trump si vanta con Woodward che gli Stati
Uniti hanno un nuovo sistema segreto di armi nucleari. Pare che alcune fonti
della difesa abbiano confermato l’esistenza dell’arma misteriosa al giornalista.
Un capitolo che resta ancora oscuro.
Da corriere.it il 2 ottobre 2020. Il presidente degli Stati
Uniti Donald Trump e la moglie Melania sono positivi al coronavirus. A
comunicarlo è stato, con un tweet, lo stesso Trump. «Questa notte io e Melania
siamo risultati positivi al Covid-19. Cominceremo il nostro processo di
quarantena e cure immediatamente. Supereremo tutto questo insieme», ha scritto.
«Come avvenuto a troppi americani, quest’anno, io e il presidente siamo isolati
a casa, dopo essere risultati positivi per il Covid», ha scritto Melania Trump
su Twitter. «Stiamo bene, e ho rimandato tutti gli eventi in programma. Abbiate
cura di voi, prestate attenzione, e supereremo tutto questo, insieme».
L’annuncio arriva a poche ore dal primo dibattito televisivo con lo sfidante
democratico, Joe Biden, e immediatamente dopo il risultato positivo del test di
Hope Hicks, una delle più strette consigliere di Trump, che aveva con lui
partecipato alle ultime trasferte. Hicks, 31 anni, aveva accompagnato Trump, 74
anni, sull’Air Force One, dopo aver assistito allo scontro televisivo con Biden
a Cleveland, martedì 29 settembre, e aveva seguito il leader americano in un
comizio nel Minnesota.
Trump e il Covid negli Stati Uniti. Durante le scorse settimane,
Trump ha tenuto comizi con migliaia di persone, nonostante il parere contrario
di esperti che sconsigliavano di far assembrare molte persone. Il presidente,
che ha valutato le sue politiche di risposta alla pandemia con un voto altamente
positivo («Mi do 10 e lode!», ha detto), è stato aspramente criticato per un
atteggiamento che, secondo gli osservatori, ha minimizzato l’impatto della
pandemia. Trump, in una intervista al giornalista Bob Woodward del Washington
Post avvenuta a febbraio, ma resa nota solo a settembre, aveva detto di
conoscere perfettamente sin da gennaio quanto il virus fosse pericoloso, ma di
non voler comunicare in modo esplicito questo dato per non terrorizzare la
popolazione. «Sapevo da gennaio che Covid era mortale, tacevo per evitare il
panico», ha detto. Negli Stati Uniti, il Covid ha ucciso oltre 200 mila persone.
Nei primi mesi della pandemia, Trump aveva fatto del non indossare una
mascherina una sorta di punto d’onore. Le mascherine non sono compatibili con il
ruolo di leader, aveva spiegato, dicendo che non poteva pensare di incontrare
capi di stato, «presidenti, premier, dittatori, re, regine» con indosso una
mascherina. «Non credo che io ne userò una», aveva precisato il 4 aprile scorso,
quando le autorità sanitarie statunitensi avevano raccomandato agli americani di
indossarla per prevenire il contagio da coronavirus. «Potere farlo, potete non
farlo: quella del Center for Disease Control and Prevention è solo una
raccomandazione», aveva aggiunto. Solo il 22 maggio Trump venne visto in
pubblico indossare una mascherina. A luglio, Trump aveva detto — ribaltando
quanto affermato in precedenza — di essere assolutamente a favore delle
mascherine»: ma poi, l’8 agosto, aveva sostenuto che la pandemia stesse
«scomparendo negli Stati Uniti», e il 22 settembre che «in pratica, Covid non
colpisce nessuno» tra i più giovani.
Il referto di Hicks era noto da mercoledì sera. Il protocollo di
controllo è stato applicato anche al vice presidente Mike Pence, al consigliere
Jared Kushner e, con tutta probabilità agli altri componenti dell’entourage, da
Ivanka Trump al capo dello staff della Casa Bianca, Mark Meadows. La Casa Bianca
aveva il referto sulle condizioni di Hicks da mercoledì sera, ma le ha tenute
riservate per almeno ventiquattro ore, fino a quando i reporter di Bloomberg non
hanno dato la notizia.
Gli allarmi nel passato. Diverse volte, negli scorsi mesi, membri
dello staff di Trump sono risultati positivi, senza però che il presidente
risultasse contagiato. Il 27 luglio scorso era rimasto contagiato il Consigliere
per la sicurezza nazionale, Robert O’ Brien, 54 anni. Poche settimane prima, il
3 luglio, test positivo per Kimberly Guilfoyle, 51 anni, la fidanzata di Donald
Trump jr, primogenito del presidente. Prima ancora, il 7 maggio, il virus colpì
Katie Miller, portavoce di Pence e moglie di Stephen Miller, un altro «advisor»
di Trump. Il giorno prima, il 6 maggio, era toccato a un «valet», un assistente
personale del presidente.
Coronavirus, Trump: "Sapevo del pericolo, ma ho minimizzato".
La rivelazione nel nuovo libro di Bob Woodward.
Pubblicato mercoledì, 09 settembre 2020 da La Repubblica.it. Il nuovo libro del
giornalista del Watergate Bob Woodward contiene giudizi duri su Trump di molti
ex dirigenti della sicurezza. L'ex capo del Pentagono James Mattis lo definisce
"pericoloso" e "inadatto" ad essere il commander in chief. L'ex capo della
National Intelligence Dan Coat invece, scrive Woodward, "continua a coltivare la
segreta convinzione, benchè non supportata da prove di intelligence, che Putin
abbia qualcosa su Trump. Come altro spiegare il comportamento del presidente?
Coats non è in grado di vedere altre spiegazioni". Il libro mette in
imbarazzo Donald Trump. 'Rage' (rabbia) racconta che il presidente ha confidato
al leggendario giornalista, che sapeva settimane prima del primo decesso Usa per
Covid 19 quanto il virus fosse pericoloso, trasmissibile per via aerea,
altamente contagioso e "più fatale di una forte influenza". Nelle anticipazioni
del libro diffuse dalla Cnn ammette inoltre di aver "sempre voluto minimizzarlo
per non creare panico". Dichiarazioni che contrastano con i frequenti commenti
del presidente. "Questa è roba mortale", ha detto Trump a Woodward il 7 febbraio
scorso, nel corso di una serie di interviste con il giornalista. Trump ha
rivelato di conoscere bene il livello di minaccia del virus prima di quanto
precedentemente noto, aggiungendo che il coronavirus è stato forse cinque volte
"più mortale" dell'influenza. Le ammissioni di Trump sono in netto contrasto con
i suoi frequenti commenti pubblici all'epoca che insistevano sul fatto che il
virus "sarebbe scomparso" e che "tutto andasse bene". In “Rage”, Trump dice che
il compito di un presidente è "mantenere il nostro Paese al sicuro". Ma
all'inizio di febbraio, Trump ha detto a Woodward che sapeva quanto fosse
mortale il virus e, a marzo, ha ammesso di aver tenuto nascosta quella
conoscenza al pubblico. "Volevo sempre minimizzare", ha detto Trump a Woodward
il 19 marzo, anche se giorni prima aveva dichiarato un'emergenza nazionale a
causa del virus. "E preferisco ancora sminuire, perché non voglio creare
panico". "Donald Trump non ha fuorviato intenzionalmente gli americani sulla
gravità del coronavirus", ha detto la portavoce della Casa Bianca Kayleigh
McEnany , rispondendo alle anticipazioni di "Rage". Nelle interviste, scrive
il Washington Post anticipando i contenuti del libro, Trump parla diffusamente
della sua gestione della pandemia e delle relazioni razziali. Inoltre, il libro
riporta alcuni estratti delle lettere che Trump ha scambiato con il leader
nordcoreano Kim Jong-un .
Paolo Mastrolilli per lastampa.it l'11 settembre 2020. «Cover
up», dice Bob Woodward, ossia la stessa colpa che aveva costretto Nixon alle
dimissioni per il Watergate. «Cover up», ripete il candidato democratico alla
Casa Bianca Biden, definendo «disgustoso» il comportamento di Trump, perché ha
nascosto agli americani la verità sul Covid solo per favorire la propria
rielezione. «Rage», il libro di Woodward in uscita martedì, contiene molte altre
rivelazioni che mettono in dubbio l’adeguatezza del presidente alla sua carica,
nelle 9 ore di registrazioni fatte durante 18 interviste. Il virus però è quello
che colpisce di più, perché è costato la vita a 200.000 americani, e minaccia di
sconfiggere Donald il 3 novembre. Le date sono cruciali. Il 28 gennaio il
consigliere per la Sicurezza nazionale O’Brien aveva avvertito Trump che il
Covid era il principale pericolo per la sua presidenza. Il 7 febbraio il capo
della Casa Bianca aveva detto a Woodward che «questa roba è mortale, molto più
dell’influenza». Eppure il 25 febbraio aveva assicurato il paese che tutto era
sotto controllo e «il problema sta sparendo. Nel giro di un paio di giorni sarà
quasi a zero». Il 19 marzo aveva ammesso con Woodward che le cose si stavano
mettendo male: «Non sono solo i vecchi. Anche i giovani, un sacco». Però aveva
aggiunto: «Io l’ho minimizzato. Mi piace ancora minimizzarlo, perché non voglio
creare il panico». Il 3 aprile aveva ripetuto al pubblico che «sta sparendo», ma
il 13 aveva detto a Woodward: «È una cosa orribile. Incredibile». Ieri Trump ha
provato a difendersi dicendo che voleva evitare il panico, ma secondo Woodward
l’argomento non tiene, perché un conto è mantenere la calma, e un altro mentire.
Il primo obiettivo si poteva ottenere spiegando al paese la realtà del pericolo,
ma insieme annunciando e applicando un piano serio per contrastarlo. Il cover up
invece ha lasciato gli americani indifesi, a partire dai suoi sostenitori, che
seguendolo hanno rifiutato le misure più elementari di protezione, tipo le
mascherine, oppure sono corsi a riaprire l’economia quando non c’erano ancora le
condizioni. Ciò ha provocato migliaia di morti evitabili, che ricadono sulle
spalle di Trump. “Rage” però non si limita al Covid. Tra le altre cose, Donald
ha rivelato l’esistenza di una nuova arma nucleare devastante di cui nessuno
sapeva, che rischia ora di scatenare una corsa al riarmo con Cina e Russia. Ha
insultato i generali, dicendo che «sono fighette preoccupate per le loro
alleanze, più che i commerci». Ha negato qualunque empatia per i neri: «Ti sei
bevuto il Kool-Aid, Bob? No, non credo abbiano problemi». “Rage” rivela che nel
2017 era arrivato così vicino alla guerra con la Corea del Nord, che il capo del
Pentagono Mattis dormiva vestito, e aveva avvertito i colleghi della necessità
di «un’azione collettiva» per fermarlo. L’ex direttore dell'intelligence
nazionale, il repubblicano Coates, vede come unica spiegazione logica del
comportamento di Trump con Putin il fatto che Putin ha qualcosa su di lui. Anche
Woodward è finito sotto accusa, perché invece di pubblicare le sue interviste e
magari salvare vite, le ha tenute per il libro. Lui risponde che doveva
verificare la veridicità delle dichiarazioni e metterle nel contesto per far
capire ai lettori cosa è accaduto. Ora lo sanno, e il 3 novembre giudicheranno.
Hillary Hoffower per "it.businessinsider.com" il 24 giugno 2020.
La nipote del presidente Donald Trump, Mary L. Trump, sta pubblicando un libro
in cui si rivela come la fonte primaria di un’indagine del New York Times sulle
finanze del presidente, secondo quanto riferito da The Daily Beast. L’inchiesta
ha rivelato che Trump non è un uomo che si è fatto da solo, ma suo padre ha
rafforzato le sue attività fallimentari negli anni ’90 con centinaia di milioni
di dollari. Il Daily Beast ha riferito che il libro includerà l’affermazione di
Mary Trump di aver fornito al Times i documenti fiscali riservati della
famiglia. Il patrimonio netto di Trump è attualmente stimato in $ 2,1 miliardi,
in calo di $ 1 miliardo dalla pandemia. E questo per non parlare dei singoli
patrimoni netti dei suoi figli adulti: una cifra compresa tra 150 e 300 milioni
di dollari per Eric Trump; $ 200 milioni segnalati per Donald Trump Jr . e
$ 600.000 segnalati per Tiffany Trump, secondo Cheat Sheet. Ivanka Trump, che
gestisce le sue proprie attività, ha il patrimonio netto più grande di tutti i
figli. Si stima che lei e suo marito Jared Kushner abbiano un patrimonio di
circa a $ 762 milioni, ha riferito la CNN a luglio 2017, citando documenti
finanziari rilasciati dalla Casa Bianca. Insieme, ciò significa che la fortuna
dell’intera famiglia Trump potrebbe superare la stima di 3 miliardi di dollari.
Dai lussuosi attici e costose scuole agli acquisti di lusso e una flotta aerea
completa, ecco come spendono i loro milioni e miliardi. Il patrimonio netto di
Donald Trump è attualmente stimato in $ 2,1 miliardi – in calo di circa $ 1
miliardo dall’inizio della pandemia. Secondo la sua dichiarazione finanziaria
pubblica in qualità di staff dell’esecutivo, ha guadagnato qualcosa compreso tra
$ 597.396.914 e $ 667.811.903 tra gennaio 2016 e primavera 2017. Circa $ 42
milioni della ricchezza di Trump provengono dalle attività legate al suo marchio
– Trump Hotel Management & Licensing Business e Trump Products Licensing, e $ 38
milioni provengono dalle sue partecipazioni nel settore ospitalità. E $ 455
milioni del suo patrimonio netto è costituito da contanti, trofei, beni
personali – 160 milioni di dollari sono in particolare contanti e liquidità,
secondo Forbes. Prima di essere eletto, Trump ha speso $ 66 milioni del proprio
denaro per la sua campagna presidenziale, secondo le informazioni finanziarie
della campagna esaminate da Reuters. Trump ha spesso viaggiato durante la sua
campagna usando la sua enorme flotta di aerei. Secondo quanto riferito, ha
acquistato un Boeing 727 per $ 8 milioni in passato, che poi ha sostituito nel
2010 con un Boeing 757 che avrebbe acquistato da Paul Allen di Microsoft per $
100 milioni. Secondo il New York Times, brucia carburante a un ritmo di migliaia
di dollari l’ora. Possiede anche un jet Cessna, che secondo quanto riferito
costava, quando nuovo, $ 15,3 milioni e aveva un valore di rivendita di $ 3,2
milioni nel 2016. E questo per non parlare dei suoi tre elicotteri Sikorsky. Gli
S-76 Sikorsky usati in genere vengono venduti tra i $ 5 milioni e i $ 7 milioni,
senza contare i circa 750.000 dollari spesi da Trump per rifare l’interno del
suo acquisto più recente, che include hardware placcato in oro 24 carati.
Collettivamente, la flotta di due aerei e tre elicotteri di Trump ha un valore
di $ 32 milioni. Trump ha anche una collezione di mezzi da strada. Pare che
possieda una Rolls-Royce Silver Cloud vintage, una Rolls-Royce Phantom (che
parte da $ 500.000), una Maybach, una Ferrari e una Mercedes-Benz 3600. Secondo
quanto riferito, ha anche acquistato a Melania una SLR McLaren da $ 455.000.
Trump ha un debole per gli abiti Brioni, che vanno da $ 5.250 a $ 6.900. Sebbene
il marchio gli avesse fornito abiti durante il programma tv “The Apprentice”, ha
iniziato a pagarli durante la sua campagna presidenziale 2016. Anche a Melania
piace la moda costosa. È stata vista indossare un po’ di tutto, da un abito con
mantella di Givenchy da $ 2.095 all’International Red Cross Ball ad un abito con
paillettes di Monique Lhuillier da $ 7.995 alla cena della White House
Historical Association. Non è niente in confronto a quando è stata vista con una
giacca Dolce & Gabbana da $ 52.000. Ha anche indossato abiti più casual e meno
costosi in diverse occasioni, come le Converse, che sono vendute al dettaglio
per meno di $ 50. Per completare il suo look, Melania ha la sua truccatrice,
Nicole Bryl, che una volta disse a US Weekly dei piani di Melania di avere una
“stanza bellezza” alla Casa Bianca. Ha anche un parrucchiere che fa servizio a
domicilio e viaggia con lei. Melania ha detto che è una mamma a tempo pieno e
che rifiuta di spendere soldi per una tata. Nel 2013, ha riferito alla ABC News
di vestire suo figlio, Barron, in giacca e cravatta e idratarlo con la crema
idratante Caviar Complex C6 del suo marchio. All’epoca aveva 7 anni. A New York,
Barron frequentava la Columbia Grammar and Preparatory School, che costava $
40.000 all’anno. Ora frequenta la St. Andrew’s Episcopal School nel Maryland,
che pure costa $ 40.000 all’anno. I tre hanno vissuto nell’attico da 54 milioni
di dollari nella Trump Tower di New York prima di trasferirsi alla Casa Bianca.
Trump ha riferito che l’attico è di oltre 3mila metri quadrati, ma i registri
della città indicano che in realtà è di poco più di mille metri quadrati. I
Trump hanno anche proprietà immobiliari in luoghi dai climi più soleggiati –
come la loro casa privata sull’isola, Le Chateau Des Palmiers, a St. Martin, del
valore di $ 13 milioni. Hanno anche una villa di circa 4mila metri quadrati a
Bedford, New York, chiamato Seven Springs, per il quale secondo quanto riferito
hanno pagato $ 7,5 milioni e che usano come una casa di vacanza in famiglia.
Secondo quanto riferito, vale 24 milioni di dollari. Poi ci sono le due case a
Sterling, in Virginia, per un valore di $ 1,5 milioni totali – e tre case di
Palm Beach, per un valore di $ 25 milioni totali. Ma molta della ricchezza di
Trump sta al di fuori del suo portafoglio immobiliare privato. Circa 1,2
miliardi di dollari del patrimonio netto di Trump sono costituiti da immobili
commerciali e 148 milioni di dollari da immobili residenziali. E poi ci sono i
217 milioni di dollari che possiede in campi da golf e club, dagli Stati Uniti
alla Scozia e all’Irlanda. Questo include Mar-A-Lago da 170 milioni di dollari,
una tenuta di 17 acri a Palm Beach che Trump avrebbe acquistato per 10 milioni
di dollari. Dispone di 58 camere, 33 bagni, 12 caminetti e tre rifugi antiaerei.
La passione per le proprietà immobiliari è cosa comune nella famiglia Trump.
Secondo quanto riferito, il figlio Eric Trump e sua moglie Lara hanno due
residenze: un appartamento da 2 milioni di dollari a Trump Parc East e una casa
a Westchester, come segnalato da Town and Country nel 2016. Come suo fratello,
anche Donald Trump Jr. ha proprietà immobiliari a Manhattan. Ha comprato due
appartamenti al Sovereign per $ 1,5 milioni e $ 1,125 milioni, ha riferito Town
& Country. La pubblicazione ipotizzava che volesse unire i due appartamenti.
Entrambi i fratelli sono cacciatori di caccia grossa, il che può essere molto
costoso. Una caccia al rinoceronte bianco di 14 giorni può costare $ 66.790. Nel
frattempo, Ivanka Trump è impegnata a costruire il proprio impero. Tra il 1°
gennaio 2016 e il 31 maggio 2017, ha guadagnato almeno $ 13,5 milioni di
entrate, secondo i documenti resi pubblici dalla Casa Bianca. Più di $ 5 milioni
provengono dal marchio Ivanka Trump, oltre $ 2,5 milioni dall’organizzazione
Trump e quasi $ 800.000 per il lavoro su libri e in TV. Le attività combinate di
Ivanka Trump e suo marito Jared Kushner valgono almeno 207 milioni di dollari,
ma potrebbero superare i 762 milioni di dollari, secondo i documenti. Inclusa
una collezione di opere d’arte da $ 25 milioni. Alcuni rapporti dei media hanno
ipotizzato che il loro matrimonio del 2009 al Trump National Golf Club sia
costato loro almeno $ 1 milione. Quando Trump si stabilì alla Casa Bianca,
Ivanka e Jared si trasferirono a Washington DC, dove secondo quanto riferito
stanno affittando una casa da $ 5,5 milioni nel raffinato quartiere di Kalorama.
Hanno anche un attico con quattro camere da letto a Trump Park Avenue. Come la
sua matrigna, anche Ivanka indossa un mix di capi di lusso e fast fashion, da un
abito e cappotto Oscar de la Renta da $ 6,280 a un abito Roksanda da $ 870 o
anche a un abito Victoria Beckham per Target da $ 35. L’istruzione di Tiffany
Trump è sempre stata pagata da Donald Trump, secondo una fonte che ha parlato
con People Magazine. Ha frequentato la University of Pennsylvania per gli studi
universitari e si è laureata nel 2020 presso la Georgetown Law School, che costa
oltre $ 60.000 all’anno. Quando non è a scuola, Tiffany spende soldi in vacanze,
da un viaggio su uno yacht italiano a un’escursione a Budapest, dalle estati
trascorse a Southampton alle gite alle Bahamas. È stata vista indossare scarpe
Aquazarra da $ 725 e ha indossato più volte il designer di alta moda Daniel
Basso – i cui abiti possono costare migliaia di dollari – per eventi formali.
C’è un dibattito sull’entità delle spese in filantropia di Trump, ma nel 2009,
lui e Melania hanno donato tra i $ 5.000 e i $ 9.999 alla Police Athletic
League di New York City. Ha anche donato $ 1 milione del suo denaro in aiuto
delle vittime dell’uragano Harvey nel 2017.
(ANSA-AFP il
16 agosto 2020) - E' morto il fratello minore di Donald Trump, Robert. Era
ricoverato in ospedale. Sconosciute le cause del decesso. A darne notizia il
presidente degli Stati Uniti in una nota: "È con il cuore pesante - scrive - che
vi annuncio che il mio meraviglioso fratello, Robert, è morto stasera, in pace.
Non era solo mio fratello - prosegue la nota - era il mio migliore amico. Mi
mancherà moltissimo, ma ci rivedremo. Il suo ricordo vivrà nel mio cuore per
sempre". Donald Trump, 74 anni aveva fatto visita a suo fratello venerdì in un
ospedale di New York, rimanendovi per circa 45 minuti. Secondo i media
statunitensi, Robert Trump era gravemente malato. Il presidente Usa, parlando
nei giorni scorsi con i giornalisti, aveva detto che il fratello stava "passando
un periodo difficile", senza fornire ulteriori dettagli. Sebbene molto meno
famoso di suo fratello maggiore, Robert Trump, nato nel 1948, era stato a lungo
parte integrante dell'impero immobiliare di famiglia ed era totalmente fedele,
quasi devoto, al presidente al punto di portare in tribunale - senza successo -
la nipote Mary Trump per cercare di impedire la pubblicazione di "Troppo e mai
abbastanza: come la mia famiglia ha creato l'uomo più pericoloso del mondo".
Robert Trump non aveva esitato a definire "un disonore" il libro, che dipinge
Donald Trump come il prodotto di una famiglia "tossica". La figlia e consigliera
di Donald Trump, Ivanka, ha scritto su Twitter: "Zio Robert, ti vogliamo bene.
Sei nei nostri cuori e nelle nostre preghiere, sempre".
Libro shock di Mary Trump: "Mio zio bullo e meschino. È una
minaccia mondiale". La nipote del presidente:
"Sociopatico e narcisista, è così per gli abusi del padre". Luigi Guelpa,
Giovedì 09/07/2020 su Il Giornale. «Donald, seguendo la guida di mio nonno, e
con la complicità, il silenzio e l'inerzia dei suoi fratelli, ha fatto a pezzi
mio padre. Il suo narcisismo è una barriera fragile e inadeguata tra lui e il
mondo reale. Non posso permettergli di distruggere il mio Paese». È il ritratto
di Donald Trump che emerge dal libro scritto dalla nipote Mary, la prima della
famiglia a violare il patto di riservatezza sulla vita privata del tycoon. Too
Much and Never Enough, traducibile come «Troppo e mai abbastanza» verrà diffuso
(75mila copie) dall'editore «Simon & Schuster» il 14 luglio, in anticipo di due
settimane rispetto al previsto. Un cambio di programma che si è reso necessario
per evitare che venisse bloccata l'uscita. La Cnn ha riportato nei giorni scorsi
i primi stralci. L'inquilino della Casa Bianca viene definito come la proiezione
del padre Fred. «Donald - scrive la nipote - è sopravvissuto perché era
funzionale al padre. I sociopatici lo fanno: scelgono le persone che dovranno
seguire il loro modo di essere. Donald ha preso da lui il modo di agire senza
scrupoli. Poi quando il nonno si è ammalato di Alzheimer non ha trovato di
meglio da fare che deriderlo». In uno degli aneddoti di cui più si sta parlando,
pubblicati dalla Cnn, e nel giro dei giorni successivi dal Washington Post e dal
Guardian, l'autrice scrive che Donald Trump pagò un altro studente per redigere
al suo posto il Sat, un test per valutare a quale università possa ambire uno
studente. Trump studiò alla Wharton Business School della University of
Pennsylvania: nelle sue parole, «un posto da super geni», a cui sarebbe stato
ammesso quindi sulla base di un test truccato. Mary tra l'altro afferma anche di
essere la fonte segreta che passò al New York Times informazioni finanziarie di
Fred Trump. Rivelazioni che consentirono al giornale di scrivere un reportage,
poi premio Pulitzer. Psicologa 55enne, unica liberal della famiglia,
sostenitrice di Hillary Clinton nel 2016, Mary non perdona a Trump il fatto di
aver abbandonato Freddy, fratello maggiore e suo padre, morto nel 1981 a soli 42
anni per un infarto cardiaco dovuto al dissennato alcolismo. «Ha usato la sua
morte solo per motivi politici. Lui non era propenso all'attività immobiliare di
famiglia, quindi Donald è entrato nel ruolo del successore prediletto, mentre
mio padre preferì diventare un pilota. E fu sempre deriso per questo, anche da
Donald che un giorno gli disse che era solo un autista di autobus che ce l'aveva
fatta». Mary cita anche la sorella di Donald, Maryanne, un rispettato giudice
federale in pensione, che all'epoca lo definì «un pagliaccio che frequenta le
chiese solo quando ci sono le telecamere». Ci sono altri passaggi sgradevoli,
per esempio uno in cui Mary riporta di quando suo zio la vide in costume da
bagno e le disse «sei una tettona». «È solo un libro pieno di falsità», ha
commentato la portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, facendo circolare
la notizia che Mary serba rancore per essere stata esclusa dall'eredità di
famiglia. Il fratello minore del presidente, Robert, ha intrapreso un'azione
legale per bloccare la pubblicazione, ottenendo inizialmente un'ingiunzione
contro Mary Trump e «Simon & Schuster» presso la Corte suprema dello Stato di
New York. Il giorno successivo una corte d'appello ha revocato l'ordine
restrittivo contro l'editore. Un ordine che è ancora in atto contro l'autrice e
che quindi non è in grado di commentare le controaccuse della McEnany.
“Sociopatico, pericoloso, bugiardo”: il feroce ritratto di
Donald Trump nel libro della nipote. Redazione su Il
Riformista l'8 Luglio 2020. Narcisista, sociopatico, pericoloso, bugiardo e
imbroglione seriale. Per nulla empatico, disattento ai familiari, sempre alla
ricerca di attenzioni. La psicologa Mary L. Trump, nipote del presidente degli
Stati Uniti Donald Trump, dipinge un ritratto feroce e impietoso dello zio,
nel libro che uscirà il 14 luglio e che Associated Press ha letto in anteprima.
Mentre mancano quattro mesi alle presidenziali in cui il magnate newyorkese
spera di essere rieletto, la psicologa pronostica senza mezze parole: la sua
conferma alla Casa Bianca sarebbe una catastrofe, la fine della democrazia
americana, scrive in ‘Too Much and Never Enough, How My Family Created The
World’s Most Dangerous Man‘ (Troppo e mai abbastanza, come la mia famiglia ha
creato l’uomo più pericoloso del mondo). E’ il secondo infangante libro che
arriva da un ‘insider’ in due mesi, dopo il bestseller dell’ex consigliere per
la Sicurezza nazionale, John Bolton. “Quando il libro sarà pubblicato – scrive
la nipote del tycoon – centinaia di migliaia di vite americane saranno ormai
state sacrificate sull’altare della tracotanza e della deliberata ignoranza di
Donald”. Un riferimento alla pandemia, mentre i contagi negli Usa sono oltre 3
milioni. Il libro nasce dalla storia e dalle relazioni nel clan Trump. La
psicologa è figlia del fratello maggiore del presidente, Fred Jr., morto nel
1981 a 42 anni, dopo problemi di alcolismo. Ormai lontana dallo zio, la
psicologa fa numerose rivelazioni, affermando che “mentire”, “ingannare e
seminare divisione sono tutto ciò che lui sa fare”. Racconta che lo zio pagò un
amico perché sostenesse per lui il SAT, l’esame d’ammissione al college. E che
la sorella, Maryanne, faceva al suo posto i compiti. La portavoce della Casa
Bianca, Sarah Matthews, ha smentito che Trump si sia fatto sostituire al test. A
proposito dell’appoggio ottenuto dal magnate tra leader cristiani ed evangelici
bianchi, la psicologa scrive: “L’unica volta in cui Donald andò in chiesa fu
quando le telecamere erano lì. È da capogiro. Non ha principi”. Torna poi alla
morte del padre, quando lei aveva 16 anni. Trump, che di rado ammette errori, lo
scorso anno disse di essere dispiaciuto della pressione lavorativa che lui e il
padre fecero al fratello. Ma mentre il padre moriva solo, “Donald andava al
cinema”, racconta Mary Trump. Descrive poi lo zio come un narcisista egoriferito
che ignorava i sentimenti dei familiari, dicendo di non stupirsi quindi della
violenta retorica elettorale, visto che nei pranzi familiari lui “parlava di
tutte le donne che considerava brutte ciccione o degli uomini, di solito più
potenti, come perdenti”. Nel libro, lunga psicanalisi del clan Trump, l’autrice
racconta anche la progressione di comportamenti sviluppata sulla scia delle
azioni del padre, esigente e ‘bullizzante’ verso Donald. “Mentire”, scrive, per
lui “era una difesa, non solo un modo di evitare la disapprovazione per evitare
punizioni… era un modo di sopravvivere”. Le elezioni del 2016? Né l’autrice, né
la sorella maggiore di Donald ed ex giudice federale, lo presero sul serio. “E’
un clown, disse mia zia Maryanne in uno dei soliti pranzi, non accadrà mai”,
scrive la psicologa. Racconta poi di aver pensato molte volte di parlare
pubblicamente dello zio, ma di aver temuto di essere considerata “una nipote
scontenta e diseredata in cerca di denaro o rivalsa”. Ma dopo gli ultimi tre
anni, aggiunge, “non posso più restare zitta”. Per la Casa Bianca, tuttavia, il
libro raccoglie “accuse ridicole e assurde che non hanno alcun fondamento”.
Rivelazioni-bomba sui negoziati Usa-Russia sull'atomica.
Piccole Note il 27 giugno 2020 su Il Giornale.
Un’unità dell’intelligence russa avrebbe “offerto ricompense” ai talebani per
gli attacchi compiuti in Afghanistan, inclusi quelli contro obiettivi americani.
La rivelazione giunge da fonti interne all’intelligence Usa ed è stata sparata
dai media americani con la consueta inconsistenza giornalistica, cioè prendendo
per vangelo quanto riferito da fonti interessate e di parte, use anche a manovre
oscure, che più volte si sono rivelate fuorvianti (vedi Russiagate), senza porre
e porsi le domande del caso. Per rendere più odiosa la notizia, l’intelligence
ha specificato che tale attività segreta avveniva mentre si “svolgevano i
negoziati” tra talebani e americani, così che ai buoni americani, desiderosi di
porre fine a una guerra, sono contrapposti i cattivi russi, che pervicacemente
hanno proseguito la loro opera assassina nonostante le possibilità di pace. E
per renderla ancor più odiosa, e di più facile diffusione nel nostro Continente,
le stesse fonti riferiscono anche che la stessa agenzia russa è responsabile di
alcuni “tentati omicidi e altre attività coperte” in Europa. Che sia una bufala
è palese, e tra qualche mese, quando avrà avuto il suo effetto, è anche
possibile che la menzogna di oggi verrà rivelata come tale, come avvenuto per
altre similari in precedenza. Ma non è questo il punto, piuttosto occorre
interpellarsi sul perché tale notizia dirompente sia uscita proprio adesso, dopo
mesi in cui la consueta attività di disinformazione riguardo asserite malefatte
russe, verso i quali manca solo l’accusa di mangiare i bambini, era andata in
qualche modo in sonno, per lasciar posto a informazioni similari riguardanti i
cinesi.
Bomba atomica sul negoziato. Se si guarda l’agenda degli
avvenimenti internazionali si può notare che la “rivelazione” cade con un
tempismo perfetto. Lunedì e martedì scorso Sergei Ryabkov, viceministro degli
Esteri russo, e Marshall S. Billingslea, inviato presidenziale speciale degli
Stati Uniti per il controllo degli armamenti, si sono incontrati a Vienna per
negoziare un prolungamento del trattato START. Si tratta del primo incontro di
alto livello tra russi e americani dopo un lungo gelo. E che è stato reso
possibile dalla contro-inchiesta sul Russiagate, che ha evidenziato le
manipolazioni degli investigatori Usa per costruire inesistenti legami tra i
russi e lo staff di Trump nelle presidenziali 2016 (rivelazioni oscurate dai
media). Caduto il Muro di menzogne che aveva creato un abisso tra Trump e Putin,
l’amministrazione Usa ha così potuto tentare di riprendere il filo del dialogo
Est-Ovest, peraltro su un tema più che cruciale come quello delle armi atomiche.
L’incontro deve salvare l’ultimo trattato sulle armi nucleari che, se non sarà
rinnovato, andrà a scadenza a febbraio. Data apparentemente lontana, ma non
troppo, dato che i tempi di un simile negoziato sono lunghi e incombono le
presidenziali Usa di novembre. Se ci sarà un cambio della guardia alla Casa
Bianca, difficilmente un nuovo inquilino avrà modo di agire in tal senso, troppo
stretti i tempi. La rivelazione di “fonti dell’intelligence” Usa è tesa a
mandare a vuoto i negoziati avviati a Vienna: un rappresentante degli Stati
Uniti non può accordarsi con una nazione che ha perso vite di soldati americani.
Si può immaginare il caos che deriverebbe dal decadere anche di quest’ultimo
trattato sulle armi nucleari: senza tale freno, ricomincerà la corsa
all’atomica.
Far cadere Putin e Trump. Presumibilmente è proprio ciò che
vogliono certi ambiti internazionali votati al caos. The Nation ricorda che a
spingere Trump a stracciare il trattato INF, che regolava la produzione e il
dispiegamento delle atomiche a medio raggio, è stato il suo ex Consigliere alla
Sicurezza nazionale John Bolton (il giornale Usa elenca gli altri suoi nefasti
successi in seno all’amministrazione Usa, in un articolo in cui lo definisce,
con certa puntualità, “terrorista in gessato”). Si vuole innescare una nuova
corsa agli armamenti, nell’intento di ripetere quanto avvenne per l’Unione
sovietica, crollata sotto il peso del collasso dei prezzi del petrolio, già in
atto, e il prosciugamento delle risorse di Mosca nella corsa nucleare (causali
cui va aggiunta la guerra afghana, fattore che può ricrearsi in Siria o altrove
– Ucraina?). Non solo obiettivi di lungo periodo, la “rivelazione” vuol evitare
che Trump, che sta puntando molto su questo negoziato, ottenga un successo
diplomatico in vista delle presidenziali prossime venture. L’incontro di Vienna
prelude a un accordo. Ma, oltre ai negoziati a distanza, di certo proseguiti,
per concluderlo serve un ulteriore incontro. Ed è certo che Trump avrebbe voluto
che l’intesa si concretizzasse in un vertice tra lui e Putin. Adesso tutto è più
complicato. Ed è anzi possibile che a questa prima rivelazione si aggiungano
dettagli ulteriori che la rendano ancor più odiosa, o se ne aggiungano altre
dello stesso tenore. I terroristi in gessato – per stare alla definizione di The
Nation – sanno fare bene il loro mestiere. Posta alta, vicenda da seguire.
Trump, le registrazioni della sorella: «Si fece sostituire da
un’altra persona all’esame di ammissione al college».
Il Corriere della Sera il 23 agosto 2020. Dopo la nipote Mary, è la
sorella Maryanne Trump Barry a mettere nei guai il presidente degli Stati Uniti.
Il Washington Post ha pubblicato in esclusiva una serie di registrazioni fatte
di nascosto dalla nipote Mary in cui l’ex giudice federale definisce suo
fratello Donald «crudele», «bugiardo», «senza principi» e quindi «inaffidabile».
«Non fece lui l’esame d’ammissione al college». Nelle
registrazioni segrete diffuse dal quotidiano americano, l’83enne Maryanne
definisce il fratello Donald Trump un «moccioso» a cui lei faceva i compiti e
che era entrato al college solo grazie ad un’altra persona che aveva sostenuto
per lui l’ esame di ammissione. L’ex giudice ricorda poi che al funerale del
padre «Donald fu l’unico che non parlò di lui», dilungandosi sui propri
successi. «Non voglio che nessun dei miei fratelli parli al mio funerale. E
questo è per Donald e per quello che ha fatto al funerale di papà».
Alla vigilia della Convention repubblicana. Le registrazioni sono
state diffuse dal quotidiano alla vigilia dell’inizio della convention
repubblicana, in programma da lunedì a giovedì prossimo . Subito è arrivata la
replica di Donald Trump: «Ogni giorno c’è qualcos’altro, che importa. Mi manca
mio fratello e continuerò a lavorare duro per il popolo americano. Non tutti
sono d’accordo ma i risultati sono evidenti. Il nostro Paese diventerà presto
più forte che mai».
Poche settimane fa era stato il libro della nipote Mary
Trump «Too Much and Never Enough» a suscitare una bufera. Il fratello minore del
presidente, Robert, morto la scorsa settimana, aveva tentato di bloccare in
tribunale la pubblicazione del volume esplosivo, sostenendo che Mary stava
violando un accordo di non divulgazione firmato nel 2001 dopo la liquidazione
della proprietà del nonno. Nel solo giorno in cui è uscito il libro, subito
definito dalla Casa Bianca «pieno di menzogne», ne sono state vendute 950 mila
copie.
Lo scoop del Washington Post. Bufera
su Trump, gli audio "rubati" alla sorella: “E’ crudele, bugiardo e senza
principi”. Redazione de Il Riformista il 23 Agosto 2020. Donald Trump? Un uomo
“crudele”, “bugiardo”, “ipocrita”, “senza principi” e che “non legge”. Le
critiche pesantissime non arrivano dal fronte democratico composto da Joe Biden
e Kamala Harris, ma dalla sorella del presidente americano, l’ex giudice
federale Maryanne Trump Barry. Le accuse al tycoon emergono da una serie di
registrazioni effettuate segretamente dalla nipote Mary Trump, autrice del
libro-scandalo sullo zio (che aveva cercato di impedirne la pubblicazione, ndr),
e diffuse in esclusiva dal Washington Post alla vigilia della convention
repubblicana. Critiche che fanno notizia anche perché Maryanne Trump Barry non
aveva mai espresso pubblicamente disaccordi col fratello, mentre dalle
registrazioni si rivela una dei personaggi più critici nei confronti del
presidente Usa. Tra i comment più duri dell’ex giudice, che ha 83 anni, quello
relativo alla separazione delle famiglie degli immigrati: “Tutto quello che
vuole è far presa sulla sua base. Non ha alcun principio. Nessuno, nessuno. E la
sua base, se fosse una persona religiosa, vorrebbe che aiutasse la gente, non
fare quello”. Giudizio negativo anche sui ‘successi’ passati del fratello.
Quando infatti la nipote le chiede che cosa ha realizzato Donald da solo, la zia
le risponde: “Ha alle spalle cinque bancarotte”. Nelle registrazioni pubblicate
dal Washington Post quindi si ripete una delle accuse più gravi nei confronti di
Trump: la sorella sostiene infatti che il presidente è entrato al college solo
grazie a un’altra persona che aveva sostenuto per lui l’esame di ammissione.
Trump ha risposto indirettamente alle nuove accuse arrivate dalla famiglia:
“Ogni giorno c’è qualcosa su di me, che importa. Mi manca mio fratello e
continuerò a lavorare duro per il popolo americano. Non tutti sono d’accordo, ma
i risultati sono evidenti. Il nostro Paese diventerà presto più forte che mai”,
ha detto il presidente.
DAGONEWS il 14 agosto 2020. Michael Cohen ha sganciato la bomba:
giovedì ha pubblicato la prima parte del suo libro di memorie “Disloyal, The
Real Real Donald Trump” in cui rivela particolari scottanti dei suoi anni al
fianco del presidente come fedelissimo avvocato prima di diventare il suo nemico
giurato ed essere condannato a 3 anni di carcere per evaso il fisco (1,4 milioni
di dollari), mentito al Congresso sui suoi rapporti con i russi e violato la
legge elettorale sul finanziamento. «A parte sua moglie e i suoi figli,
conoscevo Trump meglio di chiunque altro - ha scritto Cohen, sostenendo che è
stato lui a spingerlo a candidarsi alla presidenza - In un certo senso, lo
conoscevo meglio anche della sua famiglia perché sono stato testimone del vero
uomo, negli strip club, in loschi incontri di lavoro e nei momenti in cui ha
rivelato chi era veramente: un imbroglione, un bugiardo, un prepotente, un
razzista, un predatore, un truffatore». Nella prima parte del libro, che è stato
pubblicato su DisloyalTheBook.com giovedì pomeriggio, Cohen afferma che Trump
"non ha veri amici": «Non ha nessuno di cui si fidi per mantenere i suoi
segreti. Per dieci anni io sono stato sempre lì per lui, e guarda cosa mi è
successo». Un atto d’accusa verso Trump senza risparmiare un mea culpa: «Ho
truffato per suo conto, derubato i suoi soci in affari, mentito a sua moglie
Melania per nascondere le sue infedeltà , e fatto il prepotente con chiunque
minacciasse il percorso di Trump al potere. Dalle golden shower in un sex club a
Las Vegas, alla frode fiscale, agli accordi con funzionari corrotti dell'ex
Unione Sovietica, al mettere a tacere le amanti di Trump. Non ero solo un
testimone dell'ascesa del presidente, io ero un partecipante attivo». Il
riferimento alla golden shower potrebbe riferirsi a un viaggio con Trump in un
club chiamato The Act il cui repertorio includeva la minzione di artisti sul
palco. Cohen continua: «Trump era colluso con i russi, ma non nei modi
sofisticati immaginati dai suoi detrattori. Sapevo anche che l'indagine di
Mueller non era una caccia alle streghe. Trump aveva imbrogliato alle elezioni,
con la connivenza russa, come scoprirete in queste pagine, perché era disposto a
fare qualsiasi cosa - e intendo qualunque cosa - per vincere». Dice che Trump ha
cercato di "insinuarsi" nel mondo di Putin e nella sua "cerchia di oligarchi
miliardari corrotti": «Lo so perché ho gestito personalmente quell'accordo e ho
tenuto Trump e i suoi figli strettamente informati di tutti gli aggiornamenti,
anche se il candidato ha mentito apertamente al popolo americano dicendo: “Non
c'è collusione russa, non ho rapporti con la Russia”». Cohen chiarisce di sapere
molte informazioni visto di essere stato per 10 anni l'ultima chiamata di notte
e la prima al mattino di Trump e di entrare e uscire dal suo ufficio almeno 50
volte al giorno: «I nostri telefoni cellulari avevano le stesse rubriche, i
nostri contatti era così sovrapposti che parte del mio lavoro consisteva
nell'affrontare le infinite domande e richieste, grandi o piccole, degli
innumerevoli ricchi e famosi conoscenti di Trump. Ho chiamato tutte le persone
con cui ha parlato, il più delle volte a suo nome come suo avvocato ed
emissario, e tutti sapevano che quando parlavo con loro, era come se stessero
parlando direttamente con Trump. So dove sono sepolti i suoi scheletri perché
sono stato io a seppellirli. Mi aveva detto di essere uno di famiglia e io gli
avevo creduto, cazzo». Dopo aver collaborato con Mueller, Cohen racconta di come
temesse per la sua vita e di come Trump agisca come un “boss della mafia” che
non avrebbe mai ordinato di farlo fuori, ma lanciava messaggi ai suoi
sostenitori: “Il presidente degli Stati Uniti mi voleva morto. Il presidente mi
ha definito un ratto e ha twittato accuse contro di me, così come contro la mia
famiglia. Ho ricevuto centinaia di minacce di morte sul mio cellulare, sulla mia
e-mail e persino per posta. Ero esattamente la persona di cui parlava Trump
quando ha detto che poteva sparare e uccidere qualcuno sulla 5th Avenue e farla
franca. Inoltre ha anche un controllo simile a quello di una setta sui suoi
sostenitori, alcuni dei quali sono folli e disposti a fare qualsiasi cosa per
compiacere o proteggere il presidente. Sapevo quanto fossero impegnati questi
fanatici perché ero stato uno di loro». Cohen, inoltre, ritiene che Trump voglia
evitare la prigione diventando leader a vita e ha accennato a un Donald con
mille paturnie, perso, solo e senza le persone di cui ha davvero bisogno:
«Guardando Trump al telegiornale della sera nella sala giochi della prigione,
quasi mi dispiace per lui. Lo conosco così bene e conosco i suoi tic facciali.
Vedo lo sguardo, si sente con le spalle al muro mentre si agita, inveisce e
delira, alla ricerca di un protettore e difensore, qualcuno disposto a
combattere sporco e distruggere i suoi nemici». Tra gli aspiranti adulatori
disposti a infrangere le regole per lui ci mette Bill Barr, Jared Kushner, Rudy
Giuliani e Mike Pompeo. «È solo un gangster che può rivelare i segreti della
criminalità organizzata. È un uomo artefatto al cento per cento». E poi torna a
fare un mea culpa: «Il mio insaziabile desiderio di compiacere Trump per
ottenere potere è stato il difetto fatale che ha portato alla mia rovina. Donald
Trump e io eravamo simili; in questa brama di potere, io e il presidente eravamo
anime gemelle. Ero così vulnerabile alla sua forza magnetica perché offriva un
cocktail inebriante di potere, forza, celebrità e un completo disprezzo per le
regole. Per Trump la vita è un gioco e tutto ciò che conta è vincere. Vedo il
Partito Repubblicano e i seguaci di Trump che minacciano la costituzione e che
seguono uno dei peggiori impulsi dell'umanità: il desiderio di potere a tutti i
costi».
Da repubblica.it il 7 settembre 2020. Gli afroamericani "non sono
la mia gente" e gli ispanici "così come gli afroamericani sono troppo stupidi
per votare per Trump". A ricostruire le parole del presidente americano è il
suo ex legale personale, Michael Cohen, nel libro Disloyal: A Memoir in uscita
nei prossimi giorni e di cui il Washington Post ha ottenuto una copia. Cohen
racconta di come il presidente, per criticare Barack Obama, avrebbe detto:
"Dimmi un Paese che è guidato da un afroamericano che non è un cesso". Poi ha
aggiunto: Nelson Mandela ha "rovinato il Sud Africa", "non era un leader". L'ex
legale di Trump spiega poi la passione del presidente per Vladimir Putin, in
grado di guidare il suo Paese come fosse la sua società. Le rivelazioni del
libro escono nel giorno in cui Trump ha twittato un amaro: "Steve Jobs non
sarebbe contento di vedere sua moglie sprecare i soldi che le ha lasciato in un
magazine della sinistra radicale guidato da un truffatore (Goldberg) e che
diffonde fake news e odio". Trump si riferisce a Laurene Powell Jobs, la vedova
del fondatore di Apple, co-proprietaria di The Atlantic, il magazine che ha
rivelato i commenti shock di Trump sui caduti americani in guerra.
Massimo Gaggi per corriere.it il 5 settembre 2020. Due anni fa,
in Francia per le commemorazioni della Prima Guerra Mondiale, Donald Trump salta
la visita al cimitero militare americano di Aisne-Marne: sostiene che le
condizioni meteo non consentono all’elicottero di volare. Ora The Atlantic
scrive, sulla base delle testimonianze di quattro partecipanti a quella missione
dei quali non cita, però, i nomi, che il presidente si rifiutò di andare dicendo
che non aveva senso visitare un posto pieno di losers, sconfitti. Poi parlò dei
1300 marines lì sepolti come di una massa di «sfigati che si sono fatti
ammazzare». Irrilevante, per lui, il fatto che il loro sacrificio impedì ai
tedeschi di raggiungere Parigi: disse, anzi, di non capire perché l’America si
schierò con gli Alleati.
La smentita. La storia, se vera, sarebbe molto dannosa per Trump
anche in prospettiva elettorale. I militari sono prevalentemente conservatori e
lui li ha corteggiati. Ma il presidente ha anche fatto cose che non sono
piaciute al mondo della Difesa: coinvolgere lo Stato maggiore in sortite di
sapore elettorale, cercare di usare i militari nella gestione dell’ordine
pubblico nelle città durante le proteste razziali, e poi la rottura con alcuni
dei generali più stimati d’America che aveva chiamato al governo: James Mattis,
John Kelly, HR McMaster. Trump decide quindi di smentire e lo fa con veemenza:
«Mai detto niente di simile, lo giuro su qualunque cosa. Solo un animale può
dire una cosa simile. Ho grande rispetto per gli eroi caduti».
I precedenti. Storia finita qui? Non proprio perché la rivista
(di proprietà della moglie di Steve Jobs) è autorevole e conferma tutto (altri
giornali e agenzie ottengono conferme analoghe). L’articolo è del suo direttore,
Jeffrey Goldberg: è molto approfondito e cita altri casi nei quali Trump ha
usato un linguaggio simile. Contro John McCain che, per lui, non fu un eroe di
guerra perché, abbattuto sui cieli di Hanoi, finì in una prigione vietnamita:
«Non mi piacciono quelli che si fanno catturare». Trump aveva poi condiviso un
articolo nel quale McCain veniva definito un loser. E in passato ha considerato
un loser anche George Bush padre: pure lui abbattuto ma dai giapponesi nella
Seconda guerra mondiale. E mai catturato.
La nipote di Bin Laden: "Se vince Biden, gli Usa avranno un
altro 11 settembre". La nipote di Bin Laden ha
dichiarato di essere una sostenitrice sfegatata di Trump e di seguire sempre le
trasmissioni di emittenti conservatrici. Gerry Freda, Lunedì 07/09/2020 su Il
Giornale. La nipote di Osama Bin Laden ha ultimamente messo in guardia gli
americani riguardo alle conseguenze di una possibile vittoria di Joe Biden alle
presidenziali. Qualora dovesse appunto insediarsi l’esponente dem alla Casa
Bianca al posto di Donald Trump, gli Stati Uniti, ad avviso delle trentatreenne
Noor bin Ladin, dovranno subire “un altro 11 settembre”. Tale fosca profezia
della donna, residente in Svizzera ma che si sente americana nel profondo
dell’anima, è stata da lei fatta nell’ambito di un’intervista, la sua prima in
assoluto, concessa al New York Post. Finora, la nipote dell’ex sceicco del
terrore aveva appunto sempre condotto una vita estremamente riservata,
contrariamente a sua sorella Wafah, che è una cantante pop e una diva del mondo
dei social. Noor (il cui ramo familiare ha scelto per precauzione di cambiarsi
il cognome in bin Ladin, rigettando così quello del tristemente famoso zio
terrorista) è la figlia di Carmen Dufour, scrittrice svizzera, e di Yeslam bin
Ladin, fratellastro maggiore del fondatore di Al Qaida. Dopo il divorzio dei
genitori, Noor è rimasta in Svizzera con la madre e le due sorelle, la già
citata Wafah e Najia, crescendo in un ambiente impregnato dei valori occidentali
e viaggiando negli Usa dall’età di tre anni, fino a considerare gli Stati Uniti
come la sua seconda casa. Lei avrebbe poi studiato Economia e Gestione aziendale
presso gli atenei di Ginevra e Londra. Quando lo zio organizzò gli attentati
dell’11 settembre 2001, ha rivelato Noor alla testata newyorchese, lei aveva
quattordici anni e le immagini degli aerei che si schiantavano contro le Torri
gemelle l’avevano allora “devastata”. Tuttavia, proprio all’indomani di quella
tragedia, la donna dal cognome ingombrante avrebbe compreso che l’America non è
affatto un Paese razzista, dato che, nei suoi viaggi effettuati lì in seguito
alle stragi jihadiste, sarebbe stata sempre “travolta” dalla gentilezza e dalla
comprensione dei cittadini statunitensi, nonostante fosse la nipote della mente
degli attentati islamisti incriminati. La formazione di Noor nel contesto
sociale svizzero scelto dalla madre, culturalmente lontano anni luce da quello
che avrebbe trovato se avesse seguito il padre in Arabia Saudita, le ha così
permesso di sviluppare una profonda fede nei valori liberali e, recentemente,
nel motto trumpiano Make America Great Again. La trentatreenne, ha rivelato
al New York Post, è infatti un’accanita sostenitrice del leader repubblicano ed
è solita camminare per strada con indosso cappellini o altri articoli di
abbigliamento targati con le parole d’ordine di The Donald. Alla luce della sua
infatuazione per l’attuale inquilino della Casa Bianca, la nipote di Bin Laden
ha affermato ai giornalisti della medesima testata che un’eventuale vittoria di
Biden potrebbe celare dietro l’angolo un attentato contro gli Stati Uniti
analogo a quelli perpetrati l’11 settembre 2001. A sostegno della sua profezia,
lei ha ricordato i gravi errori e le debolezze in politica estera e di sicurezza
in cui sarebbbe incappata proprio la coppia Obama-Biden durante il loro mandato
alla Casa Bianca: “L'Isis ha proliferato durante l'amministrazione Obama/Biden.
Trump ha dimostrato di volere proteggere l'America e noi”. A detta di Noor,
dalla rielezione di Trump dipenderebbe addirittura il destino dell’intera
cultura occidentale: “Sono stata una sostenitrice del presidente Trump da quando
ha annunciato la sua candidatura all'inizio del 2015. Deve essere rieletto: è
vitale non solo per il futuro dell'America ma della civiltà occidentale nel suo
insieme”. Lei ha poi chiarito al New York Post di non avere legami con alcuna
religione, meno che mai con l’islam, condannando contestualmente la deputata dem
musulmana al Congresso federale Ilhan Omar. Secondo la nipote di Bin Laden, tale
parlamentare progressista, con i suoi continui inviti alla compassione verso i
terroristi dell’Isis avrebbe dato prova di “odiare gli Stati Uniti”. Data la sua
forte fede trumpiana, la trentatreenne non poteva non amare le emittenti
dichiaratamente filo-repubblicane e conservatrici. Noor ha infatti confessato di
seguire costantemente le trasmissioni in onda su Fox News, in particolare il
talk-show di orientamento anti-liberal Tucker Carlson Tonight.
Carlo Nicolato
per ''Libero Quotidiano'' l'11 ottobre 2020. Contando 20 fratelli e 24 figli
della famiglia di Bin Laden non si può fare a meno di parlare con puntuale
cadenza, è una questione di probabilità. Ricorderete forse la nipote Wafah
Dufour che negli anni addietro aveva abiurato il nome di famiglia per
intraprendere tra gli Stati Uniti e l'Europa una carriera da cantante punk, ora
a far parlare di sé è la sorella minore, la 33enne Noor che come lei e come la
terza sorella, la secondogenita Najia, si fa chiamare con il cognome della
madre. Dufour appunto, che era quella Carmen, svizzera di nascita, passata alla
cronaca per aver scritto un libro sulla famiglia Bin Laden e su come il marito
Yeslam Bin Laden, fratellastro maggiore di Osama, la tradisse sistematicamente,
ragione per cui lo abbandonò rimanendosene in Svizzera con le tre figlie.
Decisamente benestanti, "pecunia non olet", le figlie di Carmen hanno menato una
vita piuttosto agiata, tra gli studi in Svizzera e quelli in America, della
quale le tre donne si sentono giustamente figlie predilette avendole, l'America,
accolte con generosità nonostante l'ingombrante discendenza. È proprio di questo
e del suo amore per Trump che Noor ha recentemente parlato in un'intervista al
britannico Spectator, sottolineando come le sia costato di più in termini di
rogne l'essere una supporter dell'attuale presidente Usa che l'essere la nipote
del più famoso terrorista del mondo, ideatore peraltro dell'abbattimento delle
Torri Gemelle di Manhattan. «Nella mia esperienza, gli americani sono il popolo
più affettuoso, gentile e aperto del mondo. Così è stato per tutta la mia vita,
nonostante io sia la nipote di Osama Bin Laden e condivida con lui lo stesso
cognome», ha detto, sottolineando poi ciò che tra l'altro non si aspetterebbe
mai di sentire dire, da un'immigrata, un qualsiasi Dem prevenuto: «Gli americani
fondano il proprio giudizio sul contenuto del carattere e delle azioni degli
altri, non sul colore della loro pelle, o sul loro cognome». Noor sostiene di
averne avuto la riprova quando il mese scorso ha scritto la sua «lettera
all'America», una lettera accorata, d'amore per un Paese che più degli altri «ha
offerto un ideale sociale senza pari e uno stile di vita dignitoso», «faro di
speranza e democrazia». Ma di aver avuto anche la prova di come «un'intera
generazione (di quel Paese) sia stata sottoposta con successo al lavaggio del
cervello al fine di odiare proprio la nazione che ha prodotto più libertà,
giustizia e uguaglianza ovunque nel mondo». E proprio di quella generazione e
mentalità lei stessa, che in tale lettera ha anche espresso la sua ammirazione
per Trump e la sua speranza riunita nello slogan del presidente, «Make America
great again», è vittima. «Uscire pubblicamente allo scoperto», ha spiegato allo
Spectator, «è stato agli occhi di qualcuno un passo eccessivo, e il livore di
cui sono stata fatta oggetto per aver espresso le mie idee politiche ha messo in
mostra il lato sgradevole di certe persone. Da un punto di vista sociologico, è
abbastanza interessante che in taluni circoli elitari l'essere pro-Trump mi
abbia attirato più seccature che non portare il nome Bin Laden». Sostenitrice
accanita di Donald a suo rischio e pericolo, tanto da uscire per strada con
magliette e cappellini con la scritta "Make America Great again", ma non solo
una tifosa, visto che nella stessa famosa lettera accenna anche una pretenziosa
analisi in cui fa risalire la crisi della società americana alla globalizzazione
del pensiero, ai tecnocrati, i banchieri internazionali ecc. In un'altra
intervista al New York Post aveva addirittura sostenuto che una vittoria di
Biden potrebbe voler dire un altro attacco terroristico agli Usa, stile Torri
Gemelle. La debolezza in politica estera dimostrata dal tandem Obama-Biden ha
favorito la nascita dell'Isis e questo, per Noor, è un segnale inquietante, la
dimostrazione dell'inadeguatezza del candidato democratico.
Donald
Trump, coltellata dell'ex assistente Omarosa Newman: "Melania a volte
disgustata, cosa ho visto in questi 17 anni".
Libero
Quotidiano il 28 ottobre 2020. Non è certo un mistero il fatto che tra Donald
Trump e la moglie Melania Trump non corra, da tempo, buon sangue. Molti
retroscena e altrettanti gesti in pubblico della first lady, nel corso di questi
anni, hanno avuto il ruolo di lampanti conferme. E ora ne arriva una ulteriore,
di conferma. Piuttosto fragorosa. A parlare, come riporta Dagospia, è Omarosa
Manigault Newman, ex assistente del presidente Usa: incontrò il magnate nel 2004
a The Apprentice e nel gennaio 2017 divenne assistente e direttore delle
comunicazioni per l'ufficio delle relazioni pubbliche. Dunque il
libro, Unhinged, che Trump cercò di bloccare prima della pubblicazione. "Una
relazione tra i due". Bomba su Trump e Melania: la consigliera ex modella la
prima a essere contagiata? Ora si capisce tutto
Ora, sul
rapporto tra Donald e Melania, Omarosa spiega: "È un matrimonio molto strano.
Sono molto cauta nel commentare le dinamiche di un matrimonio perché non sai mai
cosa succede a porte chiuse. Ma conosco questa coppia da quando si
frequentavano, si sono sposati un anno dopo la messa in onda di The Apprentice".
E ancora: "Quello che ho osservato negli ultimi 17 anni ti farebbe girare la
testa. A volte si piacciono, ma a volte lei è disgustata da Trump. È un
matrimonio molto strano", ha concluso la Newman.
DAGONEWS il 29 agosto 2020. «Melania pensava che gli alloggi
della residenza presidenziale fossero una discarica». Sono le scoppiettanti
verità rivelate nel libro “Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship
with the First Lady” scritto dall’ex amica e consigliera Stephanie Winston
Wolkoff. «Melania si è rifiutata di trasferirsi a Washington DC fino a quando la
Casa Bianca non è stata completamente ridisegnata e rinnovata – racconta una
fonte che ha letto il libro – Stephanie racconta di come Melania ha dato
un'occhiata alla sua camera da letto e al bagno e ha chiesto una nuova doccia e
servizi igienici. Non era disposta a usare lo stesso bagno degli Obama o di
chiunque altro, non avrebbe avuto importanza se si trattava della regina
d'Inghilterra. Voleva che tutto fosse ridecorato, ridipinto, voleva nuovi
mobili: tutto era vecchio e malandato e voleva che fosse nuovo di zecca. Melania
è la moglie del presidente e non si aspettava di doversi accontenatare di roba
usata e di seconda mano». E così Melania è rimasta nel suo attico alla Trump
Tower di New York mentre il bagno veniva rifatto e altri miglioramenti venivano
apportati al vecchio spazio abitativo di Michelle Obama.
Giuseppe Sarcina per corriere.it il 13 giugno 2020. Washington -
Farò la First Lady, ma voglio più garanzie per mio figlio Barron. Tra il 20
gennaio e il 12 giugno del 2017 Melania Trump restò a New York, mentre il marito
prendeva possesso della Casa Bianca e cominciava a governare il Paese. In quei
mesi fioccavano le indiscrezioni e le congetture. L’ex modella slovena fece
sapere che sarebbe rimasta nella Trump Tower fino a quando il figlio Barron,
all’epoca undicenne, non avesse terminato l’anno scolastico. Qualcuno ipotizzò
un’imminente separazione, se non il divorzio. Gli ultimi mesi della campagna
elettorale erano stati molto pesanti per Melania. Da tutte le parti fioccavano
rivelazioni sugli intrallazzi sessuali di «The Donald». Pochi giorni prima delle
elezioni del novembre 2016, veniva pubblicata una registrazione che risaliva al
2005. L’allora costruttore venuto dal Queens si vantava di «essere un vip» e
quindi «di poter prendere anche le sconosciute per la f..». In realtà Melania
usò quei primi sei mesi del 2017 per rinegoziare l’accordo pre-matrimoniale
firmato con il consorte, prima delle nozze, festeggiate il 22 gennaio 2005, a
Mar-a-Lago. Il «matrimonio del secolo», titolarono diversi tabloid e
rotocalchi. Centinaia di invitati, tra i quali Bill e Hillary Clinton. La sposa
aveva 34 anni, lo sposo 58. Dodici anni dopo gli equilibri sono cambiati, scrive
Mary Jordan, giornalista Premio Pulitzer del Washington Post, autrice del libro
«The Art of her deal: the Untold Story of Melania Trump», L’arte dei suoi
affari: la storia mai raccontata di Melania Trump, (Simon and Schuster editore,
disponibile dal 16 giugno). Il titolo riprende quello del volume più conosciuto
dell’allora costruttore newyorkese. «The Art of the Deal» (1987). Un modo per
spiegare come anche Melania sia molto attenta ai suoi interessi personali. O
meglio, spiega Jordan, a quelli di suo figlio Barron. Le anticipazioni del libro
non rivelano molti dettagli, ma la notizia c’è. Con Trump alla Casa Bianca,
Melania temeva di essere tagliata fuori dalla gestione del business di famiglia,
passato nelle mani di Donald Jr ed Eric Trump. Senza contare l’attivismo di
Ivanka, la pupilla del presidente. Alla fine, scrive Mary Jordan, si trova il
«deal», l’accordo. Barron, se vorrà, si potrà dedicare alla gestione delle
attività della Trump Organization in Europa, forse anche in Russia. L’unico
figlio della First lady e del Presidente ha anche la cittadinanza slovena,
quindi, una volta diventato maggiorenne, potrà muoversi agevolmente nel Vecchio
Continente.
Un libro racconta la vera Melania: dopo la vittoria di Trump
rinegoziò l'accordo matrimoniale. Pubblicato venerdì,
12 giugno 2020 da La Repubblica.it. La vera Melania Trump è molto diversa da
quello che appare. Per niente timida e riservata, la First Lady ha in comune
con Donald Trump molto più di quanto si possa pensare, prima di tutto
l'ambizione. E la dimostrazione sta nell'aver usato il trasferimento alla Casa
Bianca come pretesto per rinegoziare l'accordo prematrimoniale. A mostrare l'ex
modella sotto una luce nuova è 'The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania
Trump', il libro della giornalista del Washington PostMary Jordan. Il titolo
fa chiaramente riferimento a uno dei libri più popolari del tycoon (The Art of
The Deal) e sta ad indicare le somiglianze fra marito e moglie: "Sono tutti e
due dei combattenti per i quali la lealtà non ha prezzo, e nessuno dei due ha
molti amici stretti. I loro istinti solitari" caratterizzano anche il loro
matrimonio, si legge in un passaggio del libro. Jordan racconta Melania nella
sua nativa Slovenia, il suo arrivo nel mondo della moda, l'incontro con Trump e
l'approdo alla Casa Bianca. Un trasferimento a Washington ritardato di alcuni
mesi rispetto a quello del marito: ufficialmente Melania è rimasta a New York
per diversi mesi prima del trasloco per consentire a suo figlio Barron di finire
l'anno scolastico. Ma il ritardo, secondo la giornalista, nascondeva altro. La
First Lady, racconta infatti Jordan, avrebbe usato quei mesi di distanza per
rinegoziare l'accordo prematrimoniale, approfittando della leva offertale dal
pressing dei figli adulti di Trump affinché si trasferisse in tempi brevi a
Washington in modo da poter esercitare il suo potere "calmante" sul marito.
Quello siglato all'inizio non era un accordo matrimoniale particolarmente
generoso per Melania. Ma con gli anni il suo ruolo è cambiato e cresciuto: l'ex
modella è ora la moglie di più lunga durata di Trump, colei che ha superato
tutte le scappatelle del marito emerse durante la campagna elettorale e la First
Lady degli Stati Uniti. Consapevole di questo, avrebbe rinegoziato l'accordo
affinché le venisse riconosciuto il giusto, soprattutto per la tranquillità
futura di Barron. Nel libro Melania è descritta come molto influente sul marito
- sarebbe grazie a lei che Mike Pence è il vice presidente - ma emerge anche
come una figura controversa. Pur avendo negato il ricorso a interventi di
chirurgia estetica, almeno tre fotografi, sostiene Jordan, riferiscono di aver
visto le cicatrici delle operazioni. Ci sono poi poche prove che indicano che
sia in grado di parlare fluentemente quattro o cinque lingue (come viene
raccontato) e che sia stata una supermodel nel vero senso della parola. A
dispetto delle voci e delle indiscrezioni, Melania è stata fin dall'inizio
un'accanita sostenitrice della candidatura di Trump. E ora sarebbe impegnata in
prima fila per la rielezione del marito.
Giovanni Terzi
per “Libero quotidiano” il 27 aprile 2020. «Una cosa la voglio dire subito e
desidero che tu la scriva: sei assieme ad una delle donne più belle del mondo».
Questo l' esordio di Paolo Zampolli, imprenditore e diplomatico, ambassador
della Repubblica di Dominica, conosciuto in tutto il mondo come il "cupido" che
ha fatto scoccare la scintilla e l' amore tra Donald Trump e Melania. «Ma mi
raccomando, scrivi che Simona Ventura è sempre la numero uno». Francamente non
esiste per me cosa più semplice se non scrivere sotto dettatura una cosa che io
penso in maniera naturale. Intervistare Paolo Zampolli è un' esperienza unica. I
suoi racconti sono paradigma di quello che sono stati per molti di noi gli anni
Novanta. Un momento straordinario, pieno di energie positive, dove tutto
sembrava possibile; anche il classico "american dream". Ed è proprio dal sogno
americano che parte il nostro racconto.
Paolo, perché
scelse di venire in America più di un quarto di secolo fa?
«Era il sogno
americano che avevo dentro di me. Sono nato in via Borgonuovo, a Milano, e
sebbene negli anni Ottanta e inizio Novanta fosse una città già capitale della
moda e dello stile, a me andava stretta».
Paolo Zampolli
nasce in una importante famiglia milanese. Suo padre Giovanni, mancato
precocemente, era il fondatore di un' azienda di giocattoli milanese, la
Harbert, che distribuiva in Italia celebri marchi di giocattoli statunitensi
come "Dolce Forno", "Festacolor", le figure di "Guerre Stellari"e dei supereroi
"Comics" e "Marvel", e poi ancora "Mr. Muscolo" e l'"Uomo Ragno" e tanti altri.
Chi ha vissuto gli anni Ottanta ricorderà sicuramente quello slogan, "non puoi
giocare senza (nome del giocattolo), sarebbe un peccato". In un contesto quindi
agiato, Paolo Zampolli sceglie gli States.
Che ricordi ha
della sua adolescenza?
«Ho bei
ricordi assieme a tanti amici, tra cui quella di una vita, Magda Pozzo. Ricordo
le nostre vacanze a Ibiza da quando avevo quattro anni: negli anni Settanta e
Ottanta Ibiza era un' isola sensazionale».
Partito da
Milano che sogni aveva, quale era il suo obiettivo?
«La Casa
Bianca, e in qualche modo ci sono arrivato».
Grazie all'
amicizia con il presidente Donald Trump?
«Il presidente
Trump è un uomo generoso e riconoscente, e ha dimostrato nei miei confronti un'
amicizia reale. Sono cose che fanno piacere!».
Come poteva
fare diversamente: in fin dei conti le ha presentato Melania, la First Lady...
«Rimanere se
stessi con gli amici e la gratitudine non è da tutti, soprattutto in questo
momento storico».
Come avvenne
l' incontro?
«Quando
arrivai a New York aprii una agenzia di modelle importante. Tra le modelle che
lavoravano con me c' erano Heidi Klum, Claudia Schiffer e Melania Knauss. Sì,
proprio lei, l' attuale moglie di Trump. Una sera, ad una festa organizzata al
"Kit Kat Club" di New York, Melania e Donald si conobbero. Lui aveva 52 anni e
lei 28».
Fu un colpo di
fulmine?
«Penso di sì,
ma bisognerebbe chiederlo agli interessati, sempre rimasti molto riservati
rispetto alla loro storia d' amore. Comunque poche settimane dopo, a un' altra
cena a casa mia, il presidente venne accompagnato da Melania».
Che cosa pensa
abbia colpito il presidente Trump di Melania?
«La First Lady
già a 28 anni era una donna molto elegante, educata ed istruita, oltre che
naturalmente molto bella. E credo che fu il complesso della personalità che
colpì Trump».
Questo
incontro sfociò in un matrimonio, nel 1995 a Palm Beach, che però significò
molto anche per lei. Fu Trump a consigliarle di lasciar perdere l' agenzia di
modelle?
«Sì. Una sera
eravamo a cena, e assieme a Melania e Trump c' era anche David Coperfield, il
famoso mago-illusionista. A un certo punto Trump mi disse che ero troppo
intelligente per portare avanti l' agenzia di modelle: «Sai cosa ti succede se
perdi una delle tue super top model? Vai in rovina». Io ci pensai, ed
effettivamente non aveva torto».
E poi?
«Poi aggiunse:
«E sai che cosa mi succede se perdo un portiere delle mie Tower? Nulla, perché
ho la fila di gente che vorrebbe venire a lavorare nei miei bulding». Così mi
propose di andare a lavorare con lui».
E lei?
«Io mi girai
verso David Copperfield e chiesi se fosse una magia. Poi sorrisi a Melania, e il
giorno dopo ero a lavorare come direttore della sezione internazionale della
Trump Organization».
Frequenta
ancora Trump da quando è presidente?
«Natale e
Pasqua ogni anno siamo insieme alla Casa Bianca, siamo sempre invitati. Tranne
questa Pasqua, per colpa del Covid-19. Ma uutti i Natali siamo al tavolo con il
presidente. Mio figlio Giovanni, che ha 10 anni, è molto legato a Donald: "Sono
amico del presidente", dice sempre».
Secondo lei
Trump vincerà le elezioni del prossimo novembre?
«Penso di sì.
Lui è l' unico che ha parlato di questo Coronavirus chiamandolo "China-virus",
perché è responsabilità loro, dei cinesi, se siamo in questa situazione. Molti
suoi sfidanti hanno invece relazioni con la Cina. Trump, grazie alla sua potenza
economica, non ha bisogno di nulla e di nessuno».
Lei che ha
mangiato con il presidente: quali sono i piatti più amati?
«Intanto non
beve. Mangia carne e verdura. E ama la cucina italiana. Andavamo spesso a
mangiare da "Cipriani e Serafina", a New York».
In quest'
ultimo periodo è anche uscito sulla stampa che lei avrebbe aiutato il Vaticano
ad avere i test per vedere se si è positivi al Covid-19.
«Sì, conosco
Papa Francesco, a cui ho regalato il mio "Laudato si'" personale, uno "shark",
uno squalo, quando lo incontrai. E così mi sono fatto promotore. Dalla Farmacia
Vaticana arrivo la richiesta negli Stati Uniti di settecento test per Covid. Io
ho semplicemente facilitato tutto questo».
Ma perché
regalò uno squalo a Papa Francesco?
«Lui, come me,
ama la natura. Fra i miei impegni più importanti c' è sempre stato tutto ciò che
riguarda l' ambiente».
Trump e il
Santo Padre: un rapporto complesso?
«Non credo.
Trump è cattolico tradizionalista, e il Santo Padre adora Melania».
Come fa a
dirlo?
«Lo capirebbe
chiunque».
In questa sua
vita ha ancora sogni da realizzare?
«Sì, per
quanto mi riguarda, essere "adottato" da Jeff Bezos, il capo di Amazon. Per mio
figlio Giovanni, che studi all' università di Harvard, e... diventi presidente
degli Stati Uniti!».
Ride, Paolo
Zampolli. Sicuramente avrebbe ancora molte cose da raccontare, che fanno parte
di una vita piena di esperienze e conoscenze. Così lo ringrazio. Ma prima di
congedarsi, mi dice: «Si ricordi di scrivere che Trump è amico dell' Italia, e
che a lui "Giuseppi", il presidente del Consiglio, piace davvero».
Anticipazione da “Grazia”
il 7 maggio 2020.
Lucy Flores, 40 anni, attivista per i diritti femminili, è la
prima delle otto donne che ha sostenuto di aver subìto abusi da Joe Biden, l’ex
vicepresidente americano e avversario di Donald Trump che punta alla Casa
Bianca. Nel numero di Grazia, il magazine diretto da Silvia Grilli, in edicola
questa settimana Lucy Flores racconta la sua versione e spiega perché bisogna
fare chiarezza prima delle elezioni del 3 novembre: «Non veniteci a dire, se Joe
Biden non vince a novembre, che e colpa di noi donne. Sara solo colpa sua se non
e capace di comportarsi da leader e convincere gli americani a votarlo. Noi
donne lo abbiamo giustamente richiamato alle sue responsabilità». A Grazia
l’attivista spiega perché è d’accordo con la richiesta de The New York Times di
aprire un’inchiesta indipendente: «E importante avviare un processo equo per
porre le domande importanti e cercare le prove. Solo cosi la gente potrà
sentirsi bene scegliendo il prossimo presidente. Sarebbe orribile per noi donne
dover decidere se votare per un candidato che e molto probabilmente uno
stupratore e un altro che forse e uno stupratore». E a proposito di chi voterà
alle prossime elezioni, svela: «Per Biden, perché altri quattro anni di Donald
Trump alla Casa Bianca danneggerebbero ulteriormente noi donne». Sulle pagine
del magazine Lucy confida anche di credere a Tara Reade, l'ultima donna che ha
raccontato di essere stata trattata da Biden in modo non rispettoso: «Credo a
Tara perché ha sempre raccontato gli stessi fatti a diverse persone fin da
subito». E sottolinea: «Costa tantissimo a una donna esporsi con una simile
denuncia: la tua reputazione è macchiata, ricevi insulti e minacce, persino di
morte».
Giuseppe Sarcina per il "Corriere della Sera" il 12 agosto 2020.
Nell'inverno del 2019 il ticket più gettonato tra i parlamentari democratici al
Congresso di Washington era Joe Biden- Kamala Harris. In questi due anni è
accaduto di tutto, dentro e fuori il partito democratico. Ma quell'ipotesi ha
resistito e ora darà il tono alla sfida dei progressisti contro Donald Trump.
Kamala Harris, 55 anni, senatrice della California, studi giuridici, ha
cominciato come sostituto procuratore a San Francisco. Nel 2010 è stata eletta
Procuratore Generale della California. Nel 2016 è approdata al Congresso. Figlia
di una scienziata Tamil e di un professore di economia giamaicano, Kamala ha
corso nelle primarie presentandosi come la rappresentante degli afroamericani e
delle altre minoranze. Aveva iniziato con il botto, il 27 gennaio 2019: un
comizio-evento con circa ventimila persone a Oakland, la sua città natale. Una
folla trumpiana (dei tempi d'oro). Per qualche mese era sembrato che potesse
diventare la lepre, la sorpresa della gara tra i democratici. Il suo momento
migliore, forse, risale al 27 giugno 2019, quando affondò proprio Biden, in un
dibattito televisivo tra candidati. Kamala rinfacciò all'ex presidente di aver
ostacolato, in un lontano passato, il cosiddetto «busing», il servizio bus che
trasportava i bambini e i ragazzini afroamericani nelle scuole di altri
quartieri per favorirne l'integrazione. La luce di Kamala, però, si spense
rapidamente. Si è ritirata il 3 dicembre 2019, senza partecipare neanche a una
prova elettorale. La sua prestazione sollevò molti dubbi. Le quotazioni della
senatrice risalirono nel corso dell'impeachment nei confronti di Donald Trump.
Durante la lunga tornata di audizioni dei veri testimoni, dimostrò grande
personalità e anche una certa tenuta scenica. Gradualmente si è riavvicinata al
campo di Biden. Lo ha appoggiato pubblicamente l'8 maggio scorso. Contano anche
i legami personali, familiari. Kamala era molto amica di Beau Biden, il figlio
del presidente, scomparso nel 2015. Ora, però, Harris dovrà dimostrare che le
perplessità, le riserve sul suo conto, sono infondate. In queste settimane, per
esempio, molti deputati democratici si sono chiesti se davvero Kamala sia così
popolare tra gli afroamericani. Dai sondaggi realizzati nei mesi scorsi non si
direbbe. La «black community» gli ha preferito non solo Biden, ma anche Bernie
Sanders. Inoltre. Qual è la sua identità politica? Difficile dirlo. Spesso usa
un linguaggio simile a quello della sinistra radical; sui contenuti, invece,
oscilla parecchio, arenandosi su una generica terra di nessuno. Biden ha bisogno
di allargare il più possibile il blocco sociale, mettendo insieme moderati e
oltranzisti. Kamala Harris ha convinto Biden, da oggi ha il compito di
rassicurare tutte le componenti del partito, diventando una figura di sintesi.
Inoltre dovrà dare una spinta sul territorio, vivacizzando la campagna di «Joe»,
finora rimasta un po' troppo coperta.
Come può competere, il pane, con le campagne d’odio?
Alessandro Maran, Consulente aziendale, appassionato di politica estera, su Il
Riformista il 13 Agosto 2020. Joe Biden ha scelto Kamala Harris come sua vice
nel ticket democratico che proverà a strappare la Casa Bianca a Donald Trump. Va
da sé che la riconferma o meno di Trump sarà, come ha scritto
giustamente Christian Rocca, «il momento decisivo della nostra epoca»: il 3
novembre sapremo, cioè, se l’esperimento nazionalista sovranista
populista continuerà a imperversare di qua e di là dell’Atlantico oppure se
finalmente saranno scattate le contromisure per ristabilire la normalità
democratica e contrastare lo sgretolarsi della società aperta. La democrazia, si
sa, di questi tempi non se la passa molto bene. Al contrario, i suoi rivali
politici globali sembrano prosperare e, soprattutto, sembrano in grado di
offrire una valida alternativa. Commentando allegramente poche settimane dopo
l’elezione di Donald Trump, Vladimir Putin ha celebrato «il degrado dell’idea di
democrazia nella società occidentale». Su Changhe, uno studioso cinese che ha
magnificato i successi del suo paese sotto il presidente a vita Xi Jinping, ha
rilevato con soddisfazione che «la democrazia occidentale sta già mostrando
segni di decadimento». Lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, sovrano di
Dubai e primo ministro degli Emirati Arabi Uniti, ha detto di sperare che il suo
governo sarà presto «più vicino al suo popolo, più veloce, migliore e più
reattivo» della democrazia occidentale; e poiché, a suo dire, la versione della
democrazia degli Emirati Arabi Uniti è profondamente radicata nella società
locale, secondo «Big Mo» (così viene chiamato in patria), quel sogno è già in
fase di realizzazione. In un saggio illuminante, «The New Dispotism», John
Keane sostiene in modo convincente che lo slancio e la forza attuali del «nuovo
dispotismo» (in Cina, in Ungheria, in Iran, in Russia, in Arabia Saudita, a
Singapore, negli Emirati Arabi Uniti e in molti altri paesi), testimoniano sia
la sua vitalità attuale, sia la sua capacità di durare nel tempo. A differenza
di quello vecchio, il «nuovo dispotismo» veste i panni della democrazia,
nutrendosi delle sue debolezze come un parassita; e quel che è più grave,
minaccia di fare breccia anche nelle democrazie di vecchia data, nelle quali il
declino politico festeggiato da Putin è più di una fantasia distorta e
auto-compiaciuta. Non è infatti un mistero per nessuno che in Italia, ad
esempio, come ha ricordato Francesco Cundari, «abbiamo lasciato che una società
privata specializzata nelle campagne di demonizzazione e disinformazione
riempisse le istituzioni di personaggi senza arte né parte, reclutati al solo
scopo di coprirle di fango». John Keane sfata il mito che i despoti governino
solo con la repressione. Certo, nel nuovo dispotismo la violenza non è scomparsa
del tutto, ma è molto più discreta e meditata, ed ha rimpiazzato l’intimidazione
e la sorveglianza con la seduzione. La forza del nuovo dispotismo deriva,
infatti, dall’uso sapiente dei media; un uso che va ben oltre l’abituale
diffusione di fake news e la calunnia degli oppositori. Insomma, malgrado le
elezioni si tengano regolarmente e i nuovi tiranni ostentino le procedure
elettorali come prova della loro legittimità popolare, essi seguitano ad
utilizzare una serie aggiornata di nuove (e vecchie) «arti oscure»: perseguitare
i candidati avversari, ridisegnare i confini dei collegi elettorali in modo da
favorire i propri candidati, «sbagliare» di conteggiare i risultati elettorali
scomodi, ecc. Quel che rimane è una «democrazia fantasma» che, secondo Keane,
potrebbe essere più longeva del totalitarismo stalinista o maoista del passato.
Mentre allora la sorveglianza di massa e le dure punizioni erano all’ordine del
giorno, i despoti di oggi tollerano il dissenso (fino ad un certo punto) e
traggono vantaggio dalla parvenza di democrazia, da una classe media
compiacente, attirata dalle entrate clientelari del capitalismo di Stato, e da
un falso sistema democratico di feedback che permette loro di misurare la
temperatura politica, anche se le elezioni non sono reali. Per i critici del
primo ministro indiano Narendra Modi, ad esempio, l’elenco delle sue malefatte
continua a crescere. Dopo una critica molto dura e severa della gestione del
Covid-19, Edmond Roy ha scritto su The Interpreter, il blog del Lowy Institute,
che «in effetti il governo di Modi si è sottratto ai propri doveri» nel
fronteggiare la pandemia. «Nel frattempo, ha cercato di mettere a tacere ogni
dissenso», intimidendo i media del paese per costringerli «a riportare la
versione ufficiale degli eventi». Ma il Covid-19 è solo uno dei punti dolenti.
La settimana scorsa, il primo ministro indiano ha posato la prima pietra della
costruzione di un nuovo tempio indù nell’antico sito di una moschea del XVI
secolo, nel posto in cui si crede sia nata la divinità indù Rama. L’Economist ha
definito il luogo «un tema perenne di campagna elettorale» per il partito di
Modi. Inoltre, in un saggio sul Guardian, la scrittrice indiana (e attivista
politica impegnata nel campo dei diritti umani e dell’ambiente) Arundhati Roy,
ha elencato pressoché tutti i peccati illiberali che, agli occhi dei suoi
oppositori, Modi ha commesso: la risposta alla pandemia, il nuovo tempio, la
repressione in Kashmir che è cominciata un anno fa proprio in questi giorni, gli
scontri di confine con la Cina, la nuova legge sulla cittadinanza che discrimina
i musulmani e le perduranti tensioni con il Pakistan. Nella bordata che ha
indirizzato contro la politica nazionalista indù di Modi, Roy scrive: «Soltanto
gli ingenui o gli indottrinati senza speranza possono ancora credere che la fame
e la disoccupazione possano condurre alla rivoluzione – che i templi e i
monumenti non possano nutrire il popolo. Lo possono fare. Il Ram Mandir (il
nuovo tempio) è cibo per milioni di anime indù affamate. L’ulteriore umiliazione
dei già umiliati musulmani e delle altre minoranze affina il sapore della
vittoria sulla lingua. Come può il pane competere?». Già. Vuoi mettere (in India
come dappertutto) una bella «campagna d’odio»?
Viviana Mazza per corriere.it il 20 agosto 2020. Steve Bannon,
«ideologo» della destra americana sovranista ed ex stratega della campagna
elettorale di Donald Trump, è stato fermato con l'accusa di frode. Bannon è
accusato dalla procura federale di New York in relazione a una raccolta di fondi
online a sostegno della costruzione del muro anti-migranti al confine con il
Messico. Con lui sono state arrestate altre tre persone. Gli altri sono Brian
Kolfage, veterano della guerra in Iraq, dove ha perso entrambe le gambe e il
braccio destro, Andrew Badolato e Timothy Shea. «We Build the Wall» era il nome
di un gruppo non-profit deciso a portare avanti la costruzione del Muro su
terreni privati al confine con il Messico, in cui Bannon figurava come
presidente del comitato consultivo. Hanno preso la situazione nelle proprie
mani vedendo i fondi per il Muro promesso da Donald Trump bloccati dai
democratici al Congresso. La campagna era arrivata a raccogliere 25 milioni di
dollari, donati da centinaia di migliaia di persone. Secondo la procura, Bannon
avrebbe trasferito almeno un milione di dollari ad un’altra società da cui
controllata, passandone centinaia di migliaia a Kolfage e trattenendo «una parte
sostanziosa» per se stesso, emettendo inoltre ricevute per nasconderne le
tracce.
Il rapporto con Trump. Bannon, 66 anni, è considerato uno degli
architetti della vittoriosa campagna di Trump per la Casa Bianca nel 2016. «Sono
un leninista. Lenin voleva distruggere lo Stato, io lo stesso — è una delle
frasi coniate in quella circostanza —. Voglio demolire l’‘establishment”
attuale». Trump, dopo la vittoria elettorale, lo aveva incluso nel suo staff.
Incluso inizialmente nel Consiglio sulla sicurezza nazionale, è stato rimosso da
questa carica nell'aprile del 2017, anche se lui ha sempre affermato di aver
deciso di andarsene.
La causa con lo Stato italiano. L'ideologo sovranista aveva
guardato con molto interesse proprio all'Italia e all'esperienza politica di
Matteo Salvini di cui è stato sostenitore. E proprio in Italia Bannon ha avviato
una delle sue più ambiziose esperienze politiche: l'apertura di una «accademia»,
di un centro studi dedicato alla nuova destra. La sede di questo progetto era
stata individuata nell'abbazia benedettina di Trisulti, nel Lazio; il ministero
dei Beni culturali aveva inizialmente concesso la struttura, salvo poi tornare
sui suoi passi. Tra l'associaszione di Bannon e il ministero è in corso una
causa; il Tar ha dato ragione a Bannon, ma la pubblica amministrazione ha fatto
ricorso al consiglio di Stato.
Valeria Robecco per “Il Giornale” il 22 agosto 2020. Per Steve
Bannon, finito in manette e accusato di frode per aver partecipato a «We Build
The Wall», raccolta fondi online a sostegno della costruzione del muro con il
Messico, l'inchiesta è «politicamente motivata». L'ideologo dell'alt-right ed ex
chief strategist di Donal Trump è comparso in video davanti a un giudice di New
York, poi è stato rilasciato dietro una cauzione da 5 milioni di dollari e
restrizioni ai viaggi (potrà muoversi fra New York e Washington, ma non gli sono
consentiti spostamenti internazionali o l'uso di voli o barche private). Gli
agenti federali lo hanno arrestato mentre si trovava al largo di Westbrook,
Connecticut, a bordo del Lady May, un super yacht di 45 metri (da 28 milioni di
dollari) di proprietà di Guo Wengui, dissidente cinese in esilio. Il miliardario
è una figura misteriosa e controversa: fuggito negli Usa nel 2014, ora è uno dei
most wanted del governo di Pechino, ricercato per frode, riciclaggio e altri
reati finanziari. Lui e Bannon hanno unito le forze negli ultimi anni come duri
critici del Partito Comunista Cinese, e recentemente hanno trascorso molto tempo
insieme sul Lady May. Dopo esser stato silurato dalla Casa Bianca, l'ex
direttore del sito ultra-conservatore Breitbart News ha lanciato con Guo la GTV
Media Group. Anche se l'incriminazione di Bannon non ha nulla a che vedere con
il dissidente, secondo il Wall Street Journal sarebbe in corso un'altra indagine
delle autorità federali e statali proprio sulla GTV. Dopo che la società ha
raccolto 300 milioni di dollari in un'offerta privata, almeno due banche (JP
Morgan Chase e Wells Fargo) hanno congelato i suoi conti, e sia l'Fbi che la
Securities and Exchange Commission hanno aperto delle indagini per verificare se
l'azienda o i soci di Guo violassero le leggi sui titoli attraverso il
collocamento di azioni private. La GTV Media - che come scrive il Wsj mira ad
essere «l'unico ponte non soggetto a censura e indipendente tra la Cina e il
mondo occidentale» - ha fatto sapere di essere pronta a collaborare con le
agenzie Usa che hanno domande in merito. Il sito Axios, intanto, ha riferito che
una società legata a Guo - la Guo Media - ha pagato a Bannon almeno un milione
di dollari per «servizi strategici di consulenza» tra il 2018 e il 2019: il
contratto prevedeva che Stephen presentasse Wengui a «personalità dei media». E
dopo il presidente Trump, anche il figlio Donald Jr ha preso le distanze dalla
campagna «We Build The Wall». «Don ha tenuto un discorso ad un singolo evento
del gruppo oltre un anno fa e non ha alcun coinvolgimento con la loro
organizzazione», ha spiegato la portavoce Amanda Miller. Precisando poi che
Trump jr «non ha mai concesso il permesso di venire citato come testimonial sul
loro sito web, e non sapeva di essere stato indicato come tale fino a quando i
media non hanno diffuso la notizia».
Viviana Mazza per il “Corriere della Sera” il 22 agosto 2020.
Alle 7,30 del mattino di giovedì scorso, Steve Bannon è stato arrestato in
Connecticut a bordo dello yacht di 45 metri del miliardario cinese Guo Wengui,
alias Miles Kwok. Le accuse contro Bannon, ex stratega di Trump: frode e
riciclaggio, in relazione a una raccolta fondi a sostegno della costruzione del
muro anti-migranti al confine con il Messico. Avrebbe intascato un milione di
dollari per spese personali, passando al socio Brian Kolfage, mutilato nella
guerra in Iraq, 350 mila dollari usati per la chirurgia plastica, un Suv, un
golf cart. Bannon si è dichiarato non colpevole: «Inchiesta politicamente
motivata». Rilasciato su cauzione, non può viaggiare in aereo (o yacht) senza il
permesso del giudice. Le accuse non riguardano il miliardario cinese. Ma la sua
amicizia con Bannon potrebbe in parte spiegare la disponibilità di contante che
permetteva all'«ideologo» della destra sovranista di volare tra l'America e
l'Europa da un hotel di lusso all'altro. Inoltre, secondo il Wall Street Journal
, è in corso un'altra indagine federale su un'azienda mediatica che ha legami
con Guo e Bannon: il GTV Media Group. Almeno un investitore si è rivolto alla
polizia, sostenendo di aver versato 500 mila dollari in cambio di azioni per il
lancio di una piattaforma di video-sharing: impegni non mantenuti. L'Fbi
starebbe indagando da un mese sulle attività di Guo, una figura misteriosa: vive
a New York dal 2015, ha chiesto asilo politico. Pechino vuole la sua
estradizione per frode e corruzione, ma lui dice che lo perseguitano perché
appoggiò le proteste di Tienanmen e da allora lotta per i diritti umani e la
democrazia. Solo che alcuni dissidenti non si fidano: lo definiscono una «spia
del Partito comunista», un «gangster» (e una ex dipendente lo accusa di stupro).
Guo nega. Però - notano ancora i critici - si è arricchito in Cina grazie
all'edilizia, settore in cui i buoni rapporti con il governo contano molto.
Bannon avrebbe incontrato il miliardario pochi mesi dopo la cacciata dalla Casa
Bianca nell'agosto 2017. In comune avevano la visione del Partito comunista
cinese come «nemico numero 1». Secondo il New York Times, Bannon ottenne un
prestito di 150 mila dollari per un film contro il Partito (mai realizzato),
seguito nel 2018 da un contratto da 1 milione di dollari con «Guo Media» per un
anno di «servizi strategici di consulenza» (Steve doveva presentargli
«personalità dei media»). Bannon ha sempre rifiutato di identificare i suoi
finanziatori. Ma è apparso con Guo, in video e podcast, realizzati sullo yacht o
nell'appartamento dell'amico con vista su Central Park. E ha volato sul jet
privato del miliardario cinese. Il sito NbcNews sostiene che possa aver violato
le norme che vietano il finanziamento straniero alle campagne elettorali, perché
Bannon andava a promuovere i candidati repubblicani al Congresso. Ma l'ex
stratega sostiene che pubblicizzava solo un suo film, intitolato «Trump@War».
Quel colpo inferto a Trump a pochi mesi dalle elezioni.
Francesco Boezi il 20 agosto 2020 su Inside Over. Il
provvedimento giudiziario disposto nei confronti di Steve Bannon dalla procura
di New York può influire sulle sorti del sovranismo politico. L’ex capo stratega
della Casa Bianca, nel corso di questi anni, è divenuto un simbolo della
corrente ideologica che privilegia lo Stato nazionale, dunque i confini e
l’economia interna. Non tutti i sovranisti si rifanno a Bannon, ma quest’ultimo
ha guardato con attenzione a tutti i movimenti sovranisti occidentali. Tanto da
aver anche pensato per un po’ di tempo alla costituzione di una “internazionale”
in grado di racchiudere tutte queste formazioni. Non se n’è fatto niente ma, dal
punto di vista mediatico, l’arresto di Bannon è un colpo che può essere
sfruttato per mettere in crisi l’intero panorama populista: molti attori del
sovranismo europeo, politicamente parlando, hanno avuto a che fare con l’ex
Chief strategist di Donald Trump. E l’Europa è solo il secondo dei teatri in cui
il “bannonismo” ha provato ad attecchire. L’arresto di Bannon per presunta
frode, soprattutto, arriva in un momento particolare per la politica americana:
alle elezioni americane mancano ormai tre mesi. Novanta giorni in cui il
presidente in carica, stando ai sondaggi, deve rimontare parecchio per
impensierire il rivale Joe Biden. Trump ha allontanato Bannon dalla Casa Bianca
nell’estate di tre anni fa, ma il leader di “The Movement” è associabile al
presidente degli States per essere stato uno degli artefici della vittoria del
2016. Bannon ha fatto parte della campagna elettorale in seconda battuta, ma si
è rivelato decisivo in termini contenutistici. Trump ha trionfato contro la
Clinton anche per via della propaganda sulla costruzione del muro al confine con
il Messico: un simbolo di come l’esponente Repubblicano avrebbe inteso gestire i
fenomeni migratori. Ecco, il fatto che Bannon – questo è il cuore delle accuse –
si sarebbe indebitamente appropriato di parte dei fondi di una raccolta
destinata proprio alla costruzione del muro non fa che favorire la narrazione
progressista. Quel muro è un simbolo del trumpismo. The Donald ha fatto di tutto
per farlo edificare prima del voto di novembre. Prescindendo dal risultato
pratico della costruzione, che può essere positivo o meno, quella barriera di
separazione è tornata così al centro del dibattito politico statunitense,
consentendo ai Democratici di attaccare il presidente pure sull’argomento
“Bannon”. Le tempistiche dell’arresto – quelle che insospettiscono i
complottisti – possono rivelarsi politicamente sensibili, e cioè in grado di
smuovere l’opinione pubblica dei moderati in direzione dell’anti-trumpismo. A
Trump, per essere riconfermato, serve il favour della “maggioranza silenziosa”.
In altre parole, al tycoon occorre che l’America moderata preferisca lui a
Biden. L’arresto di Bannon fa sì che si torni a parlare di un esponente legato
al “trumpismo” in passato e considerato estremista dalla stampa mainstream. In
questo senso, la notizia data qualche ora fa, può smuovere gli animi dei
moderati americani in direzione di Joe Biden. La propaganda progressista –
possiamo esserne certi – porrà molti accenti sul caso. Donald Trump ha insomma
un nuovo problema. E per quanto il presidente degli States abbia, almeno sino a
questo momento, dribblato i commenti, è lecito immaginare che presto il tycoon
venga travolto da un’altra bufera. Il presidente degli States, sempre nel caso
Bannon dovesse effettivamente essere riconosciuto colpevole di frode, potrebbe
comunque giustificarsi, affermando di averlo rimosso dal ruolo in cui era stato
incaricato nella Casa Bianca in tempi non sospetti. Ma potrebbe non bastare: per
un lungo periodo di tempo, Bannon è stato considerato l’ideologo del trumpismo.
L’uomo che aveva risvegliato l’America profonda, contrastando le contraddizioni
della dinastia Clinton e di quella Obama. Nei suoi discorsi, Trump sembra essere
consapevole del numero degli attacchi che sarà costretto a subire da qui
all’appuntamento elettorale: nel 2016, il candidato dei Repubblicani ha
sfruttato la polarizzazione ideologica e il fatto che i media, nel bene e nel
male, non facessero che parlare di lui. Vedremo se questi elementi si
ripresenteranno anche nel corso di questi tre mesi che ci separano dalle
presidenziali.
Flavia Perina per “la Stampa” il 21 agosto 2020. Lo zio d'America
del sovranismo, dunque, era probabilmente un magliaro d'oltreoceano. Uno venuto
a rovesciare la vecchia gag di Totò Truffa che vende la Fontana di Trevi al
turista yankee, anche se Steve Bannon è sbarcato in Italia per smerciare un
prodotto assai più immateriale: le capacità da stratega che - giurava - avevano
portato Donald Trump alla Casa Bianca e altrettanto potevano fare per i suoi
emuli italiani, Matteo Salvini e Gorgia Meloni tra tutti. Ci credettero
entrambi, e mica solo loro. Anche una parte significativa della fazione
ecclesiastica ostile a Papa Bergoglio abboccò all'amo di quel giornalista
spettinato, inventore della Alt Right, supremo manipolatore del consenso
attraverso l'intermediazione dati, guru di Cambridge Analytica, maestro di
complottismo e di scenari apocalittici. Bannon arrivò in Italia nel marzo 2018,
subito dopo aver perso il suo posto di Chief Strategist a Washington. Prima si
era fatto un giro a Zurigo, per incontrare i leader dell'ultradestra di AfD, poi
sarebbe volato a Parigi, dove lo aspettava il congresso del Front National.
Parlò con Matteo Salvini in un incontro riservato a Milano. Avviò contatti con
Fratelli d'Italia e ottenne un appuntamento anche con Luigi Di Maio. La merce
che metteva all'asta fu pubblicamente esposta qualche mese dopo, in settembre,
alla festa romana di FdI. Se negli Usa aveva monetizzato il sogno di un muro per
blindare il Paese, costruito con le donazioni dei cittadini decisi a proteggersi
dall'immigrazione, da noi spacciò la profezia millenarista di un'imminente fine
della civiltà, di una nuova crisi economica planetaria alle porte architettata
dal «Partito di Davos» che avrebbe portato (testuale) «alla fine della razza
umana». Brividi in platea. Applausi. Si era alla vigilia delle elezioni europee.
In quel momento, l'unico rischio concreto per il Vecchio Continente era la
guerra dei dazi aperta da Trump, e tuttavia a nessuno venne il dubbio che Bannon
stesse vendendo fumo. Nessuno notò la contraddizione in termini di un'idea
sovranista che si lascia suggestionare dal Gran Mogol di un sovranismo
straniero. Il racconto di Steve forniva un arsenale potente e persino sexy al
nostro partito della paura: un misterioso e potentissimo nemico, lo spavento di
altri cosacchi pronti ad abbeverarsi nelle fontane di San Pietro, la necessità
di armarsi per una definitiva guerra del Bene contro il Male. Fu sorprendente
vedere la rapidità con cui il mondo del sovranismo si innamorò di quel
predicatore a stelle e strisce e ne adottò i suggerimenti. Lui ricambiò
incoronando Salvini come «la figura politica più importante sulla scena mondiale
insieme a Jair Bolsonaro», Meloni come titolare di una «rivoluzione» e tutti e
due come leader paragonabili a Trump. Insomma, la merce fu comprata anche se non
è chiaro il prezzo. Non si è mai saputo, ad esempio, quale sia stato il partito
italiano abbonato ai servizi di profilazione social di Cambridge Analytica, nè
si è mai capito con esattezza con quali risorse, appoggi, facilitazioni Bannon
abbia tirato su il suo network euroscettico The Movement, l'associazione che
avrebbe dovuto demolire l'Unione portando ovunque i sovranisti al potere.
Misteriose anche le vie che gli hanno consentito di aggiudicarsi per un
ventennio la Certosa di Trivulzi, allo scopo di farne il cuore pulsante dei suoi
nuovi Crociati (operazione poi fallita per un ripensamento dei Beni Culturali).
Il dubbio che Bannon avesse rifilato agli italiani una solenne fregatura è
piuttosto recente. Non uno degli apocalittici scenari con cui abbindolò i suoi
referenti e fan si è realizzato. I suggerimenti al «Patriota Salvini» all'epoca
della crisi del Conte I («Sarà ancora più potente se andrà all'opposizione di
quanto non è al governo») si sono rivelati avvelenati. Meloni non ha ottenuto le
entrature di livello che sperava con l'amministrazione Usa. La fronda
anti-Bergoglio è stata sconfitta. L'europeismo ha recuperato terreno con
l'illuminata reazione all'emergenza Covid. L'idea di fare dell'Italia
l'epicentro di un terremoto politico continentale è svanita insieme alle
relazioni con gli altri nazionalismi europei, da Marine Le Pen a Viktor Orban,
peraltro assai cauti nell'offrire sponde al bannonismo. Resta da domandarsi
perché proprio qui, in Italia, il Paese della scaltrezza politica e del sospetto
permanente, l'ex-pifferaio magico di Trump sia riuscito a vendere la sua Fontana
di Trevi senza troppi sforzi: ingannare gli americani promettendo un muro lungo
tremila chilometri è un conto, spacciare a noi (a qualcuno di noi) il miraggio
di annientare l'Europa e defenestrare il Papa avrebbe dovuto risultare più
difficile.
Andrea Tagliaferri per “il Messaggero” il 21 agosto 2020. Steve
Bannon, ex stratega del presidente americano Donald Trump e ideologo dei
sovranisti ultracattolici internazionali, è stato arrestato con l'accusa di
frode negli Usa. E subito, dalla Ciociaria, si alza in sua difesa la voce del
suo fedelissimo pupillo, Benjamin Harnwell, gestore della duecentesca Certosa di
Trisulti. «La notizia mi ha colto di sorpresa - commenta a caldo - ma,
conoscendo molto bene Steve, sono sicuro che tutte le accuse, amplificata dalla
stampa, ben presto cadranno. L'imputazione di frode, che oggi gli viene rivolta,
è puramente fantasiosa. D'altronde è bene ricordare che un uomo va sempre
ritenuto innocente fino a quando non sarà dimostrato il contrario». La notizia
dell'arresto subito si è diffusa in provincia di Frosinone dove Bannon è stato
di recente protagonista di un'operazione che ha visto nella Certosa di Trisulti
il punto focale di una strategia politico-religiosa molto ambiziosa. E' qui,
infatti, che il movimento ultraconservatore Dignitatis Humanae Institute, legato
ai Teocon americani e finanziato proprio da Bannon, ha intenzione di fondare la
sua prima scuola politica europea di sovranismo. Un mix di pensiero politico e
religioso al quale si è ben presto opposto, dapprima la comunità locale
frusinate con manifestazioni e cortei delle associazioni schierate per il
contrasto al progetto ultraconservatore; poi il Ministero per i Beni e le
Attività Culturali che, in realtà, è stato coprotagonista dell'intera vicenda,
sottovalutando (all'inizio) la portata del progetto. Nel 2016, infatti, il
Mibact guidato dall'allora ministro Franceschini, emise un bando per dare in
gestione a privati alcuni beni artistici e monumentali dello Stato, mediante lo
strumento della concessione. Nel giugno del 2017 la procedura si concluse con
l'atto del Segretario Generale che decretò il Dignitatis Humanae Institute (DHI)
concessionario per 19 anni: in pratica, oltre a versare 100 mila euro all'anno
al ministero, il DHI deve provvedere anche alla manutenzione della struttura. Ma
da allora le associazioni del territorio, hanno cominciato una dura opposizione
marciando diverse volte verso la Certosa, raccogliendo migliaia di firme per
avviare una dura battaglia legale. In un primo momento sembrava che la guerra
fosse stata vinta proprio dalle associazioni, in quanto l'Avvocatura dello Stato
fece degli approfondimenti sui requisiti richiesti per poter rispondere al
bando. Ed emerse che alcuni erano carenti, quali la comprovata esperienza nella
gestione di un bene artistico. Tesi, queste, sempre respinte dal concessionario
che, nel frattempo si era insediato a Collepardo sotto l'occhio vigile del
Presidente della fondazione, Benjamin Harnwell, appunto. Nel maggio del 2019,
però, il Ministero, guidato da Alberto Bonisoli, su indicazioni degli avvocati
dello Stato, decise di annullare la concessione, anche se, per una coincidenza
molto particolare, fu proprio Dario Franceschini, ad ottobre dello stesso anno,
a portare a compimento l'iter per l'annullamento della concessione che proprio
lui aveva firmato un anno e mezzo prima. Ma a questa decisione del Mibact il
Dignitatis Humanae Institute, nel frattempo visitato più volte da Bannon stesso,
ha fatto subito opposizione dinnanzi al Tar del Lazio che si è espresso, proprio
a suo favore, assegnando di diritto la gestione del gioiello cistercense al DHI.
Ad oggi si attende che il Ministero, supportato da tutte le associazioni locali
e non, faccia ricorso al Consiglio di Stato, come annunciato dallo stesso
ministro Franceschini all'indomani della sentenza dei giudici amministrativi nel
maggio scorso. Dunque, ieri, Benjamin Harnwell, saputo dell'arresto del proprio
mentore, è subito sceso in sua difesa a spada tratta. «Conosco quest' uomo da
tempo - ha commentato il presidente del DHI-. E la possibilità che abbia
commesso una frode per me è è totalmente impensabile. Ritengo con certezza
assoluta che è innocente. Devo aggiungere - rincara Harnwell- che io stesso, da
persona che ha sofferto molto per le tante accuse di mendacità ricevute da più
parti (e per le quali sono stato sempre assolto) ho preso atto che troppo spesso
le notizie che si leggono sulla stampa non corrispondono, poi, alla realtà.
D'altronde mi preme sottolineare che è segno di civiltà ricordare che un uomo va
sempre considerato innocente, fino a prova contraria». Per la cronaca, va infine
precisato che sia la Procura di Roma che la Corte dei Conti hanno aperto due
inchieste sull'assegnazione dell'abbazia alla DHI.
Viviana Mazza per il “Corriere della Sera” il 21 agosto 2020.
Prima delle elezioni del 2016, quand'era direttore esecutivo del sito della
destra xenofoba Breitbart, Steve Bannon fu definito «l'operatore politico più
pericoloso d'America». Aveva più volte cambiato pelle: sette anni in Marina, un
Mba ad Harvard, banchiere di Goldman Sachs, produttore di Hollywood. Donald
Trump lo mise a capo della sua campagna elettorale, ed è considerato l'artefice
del messaggio populista, anti-immigrazione e di protezionismo economico che ha
portato alla vittoria l'attuale presidente degli Stati Uniti. Lo show Saturday
Night Live lo rappresentò come il diavolo, discreto e onnipresente sulla spalla
di Trump. Lui non faceva mistero di adorare il soprannome. Nel 2017 Bannon
diventò uno stretto consigliere del presidente, fu incluso persino nel Consiglio
di sicurezza nazionale, ma i coltelli dei suoi nemici a Palazzo (tra cui Ivanka
Trump e il marito Jared Kushner) erano affilati. Contro di lui giocava pure il
fatto che a Trump non è mai piaciuto che gli rubasse la scena e fosse
considerato il «cervello» dell'Amministrazione. Nell'agosto 2017 Bannon fu
defenestrato, ma lui l'ha sempre definita «una decisione consensuale». Dalla sua
casa a Washington, alle spalle della Corte suprema, seduto al tavolo da pranzo
tra cimeli della Guerra Civile, pile di Financial Times , libri sul Partito
comunista cinese (il nemico) e una lista di cibi leciti sulla porta del frigo
(la dieta), non ha smesso di fare progetti grandiosi. Tre mesi fa ci aveva
preannunciato che presto ne avrebbe lanciato uno sulla Cina. Nel marzo 2018,
alla vigilia delle elezioni italiane, nell'attico dell'Hotel Raphael a Roma
(quello dove Craxi fu contestato sotto una pioggia di monetine per
Tangentopoli), davanti ad una tavolata di dolci per nulla toccati, Bannon
profetizzò le nozze tra Lega e Cinque Stelle, salvo poi un anno dopo benedirne
il divorzio. In Italia voleva aprire una scuola di populismo nel monastero di
Trisulti, ispirato da quella di Armando Siri. Soprattutto pensava alle elezioni
europee del 2019. «Sarà un anno straordinario per i populisti», diceva. Il suo
progetto era Il Movimento, una fondazione per connettere i sovranisti europei (e
non solo). Si definiva uno «street fighter», a contatto con la «base», a favore
di Trump. Ma le distanze erano cresciute, a causa delle rivelazioni ai
giornalisti, in particolare a Michael Wolff, che lo ha definito il suo Virgilio.
Bannon ha aperto la porta ai reporter, inclusa la regista di «The Brink» che lo
seguì nella sua «campagna per l'Europa», di capitale in capitale e da un hotel
di lusso all'altro, documentando il fallimento nel costruire un'Internazionale
populista. «Trump mi ha insegnato che non esiste la cattiva stampa - diceva -. I
media sono ossessionati da noi e sono il nostro più grande alleato». Nel Natale
2018 dopo un'intervista nella sua casa a Washington, Bannon ci fece strada nel
seminterrato (la chiamava ancora Breitbart Embassy, anche se i finanziatori,
sostenitori di Trump, non lo hanno ri-voluto al sito). Ci presentò Brian
Kolfage, veterano di guerra in sedia a rotelle, ora accusato di frode insieme a
lui. Kolfage aveva appena lanciato un sito di crowdfunding per raccogliere i
soldi e costruire «privatamente» il Muro al confine col Messico. Nell'agosto
del 2019, nel deserto dove il Messico diventa New Mexico, in un luogo dal nome
allegro, Sunland Park (ma adatto a girare un remake di Mad Max ) Bannon ci
disse: «Questa è la mia Masada». Avanzava in scarponi militari, pantaloni cargo
e camicia nera verso la vetta su cui sventolava una bandiera a stelle e strisce,
mentre centocinquanta attivisti con i cappelli «Make America Great Again» si
erano radunati all'ombra del chilometro di Muro appena costruito da «We Build
the Wall». Si definivano «le forze speciali» di Trump. Ora il presidente afferma
di non sapere nulla del progetto. Eppure nel 2019 il politico Kris Kobach,
membro dell'advisory board, disse al New York Times di aver ricevuto, per
telefono, l'appoggio di Donald. A Sunland, dove i bambini gestivano la raccolta
fondi, fece una donazione anche Don Jr, il figlio del presidente. Arrivò con la
fidanzata. La folla gridò più volte, con calore:«2024», anno in cui sperano di
vederlo succedere al padre alla Casa Bianca.
Arrestato Steve Bannon. Così sostenne il governo gialloverde.
Il Corriere del Giorno il 20 Agosto 2020. Un
osservatore esterno, come amava definirsi, ma anche qualcosa di più visto che
non ha mai nascosto di aver caldeggiato a Matteo Salvini un accordo con l’allora
capo politico del Movimento Luigi Di Maio. Bannon vide nel governo gialloverde
la realizzazione di un progetto politico a cui lavorava da tempo. E lui, teorico
dell’ ‘alt-right’ americana, la destra alternativa, cominciò a spendere molto
tempo in Italia, avamposto della rivoluzione populista in Europa. Nelle
settimane successive alla nascita del governo gialloverde Steve Bannon era un
fiume in piena: “Roma oramai è il centro della politica mondiale. Quello che sta
accadendo qui è straordinario. Non c’è mai stato in tempi moderni un vero
governo populista. Ora c’è”. Pochi come l’ex stratega di Donald Trump, arrestato
oggi negli Usa con l’accusa di appropriazione indebita, manifestarono con tanta
energia il proprio entusiasmo per l’accordo politico che fece nascere il primo
governo Conte. Un osservatore esterno, come amava definirsi, ma anche qualcosa
di più visto che non ha mai nascosto di aver caldeggiato a Matteo Salvini un
accordo con l’allora capo politico del Movimento Luigi Di Maio. Che qualcosa in
Italia stesse cambiando Bannon lo respirava nell’aria. A poche ore dall’apertura
delle urne, il 4 marzo 2018, fu intercettato per le strade di Roma: “Passerò
molto tempo in Europa. Qui c’è l’avanguardia del populismo. Sento il clima che
portò all’avvento di Trump. Quest’elezione è cruciale per il movimento populista
globale“. Bannon vide nel governo gialloverde la realizzazione di un progetto
politico a cui lavorava da tempo. E lui, teorico dell’ ‘alt-right’ americana, la
destra alternativa, cominciò a spendere molto tempo in Italia, avamposto della
rivoluzione populista in Europa. Aumentarono le sue interviste, i suoi
interventi a conferenze e manifestazioni di partito: “Il mondo intero sta
guardando all’Italia. è arrivato il momento di celebrare questo grande
cambiamento“. Bannon ha sempre manifestato apertamente il suo apprezzamento per
leader dei due partiti che hanno sostenuto il primo governo Conte: “Salvini e Di
Maio sono bravissimi. Il popolo italiano ha dimostrato di volersi riprendere in
mano il proprio destino. Il voto ha dimostrato che le persone sono stanche
dell’establishment. E l’èlite ha gettato la maschera per mostrare il suo vero
volto”. L’èlite, il suo principale nemico: l’establishment, o "il partito del
diavolo" come era solito definirlo. Quello che a suo avviso dall’Europa stava
dando battaglia al governo gialloverde in Italia e che vedeva in Emmanuel Macron
il suo esponente principale. Un partito che per Bannon aveva le ore contate,
schiacciato dal vento dell’antipolitica: “Gli esponenti del M5s non hanno una
formazione politica”, aveva detto intervistato a Roma dalla Cnn. “Il
leader, Luigi di Maio, è un ex cameriere mentre il sindaco di Roma, una donna,
giovane, penso sia una ex segretaria“, riferendosi a Virginia Raggi, ma
ignorando la sua laurea in Legge. In quel periodo l’unica amarezza dalla
politica romana per Bannon venne dal mancato coinvolgimento di Fratelli
d’Italia nel governo Lega-M5s. “L’Italia ora è il centro dell’universo della
politica“. disse ed aggiunse ancora: “Sono venuto qui per dirvi che non siete
soli. La Brexit, l’elezione di Trump e quello per cui avete votato a marzo 2018…
è tutto collegato“. Da qui il motivo di scegliere l’Italia come patria politica
d’adozione: “L’Italia è il centro dell’universo della politica”. Poi un appello
ai ‘patrioti’ italiani: “Alzatevi e combattete il partito di Davos”. Il
palcoscenico italiano gli servi’ per il lancio di ‘The Movement‘, la sua
creatura politica, una coalizione transnazionale di sovranisti. Non solo
l’Italia. Qualche soddisfazione Bannon l’ha avuta anche dai suoi legami con
altri Paesi. La vera delusione però arrivò con la crisi di governo aperta da
Salvini ad agosto 2018. Eppure la fiducia nel leader leghista non venne a
mancare: “Ha commesso un paio di errori ma nei prossimi sei mesi farà un grande
ritorno”, profetizzava lo scorso giugno. L’Italia sarebbe rimasta comunque al
centro del suo laboratorio politico. Anche perché è in Italia che Bannon ha
progettato la sua scuola internazionale dei sovranisti: la Certosa di Trisulti,
nel comune di Collepardo, Frosinone. Qui doveva nascere la sua accademia del
nazionalismo tramite la sua associazione Dignitatis Humanae Institute. Ma il
progetto non è mai decollato, frenato anche dalla richiesta di revoca della
concessione da parte del Governo. Nel dicembre 2019 il Tar ha bloccato lo
sfratto della scuola sovranista. Partita che ora rischia di ingarbugliarsi
ulteriormente con i guai legali della mente della destra alternativa
americana. Secondo le imputazioni contenute nell’incriminazione depositata
presso la Corte federale di Manhattan, Bannon, uno dei principali esponenti
dell’alt-right, o “destra alternativa”, e i tre soci Brian Kolfage, Andrew
Badolato e Timothy Shea, “hanno escogitato una truffa ai danni di centinaia di
migliaia di donatori” in relazione alla campagna di crowdfunding che ha
raccolto oltre 25 milioni di dollari. Sul sito del Dipartimento di Giustizia
Usa si legge: “Kolfage, 38 anni, di Miramar Beach, Florida, Bannon, 66 anni, di
Washington, D.C., Badolato, 56 anni, di Sarasota, Florida, e Shea, 49 anni, di
Castle Rock, Colorado, sono accusati dei reati di frode e associazione a
delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro, ciascuno dei quali comporta una
pena massima di 20 anni di carcere. Le pene massime previste dalla legge sono
prescritte dal Congresso e sono qui fornite solo a scopo informativo, poiché
qualsiasi condanna degli imputati sarà determinata dal giudice“. “Non solo hanno
mentito ai donatori, hanno tramato per nascondere la loro appropriazione
indebita di fondi creando fatture e conti fittizi per riciclare donazioni e
coprire i loro crimini, senza mostrare alcun rispetto per la legge o la verità”,
ha sottolineato Philip Bartlett, a capo della divisione che ha lavorato
all’indagine. “We Build the Wall” era stata lanciata come campagna GoFundMe alla
fine del 2018, con l’obiettivo di raccogliere direttamente dal pubblico il
denaro necessario per costruire un muro anti migranti alla frontiera del
Messico, malgrado l’opposizione del Congresso a quella che era una delle maggior
promesse elettorali del presidente americano Donald Trump. Brian Kolfage, Il
veterano dell’Air Force, aveva dichiarato di essersi impegnato gratuitamente per
la causa e che il 100% dei fondi raccolti sarebbero serviti a costruire il muro.
In realtà avrebbe utilizzato a fini personali oltre 350mila dollari. A sua
volta Steve Bannon si è appropriato di più di un milione di dollari tramite una
organizzazione no profit da lui controllata. Secondo l’atto d’accusa del Gran
Giurì, Kolfage avrebbe utilizzato il danaro per ristrutturare la sua casa, per
pagare una barca, un Suv, una golf cart, gioielli, chirurgia estetica, pagamento
di tasse e delle spese della carta di credito. Bannon e gli altri imputati,
hanno usato i fondi per viaggi, alberghi, carte di credito, in ogni caso nulla
che avesse a che fare con la costruzione del Muro, e poi verso un società
fantasma, grazie a fatture false. Steve Bannon, 66 anni, ad agosto 2017 fu
sollevato dall’incarico di capo stratega alla Casa Bianca . Dopo essere tornato
a dirigere Breitbart News, lasciò nel 2018 dopo l’uscita del libro “Fire and
fury” in cui lui criticava Ivanka Trump e suo marito Jared Kushner. Ad
oggi, Bannon sostiene molti movimenti di destra e populisti europei come
il Rassemblement National francese, il Partito per la Libertà olandese,
l’Alternativa per la Germania, ed in Italia la Lega di Matteo Salvini. La
procuratrice di New York Audrey Strauss “ha elogiato l’eccezionale lavoro
investigativo dell’USPIS degli agenti speciali dell’ufficio del procuratore
degli Stati Uniti e per l’assistenza, l’ufficio della procura del distretto
settentrionale della Florida”.
Maria Antonietta Calabrò per huffingtonpost.it il 21 agosto 2020.
Le accuse contro l’ex stratega del Presidente Donald Trump, Steve Bannon e altri
tre coimputati di associazione per commettere una frode di centinaia di migliaia
di dollari ai danni di cittadini americani che avevano fatto donazioni in favore
della campagna “We build The Wall” ( per costruire il muro antimigranti al
confine con il Messico) sono contenute in un documento di 24 pagine della Corte
del Distretto Sud di New York, firmato da Audrey Strauss, acting US attorney.
Uno dei protagonisti dell’elezione di Donald Trump nel 2016 è stato arrestato e
subito il presidente si è sfilato da ogni coinvolgimento, dichiarando di non
aver più avuto nulla a che fare con Steve Bannon dai primi giorni del suo
insediamento alla Casa Bianca: ”È una cosa molto triste per Bannon, non ho a che
fare con lui da molto tempo. Non so nulla del progetto” ha detto rispondendo a
una domanda, sottolineando come il progetto non gli piacesse: “Ho pensato fosse
stato fatto per mettersi in mostra”. Il Grand Jury ha accusato Bannon , Brian
Kolfage, Andrew Badolato e Timothy Shea di aver utilizzato per spese personali
che non avevano niente a che fare con lo scopo della raccolta fondi per il Muro,
nonostante avessero pubblicamente affermato di organizzare la raccolta su base
volontaria e senza distogliere un solo penny dei soldi raccolti dallo scopo di
costruire il Muro. In particolare Kolfage ha preso per uso personale in modo
coperto più di 350 mila dollari, mentre Bannon, attraverso una sua
organizzazione non profit (Non profit 1) e una compagnia ombra, ha ricevuto un
milione di dollari da “We build the Wall”, per pagare Kolfage e per “coprire
centinaia di migliaia di dollari di spese personali dello stesso Bannon. Per
fare questo hanno utilizzato false fatturazioni per assicurarsi, come ha scritto
Kolfage in un messaggio a Badolato che i pagamenti rimanessero confidenziali.
DAL 17 DICEMBRE 2018 ALLA FINE DI GENNAIO 2019. La campagna di
raccolta fondi per la costruzione del Muro partì su iniziativa di Kolfage il 17
dicembre 2018 e fu un tale successo che nel corso della prima settimana raccolse
su un apposito sito web 17 milioni di dollari da donare al governo federale di
Trump per finanziare il Muro. Ma poi nacquero dubbi sul background di Kolfage e
sulla possibilità di trasferire i fondi al governo federale. A fine dicembre, la
raccolta (che aveva raggiunto i 20 milioni di dollari) fu sospesa in attesa di
trovare un modo legittimo per raggiungere lo scopo, in quelle stesse settimane
furono coinvolti nell’iniziativa, Bannon e gli altri due imputati, venne creata
una nuova organizzazione (We build the wall Inc ) cui vennero trasferiti tutti i
fondi raccolti che avrebbero dovuto a questo punto finanziare un Muro privato
per chiudere il confine meridionale degli Stati Uniti. A cominciare dal gennaio
2019, secondo le accuse, Bannon e gli altri attraverso il website continuavano a
indurre in errore i sottoscrittori, mentre si appropriavano di centinaia di
migliaia di dollari per uso personale , nonostante pubblicamente, con
dichiarazioni ed interviste i donatori venivano rassicurati che il 100 per cento
dei soldi raccolti sarebbero serviti per costruire il Muro.
DA GENNAIO AD OTTOBRE 2019. Convinti dalla “ falsa narrativa” che
tutti i nuovi soldi donati alla nuova società (We bill the wall Inc) o
trasferiti ad essa con opzione dei vecchi donatori, sarebbero serviti per
costruire un Muro “privato” al confine con il Messico, fino all’ottobre 2019, la
nuova società gestita da Bannin e dagli altri coimputati raggiunse la cifra di
25 milioni di dollari di donazioni. Secondo l’atto d’accusa del Gran Giurì,
Kolfage avrebbe utilizzato il danaro per ristrutturare la sua casa, per pagare
una barca, un Suv, una golf cart, gioielli, chirurgia estetica, pagamento di
tasse e delle spese della carta di credito.
Bannon e gli altri imputati, hanno usato i fondi per viaggi,
alberghi, carte di credito, in ogni caso nulla che avesse a che fare con la
costruzione del Muro.
Estratto dell’articolo di Flavio Pompetti per “il Messaggero” il
21 agosto 2020. (…) L'arresto è stato eseguito su uno yacht che navigava al
largo della costa del Connecticut, e il politico-finanziere è stato tradotto in
carcere a New York. Dalla cella si è collegato in video con il tribunale, una
grande maschera bianca gli copriva gran parte del viso, e si è proclamato
innocente. Il giudice in serata gli ha concesso la libertà su una cauzione di
cinque milioni di dollari, garantiti da Bannon da beni per un valore di 1,75
milioni. L'accusa è partita dall'ufficio centrale della procura federale a New
York, con la firma della giudice Audrey Strauss che lo dirige ad interim, dopo
lo spettacolare licenziamento lo scorso giugno dell'ex capo Geoffrey Berman.
Bannon e tre suoi soci in affari operavano un sito web di foundraising dal nome
Build the Wall (costruiamo il muro) per raccogliere donazioni private da
destinare alla costruzione di una porzione del muro al confine con il Messico, e
aiutare così il presidente ad aggirare i problemi di finanziamento pubblico che
stanno attardando la costruzione. Immediata la presa di distanza di Donald
Trump: «Non ne so nulla, e per quel poco che ne sapevo, l'idea non mi è mai
piaciuta ha detto il presidente quando ha appreso degli arresti - Questo è un
progetto pubblico, non un'iniziativa privata». «Ogni centesimo donato sarà speso
per la realizzazione del progetto, e nemmeno un dollaro sarà pagato alle persone
che lavorano a questa idea» prometteva sul sito l'uomo di facciata: Brian
Kolfage, veterano della guerra in Iraq dove ha perso entrambe le gambe e un
braccio, e medaglia al valor militare. In realtà almeno 350.000 dollari del
fondo che aspirava a raggiungere un tetto di 25 milioni sono finiti nelle sue
tasche, mentre Bannon ha beneficiato di almeno un milione di dollari, spesi non
per la causa, ma per sostenere un ricco stile di vita. La giudice Strauss è in
possesso della trascrizione di una comunicazione privata tra i tre complici,
nella quale si raccomanda il massimo riserbo nel divulgare il meccanismo che
permetteva di stornare i fondi a favore dei responsabili dell'iniziativa. E'
stato Bannon ad agevolare il passaggio, e far transitare sul conto di una sua
società non profit le somme di denaro in cambio di fatture falsificate. Le
vittime del raggiro sono decine di migliaia di piccoli risparmiatori, convinti
dell'assoluta necessità di costruire il muro con il quale Trump vuole respingere
gli immigranti clandestini alla frontiera con il Messico Il profilo dei complici
la dice lunga sul declino delle fortune dell'uomo che sembrava il più potente
negli Usa dopo il presidente, solo tre anni e mezzo fa. Kolfage ha alle spalle
la fondazione di diversi pagine web ultra conservatori sui quali circolavano
teorie cospirazioniste, poi chiusi da Facebook che le ospitava. Lo scorso marzo
l'ex marine è stato scoperto nell'atto di ammassare maschere sanitarie N-95, nel
momento in cui gli ospedali faticavano a procurarsele. Un altro associato nel
crimine è Andrew Badolato, amico di lunga data di Bannon, e sospettato insieme a
lui di diverse frodi finanziarie per le quali i due non sono mai stati
incriminati. L'astro di Bannon ha subito un tracollo dal momento in cui la sua
strada alla Casa Bianca ha incrociato quella del genero di Trump. Jared Kushner
non ha mai visto di buon grado Bannon, e finì per ottenerne il licenziamento tre
anni fa. Il consulente ebbe una reazione di stizza e pronunciò parole dure
contro il suo ex capo: «L'amministrazione Trump è inefficiente e corrotta». Poi
si trasferì in Europa, nel tentativo fallimentare di fondare in Italia
un'accademia per la formazione di leader conservatori. Negli ultimi mesi era
tornato negli Usa e aveva ripreso a corteggiare Trump dal microfono di una radio
privata, con la speranza essere di nuovo chiamato a collaborare per il voto di
novembre.
Steve Bannon, il santone anti-Bergoglio regista della sommossa
sovranista. Fabrizio Mastrofini su Il Riformista il 25
Agosto 2020. «Bannon, il prototipo dei falsi leader religiosi di una fede che
però esiste davvero. Negli ultimi anni è cresciuta un’ala del mondo cristiano
che, pressata da una secolarizzazione iper-aggressiva, ha arroccato le sue
posizioni su una versione della religione identitaria e oppositiva alla
democrazia occidentale». Così ha titolato Il Foglio, con un’ampia analisi
di Maurizio Crippa. Interessante certo. Però parziale. Nell’arresto per frode
(reato gravissimo negli Usa, molto meno da noi…) – e poi rilascio su cauzione
milionaria – arrivano al «dunque» diversi aspetti. Il primo e più importante
manca nelle analisi nostrane: gli interessi economici e gli intrecci
politico-finanziari. Il fenomeno Bannon non nasce dal nulla, come è evidente. È
piuttosto la saldatura di un groviglio di interessi economico-finanziari
prestati e utilizzati dalla politica. Gli stessi che hanno portato quattro anni
fa all’elezione di Trump, all’emergere di un populismo/sovranismo accesi
esportati in Europa. Dall’altra parte abbiamo visto crescere i tentativi di far
comprendere ai poteri forti (finanziari) che lo sfruttamento indiscriminato
delle risorse (vedi petrolio?) e la povertà di miliardi di persone, gettano
tutto il pianeta in una corsa rapida alla distruzione. E chi è il capofila della
denuncia? Papa Francesco fin dall’inizio del pontificato e soprattutto con
l’enciclica «francescana» Laudato Si’ del 2015 in cui mette in luce due aspetti:
la cura della creazione deve venire considerata una priorità assoluta; e,
secondo, «tutto è connesso»: il benessere di pochi è fondato sullo sfruttamento
di molti; la natura e l’ambiente non sono a disposizione in maniera assoluta e
per sempre ma vanno protetti e tutelati per dare un futuro alle generazioni dopo
la nostra ed al pianeta. Il documento in modo particolare e tutto il magistero
di Papa Francesco – sui popoli fautori del proprio destino, sulla libertà, su un
Vangelo da vivere e non da predicare, contro i «perbenismi» e le ipocrisie
ecclesiali, perfino la sua decisa azione di contrasto alla pedofilia – vengono
ribaltati da questi settori economico-finanziari che non desiderano una Chiesa
coscienza critica del pianeta. E lo scontro si è acceso assoldando ampi settori
conservatori della Chiesa negli Usa, a maggior ragione da quando sta crescendo
il sostegno alle posizioni del Papa. Se ci pensiamo bene, uno scontro simile era
già accaduto e guarda caso proprio nell’America Latina da cui proviene
Bergoglio. Il riferimento è al dopo 1968, cioè gli anni immediatamente
successivi alla conferenza dei vescovi latinoamericani che si svolse a Medellin,
in Colombia, aprendo alla teologia della liberazione e alla «opzione
preferenziale per i poveri». L’impegno della Chiesa cattolica per la giustizia
sociale allarmava i padroni del «cortile di casa», cioè la politica statunitense
che sosteneva in chiave anti comunista i regimi militari di allora. Per
scoraggiare l’impegno della Chiesa i settori conservatori finanziarono
massicciamente l’ingresso delle sétte «evangelical», quei settori del
protestantesimo fuori dalle chiese storiche, e la cui predicazione era tutta
funzionale ad un «Regno di Dio» da acquisire nella vita dopo la morte, senza
stare a guardare l’ingiustizia e l’oppressione e tanto meno lo sfruttamento
lavorativo o sociale. Cinquant’anni dopo la sfida è la stessa, però su scala
mondiale. In Vaticano siede un papa latinoamericano «imbevuto» di cultura
«popolare» (non populista, attenzione!), che mette al centro della predicazione
le classi povere (economicamente e spiritualmente), invita al cambiamento
interiore come spinta per il cambiamento sociale, invita la Chiesa a «uscire»
dalle quattro mura degli edifici religiosi e scendere tra la gente, chiede
soprattutto che si colleghi la giustizia sociale con il Vangelo e con la cura
dell’ambiente. «Tutto è connesso» e dunque è ovvio che contro Bergoglio e la sua
«economia» si scaglino i settori conservatori che da un lato desiderano non
cambiare lo statu quo dei privilegi e dall’altro non accettano di venire
discussi i princìpi dell’economia capitalista. La «terza via» della dottrina
sociale è piuttosto scomoda, soprattutto se aumentano aziende e studiosi (come
Luciano Floridi da Oxford) convinti della possibilità di un progetto umano
etico, capace di unire politiche verdi (economia green, circolare e dello share)
e politiche blu (economia digitale e dell’informazione) e favorire un modo di
vivere insieme centrato sulla qualità delle relazioni e dei processi, anziché
sul consumo e sulle cose. Ecco allora delineati i due fronti. Ed è comprensibile
come dietro Bannon ci siano interessi economici molto forti che compattano
larghi settori di un mondo cattolico semplicemente schierato a favore di aree di
privilegio finanziario. Le critiche «teologiche» a Bergoglio servono solo a
occultare lo scontro in atto. Tanto che gli epigoni di Bannon a proposito del
suo arresto per truffa parlano di un complotto ordito per fermarlo. Come da
copione. Ma da copione non è la portata della posta in gioco.
E Biden lancia la sfida (con l'aiuto di Obama) "Riprendiamoci
l'anima". Chiusa la convention Dem. Il candidato:
"Unirò l'America". Barack: "Donald vive in un reality". Valeria Robecco, Venerdì
21/08/2020 su Il Giornale. New York. Cala il sipario sulla convention
democratica, con Joe Biden che lancia ufficialmente la sfida a Donald Trump.
«Sono in corsa per sconfiggere Trump - un presidente incompetente che minaccia
la nostra democrazia - unire l'America e restituirle la sua anima», è il
messaggio che Biden lancia al termine di questo appuntamento elettorale dalle
connotazioni surreali dettate dall'emergenza coronavirus. Parole che pronuncia
durante il discorso di accettazione della nomination dell'Asinello all'indomani
dell'incoronazione della sua vice, Kamala Harris. Un discorso atteso da una
vita, suggellata da quasi mezzo secolo di carriera politica iniziata quando,
29enne, fu eletto senatore del Delaware, incarico mantenuto per 36 anni prima di
passare alla Casa Bianca come vice di Barack Obama. Sul palco la sua famiglia, a
partire dall'aspirante first lady Jill: in caso di vittoria, inizierà il suo
mandato a 78 anni, diventando il più anziano presidente della storia Usa.
L'intervento di Biden chiude una kermesse concentrata in gran parte sugli
attacchi all'attuale inquilino della Casa Bianca, a partire da quelli dell'ex
coppia presidenziale. Michelle Obama ha aperto la convention sparando a zero sul
tycoon, e l'ex presidente Barack ha proseguito sferrando il suo attacco
personale più duro a Trump. Parlando dal Museo dell'American Revolution di
Philadelphia, la città dove è stata firmata la costituzione americana, ha detto:
«Speravo che Trump potesse mostrare qualche interesse nel prendere sul serio la
carica, che potesse arrivare a sentire il peso del ruolo e scoprire qualche
riverenza per la democrazia affidata alle sue cure, ma non lo ha mai fatto».
«Non ha mostrato alcun interesse nel mettersi al lavoro, nel trovare un terreno
comune, nell'usare l'eccezionale potere del suo ufficio per aiutare qualcuno
tranne se stesso e i suoi amici - ha proseguito -. Nessun interesse nel trattare
la presidenza se non come un altro reality show». E «le conseguenze di questo
fallimento sono gravi: 170 mila americani morti, milioni di posti di lavoro
persi, la nostra orgogliosa reputazione nel mondo compromessa e le nostre
istituzioni democratiche minacciate come mai prima. La posta in gioco ora è
proprio la democrazia». Quindi, ha sollecitato a votare per il ticket
Biden-Harris, che «ha la capacità di guidare il nostro paese fuori delle tenebre
e ricostruirlo meglio». «Quando sento questo e vedo l'orrore che ci ha lasciato,
la stupidità degli accordi che ha concluso... guardate come è stato terribile,
fino a che punto è si è dimostrato un presidente inefficace», è stata
l'altrettanto dura replica di Trump alle parole del predecessore. «Perché si è
rifiutato di appoggiare slow Joe fino alla fine? Perché ha cercato di
convincerlo a non correre alla Casa Bianca?», ha twittato. Nello stesso giorno
dell'incoronazione di Biden, e mentre sulla passerella virtuale della convention
dem salivano anche gli ex candidati alle primarie Cory Booker, Pete Buttigieg e
Andrew Yang, oltre alla sindaca di Atlanta, Keisha Lance Bottoms, il Comandante
in Capo era a fare campagna elettorale in Pennsylvania. Per la precisione a due
passi da Scranton, la città natale dell'ex vice presidente, ultima tappa di una
settimana che lo ha portato anche in Minnesota, Wisconsin, Iowa e Arizona, tutti
stati in bilico fondamentali per la conquista del secondo mandato.
Hillary rompe l'esilio e torna in campo ma la sinistra dem la
tiene in un angolo. Francesco Semprini per “la Stampa”
il 20 agosto 2020. Joe Biden e Kamala Harris dovranno essere pronti ad agire
contemporaneamente su diversi fronti, interni e internazionali, perché il lavoro
che li attende sarà «enorme». Hillary Clinton torna a calcare la passerella
(virtuale) della Convention da quel 26 luglio 2016, quando a Filadelfia accettò
la nomination per la corsa alla presidenza. Ironia della sorte, mettendo fuori
gioco proprio Biden che, con un doppio mandato da vice di Obama, si sentiva il
candidato naturale. A farlo fuori però fu proprio l'ex inquilino della Casa
Bianca, che già prima delle primarie diede il suo endorsement a Hillary. Trame
di palazzo che si risolsero in una debacle: l'ex First lady, data per vincitrice
plebiscitaria da media e sondaggi, perse di fronte ad uno straripante Donald
Trump. Ne seguì l'esaurimento nervoso, l'esilio tra i boschi di Chappaqua,
Upstate New York, e rare incursioni nella politica, prontamente cassate dagli
stessi colleghi di partito. Ironia della sorte, quasi 1.500 giorni dopo i bagni
di folla nella «hockey arena», dove salì sul palco col pantalone bianco in
omaggio al movimento di emancipazione delle donne, Hillary torna davanti al
popolo Dem, ma relegata ad un ruolo marginale. Beninteso, l'ex segretaria di
Stato si è spesa molto a favore di Biden. Tra i due c'è identità politica e di
veduta, entrambi puntano sull'elettorato moderato, centrista e dei repubblicani
delusi. «Gli Stati Uniti riprenderanno una posizione di leadership globale nelle
battaglie contro minacce comuni, che si tratti del cambiamento climatico o della
pandemia», ha anticipato Clinton. Parole che si sovrappongono a quelle di Biden.
Il punto è un altro, a livello di immagine Hillary può danneggiare più che
avvantaggiare il ticket democratico a causa della sconfitta di 4 anni fa, della
carenza di empatia e per l'ostilità nutrita dalla sinistra liberal. Ecco allora
che per l'ex First lady è stato ritagliato uno spazio più defilato, come
accaduto a suo marito Bill, che mentre parlava veniva bombardato sui social per
le nuove immagini che lo ritraggono «massaggiato» da una delle giovani vittime
dall'amico pedofilo Jeffrey Epstein. Segnali di decadenza di una dinastia
politica dinanzi alla quale Hillary torna a giocare la carta delle donne,
ricordando il movimento femminista, la scelta saggia di Harris come vice e
l'importanza del 19° emendamento, che riconosce il diritto di voto alle donne,
adottato il 18 agosto 1920. Centenario in vista del quale Trump ha astutamente
giocato d'anticipo, concedendo il perdono postumo a Susan Anthony, attivista
arrestata nel 1872. Tirate le somme la comparsata di Hillary ha ricordato più
che altro come nel 2016 la prima donna candidata alla presidenza si dovette
piegare davanti al sistema dei collegi elettorali, nonostante la supremazia nel
voto popolare. Una lezione che Biden e Harris non potranno ignorare.
Scandali e rancori, il lento crepuscolo di Bill e Hillary: da
famiglia reale a comparse. Massimo Gaggi per
il “Corriere della Sera” il 20 agosto 2020. Il crepuscolo è sempre triste.
Quello della famiglia reale del partito democratico, i Clinton, è anche fonte di
conflitti e grandi imbarazzi nella sinistra americana, divenuti evidenti nelle
ore cruciali della convention di Milwaukee trasformata dal coronavirus in
asettico evento digitale. Provvidenziale per Bill e Hillary: lui ha evitato la
contestazione della sinistra e delle donne del # metoo , lei la presa di
distanze delle attiviste che non le riconoscono il ruolo storico che si è
attribuita, quello di apripista della politica al femminile. Nel 2012, quello di
Bill Clinton fu il discorso più importante della convention: la sua figura
carismatica, il suo eloquio magnetico, furono un salvagente per Barack Obama, in
grande difficoltà al termine del primo mandato. Ma Bill è sempre stato mattatore
della politica: nel 2008 cercò di tagliare la strada al giovane e impertinente
Barack che aveva sfidato sua moglie. Quattro anni fa, poi, si preparava a
tornare alla Casa Bianca come first husband (oltre che presidente «emerito»).
Quella alla quale il partito democratico l'altra sera ha concesso un discorso di
appena 5 minuti (ma molti volevano la sua esclusione totale) è però una figura
politica ormai ridimensionata, non solo dal vento degli scandali e dalla
sconfitta della moglie, ma anche per una revisione storica della sua presidenza:
Bill è stato molto amato per la sua simpatia, la capacità di interpretare i
sentimenti della gente, per essere stato presidente in anni di benessere. Sono
ancora in tanti ad apprezzarlo, ma la sua Terza Via centrista è finita da tempo
in soffitta, mentre sono moltissimi - anche fra i democratici - coloro che
vedono le radici del crollo finanziario del 2008, dell'aumento delle
diseguaglianze e della crisi della giustizia penale nelle politiche clintoniane
degli anni Novanta: il taglio dei benefici del welfare per i disoccupati, la
deregulation di Reagan portata alle estreme conseguenze, dando mano libera a
Wall Street. E poi la stretta sui crimini, soprattutto quelli di droga, che ha
fatto finire in carcere un gran numero di americani, prevalentemente di colore,
per reati minori. Pesano soprattutto le vicende a sfondo sessuale, a partire
dall'amicizia col miliardario pedofilo Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere
un anno fa, da lui frequentato assiduamente. Non ci sono prove che Bill ne abbia
condiviso gli abusi e l'ex presidente nega di essere mai stato nell'isola
privata di Epstein, ma ha volato più volte sul suo jet privato, il Lolita
Express, e si è fatto fotografare coi collaboratori del miliardario che lo
assistevano nelle sue «battute di caccia» sessuali. Poche ore prima del suo
discorso alla convention sono state pubblicate altre foto imbarazzanti: Bill
massaggiato da una delle ragazze di Epstein (che ora accusa il miliardario ma
non coinvolge l'ex presidente) in un aeroporto europeo durante un viaggio in
Africa. Stanotte è stata la volta di Hillary: travolta non dagli scandali che
hanno rovinato il marito, ma dalla sua arroganza e dalla mancanza di
quell'empatia che Bill aveva, invece, da vendere. Ha sfiorato la presidenza: ora
deve reprimere rimpianti e rancori. Spera che le venga riconosciuto almeno un
ruolo storico: aver aperto una strada alle donne impegnate in politica. Forse
otterrà qualche attestato formale, ma difficilmente Kamala Harris darà spazio a
un personaggio così poco popolare.
Paolo Mastrolilli per “la Stampa” il 20 agosto 2020. Barack e
Kamala, cioè il primo presidente nero degli Usa, e quella che spera di diventare
la prima donna di colore alla Casa Bianca. Già dai nomi si intuisce la
rivoluzione che i democratici stanno tentando in America, che però passa prima
dal sostegno di un uomo bianco irlandese di 77 anni alla presidenza. Perciò ieri
Obama e Harris hanno parlato alla Convention virtuale di Milwaukee, nella serata
intitolata "A More Perfect Union", dal preambolo della Costituzione che
sollecita i cittadini a tendere sempre verso la costruzione di una unione più
perfetta. Il primo, per sottolineare quello che non va oggi, perché «la
democrazia è in gioco» a causa del cinismo di Trump. La seconda, per indicare la
strada della ricostruzione possibile, attraverso la sua biografia, e il
programma concreto condiviso con Biden. Barack, che nel 2016 aveva preferito
Hillary e secondo i maligni ha sempre dubitato delle capacità del vice di
prendere il suo posto, ha usato il discorso per sottolineare soprattutto tre
punti. Primo, il successo di Joe nel gestire la ricostruzione dell' economia
dopo la Grande recessione, dimostrando che può adesso risollevarla dalla
devastazione del Covid e di Trump. Secondo, il cinismo di Donald, che non si
vergogna neppure di sabotare il Servizio Postale, pur di sopprimere il voto dei
suoi oppositori e restare alla Casa Bianca con l' inganno. Terzo, la visione per
tornare a costruire un paese più generoso, nobile e inclusivo. «Ho sperato che
Trump manifestasse qualche interesse a prendere seriamente il lavoro, che
potesse sentire il peso della carica e scoprire un po' di reverenza per la
democrazia messa nelle sue mani. Ma non l'ha mai fatto. Non ha mostrato l'
interesse di trattare la presidenza come niente altro che un reality show, da
usare per ricevere l'attenzione a cui anela. Trump non è cresciuto perché non
può. E le conseguenze del fallimento sono severe. 170.000 americani morti.
Milioni di lavoro perduti». Quindi Obama ha elogiato Biden: «Ha il carattere e
l' esperienza per rendere migliore il nostro Paese». E si è appellato agli
elettori: «Vi chiedo di credere nella vostra capacità di garantire che i
principi basilari della nostra democrazia resistano. Perché questo è in gioco
ora. La nostra democrazia». Obama doveva funzionare da ponte fra la generazione
di Biden, la sua, e quella dei giovani, facendo accettare a tutti il ruolo di
transizione di Joe, per battere Trump e poi aprire la strada ai leader del
futuro. Qui entra Kamala, con la sua età, la biografia di figlia di immigrati
giamaicani e indiani, e il curriculum di procuratrice. Biden l' ha scelta perché
i sondaggi interni dei democratici dicono che può aiutarlo con alcuni gruppi di
elettori decisivi negli stati più contesi, come le donne suburbane, i giovani e
gli ispanici. Il discorso serviva anche a sedurre l' ala più liberal del
partito, orfana di Sanders, anche se il suo passato di procuratrice dura che
mandava in galera gli spacciatori insospettisce i progressisti. E poi bisogna
riportare alle urne i neri, che con il loro calo di affluenza del 7% tra il 2012
e il 2016 hanno condannato Hillary alla sconfitta in stati come Pennsylvania e
Michigan. Il 95% di quelli sopra i 65 anni vuole votare Joe, ma la percentuale
scende al 77% sotto i 45 anni. Durante un briefing virtuale con i giornalisti,
la vice manager della campagna Kate Bedingfield ha spiegato che le prime due
giornate della Convention servivano a demolire Trump, e fin qui ci siamo: il
partito è unito sulla priorità di batterlo. Ieri e oggi invece riguardano la
visione propositiva di Biden, e qui la strada si fa più scivolosa. Perché lui
punta a ristabilire la normalità, più che lanciare la rivoluzione. Su economia,
sanità, istruzione, ordine pubblico, immigrazione, ambiente, l' unità fra l'
anima moderata e quella liberal è più fragile, e Trump è pronto a sfruttare ogni
slittamento verso il socialismo per deragliare Joe.
Anna Guaita per “il Messaggero” il 20 agosto 2020. Al secondo
giorno della Convention democratica, ben pochi si sarebbero aspettati che a
dominare fosse la parola calamari. Si deve al deputato del Rhode Island, che si
è presentato all'appello per l'investitura di Joe Biden comparendo su una
spiaggia con accanto un cuoco che mostrava un vassoio pieno di calamari fritti,
il piatto tipico del piccolo Stato affacciato sull'Oceano. L'iniziativa ha
riassunto il carattere di questa «unconventional convention», tutta virtuale,
che i democratici hanno ideato nell'era del covid. Il Philadelphia Inquirer è
stato il primo a sottolineare che la Convention ha assunto un carattere da
TikTok, scrollandosi di dosso il vecchiume delle maratone politiche. E così
invece di lunghi discorsi di senatori, governatori, ecc, abbiamo visto alcuni
big del partito ridotti a soli cinque minuti (Bill Clinton ad esempio) mentre le
telecamere sono entrate nelle case della gente, dando loro il microfono. E
invece di sentire i politici riassumerci i problemi degli americani, abbiamo
sentito gli americani stessi raccontarceli, dai loro salotti, cucine, giardini.
Ognuno di questi testimonials ha la lunghezza proprio di un minivideo TikTok, e
difatti molti già girano sui social, più popolari degli interventi dei vip
politici. Il capitolo più vivace è stato comunque il roll call, quando gli Stati
confermano i voti per un candidato, che martedì sera è stato una carrellata di
mini-video dai diversi Stati. Il Rhode Island ha vinto su tutti per la sua
originalità, facendo pubblicità ai suoi «calamari». Il Montana ha centrato sulle
sue famose mucche, l'Iowa sui suoi vasti campi di mais, la delegata dell'Arizona
si è sistemata davanti ai leggendari cactus giganti, il deputato del Nuovo
Messico ha parlato nel suo costume della tribù Pueblo Sandia, la delegazione del
Michigan ha puntato sull'industria delle auto e ha messo come background tre
smaglianti e patriottiche macchine, una rossa, una bianca e una blu. A
rappresentare i vari Stati, poi, erano quasi sempre persone comuni: vigili del
fuoco, infermiere, agricoltori, giovani e anziani, l'America in carne ed ossa,
non l'establishment politico. Naturalmente la serata ha avuto anche la sua parte
di politica, con gli interventi dell'ex segretario di Stato John Kerry, con la
testimonianza di due repubblicani pro-Biden, l'ex generale Colin Powell e la
vedova del senatore John McCain. Abbiamo sentito l'intervento della pasionaria
della sinistra, Alexandria Ocasio Cortez, e infine la testimonianza della moglie
di Joe Biden, Jill. Tutti hanno fatto il loro dovere di criticare Trump e lodare
Biden, e sollecitare la gente a votare il prossimo 3 novembre. E ieri sera si
ricominciava, con Elizabeth Warren, Kamala Harris, Hillary Clinton e Barack
Obama, mentre stasera ci sarà l'ultimo appuntamento, e ascolteremo Biden stesso
presentare la sua battaglia «per l'anima dell'America».
Ritratto di
Kamala Harris, la top cop vice di Biden. David Romoli su Il Riformista il 12
Ottobre 2020. Per Trump è “molto più a sinistra di Sanders”. Esagera ma non
senza argomenti da addurre. Per i radical che hanno storto il naso
quando Biden se l’è scelta come vicepresidente invece resta “Top Cop”, come la
chiamavano quando era procuratrice generale della California: il capo delle
guardie. Capita che anche loro possano squadernare esempi validi per
giustificare il loro pollice verso. La sinistrissima Top Cop è Kamala Harris, il
vero pezzo forte del tandem democratico che sfida il presidente uscente. Un
listone di primi posti da fare impallidire i più ricchi Palmarès: la prima
afroamericana che corre per la vicepresidenza (e la terza donna), la prima
americana di discendenza asiatica, la prima figlia di immigrati diprima
generazione. Del resto era già stata la prima procuratrice nera di san
Francisco, eletta a 40 anni tondi nel 2004, e poi la prima donna, prima nera
e prima asiatico-americana a conquistare la Procura generale della California,
quattro anni più tardi, sostenuta da Nancy Pelosi in persona, la prima senatrice
asiatica e la seconda nera. Per la Harris è una tradizione: era anche stata una
delle prime bambine nere di Berkeley a frequentare la scuola elementare
di Thousand Oaks, quartiere ricco e all’epoca bianco come il latte, nel quadro
del programma cittadino di desegregazione. Ritrovarsi a essere la prima
candidata vicepresidente deve sembrarle un’abitudine. Minoranza per minoranza
Kamala è sposata con un avvocato ebreo di serie A, suo ex collega, Douglas
Emhoff: patrimonio familiare dei suoi stimato sui 5 milioni e mezzo di dollari
nel 2019. La numero due di Biden, del resto, viene da una famiglia dell’upper
class di colore. La madre, Shyamala Golapan, immigrata dall’India a 19 anni, è
una biologa con importanti studi sul progesterone all’attivo, il padre, Donald
J. Harris, arrivato dalla Giamaica nel 1961 è professore di economia
alla Stanford University e discendente di uno dei principali proprietari di
piantagioni e schiavi della Giamaica, l’irlandese Hamilton Brown. Nata a
Berkeley nel 1964 è cresciuta in California, spostandosi però, dopo il divorzio
dei genitori a Montreal, dove ha studiato nelle scuole francesi, ha rapporti
stretti con l’India, dove risiede la famiglia materna che la ha introdotta allo
studio della molto amata e molto studiata mitologia Hindu. Con una laurea in
Scienze politiche ed economiche e una in Legge, autrice di tre libri, due
accademici ma il terzo per bambini, Kamala Harris è certamente una donna di
grande e vasta cultura e di accertata competenza. Ma è anche una donna di
sinistra radical, come da accuse presidenziali? Se si guarda all’attività al
Senato è impossibile dare torto a The Don. Si è battuta per la depenalizzazione
della marijuana, la cittadinanza ai clandestini, una riforma sanitaria pur se
meno radicale di quella proposta da Sanders, l’introduzione di un sistema
fiscale progressivo. Perché allora da sinistra sono arrivati sin dalla scelta d
Biden molti applausi ma anche molte espressioni dubitose e perplesse? Diversi
motivi. La legalizzazione della marijuana, per esempio, è uno dei cavalli di
battaglia della senatrice. Come procuratrice però si era distinta per la durezza
con la quale aveva perseguito consumatori e piccoli spacciatori di cannabis,
incidentalmente colpendo così soprattutto i quartieri neri e ispanici. Come capo
della Procura, Kamala Harris si è sempre rifiutata di chiedere la pena di morte,
anche nel caso rimasto molto celebre di un poliziotto ucciso nel 2004.
Nonostante le pressioni fortissime dei vertici del Partito democratico, l’allora
neo procuratrice distrettuale si rifiutò di chiedere la pena capitale e ha
sempre sostenuto che l’ergastolo senza possibilità di libertà sulla parola sia
allo stesso tempo una pena più civile e meno costosa per la comunità. In
tribunale, però, la ex procuratrice ha difeso il mantenimento della pena di
morte e ha scelto di non partecipare ad alcune iniziative a favore della sua
soppressione. La macchia più spesso contestatale è però proprio quella che le è
valsa il soprannome di Top Cop. In realtà anche in veste di procuratore Kamala
Harris ha fatto molto per ricucire i rapporti tra comunità e forze di polizia e
ha spinto verso l’adozione delle bodycams per gli agenti, adottate per la prima
volta proprio dalla California, riprendendo poi la campagna su scala nazionale
dal Senato, e ha lanciato la piattaforma Open Justice, per consentire ai
cittadini di monitorare il comportamento delle forze di polizia. È accusata però
di aver nel concreto evitato di perseguire, come Attorney General, i poliziotti
accusati di violenza. Ha certamente gestito con grande oculatezza la
assurda Three Strikes Law, quella che permette di condannare a pene dai 25 anni
all’ergastolo i colpevoli di qualsiasi reato, anche minimo, se già condannati
due volte. Kamala Harris la ha impugnata solo nei casi di crimini
particolarmente gravi. Allo stesso tempo però ha provato a opporsi con ogni
mezzo alla scarcerazione di Daniel Larsen, condannato a una pena minima di 28
anni fino al possibile ergastolo per il possesso di un pugnale. Anche se dopo 10
anni di prigione era apparso chiaro e provato che la condanna era ingiusta e il
pugnale non era di Larsen, la procura guidata da Kamala continuò a battersi
contro la scarcerazione per oltre due anni. Una macchia che i liberal più
convinti della California considerano indelebile. In definitiva, la senatrice
Harris è certamente una donna di sinistra, attenta alla rieducazione dei
condannati, impegnatissima sul fronte del contrasto alle discriminazioni di
genere e su quello delle politiche ambientali, con proposte di gran peso come
una riforma della cauzione, che, nelle forme attuali,condanna i non abbienti a
restare comunque in galera. È certamente questa la sua propensione più sincera.
In fondo il solo vero scoglio di una carriera in continua ascesa fu, nel 1998,
l’opposizione alla Proposition 21, che permetteva di processare anche i
minorenni di fronte a corti normali invece che delegare le cause ai tribunali
minorili. Per rappresaglia fu pesantemente demansionata e abbandonò il posto che
occupava in quel momento nella procura di San Francisco. Allo stesso
tempo Kamala Harris è una politica attenta, che ci pensa più volte prima di
imbarcarsi in sfide che non pensa di poter vincere, pragmatica al punto giusto.
Per l’etica di molti radical è un grosso limite. Per una leader politica però è
una dote.
DAGONEWS il 14 agosto 2020. Anche Kamala Harris ha i suoi
scheletri nell’armadio. Il DailyMail ha dedicato un lungo articolo alla
relazione della candidata vicepresidente con Willie Brown, il primo sindaco nero
di San Francisco. La storia risale al 1993, quando Kamala Harris aveva 29 anni e
Brown 60. Il politico californiano era sposato con Blanche, i due vivevano
separati ma non avevano mai divorziato. Per qualche anno però la sua “compagna
stabile” fu appunto la Harris, che poi scaricò quando fu eletto sindaco nel
1996. Il giorno dell’insediamento al suo fianco c’era appunto la moglie Blanche
e non Kamala. Cosa è successo in quegli anni? Di sicuro qualcosa che la Harris
ha provato negli anni a rimuovere: di Brown ha detto “era un albatro appeso al
mio collo”, eppure la sua rampante carriera politica deve molto a quel periodo e
all’allora speaker dell’Assemblea del Golden State, che la nominò in due
commissioni statali, facendole avere uno stipendio da quasi 170mila dollari
l’anno. Brown, che Clinton chiamava “Real Slick Willy” – il vero viscido Willy –
era già noto per il suo amore per la bella vita, le auto sportive, e per essere
stato nominato uno dei 10 uomini più sexy del mondo dalla rivista Playgirl.
Nonostante i suoi 25 anni di matrimonio, avrebbe avuto molte amanti, tra cui
appunto Kamala Harris. "La misura del suo stile di vita è che va a una festa con
sua moglie sotto un braccio e la sua amante dall'altra", disse a People Magazine
nel 1996 James Richardson, giornalista del Sacramento Bee. Harris, in quegli
anni, era considerata una diligente e capace procuratore "in ascesa" presso
l'ufficio del procuratore distrettuale della contea di Alameda, dove aveva
lavorato per i tre anni precedenti. Poi iniziò a frequentare Brown, che le
regalò una Bmw e la introdusse negli ambienti politici californiani che
contavano all’epoca, dove era conosciuta appunto come “la fidanzata di Brown”.
Kamala si prese un anno di aspettativa per le nuove “occupazioni”. I resoconti
di stampa portati alla luce da DailyMail.com confermano che quando si è messo
con Harris, Brown era apertamente separato da Blanche, un'insegnante di danza
che aveva sposato nel 1958 e con cui aveva tre figli, ma da cui non aveva mai
divorziato. Anche per questo – e data la pubblicità del suo rapporto con Kamala
– il giorno in cui Brown si è insediato come sindaco di San Francisco,
consolidando la sua posizione di politico afroamericano più importante della
California, è stata una sorpresa per molti vedere Blanche al suo fianco, la
Bibbia in mano. Brown "ha sbalordito i suoi amici annunciando che stava per
lasciare Kamala", ha detto Richardson dell'episodio. Fino a quel momento invece,
si erano fatte insistenti le voci di un matrimonio con la Harris. Nonostante sia
stata scaricata da Brown, Kamala ha continuato a godere del suo sostegno quando
si è candidata lei stessa, venendo eletta come primo procuratore distrettuale
nero di San Francisco nel 2004. A quel punto Brown aveva affrontato un'indagine
sulla corruzione dell'FBI per presunta distribuzione di contratti e appuntamenti
cittadini redditizi ad amici e alleati politici. La sua elezione le ha provocato
accuse di clientelismo, prontamente smentite da Harris che all'epoca usciva con
il presentatore di talk show Montel Williams. Sotto il fuoco dei suoi avversari,
Terence Hallinan e Bill Fazio, Harris non ha esitato ad attaccare il suo ex
“mentore”, etichettandolo appunto come un "albatro appeso al collo". "Mi rifiuto
di progettare la mia campagna intorno a Willie Brown", ha detto a SF Weekly.
'Non ho dubbi di essere indipendente da lui e che probabilmente in questo
momento esprimerebbe un po' di paura per il fatto che non può controllarmi.
Harris è stata eletta procuratore generale della California nel 2010. Quando si
è candidata al Senato nel 2016, Brown ha invitato il suo probabile avversario,
Antonio Villaraigosa, a rimanere fuori dalla corsa. Ora che è felicemente
sposata con l'avvocato Doug Emhoff, Harris ha poco da dire su Brown, al punto
che non menziona il suo nome nemmeno una volta nel suo libro di memorie del
2019, The Truths We Hold. Brown, invece, ha molta voglia di parlare. Quando
Kamala Harris ha annunciato la sua candidatura presidenziale nel gennaio 2019,
ha scritto un articolo per il San Francisco Chronicle dal titolo: "Certo, ho
frequentato Kamala Harris, e allora?" "Sono stato tempestato di chiamate dai
media nazionali sulla mia" relazione "con Kamala Harris, soprattutto da quando è
diventato ovvio che si sarebbe candidata alla presidenza", ha scritto Brown, che
ora ha 86 anni. "Sì, ci siamo frequentati. Sono passati più di 20 anni. Sì,
potrei aver influenzato la sua carriera nominandola a due commissioni statali
quando ero presidente dell'Assemblea. 'E di certo l’ho aiutata con la sua prima
corsa per procuratore distrettuale a San Francisco. Ho anche aiutato le carriere
del presidente della Camera Nancy Pelosi, del governatore Gavin Newsom, della
senatrice Dianne Feinstein e di una miriade di altri politici. Brown ha iniziato
la scorsa settimana esortando pubblicamente Harris a "rifiutare educatamente"
l'offerta di Biden, dicendo che la Vice Presidenza era un vicolo cieco e che
sarebbe stata più efficace come Procuratore Generale degli Stati Uniti. Brown ha
commentato l’offerta di Biden invitando Kamala Harris a "rifiutare
educatamente", dicendo che la Vice Presidenza era un vicolo cieco e che sarebbe
stata più efficace come Procuratore Generale degli Stati Uniti. Quando ha
ignorato il suo consiglio, Brown ha cambiato tono, dicendo alla NBC Bay Area:
"Come uomo di colore, sono assolutamente sbalordito".
Quello che nessuno dice su Kamala Harris, la pupilla di Joe
Biden. Rec News il 13/08/2020. Dai finanziamenti scomodi alla mancanza del
requisito che le impedì di correre alle presidenziali, tre (o quattro) cose che
il mainstream non dice sulla senatrice dello Stato della California. Che la
campagna elettorale di Joe Biden – per i sostenitori “il nonnino” e per i
detrattori personaggio accusato di molestie a danno di minori – dovesse contare
su personalità esterne era prevedibile. La sintesi migliore delle ultime ore è
di Donald Trump: Joe “il lento” ha bisogno della “furba”, e la furba è quella
Kamala Harris che gli deve tutta la carriera professionale, con cui secondo le
malelingue condivide molto di più degli interessi di partito. “E’ la partner
migliore che potesse trovare”, è del resto il sunto di Barack Obama. La mancanza
di un requisito essenziale le impedì la corsa alle presidenziali. Ma chi è
(davvero) Kamala Harris? Della biografia privata e professionale si sa più o
meno tutto. Sposata con l’uomo di spettacolo Douglas Emho, è figlia del
jamaicano Donald Harris e dell’indiana Shyamala Gopalan, entrambi sprovvisti di
cittadinanza americana. E proprio la mancanza del requisito previsto
dall’Articolo 2 della Costituzione americana (che parla di natural born citizen)
ne aveva sancito l’impresentabilità come candidata a presidente. Ma i
democratici, dopo il colpo messo a segno con Obama, del resto ci speravano. I
finanziamenti scomodi smascherati da Follow the money Senatrice dello Stato
della California, auto-proclamatosi “avvocato dei senza voce e dei vulnerabile”
secondo la retorica tipica del copione dei presunti democratici, gode in realtà
dagli albori dei finanziamenti di Planned Parenthood, la controversa
organizzazione sorosiana che promuove l’aborto e che è stata al centro di
un’inchiesta sul commercio di parti di bambini abortiti. A smascherare la fonte
di reddito scomoda, come avevamo scritto, era stata l’organizzazione Follow the
Money, secondo cui Kamala ha ingoiato l’equivalente di 81,215 dollari in
contributi elettorali dagli abortisti, pur appellandosi di frequente alla
protezione dei deboli e dei loro diritti. Evidentemente, non del diritto di
nascere o di quello di diventare madre. I legami con i colossi tecnologici
Harris avrebbe, inoltre, in mente il disegno di “colonizzare la Silicon Valley”,
stando alle indiscrezioni pubblicate da Breitbart. Agirebbe infatti su impulso
diretto dei leader tecnologici più influenti, e proprio questo l’avrebbe portata
a sostenere la S.386, la legge di settore che vuole dare priorità alla forza
lavoro straniera, contrariamente a quanto disposto recentemente da Donald Trump.
Paolo Mastrolilli per "La Stampa" il 18 agosto 2020. «Amavo
andare a trovare i miei nonni. Con le fettuccine appena fatte che si seccavano
in cucina, l'odore del basilico, l'origano, i pomodori freschi per il sugo.
Ancora oggi il profumo del pane italiano tostato riporta alla mia mente
l'incredibile calore e l'amore che provavo, ogni volta che stavo con loro». Jill
Giacoppa punta sulle sue origini, per diventare la prima First Lady italiana
nella storia degli Stati Uniti. Perché pochi lo sanno, ma la moglie di Joe Biden
è siciliana, ed è convinta che i valori ereditati dalla sua famiglia saranno
decisivi per aiutare il marito a vincere le presidenziali e ricostruire l'anima
dell'America. Lo dice lei stessa, durante una «festa» organizzata via Zoom dagli
Italian Americans for Biden/Harris e dall'Italian American Democratic Leadership
Council: «Quando i miei bisnonni Gaetano e Concetta Giacoppa vennero negli Usa,
diventarono Jacobs. Ma anche se il cognome era cambiato, hanno sempre tenuto un
pezzo di Italia nel cuore, come me. Questi legami sono molto forti». Famiglia e
patriottismo Quindi Jill ricorda: «Mio nonno consegnava mobili per un piccolo
negozio in New Jersey, e lavorava duro per sostenere la famiglia. Era gentile,
generoso, ha costruito una vita di cui essere orgoglioso. Sono tornata nella
città del New Jersey dove ero nata, ho visitato il vecchio negozio, e mi ha
riportata indietro nel tempo. Famiglia, lealtà, gentilezza, generosità,
passione, patriottismo, sono i valori italiani che imiei bisnonni avevano
portato con loro sulle nostre coste, e hanno forgiato la mia famiglia per
generazioni. Hanno ispirato i miei parenti a combattere per la nostra nazione
nella Seconda guerra mondiale, e me a diventare un'insegnate, usando la mia
piattaforma per parlare a nome della mia comunità: famiglie militari, college
locali, donne e ragazze in tutto il mondo. Gli italoamericani hanno contribuito
moltissimo alla nostra nazione. La cultura, i valori, le nostre vite, l'hanno
resa più ricca e forte. E poi il nostro bel Paese d'origine: sono orgogliosa di
fare parte di questa comunità». Perciò la moglie di Biden, molto ascoltata dal
marito anche nelle scelte politiche, chiede alla sua gente di aiutarla: «Noi
italoamericani sappiamo come usare la nostra voce. A volte forse siamo un po'
chiassosi, ma in questo momento nessuno può essere accusato di alzare la voce,
perché c'è così tanto in gioco nelle elezioni. Quindi vi chiedo di unirvi alla
campagna, offrirvi volontari. Grazie per la vostra fede in un'idea che ci motiva
tutti, insieme possiamo costruire un Paese migliore». La scelta della
comunità Un tempo italiani e cattolici erano in maggioranza democratici, ma nel
2016 hanno preferito Trump. La Speaker della Camera Nancy Pelosi interviene a
spiegare perché la tendenza deve cambiare: «In pochi mesi si terranno le
elezioni più determinanti della nostra vita. Decideremo se la nazione seguirà la
voce dell'odio e la divisione, oppure sceglierà speranza, libertà e giustizia
per tutti. Noi però non agonizziamo, ci organizziamo, e il voto italiano porterà
la vittoria». Eric Garcetti, sindaco di Los Angeles e copresidente della
campagna di Biden, discute come con Leon Panetta: «La vera scelta - dice l'ex
capo del Pentagono - riguarda la leadership che vogliamo. Trump ha fallito. Gli
Usa soffrono crisi tremende, come la pandemia fuori controllo, la recessione, la
disuguaglianza. Il presidente non crede ai valori americani. Non distingue il
bene dal male, non capisce che il Paese per vincere deve unificarsi, ma ci
divide per il suo tornaconto». Gli Usa, commenta Garcetti, «hanno un capo senza
moralità ed esperienza». E questa, secondo Panetta, sarà la chiave per Biden:
«Joe sa come si governa, e come ristabilire i valori della presidenza, che poi
coincidono con quelli di noi italiani. Perciò vincerà, salvando il futuro della
nostra democrazia».
(ANSA il 24 agosto 2020) - Kellyanne Conway ha annunciato le sue
dimissioni dall'incarico di consigliere del presidente degli Stati Uniti. Lo
riportano Bbc e Cnn. In una dichiarazione, Conway ha detto che lascerà la Casa
Bianca alla fine di agosto per concentrarsi sui suoi figli, dando loro "meno
drammi, più mamma". Anche suo marito George, che non ha mai risparmiato critiche
al presidente Donald Trump, si ritirerà dall'attivismo politico. "Me ne andrò
dalla Casa Bianca alla fine di questo mese" - ha detto Conway in una
dichiarazione, aggiungendo che anche il marito "sta preparandosi a un
cambiamento". Poco prima George Conway aveva scritto su twitter che lascerà il
Lincoln Project, un gruppo formato da repubblicani anti-Trump, anche lui, almeno
ufficialmente, per dedicarsi maggiormente alla famiglia. "Siamo in disaccordo su
molte cose - ha detto Kellyanne Conway, ma siamo uniti su ciò che conta di più:
i ragazzi. I nostri quattro figli sono adolescenti che iniziano un nuovo anno
accademico, alla scuola media e al liceo, in remoto da casa per almeno qualche
mese" a causa del coronavirus. "Come ben sanno milioni di genitori di tutto il
Paese, lo studio a distanza richiede un livello di attenzione e vigilanza tanto
inusuale quanto i tempi che stiamo attraversando". Un intervento di Kellyanne
Conway era in programma per i prossimi giorni alla convention repubblicana di
Charlotte, ma non è chiaro se, a questo punto, vi parteciperà.
Paolo Mastrolilli per “la Stampa” il 24 agosto 2020. «Donald è
crudele. Non ha alcun principio, nessuno. Non ti puoi fidare di lui». Cominciare
la Convention per la rielezione alla presidenza con un simile giudizio da parte
di sua sorella non era la prospettiva ideale per Donald Trump, ma la Casa Bianca
l'ha liquidata in fretta: «Ogni giorno c'è n'è una, chi se ne importa. Io
continuerò a lavorare duro per il popolo americano, i risultati sono ovvi». E su
questa base, da oggi a giovedì, Trump cercherà di cancellare il vantaggio del
rivale democratico Biden, parlando ogni sera agli americani. La Convention sarà
lui, in sostanza. Le dichiarazioni imbarazzanti di Maryanne Trump Barry, sorella
maggiore di Donald ed ex giudice, vengono dalle conversazioni con sua nipote
Mary, per discutere come la famiglia l'aveva tagliata fuori dall'eredità. Da qui
è nato il libro "Too Much and Never Enough". Ora Mary le ha passate al
Washington Post, che le ha pubblicate. La sorella racconta che Donald «è entrato
alla Pennsylvania University perché ha chiesto a qualcuno di fare l'esame per
lui». Questo qualcuno si chiama Joe Shapiro, e l'episodio dimostrerebbe
l'inclinazione di Trump per l'imbroglio, smentendo la pretesa di essere entrato
«perché sono un genio». Maryanne però colpisce il presidente ancora più duro per
quello che fa oggi: «Non ha principi. Nessuno». La sorella denuncia «la mancanza
di preparazione, le bugie. E quello che hanno fatto con i bambini al confine».
Mary le chiede cosa ha letto Donald. Risposta: «Niente. Lui non legge». Quindi
aggiunge: «E' la falsità di tutto. La falsità e la sua crudeltà. Donald è
crudele». Quindi mette in discussione i suoi successi personali: «Cosa ha
ottenuto? Nulla. O meglio, cinque bancarotte. Quelle le ha ottenute tutte da
solo». L'attacco è imbarazzante, ma difficilmente scalfirà la base di Trump, che
continua a votarlo per ragioni indipendenti dal suo carattere. Il problema di
Donald è invece usare la Convention per consolidare il suo consenso, demolire
Biden, e riconquistare qualche moderato. Il congresso si terrà solo oggi a
Charlotte, per la nomination formale, e poi verrà trasferito a Washington e
online. Per la regia è stato coinvolto Sadoux Kim, che lavorava con Donald nel
reality "The Apprentice", e ci saranno più momenti dal vivo rispetto ai
democratici. Stasera parleranno il figlio Don junior e l'ex ambasciatrice
all'Onu Nikki Haley, ma anche Mark e Patricia McCloskey, la coppia che aveva
puntato le armi contro i manifestanti di Black Lives Matter a St. Louis. Domani
toccherà a Melania dal Rose Garden, Mike Pompeo, e i figli Eric e Tiffany.
Mercoledì il vice Pence, e giovedì Rudy Giuliani, Ivanka e Trump dalla Casa
Bianca. Ieri il presidente ha anticipato la determinazione a usare tutti i mezzi
per vincere, annunciando di aver costretto la Food and Drug Administration ad
approvare l'uso del plasma per curare il Covid, nonostante le obiezioni dei
consiglieri scientifici. Gli obiettivi principali della Convention sono due:
primo, contrastare l'immagine delle tenebre in America usata da Biden,
difendendo l'operato di Trump e proiettando una visione ottimistica del Paese;
secondo, definire i candidati democratici, convincendo gli elettori che Joe e
Kamala Harris sono pericolosi estremisti di sinistra. E' la linea negativa
inventata da Lee Atwater, che nel 1988 aveva consentito a Bush padre di
recuperare 17 punti di svantaggio e sconfiggere Dukakis. Biden in media è avanti
di circa 9 punti, dalla Convention avrebbe ricavato un rimbalzo di un solo
punto, e Donald è convinto che la "maggioranza silenziosa" sia pronta farlo
rivincere come nel 2016. Dietro le quinte poi è in corso la battaglia per
l'anima del Gop. Ormai l'impronta populista, nazionalista e protezionista di
Trump è indelebile, e ha cancellato quella liberista di Reagan, per conquistare
classe media e colletti blu. Se a novembre vincerà ancora, il cambio diventerà
definitivo, altrimenti scatterà il regolamento di conti con chi lo ha aiutato.
E il presidente grazia un detenuto.
USA 2020, la lezione di Melania Trump: “Non attacco i democratici, non dividiamo
il Paese”. Redazione su Il Riformista il 26 Agosto 2020. Un discorso
presidenziale, ben distante dai toni del marito che della Casa Bianca è
‘padrone’. Melania Trump stupisce e si prende la scena nel secondo giorno di
convention repubblicana. La First lady, parlando dal Rose garden della Casa
Bianca, evita di attaccare i democratici per non “dividere ulteriormente il
Paese” e parla di razzismo e Coronavirus, due temi sensibili per
l’amministrazione Trump. “Non voglio usare questo tempo prezioso per attaccare
l’altra parte”, ha detto infatti Melania intervenendo alla convention, perché
“come abbiamo visto la scorsa settimana, quel tipo di discorso serve solo a
dividere ulteriormente il Paese” ha rimarcato la Flotus. La First Lady non ha
mancato di ricordare come nel marito gli americani hanno un presidente “che non
smetterà di combattere per voi e le vostre famiglie” e che “non si arrenderà”.
Sul Coronavirus, con la gestione della pandemia da parte di Trump criticata da
più parti, Melania ha sottolineato che “Donald non si fermerà finché non avrà
fatto tutto il possibile per prendersi cura di tutti coloro che sono stati
colpiti da questa terribile pandemia”. “L’amministrazione di mio marito non
smetterà di combattere fino a quando non ci sarà un trattamento o un vaccino
efficace a disposizione di tutti”, ha promesso la moglie del tycoon. Dalla First
Lady quindi un appello a “fermare la violenza e il saccheggio compiuti in nome
della giustizia e di non fare mai supposizioni basate sul colore della pelle di
una persona”.
L’INTERVENTO DI POMPEO – La politica estera basata sul principio
‘America First’ del presidente americano Donald Trump contro Russia, Cina e Iran
ha reso “gli americani più sicuri”. Così ha parlato invece il segretario di
Stato Mike Pompeo intervenendo alla convention repubblicana con un video
registrato a Gerusalemme. Un intervento criticato dai Democratici e dalla
stampa: la tradizione vuole infatti che il segretario di Stato stia lontano da
questioni politiche. Ulteriore benzina sul fuoco anche per la scelta di
registrare il video da Gerusalemme, probabilmente per rimarcare la vicinanza
dell’amministrazione Trump a Israele. Pompeo ha parlato della sconfitta del
califfato dello Stato islamico, dell’agenda filo-israeliana di Trump e delle
misure contro “l’aggressione predatoria” del Partito comunista cinese. Il
"ministro degli Esteri" Usa ha sottolineato anche che “grazie a Trump” la Nato è
“più forte”.
IL PRESIDENTE GRAZIA UN DETENUTO – Durante la convention inoltre
il presidente Trump ha concesso la grazia a Jon Ponder, un detenuto del Nevada
condannato per una rapina in banca che ha fondato Hope for Prisoners,
un’organizzazione che aiuta i detenuti a reintegrarsi nella società. Un video
diffuso dalla Casa bianca durante la seconda serata della convention mostra
che Trump firma il perdono presidenziale. “Viviamo in una nazione di seconde
possibilità”, ha detto Ponder, in piedi al fianco di Trump. “La vita di Jon è
una bellissima testimonianza del potere della redenzione”, ha detto Trump prima
di firmare la grazia.
È il giorno di Melania. "Sono un'immigrata".
La first lady tenta il riscatto dopo il flop del 2016: "Trump
sostiene le donne". Valeria Robecco, Mercoledì 26/08/2020 il 25 agosto 2020 su
Inside Over. È arrivata la notte di Melania Trump, colei che potrebbe rivelarsi
la vera arma segreta del presidente americano per conquistare l'elettorato
femminile in vista del voto del 3 novembre. La first lady è apparsa dal giardino
delle rose della Casa Bianca, che ha appena rinnovato, in uno dei momenti più
attesi della convention repubblicana. Lei, infatti, è vista come la figura
chiave per raggiungere il cuore delle donne, in particolare dei sobborghi, che
secondo gli esperti rappresenterebbero un punto debole per il tyccon. Già
lunedì, nella giornata di apertura della quattro giorni di kermesse del Grand
Old Party (in gran parte virtuale per l'emergenza coronavirus), la moglie di
Trump era apparsa a un evento commemorativo del suffragio femminile: «Da quando
è in carica - ha affermato - mio marito, con questa amministrazione, ha adottato
misure storiche per responsabilizzare e sostenere le donne negli Usa e in tutto
il mondo». A differenza del resto del clan Trump, però, lei non è entrata nel
merito dell'agenda e delle polemiche politiche, ma ha raccontato la storia del
suo arrivo da immigrata (legale) negli Stati Uniti. Il suo discorso, inoltre, è
stato un'occasione di riscatto, dopo che alla convention del 2016 fu accusata di
aver copiato ampiamente le parole pronunciate da Michelle Obama nel 2008. Questa
volta, secondo fonti della Casa Bianca, la moglie del Comandante in Capo ha
passato giorni a elaborare e limare il suo intervento. Melania si è cucita
addosso l'immagine di una first lady riservata, ma è molto più popolare del
marito, e il suo ruolo nella rielezione potrebbe essere particolarmente
significativo. In campo per sostenere il tycoon in questi giorni, comunque, non
c'è solo la first lady. Nel corso del consesso sono in programma interventi di
tutti i principali componenti della famiglia, a partire dal primogenito del
presidente, Donald Jr, da molti considerato l'erede politico insieme alla
sorella Ivanka, che ha parlato nella serata inaugurale insieme alla fidanzata
Kimberly Guilfoyle. Quello di Don Jr è stato uno degli affondi più duri contro i
democratici: «Le politiche da sinistra radicale di Biden fermerebbero la nostra
ripresa economica», ha detto, avvertendo i conservatori che i dem avrebbero
annullato i guadagni realizzati dalle persone nei quattro anni del padre nello
Studio Ovale. Anche Guilfoyle, ex di Fox News, ha puntato il dito contro il
ticket dell'Asinello: «Se volete vedere il futuro socialista di Joe Biden e
Kamala Harris per il nostro paese date un'occhiata alla California». Proprio
quella California oggi guidata dal politico democratico Gavin Newsom, suo ex
marito da cui ha divorziato nel 2006. Avvocato, di origine ispanica, Guilfoyle è
stata procuratore legale a San Francisco e Los Angeles, assistente procuratore
distrettuale a San Francisco dal 2000 al 2004, e first lady della città durante
i primi due anni come sindaco di Newsom. La 51enne, che si occupa anche della
parte finanziaria della campagna del Comandante in Capo, ha tenuto un discorso
appassionato che ha infiammato la base elettorale di Trump. Ieri, invece, oltre
a Melania, sono intervenuti i figli Eric e Tiffany, avuta dalla seconda consorte
Marla Maples. Domani ci sarà la nuora Lara, moglie di Eric, e giovedì la figlia
Ivanka, che avrà il compito di introdurre il discorso di accettazione della
nomination del padre.
Melania star, "Donald vuole solo il bene dell'America".
Da ansa.it il 26 agosto 2020. "Donald vuole solo il bene
dell'America": Melania Trump non tradisce le attese e si conferma finora la star
indiscussa della convention repubblicana. Non c'è Donald Junior, Eric o Tiffany
Trump che tengano. Quello della first lady è un intervento rassicurante e
pacato, senza quella rabbia politica che finora ha caratterizzato la kermesse.
"Non attacco i rivali perchè così significherebbe dividere il Paese": altro che
le bordate fin qui sparate contro Joe Biden e i democratici, accusati di essere
ostaggio della sinistra radicale e di voler distruggere il Paese. Melania
sceglie una linea diversa. Non quella di Eric Trump che poco prima aveva
accusato Biden di non sapere nulla dei lavoratori e delle imprese. Non di
Tiffany Trump che attaccato i media per manipolare la realtà solo per colpire il
padre. La first lady, intervenendo dal Rose Garden della Casa Bianca, punta a un
messaggio di unità e promuove l'immagine di un tycoon che ha a cuore solo il
futuro degli americani, donne, bambini, veterani, lavoratori, imprese: "Mio
marito Donald Trump si batte per voi, a prescindere da quello che dicono i
media. Mio marito non è un politico tradizionale, gli piace agire. E' una
persona autentica, ci tiene, ha a cuore il futuro dell'America", assicura l'ex
modella di origini slovene. Poi nelle ore in cui in Wisconsin si assiste ancora
una volta alle proteste antirazziste, quelle contro una polizia sempre più
violenta, Melania dice basta agli scontri, ai disordini e ai vandalismi in nome
della giustizia: "Invece di buttare giù le cose riflettiamo sugli errori del
passato", afferma riferendosi alla ormai nota guerra contro le statue simbolo di
un passato colonialista e schiavista. Alla fine l'ovazione dei presenti e il
presidente che, visibilmente commosso, si alza e va a baciare la first lady. Da
Gerusalemme anche l'atteso intervento di Mike Pompeo: "Donald Trump ha reso
l'America e il mondo più sicuri prendendo iniziative coraggiose in ogni angolo
del globo, e ha reso la Nato più forte". Parlando dal tetto dell'ambasciata Usa
il segretario di stato americano ha lodato la politica estera del tycoon,
affermando che la sua famiglia "è più sicura e le sue libertà sono più sicure
perchè il presidente Trump ha tradotto in azione la sua visione dell'America
First. Forse non lo ha reso popolare in tutte le capitali straniere, ma ha
funzionato", ha aggiunto.
Paolo Mastrolilli per “la Stampa” il 26 agosto 2020. «Da quando è
entrato in carica, mio marito ha attuato misure storiche per dare potere e
sostenere le donne, negli Usa e nel mondo». Che ci creda davvero o no, questo
messaggio della First Lady Melania potrebbe risultare decisivo per la rielezione
di Donald, insieme alla sua capacità unica di dargli, o negargli, una dimensione
più umana. Perché le donne sono le elettrici su cui Biden conta di più, per far
sloggiare i Trump dalla Casa Bianca, e il rapporto con loro del presidente è
quanto meno complicato. Melania ha concluso ieri la seconda serata della
Convention repubblicana, parlando dal Rose Garden della Casa Bianca che ha
appena ristrutturato, cancellando la memoria del design precedente di Jackie
Kennedy. Il nuovo giardino non ha impressionato, perché è parso noioso, ma l'ex
modella slovena aveva due obiettivi più importanti: far dimenticare la gaffe del
2016, quando aveva copiato da Michelle Obama un bel pezzo del discorso tenuto a
Cleveland, e compiere l'ultimo dovere per spingere il marito. Melania ha
ricordato le sue origini, anche per cancellare il sospetto che sia entrata
illegalmente nel paese, e ha provato a dare un'immagine di Donald che lo
riavvicinasse all'elettorato femminile. Non era facile, considerando la sua
stessa storia. Un mese prima delle elezioni del 2016, infatti, era stata
umiliata dall'audio di «Access Hollywood», in cui il marito diceva che essendo
famoso, si sentiva in diritto di prendere le donne per i genitali. Poi erano
uscite la pornostar Stormy Daniels e la coniglietta di Playboy Karen McDougal,
pagate per tacere sulle storie avute con Donald, poco dopo che Melania aveva
messo al mondo il figlio Barron. Per questo l'avvocato Cohen è finito in
prigione, e tra breve pubblicherà nuovi dettagli imbarazzanti, nel suo libro
«Disloyal» in uscita l'8 settembre. Martedì prossimo invece andrà in vendita
«Melania and Me», scritto dall'ex migliore amica della First Lady, Stephanie
Winston Wolkoff, che contiene le sue reazioni più emotive alle umiliazioni
subite. Stephanie ha registrato conversazioni in cui Melania attacca il marito e
i figli avuti con le due moglie precedenti, prendendosela con Ivanka, da sempre
la sua rivale. Lei la definisce «la principessa», viziata e poco intelligente,
mentre la favorita di Donald la chiamava «il ritratto», perché parlava con la
stessa eloquenza di un dipinto appeso al muro. Se i rapporti famigliari sono
tesi, quelli istituzionali sono sempre stati complicati per Melania. Dopo le
elezioni del 2016 aveva aspettato sei mesi per trasferirsi alla Casa Bianca,
secondo lei per consentire al figlio Barron di completare la scuola, ma secondo
i maligni perché aveva usato la leva di essere First Lady allo scopo di
rinegoziare l'accordo «prenuptial» col marito. Quando ne parla con gli amici,
descrive l'operazione come «la necessità di garantire il futuro di Barron», che
però riguarda anche il suo, quando al massimo tra quattro anni Trump dovrà
comunque lasciare la presidenza. Una volta arrivata aveva scelto un profilo più
discreto di Michelle, dedicandosi al programma per i bambini «Be Best». Però
aveva fatto parlare lo stesso di sé, quando in varie occasioni aveva rifiutato
di dare la mano al marito, aveva fatto cacciare la consigliera per la sicurezza
nazionale Mira Ricardel, o aveva visitato i bambini al confine col Messico
indossando un giacchetto con su scritto «I really don't care do u?» (A me non
importa, e a te?). Poi aveva spiegato che la cosa di cui non le importava nulla
erano le critiche dei media, e dei suoi nemici, ma vai a sapere la verità. Per
Donald, Melania non è l'unico rapporto complicato con le donne. Amava la madre
Mary Anne, immigrata dalla Scozia perché pativa la fame, ma la sorella omonima
Maryanne lo ha appena accusato di essere «crudele e senza principi». Lo ha fatto
parlando con la nipote Mary, che ha pubblicato il libro «Too Much and Never
Enough» apposta per far deragliare la rielezione dello zio. Poi ci sono almeno
25 donne che hanno denunciato abusi sessuali, tutti negati da lui, da Jessica
Leeds molestata su un aereo, alla stessa moglie Ivana, che nelle carte del
divorzio l'aveva accusato di stupro. Dalla sua parte in famiglia è rimasta
Ivanka, che sogna la sua poltrona, come l'ex ambasciatrice all'Onu Nikki Haley.
Nel 2016 Hillary Cinton aveva vinto il voto femminile, prendendo il 54% contro
il 42% di Trump, però l'affluenza non era stata alta come nelle attese e Donald
l'aveva battuta tra le donne bianche. Biden vuole cambiare questo dato per
vincere, ma Melania spera di essere il suo ostacolo, per completare la propria
missione.
DAGONEWS il 6 ottobre 2020. Melania Trump ha bollato Stormy
Daniels come una “porno puttana” mentre parlava con l’ex amica Stephanie Winston
Wolkoff che, dopo aver scodellato un libro in cui racconta i suoi anni accanto
alla first lady, adesso ha reso nota una sua intercettazione durante il podcast
di Michael Cohen “Mea Culpa”. Nella registrazione si sente Melania dire a
Wolkoff che Daniels stava facendo un servizio fotografico per Vogue. «Vai su
Google e leggi che Annie Leibovitz sta fotografando la porno puttana che sarà in
uno dei numeri di settembre o ottobre» dice Melania. Quando Wolkoff ha chiesto
alla first lady di chiarire chi fosse la “porno puttana”, Melania ha detto:
«Stormy». Wolkoff a quel punto dice alla sua ex amica: «Chiudi il becco». E
Melania ha incalzato: «Oh non l'hai letto. È uscito ieri. Sarà su Vogue. Annie
Leibowitz l’ha fotografata».
DAGONEWS il 7 ottobre 2020. In una risposta esplicita su Twitter,
Stormy Daniels ha attaccato la first lady Melania Trump per averla definita una
"porno mignotta" mentre chiacchierava con un'amica che la registrava di
nascosto. "Anche se non sono stata pagata per il sesso [fatto con Trump] e
quindi tecnicamente non sono una “prostituta”, preferisco essere definita così
ogni giorno piuttosto che essere lei", ha twittato la pornostar che ebbe una
relazione clandestina con il miliardario nel 2006, quando era da poco sposato
con Melania e il loro figlio Barron era appena nato. Rivolgendosi direttamente a
Lady Trump, scrive: "Tu hai venduto la tua figa E la tua anima ... e io sono
dalla parte della legge. Continua a parlare di me. Ah, a proposito, mi piacciono
le tue nuove tette. Perché non pubblichi (altre) foto nuda?" Daniels ha risposto
agli audio pubblicati da Stephanie Winston Wolkoff delle sue conversazioni con
Melania: "Se vai su Google, leggerai che Annie Leibovitz ha fatto un servizio
fotografico a quella porno mignotta, sarà su ''Vogue'' sarà in uno dei prossimi
numeri''.
Luciana Grosso per "it.businessinsider.com" il 27 agosto 2020. A
casa Trump sarebbe in corso una feroce guerra tra le due donne del Presidente:
la onnipresente figlia Ivanka e la quasi invisibile moglie Melania. Le due,
stando a quanto scritto nel libro “Melania & Me”, di Stephanie Winston Wolkoff,
amica di lunga data della First Lady, si detesterebbero. In particolare sembra
che Ivanka abbia fatto di tutto, negli ultimi anni, per mettere in cattiva luce
agli occhi del padre presidente la sua consorte e per isolarla e renderla sempre
meno influente. Melania dal canto suo considererebbe la figliastra e i suoi
alleati come “serpenti”.
Paolo Mastrolilli per “la Stampa” il 26 agosto 2020. La corsa
alla successione di Trump è già cominciata, da Ivanka e Don a Nikki Haley e
Pence, e con essa la battaglia per ridefinire l'anima del Partito repubblicano.
Tornare indietro dalla sua svolta populista non sarà facile, ma gli scenari sono
diametralmente opposti, a seconda di come andranno le elezioni. Qualunque sarà
il risultato del 3 novembre, nel 2024 Donald non potrà ricandidarsi, a meno di
cambiare le leggi fondamentali del paese e stravolgere la sua democrazia, come
peraltro teme Obama. Nel 2016 Trump aveva dirottato il Gop, prendendone possesso
con la demolizione dei candidati dell'establishment nelle primarie. Però la sua
vittoria, e gli anni alla Casa Bianca, non sono stati solo un fenomeno di
colore. Dal 1980 al 2016 il Partito repubblicano era rimasto quello forgiato
dalla rivoluzione di Reagan, cioè liberale, liberista, proiettato sulla scena
internazionale per garantire gli interessi nazionali degli Usa e affermare i
principi democratici e del rispetto dei diritti umani su cui si basavano. Donald
non è un filosofo o un politologo, ma la sua pancia gli ha fatto intuire che
quella formula non funzionava più. Dopo la crisi economica del 2008 l'umore del
paese era cambiato, creando lo spazio per una nuova coalizione basata su
populismo, sovranismo, isolazionismo e protezionismo. Una rivoluzione che Trump
ha cavalcato, demolendo l'establishment incarnato soprattutto dalla famiglia
Bush, e costruendo una nuova base che includeva anche tradizionali elettori
democratici, come i colletti blu della Rust Belt e i bianchi della classe media
e bassa, terrorizzati dalla prospettiva di perdere la primazia in favore degli
immigrati. E' una coalizione di minoranza, perché sul piano nazionale ha preso 3
milioni di voti meno di Hillary, ma sfruttando bene il collegio elettorale ha
conquistato la Casa Bianca. Se il 3 novembre Trump vincerà, diventerà il monarca
assoluto del Gop e deciderà la linea per la prossima generazione; se perderà, si
scatenerà il regolamento di conti, anche se tornare all'era reaganiana sarà
difficile. I pretendenti alla successione che già manovrano possono essere
divisi in 3 gruppi: i candidati istituzionali, come il vice Pence, il segretario
di Stato Pompeo, e in parte l'ex ambasciatrice all'Onu Haley; i familiari, cioè
la figlia Ivanka e il figlio Don; i leader del partito, come i senatori Cotton,
Scott, forse ancora Rubio e Cruz, la governatrice del South Dakota Noem. Se
Trump il 3 novembre vincerà, si rafforzerà la mano dei figli e degli
istituzionali, che hanno taciuto su eventuali disaccordi per conservare il suo
appoggio. Se perderà, potranno emergere le figure del Gop che vogliono
ricostruirne l'anima.
Massimo Gaggi per corriere.it il 28 agosto 2020. Una settimana
fa, nei suoi 25 minuti di discorso alla convention democratica, Joe Biden, pur
attaccando il presidente, non lo aveva mai citato per nome. Ieri sera in 70
minuti Donald Trump lo ha tirato in ballo ben 40 volte attaccandolo con molta
più veemenza di quanto aveva fatto la sera prima il suo vice, Mike Pence, al
quale era stato affidato il compito di demolire l’avversario. Chi si aspettava
che il candidato di un partito repubblicano che non ha presentato un programma
per il prossimo mandato avrebbe esposto la sua agenda, l’ha dovuta cercare, in
negativo, nella descrizione di tutti i disastri che accadranno in America se
Biden verrà eletto. Disastri che Trump sarà, invece, in grado di evitare. Come
sempre il presidente ha fatto ricorso a frasi iperboliche e a slogan velleitari
ma efficaci: «Noi costruiamo il futuro, loro demoliscono il passato
dell’America», «Biden non ha salvato l’anima dell’America, ha solo distrutto i
suoi posti di lavoro» regalandoli alla Cina, «non ha una soluzione per la
pandemia, la sua è solo una resa al virus» con conseguenze economiche e sociali
micidiali. Una demonizzazione del candidato democratico che sfiora gli accenti
grotteschi di suo figlio, Donald Junior, che due sere fa aveva parlato di Biden
come del «mostro di Loch Ness che emerge dalla palude» della politica americana.
Ma in un discorso comunque molto efficace anche perchè stavolta il leader,
costretto alla disciplina del teleprompter, ha seguito il copione studiato dagli
strateghi della sua campagna, Trump è riuscito a gettare sale sulle ferite
brucianti dei tanti errori commessi da Biden nei suoi 47 anni di carriera
politica: il presidente ha sottolineato che l’ex senatore ed ex vice di Obama
alla Casa Bianca, ha votato a favore della disastrosa guerra in Iraq, ha
promosso accordi commerciali che hanno spinto le imprese Usa a spostare molte
produzioni all’estero, si era opposto all’eliminazione di Bin Laden e ha
criticato il blitz contro il generale iraniano Souleimani. E quando, scoppiata
l’emergenza coronavirus, Trump ha ordinato lo stop ai collegamenti aerei con la
Cina, Biden ha giudicato questa mossa isterica e xenofoba. Tutta propaganda il
cui impatto sul voto del 3 novembre è difficile da valutare. Ma è curioso notare
che la critica più penetrante, quella che potrebbe fare più male a Biden
danneggiando il suo patrimonio politico più importante, il rapporto con
l’elettorato di colore, è venuto non dal presidente ma dalla figlia Ivanka.
(ANSA il 27 agosto 2020) Joe Biden "è un cavallo di Troia della
sinistra radicale. L'America ha bisogno di altri quattro anni di Donald Trump,
un presidente che finora ha mantenuto la sua parola con il popolo americano": lo
ha detto il vicepresidente Usa Mike Pence intervenendo alla convention
repubblicana.
Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera” il 27 agosto 2020. L'
altra sera, conclusa la diretta della convention repubblicana che ha presentato
quello per Donald Trump come un voto per la libertà e la prosperità mentre
scegliere Biden significherebbe disordini e saccheggi - e poco prima dei
disordini di Kenosha con l' uccisione di due manifestanti - Chris Cuomo e Don
Lemon, due dei conduttori della Cnn che per mesi hanno inneggiato alla
resistenza contro il razzismo delle polizie, hanno cambiato rotta: gli
americani, neri compresi, non vogliono meno polizia. Ne vogliono di più perché
hanno bisogno di protezione, soprattutto nelle periferie del disagio sociale. E
Lemon, anchorman afroamericano che spesso ha accusato Trump di criminalizzare le
grandi proteste pacifiche, ha finito per riconoscere, con aria sconsolata, che
ormai per molti americani proteste e insurrezioni sono uguali. Per mesi la
sinistra americana si è rifiutata di considerare le violenze notturne e i
saccheggi che avvenivano in margine alle grandi manifestazioni antirazziste come
una vera emergenza. Dietro l' obiezione ideologica - è meschino preoccuparsi dei
danni patrimoniali quando ci si batte per il diritto alla vita dei neri - c'
erano anche considerazioni pratiche: sconvolta dalle immagini dell' uccisione di
George Floyd da parte della polizia, la maggioranza dell' America (il 64%
secondo un sondaggio Reuters-Ipsos del 2 giugno) si era schierata per la prima
volta con le proteste di Black Lives Matter. Mentre Donald Trump, che aveva
reagito mobilitando l' esercito, continuava a perdere terreno negli indici di
popolarità. Lontanissimo da quelli di Biden, sembrava alle corde anche per la
sua incapacità di affrontare la crisi del coronavirus. Per molti era ormai
votato a una sconfitta inevitabile alle presidenziali del 3 novembre.
Sottovalutando i problemi di ordine pubblico, il fronte progressista ha commesso
un errore politico grave subito segnalato da molti. Un analista che, sulla base
degli studi sui disordini degli anni Sessanta, aveva ammonito che mentre le
grandi proteste pacifiche fanno guadagnare voti al partito democratico, gli atti
di ribellione violenta gliene fanno perdere, era stato addirittura licenziato da
Civiqs Analytics, un istituto di ricerche sociali vicino alla sinistra. Eppure
già all' inizio dell' estate bastava girare per le strade di una New York
stremata dalla pandemia e ora costretta a blindare le vetrine con pannelli di
legno o parlare con i negozianti neri e ispanici delle periferie che erano stati
le vittime principali di incendi e saccheggi, per capire che stava montando una
situazione sociale esplosiva: esasperazione che poteva diventare un' efficace
ciambella di salvataggio per la campagna di Trump: la paura dell' anarchia.
Incapace di contenere la diffusione del virus e con l' economia a pezzi, al
tycoon arrivato alla Casa Bianca non restava che giocare la carta law and order.
Per tutta l' estate i disordini si sono moltiplicati da un capo all' altro del
Paese. E quando a Kenosha, dopo due notti di devastazioni, sono scese in campo
le milizie degli attivisti di destra e un «giustiziere» ha ucciso due
dimostranti, gli analisti di sinistra si sono improvvisamente resi conto che
tutto questo rischia di portare acqua al mulino di Trump, anche se chi protesta
è la vittima e i razzisti sono i carnefici. Già alle prese con un presidente che
viola di continuo regole e vincoli istituzionali e che minaccia, se sconfitto,
di non riconoscere l' esito del voto, ora l' America democratica assiste a un
principio di recupero di Trump nei sondaggi che potrebbe diventare una vera e
propria riscossa da qui al giorno del voto. Un cambio di rotta legato agli umori
degli americani che temono soprattutto disordine e criminalità. Un senso di
insicurezza facile da fomentare in un Paese con i nervi a fior di pelle e nel
quale chiunque è libero di andare in giro armato.
Il vicepresidente Pence rilancia per altri 4 anni alla Casa
Bianca: "Basta violenze. Biden un cavallo di troia della sinistra radicale".
Massimo Basile il 27 agosto 2020 su La Repubblica. Terza serata della convention
repubblicana: Trump non si è fatto vedere, lasciando spazio al suo vice. Che in
una serata piena di messaggi politici diretti alle donne ("Trump è al nostro
fianco nelle nostre lotte") e alla base del partito, parla delle proteste di
questi giorni, schierandosi contro i manifestanti: "Avremo legge e ordine per le
strade dell'America e per ogni americano di ogni razza". "Vediamo violenze nelle
strade, il presidente Trump sostiene le manifestazioni pacifiche, ma le
devastazioni non sono proteste. La violenza deve finire, a Minneapolis, Portland
e Kenosha. Troppi eroi sono morti per difendere la nostra libertà per vedere gli
americani colpirsi gli uni con gli altri. Noi avremo la legge e l'ordine nelle
strade di questo Paese per ogni americano di qualsiasi credo e colore". Con
questo messaggio il vicepresidente Mike Pence, da Fort McHenry, Maryland, dove
nel 1812 venne issata la bandiera americana con cui si annunciava la vittoria
contro gli inglesi nella battaglia di Baltimora, ha rilanciato lo slogan di
Trump "law and order", al fianco della polizia nelle ore in cui il nuovo caso di
violenza verso un afroamericano infiamma l'America. I Milwaukee Bucks hanno
deciso di non giocare gara 5 dei playoff del campionato Nba in segno di protesta
e il ragazzo di 17 anni che ha ucciso due manifestanti pacifici afroamericani, è
risultato essere stato a un comizio di Trump.Pence ha ribadito piena fiducia
nella polizia: "Uomini e donne che indossano quell'uniforme sono i migliori di
noi. Ogni volta escono dalla porta di casa, pensano alla vita degli altri più
che alla loro". Pence ha poi ricordato la morte di un poliziotto, Dave Patrick
Underwood, ucciso durante gli scontri a Oakland. La sorella dell'agente, Angela,
commossa, ha seguito il discorso in platea. "Gli americani sanno - ha aggiunto -
che noi non scegliamo tra sostenere le nostre forze di polizia e i nostri vicini
afroamericani perché migliorino la qualità della loro vita. E per la prima
volta, questa amministrazione ha realizzato entrambe le cose". Il vicepresidente
ha ricordato la posizione di Joe Biden, che ha parlato di razzismo in America e
di pregiudizio nella polizia. E a quel punto, Pence ha ripetuto il mantra
repubblicano: "Biden vuole togliere fondi alla polizia. Con lui non sarete più
al sicuro. Noi non toglieremo mai i fondi alla polizia, né ora né mai". Il
messaggio relativo alle violenze, prima escluso poi inserito nel discorso
ufficiale, non ha riservato sorprese, confermando la saldatura sempre più forte
tra la Casa Bianca e la polizia. Un'ora prima, tra gli speaker si era presentato
anche Michael McHale, dell'associazione nazionale delle organizzazioni di
polizia, che aveva attaccato le città di Portland, Chicaco, Seattle e New York
per non aver appoggiato la polizia. Trump è convinto che una rivolta sociale
degli afroamericani potrebbe spaventare gli elettori americani e portarli a
scegliere il candidato repubblicano del "law and order". La polizia spera nella
rielezione di Trump, altri episodi di violenza potrebbero creare il terreno più
favorevole al tycoon. "Dovete scegliere tra il presidente più fedele alla
polizia - ha aggiunto McHale - o tra i più radicali che possiamo avere". Pence
si è messo sulla stessa linea d'onda. Il vice di Trump era entrato sulla scena,
accompagnato dalla moglie Karen, salutato da una platea di una settantina di
persone, in maggioranza senza mascherina di protezione, che hanno cominciato a
cantare "four more years". Dopo aver invitato i cittadini a stare al riparo in
attesa dell'arrivo dell'uragano Laura, Pence ha annunciato di accettare la
nomination a correre come vicepresidente, per poi ringraziare la moglie, i tre
figli, e la madre, Nancy, presente in platea. I democratici hanno speso quattro
giorni attaccando l'America - ha commentato - ma come ha detto il presidente
Trump, dove Joe Biden vede le tenebre, noi vediamo la grandezza. C'è bisogno di
altri quattro anni di Trump alla Casa Bianca. Il presidente vede l'America per
come è". E ancora un tema molto gettonato della convention: "Biden un cavallo di
troia della sinistra radicale". Pence ha ricordato l'eliminazione del generale
iraniano Qasem Soleimani, e le critiche rivolte da Biden a Trump. Ha poi
sottolineato come il presidente abbia "mantenuto le promesse" e spostato la sede
dell'ambasciata a Gerusalemme. Il numero due alla Casa Bianca ha ricordato
ancora la creazione di "sette milioni di nuovi posti di lavoro" nei primi tre
anni alla Casa Bianca e il tragardo dell'indice di disoccupazione più basso
negli ultimi 65 anni. Ma poi è arrivata la pandemia. Pence ha ribadito il
tempismo di Trump nel "bloccare i voli dalla Cina, il secondo Paese più forte
economicamente al mondo" e l'impegno della Casa Bianca nel cercare un vaccino
contro il virus. "Biden dice che nessun miracolo è in arrivo - ha detto. ma
l'America è la terra dei miracoli. E allora vi annuncio che avremo il primo
vaccino sicuro entro la fine dell'anno". "Non solo abbiamo aperto l'America - ha
continuato - ma apriremo anche le scuole". L'ingresso di Donald Trump con la
moglie Melania ha chiuso la serata, con gli applausi della platea e i reduci e
mutilati che si sono avvicinati, a fatica, supportati da stampelle, per salutare
Trump e la First Lady. Il presidente e Melania li hanno applauditi ma senza
avvicinarsi per motivi di sicurezza legata al Covid, mentre Pence ha salutato
scambiando il gesto del pugno. E' stata anche la serata della Second Lady, Karen
Pence, insegnante elementare da venticinque anni, che ha ricordato i cento anni
dal diritto di voto alle donne e il ruolo dei soldati americani, tra cui il
figlio Michael, arruolato nei Marines. Ma anche quello delle "mogli" dei
militari. La Second Lady ha poi raccontato l'incontro con chi lavora al servizio
di emergenza per i veterani. "Una in particolare - ha detto - Sidney Morgan, una
veterana, disse che il suo onore più alto è stato poter accompagnare una persona
fisicamente in ospedale perché ricevesse le cure di cui aveva bisogno". Come
insegnante di una scuola privata, Karen tornerà in classe, in Virginia. "In
questi tempi difficili - ha commentato - stiamo vedendo molti esempi di
americani che aiutano gli altri, sono tutti eroi". La terza serata della
convention repubblicana era partita con due notizie contrastanti: la netta
rimonta di Trump nei confronti di Biden secondo i sondaggi di Rasmussen, che ha
dato il 46 per cento al democratico e 45 al presidente, ma la vittoria dei
democratici nell'audience: 18 milioni di persone hanno seguito la seconda
serata della convention virtuale dei repubblicani - segnata dagli interventi
della First Lady Melania, il segretario di Stato Mike Pompeo, e i due figli di
Trump, Eric e Trump - duecentomila spettatori in meno rispetto alla seconda
giornata di quella democratica. Il dato è stato registrato da Nielsen Media
Research. Il tema di questa terza serata era "La terra degli eroi", introdotto
da un video patriottico a cui ha fatto seguito la preghiera di un rabbino. I
messaggi più forti sono stati indirizzati per rinsaldare l'immagine del governo
forte per tempi difficili. La senatrice Marsha Blackburn ha lodato le "forze di
polizia", evitando di citare le ultime violenze ai danni di afroamericani. La
governatrice del South Dakota, Kristi Noem, prima donna eletta in questo ruolo,
ha annunciato il recupero dell'80 per cento dei posti di lavoro persi con la
pandemia "grazie al fatto che non è stato mai chiuso del tutto lo Stato", dunque
esaltando la linea dura di chi ha sempre scelto di ridimensionare la gravità di
un contagio che ha provocato oltre 177 mila morti e quasi 5 milioni e 800 mila
contagiati solo negli Stati Uniti. Messaggi di forza anche dalla responsabile
per i media della Casa Bianca, Kayleigh McEnany che ha rivelato la malformazione
genetica che le aveva aumentato la possibilità di contrarre un cancro al seno.
Dopo l'intervento di mastectomia preventiva, ha raccontato, ha ricevuto la
telefonata del presidente Trump, che le ha fatto coraggio. Lara Trump, moglie
del terzogenito del presidente, Eric, ha rilanciato il messaggio del bivio per
l'America: "Non sarà una scelta tra democratici e repubblicani - ha detto - o
tra destra e sinistra, ma tra la vera America e il socialismo". Altra donna
chiamata a parlare a favore del presidente, anche Kellyanne Conway, rimasta tra
le speaker nonostante domenica sera avesse annunciato,
all'improvviso, l'interruzione della sua collaborazione con il presidente. Nel
suo intervento l'ex consigliera di Trump ha puntato sulla determinazione delle
donne, ricordando di essere cresciuta in una famiglia, che è di origine
italiana, formata da sole donne, la madre e le sorelle. "E nessuna si è mai
lamentata", ha aggiunto. "Il presidente Trump e Pence - ha continuato - hanno
dato all'America la possibilità di crescere nel segno della dignità". Conway ha
lodato il presidente per "aver sempre elevato ai ruoli maggiori le donne sia
negli affari sia nel governo. Rispetta le nostre opinioni, ci ha fatto sentire
uguali agli uomini. Si è dimostrato un campione per le donne".
Donald Trump: "Accetto la nomination. La scelta è tra il sogno
americano e il socialismo. Fermeremo le folle inferocite nelle nostre città".
Anna Lombardi su La Repubblica il 28 agosto 2020. Si
chiude la convention repubblicana. Lungo intervento di Donald Trump, oltre
un'ora, spesso interrotto dai canti "U-S-A" e "Altri quattro anni". Metà del
discorso per magnificare i risultati ottenuti, l'altra metà per attaccare i
democratici: "Biden cavallo di troia per la sinistra radicale, vogliono
aumentare le tasse, noi le ridurremo ancora e in maniera sostanziale. In tre
anni abbiamo costruito la più forte economia del mondo". "L'agenda di Joe
Biden è Made in China. La mia è completamente americana". Donald Trump appare
sul palco della convention repubblicana, per il finale tutt'altro che virtuale,
quando in America sono appena passate le 22:30. Scende le scale della Casa
Bianca tenendo per mano la First Lady Melania, inusualmente vestita di verde
(una scelta fuori dai canoni: a eventi del genere le donne del partito indossano
di solito i colori della bandiera, il rosso o il blu). E poi arringa per
olun'ora di fila i 1900 ospiti che affollano il South Lawn, il prato a sud della
residenza presidenziale. Tutti senza mascherina: e senza nessun distanziamento
sociale. "Queste sono le elezioni più importanti della storia del nostro Paese.
Dovete decidere tra sogno americano e agenda socialista", dice quasi subito il
presidente, ripetendo quello che i suoi compagni di partito hanno affermato per
quattro sere di fila. "La scelta", lo chiarisce subito, "è fra due opposte
visioni del mondo". Per poi scartabellare dati mirabolanti: "Abbiamo portato
l'economia ai livelli più alti della Storia". D'altronde a President Trump non
era piaciuto affatto il ritratto dell'America violenta, soffocante e oscura,
dipinto dai rivali democratici nei quattro giorni della loro convention, una
settimana fa. Lo ha ripetuto più volte e all'inizio del suo discorso è sembrato,
effettivamente voler indirizzare l'America in una direzione diversa, all'insegna
di una positiva speranza: "Non viviamo in un Paese ammantato di buio, siamo la
torcia del mondo". E mentre dalla strada arrivavano gli slogan di un gruppo di
contestatori piccolo ma rumoroso, si è detto pronto ad accogliere tutti:
"Democratici, indipendenti, chiunque vorrà condividere i nostri valori".
Affermando solenne, con le bandiere a stelle e strisce, svolazzanti alle spalle:
"Accetto la nomination con speranza e ottimismo". Poi, però, il lato oscuro di
questa elezione è tornato a prendergli la mano: "Questa è la più importante
elezione della Storia di questo paese" attacca. "La scelta è difendere lo stile
di vita americano o permettere che venga distrutto". Infierendo: "Joe Biden ha
chiamato l'America un luogo d'ingiustizia politica: Come sperano di guidare il
paese, quando in realtà lo vogliono abbattere?". Prima del virus "cinese"
ricorda, le cose andavano bene. E solo se lui sarà rieletto, l'economia tornerà
a volare. E per questo, promette. Eccome se promette: "Creerò dieci milioni di
posti di lavoro nei prossimi dieci mesi" dice. E ancora: "Taglierò le tasse".
"Ripristinerò la legalità nelle città sconvolte dalle proteste". E soprattutto:
"Entro la fine dell'anno vi darà un vaccino anti Covid". Il mondo che verrà se
lui sarà rieletto è però poca cosa rispetto a quello che potrebbe accadere se a
vincere, il 3 novembre, dovesse essere il rivale. Metà intervento è infatti
mirato a distruggere lo sfidante: "È il cavallo di Troia della sinistra più
estrema. Col vostro voto sceglierete se proteggeremo le leggi o daremo carta
bianca agli anarchici violenti, gli agitatori, i criminali che minacciano i
nostri cittadini".
I giorni della convention Gop: la cronaca. Anna Lombardi su La
Repubblica il 28 agosto 2020.
Ivanka Trump: "I politici scelgono il partito, mio padre le
persone. Siete voi le elite". La figlia del presidente, la sua consigliera più
fidata, introduce il discorso di accettazione della nomination del padre: "Sono
l'orgogliosa figlia del presidente del popolo". "Sono l'orgogliosa figlia del
presidente del popolo, difensore del buon senso e paladino dei lavoratori". Nel
gran finale della convention repubblicana, che - infischiandosene delle leggi
che non lo permetterebbero - ha trasformato la Casa Bianca nel palcoscenico di
un grande comizio elettorale, tocca a Ivanka Trump introdurre suo padre Donald
Trump. Chiaro segnale che la "First Daughter" è prima pure nella linea di
successione: alle presidenziali 2024, s'intende. Ivanka, d'altronde, resta la
consigliera più influente. "Mio padre non è venuto a Washington per ingraziarsi
l'élite" afferma davanti a una platea di 1900 ospiti: "Ma per battersi ogni
giorno per voi". Sì, suo padre non è un tipo convenzionale, ammette. "E per
questo lo attaccano. Ha uno stile di comunicazione che non piace a tutti ma dice
sempre quello che pensa". Pantaloni grigi con su una maglia nera molto scollata,
la figlia preferita sembra decisamente a suo agio davanti alla scenografia di
bandiere a stelle e strisce. Ivanka ha 38 anni, tre figli cui ha voluto
insegnare pure il cinese, ed è la moglie di quel Jared Kushner che si dice sia
l'unico in grado di calmare President Trump nei momenti di rabbia: per via della
sua voce suadente. "I politici scelgono il partito, mio padre le persone",
rilancia. Ricordando di essere stata sempre lei a introdurlo alla convention del
2016: "Quattro anni fa vi dissi che mio padre si sarebbe impegnato a rendere i
costi della cura dei bambini più basse. Ebbene, nel solo 2019 i nostri tagli
alle tasse per le spese che li riguardano hanno rimesso 2000 dollari nelle
tasche di 40 milioni di famiglie americane". E questa non è certo l'unica delle
promesse mantenute. "A Washington ho scoperto come fanno i politici a
sopravvivere tanto a lungo: lamentandosi invece di agire. Ma Donald Trump è
venuto qui per fare l'America Grande di nuovo. Per mio padre voi siete l'élite.
Washington non ha cambiato mio padre. Mio padre ha cambiato Washington".
Beatrice Pagan per "movieplayer.it" il 27 agosto 2020. Bette
Midler non ha risparmiato parole molto dure nei confronti di Melania Trump e via
Twitter ha criticato apertamente il suo modo di parlare e le sue origini, dando
il via a una discussione molto accesa sui social dopo che la first lady è
intervenuta per sostenere il marito nei primi passi della campagna elettorale.
Nella giornata di ieri si è svolta negli Stati Uniti la seconda serata della
convention Repubblicana che ha visto salire sul palco la coppia che potrebbe
lasciare la Casa Bianca tra qualche mese. Bette Midler, recentemente tra le
protagonista della seconda stagione di The Politician, ha quindi commentato
online la convention politica attaccando apertamente la first lady Melania Trump
per quello che stava dicendo sul palco e ricordando come avesse alimentato le
polemiche legate al certificato di nascita di Barack Obama, rispondendo poi a
chi le ha chiesto i motivi dei suoi commenti: "Perché non dovrei? Sto
semplicemente dando un assaggio della loro stessa medicina contro gli
immigrati". I commenti all'intervento della moglie di Donald Trump avevano preso
il via scrivendo: "Sa parlare alcune parole in varie lingue. Fate scendere dal
palco quell'alieno illegale". Bette aveva poi proseguito commentando il lavoro
compiuto dalla first lady sul giardino delle rose alla Casa Bianca, sostenendo
che sia riuscita a privarlo di ogni colore, ma Trump ha riequilibrato la
situazione con il suo bronzer. La star ha quindi continuato: "Perché stanno
promuovendo questa persona orribile, Melania? Era nel suo contratto? Dice che le
sembra ieri la partecipazione alla loro prima convention. Forse per te è così,
Mel. Per noi ogni giorno è stato un orribile trascinarsi verso il nono girone
dell'Inferno". Midler ha notato ironica: "Sono sorpresa che Trump voglia
distruggere la posta. Ha ottenuto tutte le sue mogli usandola". Nei tweet
successivi Bette ha scritto "A Melania manca così tanto il calore che ho dovuto
abbassare la mia aria condizionata", "Un semplice, ma coraggioso, sogno di
rimanere viva per altre 24 ore, non grazie a me e il mio orrendo marito. Donald
ama l'America e sa come twittare e dire 'Sei licenziato!'", "Sei una slovena
fortunata! E dopo tutta quella chirurgia hai ottenuto un premio orribile, sei
incatenata a un colossale idiota", fino al commento sull'uscita di scena della
coppia "Sì, sta lasciando che le tenga la mano! Ecco un altro milione da
pagare!".
Stati Uniti, ex consigliera accusa Melania Trump: "Utilizzava
account di email private dalla Casa Bianca".
Pubblicato mercoledì, 02 settembre 2020 da La Repubblica.it. Melania Trump ha
fatto regolarmente uso dei suoi account privati di posta elettronica e
messaggistica durante la sua permanenza alla Casa Bianca. A rivelarlo è l'ex
consigliera e amica della first lady, Stephanie Winston Wolkoff, intervistata
dal Washington Post in occasione della pubblicazione del suo libro di
memorie, Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady.
Il libro di Winston Wolkoff, "Melania and Me", è unico nel panorama dei libri
sui Trump, il solo che offre uno sguardo dall'interno al mondo privato della
First lady. Le due avevano un'amicizia che durava da 15 anni, ha spiegato
Winston Wolkoff, iniziata a New York City e proseguita per tutto il primo anno
di Melania alla Casa Bianca, dove Winston Wolkoff era la sua consigliera senior
non retribuita. Secondo Winston Wolkoff, la First lady ha fatto uso di un
account email privato della Trump Organization, un'email dal
dominio MelaniaTrump.com, iMessage e l'app di messaggistica
crittografata, Signal, sia per trattare questioni di natura semi privata che
ufficiale. "Melania ed io non usavamo email della Casa Bianca", ha detto Winston
Wolkoff. ll Post ha visualizzato i messaggi datati dopo l'inaugurazione che
sembrano provenire da account di posta elettronica e messaggi privati utilizzati
da Melania. I messaggi contenevano discussioni su assunzioni e contratti
governativi (incluso quello di Winston Wolkoff), programmi dettagliati per il
presidente e la First lady durante le visite di Stato israeliane e giapponesi,
partnership strategiche per l'iniziativa Be Best della first lady e le spese per
l'inaugurazione presidenziale, eventi chiave che Winston Wolkoff, già esperta
pianificatrice di eventi di New York, ha aiutato Melania Trump ad organizzare.
Lei e Melania sono diventate amiche all'inizio degli anni 2000. All'inizio di
quell'amicizia, Melania era una modella immigrata slovena conosciuta per gossip
e in seguito per aver sposato Donald Trump, Stephanie Winston Wolkoff era
un'affermata collaboratrice di Vogue. Winston Wolkoff dice di ammirare la fredda
sicurezza di Melania. "Melania non è sola; è autonoma ", ha detto al Post. "La
gente pensa che sia, tipo, triste e intrappolata, e non lo è". Ma le email dalla
Casa Bianca sono uno scivolone, come le registrazioni che l'autrice riporta nel
suo libro. Altri membri dell'Amministrazione Trump, come la figlia del
presidente Ivanka e il genero Jared Kushner, insieme al ministro del
Commercio Wilbur Ross, sono in passato stati criticati per l'uso di account
email privati nella gestione di questioni ufficiali. Nel 2016, uno dei temi
controversi della campagna presidenziale, più volte evocato dallo stesso Trump
che lo definì "peggio del Watergate", fu l'uso da parte della candidata
democratica Hillary Clinton del suo account email privato per trattare questioni
legate al suo precedente incarico di segretario di Stato. "È un'ipocrisia
totale" ha detto al PostRichard Painter, ex l'avvocato capo dell'etica della
Casa Bianca per George W. Bush dal 2005 al 2007: "Sono stati eletti
comportandosi come se Hillary Clinton dovesse essere in prigione per aver usato
l'email sbagliata." Una First lady non è un'impiegata del governo, ha detto
Richard Painter al WP, ma "se sta facendo affari con il governo degli Stati
Uniti, dovrebbe usare l'email della Casa Bianca. "L'uso di account personali è
consentito ai sensi del Presidential Records Act, ma è rischioso: se non vengono
conservati con cura, la Casa Bianca potrebbe non essere in grado di produrli in
risposta a una citazione. (Anche illegale: discutere di qualsiasi cosa
classificata su account non ufficiali). La Casa Bianca non ha risposto a una
richiesta di commento sulle email della First lady da parte del Washington Post,
ma ha ha rilasciato recentemente diverse dichiarazioni secondo cui il libro di
Winston Wolkoff è pieno di falsità. In una dichiarazione al Post, Stephanie
Grisham, portavoce di Melania Trump e capo del personale, ha stroncato il libro
definendolo "storia revisionista". Ha anche attaccato le motivazioni e il
carattere di Winston Wolkoff, suggerendo di averlo scritto "per un immaginario
bisogno di vendetta". "Non si tratta di me che faccio qualcosa a Melania", ha
replicato l'autrice del libro. "Si tratta di me che condivido con il mondo chi è
questa famiglia e cosa succede a porte chiuse".
Stefano Graziosi per “la Verità” il 25 agosto 2020. Ulteriori
grane per l'Fbi. Stando a nuovi documenti desecretati venerdì dalla commissione
Giustizia del Senato, i federali si sono macchiati di doppiopesismo a favore dei
democratici, durante la campagna elettorale per le presidenziali di quattro anni
fa. Secondo il materiale, nell'ottobre 2015 «i rappresentanti legali di Hillary
Clinton sono stati avvisati del fatto che il Bureau avesse informazioni che un
governo straniero [il cui nome è secretato nel documento, ndr] stesse tentando
di influenzare la campagna di Hillary Clinton attraverso sforzi di lobbying e
contributi alla campagna». In particolare, si precisò quanto segue: «I
contributi alla campagna potrebbero venire in una forma al di fuori dei
parametri stabiliti per tali contributi». Il briefing venne condotto dall'agente
del controspionaggio, David Archey, che - come riportato da Politico - in
seguito avrebbe operato nell'ambito dell'inchiesta del procuratore speciale,
Robert Mueller, sul Russiagate. Ora, da quanto emerge dai nuovi documenti, lo
stesso Archey sostenne che l'Fbi informò la campagna elettorale della Clinton
onde consentire a quest' ultima di «intraprendere le azioni appropriate per
proteggersi». In base ai documenti, il Bureau aveva aperto un'«indagine
approfondita» sulla questione già nel novembre 2014. Infine, secondo quanto
emerso da svariate email desecretate, alcuni agenti federali chiesero con
insistenza che venisse ottenuto un mandato per mettere sotto controllo il
soggetto anonimo, che si presumeva collegato al governo straniero. Il
procedimento tuttavia si incagliò e - secondo il presidente della commissione
Giustizia, il senatore repubblicano Lindsey Graham - la sorveglianza alla fine
non ebbe luogo. Ricapitolando: l'Fbi reperì prove del fatto che un governo
straniero volesse influenzare la campagna di Hillary Clinton. Davanti a queste
prove, non solo il Bureau informò l'allora candidata democratica dell'indagine
in corso, ma evitò anche di ottenere un mandato per mettere un sospettato sotto
sorveglianza. Un comportamento ben differente da quello tenuto con il comitato
elettorale di Trump l'anno successivo. Secondo documenti desecretati il mese
scorso, l'Fbi tenne un briefing all'allora candidato repubblicano nell'agosto
2016. Un briefing in cui Trump non venne minimamente informato del fatto che,
nel luglio precedente, il Bureau avesse avviato Crossfire Hurricane: un'indagine
su alcuni esponenti del suo stesso comitato elettorale. Non solo il Bureau non
ne fece parola ma usò addirittura quel briefing per carpire indebitamente
informazioni allo stesso Trump e al suo consigliere, Mike Flynn, sulle presunte
collusioni tra il futuro presidente e la Russia. Tutto questo, senza poi
dimenticare che i federali avrebbero messo con successo sotto sorveglianza un
collaboratore di Trump, Carter Page, ricorrendo a un documento infondato come il
dossier di Christopher Steele. Perché - a parità di situazione - il Bureau
avvertì lo staff elettorale di Hillary nel 2015 e non fece altrettanto con
quello di Trump nel 2016? In tutto questo, c'è anche da chiedersi quale fosse il
governo straniero che, secondo l'Fbi, voleva influenzare la campagna elettorale
di Hillary: una Hillary che, tra la fine del 2014 e i primi mesi del 2015, quasi
tutti gli analisti davano in pole position per la Casa Bianca. Come già
evidenziato, nei documenti il nome di questo governo resta al momento secretato.
Eppure qualche ipotesi si può avanzare. In primis, non dimentichiamo che -
nell'aprile 2015 - il New York Times riportò la faccenda Uranium One, che
metteva sotto i riflettori controversi rapporti tra la famiglia Clinton e la
Russia. In secondo luogo, guardiamo alle modalità di influenza descritte dal
Bureau, che - come detto - ha parlato di lobbying e contributi illegali. Una
modalità che ricorda molto il cosiddetto caso Chinagate, quando - il 13 febbraio
1997 - il Washington Post sostenne che «rappresentanti della Repubblica popolare
cinese» avessero cercato di inviare contributi illegali al Comitato nazionale
del Partito democratico, durante la campagna per la rielezione di Bill Clinton
nel 1996. In particolare, secondo l'articolo, un ruolo rilevante sarebbe stato
svolto dall'ambasciata cinese a Washington. Ne scaturirono polemiche e, da più
parti, si chiese di nominare un procuratore speciale che indagasse sulla
faccenda. Peccato che, nel dicembre 1997, l'allora ministro della Giustizia,
Janet Reno, respinse al mittente una simile ipotesi. L'unica cosa certa è che,
nel corso del suo secondo mandato presidenziale, Clinton fu molto accomodante
con Pechino, aprendole la strada per l'ingresso nell'Organizzazione mondiale del
commercio. Che dunque la Cina abbia tentato influenze simili su sua moglie? Non
è al momento dato saperlo. Sarà comunque un caso: ma all'inizio di agosto il
controspionaggio americano ha evidenziato che, per il 2020, la Repubblica
popolare vedrebbe con particolare favore una vittoria di Joe Biden.
La mossa del Vaticano: così la Chiesa soccorre Joe Biden.
Francesco Boezi il 30 agosto 2020 su Inside Over. La
Chiesa cattolica americana si sta spaccando in vista delle elezioni
presidenziali, mentre le istituzioni ecclesiastiche del Vaticano sembrano avere
idee chiare sul candidato da favorire. Joe Biden in queste settimane è divenuto
oggetto di discussione tra i fedeli e sui media vicini agli ambienti cattolici
per via delle sue posizioni sull’aborto. Il candidato dei Dem, come buona parte
del partito che rappresenta, non è un anti-abortista. Il cardinale conservatore
Raymond Leo Burke, anche sulla scia di considerazioni ratzingeriane, ha
dichiarato che Biden, così come gli altri politici abortisti, non dovrebbero
avere accesso al sacramento dell’eucaristia. La polemica non è nuova. Il
doppiopesismo dei cattolici democratici alla Biden è un argomento che alimenta
da sempre le critiche del “fronte tradizionale”. Joe Biden – questa è una novità
rispetto alle ultime scelte degli asinelli – è sì un candidato progressista, ma
anche un credente. In materia bioetica, però, Biden non persegue la linea della
Chiesa. E dunque perché la Santa Sede dovrebbe simpatizzare per l’esponente dei
Dem? Le politiche di Donald Trump in materia d’immigrazione ed ambiente non sono
in linea con la visione di papa Francesco, dunque con quella del Vaticano.
Durante questi anni le acredini tra le parti sono state evidenti: dalla
questione del muro al confine con il Messico alle continue rimostranze
dell’episcopato cattolico statunitense contro il tycoon, passando per la mancata
concordia sul da farsi dal punto di vista ecologico. Il Vaticano e Trump hanno
faticato a trovare punti di contatto nel corso di questi quattro anni. Biden
rappresenta in questo senso un’occasione per normalizzare i rapporti. L’ex vice
di Barack Obama, giusto per fare un esempio, è un sostenitore del
multilateralismo diplomatico. Non si può dire lo stesso di Trump. Gestione dei
fenomeni migratori, ambientalismo e geopolitica costituiscono un trittico per
cui Santa Sede e Casa Bianca potrebbero andare d’accordo nel prossimo futuro. Ma
rimane il problema del pensiero di Biden sull’aborto e sulle altre questioni
considerate non negoziabili dal Vaticano. Trump ha inviato un messaggio chiaro,
facendo della convention repubblicana pure un palcoscenico per attori politici
pro life. La presenza di suor Dede Byrne all’appuntamento pre-elettorale del
Gop, con un discorso centrato su come Trump da presidente abbia davvero tutelato
i cattolici americani, ha destato scalpore. Sembra che The Donald, anche in
funzione della turnata di novembre, voglia sfruttare la polarizzazione delle
opinioni, provando a pesuadere i cattolici di essere il loro unico paladino. La
“maggioranza silenziosa”, che è composta anche da fedeli, può essere convinta,
sfruttando il “fattore coerenza”. La Santa Sede, che forse ha fiutato l’aria, ha
in qualche modo replicato alla mossa di The Donald per il tramite di
un’intervista rilasciata a Crux da monsignor Vincenzo Paglia, ecclesiastico
progressista e presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Paglia, in
ottica di “schieramenti vaticani”, è considerato un bergogliano doc. Il
monsignore italiano, in buona sostanza, ha dichiarato che le posizioni dei
politici in bioetica non devono essere strumentalizzate per fini elettorali. Gli
“argomenti bioetici” – ha fatto intendere Paglia – non deve essere “indirizzata”
verso “strategie ideologiche”. Il che, tradotto, potrebbe suonare più o meno
così: non si deve politicamente stigmatizzare Joe Biden in quanto abortista. Un
bell’assist servito tra i piedi del candidato alla presidenza dei Dem. La Chiesa
cattolica vive così un cortocircuito piuttosto palese, dove l’anti-trumpismo può
addirittura declinarsi in simpatie verso un candidato abortista. Ma la
sensazione che permane è quella di uno scollamento tra la base dei fedeli – base
convintamente trumpiana – e le alte sfere ecclesiastiche, che sembrano
propendere per la speranza in un’affermazione di Joe Biden. Altri argomenti, in
specie relativi ai migranti, potrebbero essere sollevati nel corso dei mesi che
separano gli americani dalle urne. La Chiesa avrà insomma ulteriori occasioni di
dire la sua, ma per ora sembra che il cattolicesimo democratico propagandato da
Biden sia per lo più in grado di convincere, quantomeno tra i cattolici,
soltanto i sacri palazzi o quasi.
Il formidabile (e censurato) discorso di Trump all’Onu.
Giovanni Sallusti, 23 settembre 2020 su Nicolaporro.it.
Scusate, ma mentre nell’Italietta il partito scomparso dalle urne festeggia la
vittoria elettorale e i leader dell’opposizione si rinfacciano le rispettive
candidature sbagliate, fuori da qui è avvenuto qualcosina. Per esempio, un
discorso alle Nazioni Unite del presidente della più grande democrazia
globale, Donald Trump. Un discorso epocale, perché forse mai così esaustivamente
quello che i media liberal ci presentano come un improvvisato col parrucchino
aveva spiegato la sua visione dell’America, dunque del mondo. E lanciato le sue
sfide geopolitiche, che non sono fumosa dottrina, ma urgenze dirimenti,
chiariranno se vivremo liberi o a rischio internamento nei laogai cinesi, tanto
per dire. Un discorso che i giornaloni hanno nascosto a pagina 23 e i tiggì
accennato prima della pubblicità, pare che sia più importante per i nostri
destini la probabile depressione di Michelle Obama.
Il doppiopesismo su Trump. Ebbene, proviamo a rimediare noi, che
abbiamo molti difetti ma certo non la sudditanza alla narrazione modaiola,
quella che vuole Trump come un restauratore del Ku Klux Klan. “75 anni dopo la
fine della Seconda Guerra Mondiale, siamo ancora una volta impegnati in una
grande lotta globale”, debutta secco il Potus. Infatti, e qui Trump persevera in
un suo vizio politicamente scorretto, quello di dare alle cose il loro nome,
“siamo impegnati in una feroce battaglia contro il nemico invisibile, il virus
cinese”. Insiste, l’ostinato populista, anzi rilancia. Non solo da mesi chiama
un agente patogeno che è deflagrato ovunque partendo da Wuhan “cinese”, ma ora
lo fa nel tempio dell’ipocrisia internazionale, l’Onu. A scanso di equivoci:
“Dobbiamo ritenere responsabile la nazione che ha scatenato questa piaga nel
mondo: la Cina”. Nessun complottismo, bastano le omissioni e le menzogne
iniziali, bastano gli arresti di medici e infermieri, basta il tentativo, chiaro
fin da subito, di volgere l’epidemia sanitaria in pandemia economica a proprio
vantaggio. “Nei primi giorni del virus, la Cina ha bloccato i viaggi a livello
nazionale, consentendo però ai voli di lasciare la Cina e infettare il mondo”.
Perché questo doppiopesismo, se non per una perversa politica “virale” di
potenza? Un’ovvietà che nessuno aveva mai sbattuto in faccia al Dragone,
tantomeno alle Nazioni Unite. Del resto, “il governo cinese e l’Organizzazione
mondiale della Sanità- che è virtualmente controllata dalla Cina- hanno
dichiarato falsamente che non c’erano prove di trasmissione da uomo a uomo”.
Stanate infine dall’evidenza, “successivamente hanno falsamente detto che le
persone senza sintomi non avrebbero diffuso la malattia”.
Leader solitario contro i totalitarismi. Unico tra i leader
occidentali (e quello più frequentemente accusato di “negazionismo”, per dire
quanto le etichette progressiste siano ormai merce avariata), Trump inchioda il
più vasto totalitarismo mondiale (un totalitarismo comunista, parrà sconveniente
ai suonatori quotidiani dell’allarme fascismo, ma questo è) alla propria
malafede colpevole nel dilagare della pandemia. Lo fa perché, e tutti i
liberal-globalisti riciclatisi a cortigiani del tiranno Xi dovrebbero
riflettere, “l’America sarà sempre un leader nei diritti umani”. “Sappiamo che
la prosperità americana è il fondamento della libertà e della sicurezza in tutto
il mondo”, scandisce letterale: altro che isolazionismo, disimpegno e tutte le
fanfaronate precotte con cui l’Analista Unico ci ha taroccato la politica
trumpiana. Rifare grande l’America vuol dire anzitutto rifare grande la “città
sulla collina” reaganiana, la guardiana notturna dei popoli liberi. Meno a suo
agio del predecessore con la retorica, Trump lo dimostra quasi asetticamente,
mettendo in fila i fatti: “Abbiamo cancellato il Califfato dell’Isis al 100%.
Abbiamo ucciso il suo fondatore e leader, al-Baghdadi. Ci siamo ritirati dal
terribile accordo nucleare iraniano, abbiamo imposto sanzioni paralizzanti al
principale sponsor mondiale del terrore ed abbiamo eliminato il principale
terrorista del mondo, Qasem Soleimani”. Non c’è alcuna rottura con l’eredità
bushiana della guerra al terrorismo islamico. C’è rottura, questo sì, col dogma
bellicista aprioristico del complesso militare-industriale, ma ancora una volta
in continuità con un grande riferimento repubblicano, Dwight Eisenhower:
“Abbiamo raggiunto una svolta epocale con due accordi di pace in Medio Oriente.
Questi accordi di pace rivoluzionari sono l’alba del nuovo Medio Oriente”. E
ancora, il silenzio gretino e complice sulla Cina (le cui “emissioni di carbonio
sono quasi il doppio di quelle degli Stati Uniti”), la rivendicazione di “aver
rivitalizzato la Nato”, dove alcuni Paesi avvezzi da decenni a scroccare la
propria difesa al contribuente americano “stanno ora pagando una quota molto più
alta”, i tre vaccini anti-Covid che “sono nella fase finale dei test clinici”,
con l’apparato per produrli in serie già testato. Non è un caso, che il discorso
sia stato insabbiato. È chiaramente il discorso del comandante in capo del mondo
libero che, a differenza di commentatori e giornalisti, non vuole arrendersi
al Partito Comunista Cinese, né agli ayatollah sgozzatori in nome di Maometto,
né al burocraticismo fintamente neutrale dell’Onu e dei suoi satelliti.
Un’ottima notizia. Giovanni Sallusti, 23 settembre 2020
Perché Trump ha fatto più di Obama per gli afroamericani.
Libero Quotidiano il 24 settembre 2020. Sistemico
razzismo in America? E’ ciò che pensa e sostiene la sinistra americana, dai
Democratici pro Biden e pro Alexandra Ocasio Cortez ai loro violenti alleati di
strada di Black Lives Matter e Antifa, in permanente mobilitazione contro la
polizia. Ma, allora, perchè milioni di africani fanno ogni anno domanda per
vincere la green card ed immigrare nel paese governato da Donald Trump? Il
presidente aveva espresso l’anno scorso l’intenzione di abolire la lotteria,
puntando ad una riforma della immigrazione regolare basata sui meriti delle
persone che intendono immigrare negli USA, non sul caso. Ma il programma vive
ancora, ed è utilizzato largamente. Come fanno gli investitori in borsa, dove
il motto è che quando uno vende una certa azione sta “votando con i piedi”,
ossia sta uscendo per una sua scelta di convenienza dall’azionariato di quella
società, così si comportano gli esseri umani che cambiano il paese d’origine in
uno nuovo, di elezione. Evidentemente, ci vogliono entrare attratti dalle
migliori condizioni di vita, di lavoro, di libertà. E l’America è in cima alle
preferenze. I numeri valgono più dei sermoni, e dimostrano che proprio gli
emigranti neri fanno la fila, a legioni, per lasciare l’Africa e diventare
americani. “Il 4 settembre il Dipartimento di Stato ha pubblicato le statistiche
sulla lotteria della carta verde, un buon indicatore per la domanda di visto
degli Stati Uniti perché chiunque abbia un diploma di scuola superiore o
un'esperienza lavorativa specializzata può presentare domanda”, ha scritto il
giornalista ed ex diplomatico Dave Seminara sul Wall Street Journal (24
settembre). “Per l'anno fiscale 2020, il numero di candidati provenienti da 47
nazioni dell'Africa sub-sahariana ammissibili alla lotteria è stato di 9,2
milioni, rispetto ai soli 2,8 milioni dell'anno fiscale 2011”. In generale, tra
il 2010 e il 2016, una media di 14,9 milioni di cittadini stranieri si erano
iscritti alla lotteria annuale. E dal 2017 al 2020, la cifra media è stata di
21,9 milioni all’anno. Non tutti i cittadini dei paesi stranieri hanno sempre il
permesso di fare richiesta di “carta verde” attraverso la fortuna, perchè il
programma è concepito per equilibrare i flussi tenendo conto della attuale
percentuale di presenza delle diverse nazionalità nel “melting pot”. Quindi ogni
anno il governo stabilisce da quali nazioni si può partecipare al concorso e per
il prossimo, relativo al 2022, la lista di chi potrà fare richiesta esclude i
nativi di Bangladesh, Brasile, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Dominicana, El
Salvador, Haiti, India, Giamaica, Messico, Nigeria, Pakistan, Perù, Filippine,
Sud Korea, Gran Bretagna, Vietnam. Si tratta di circa un decimo di tutte le
nazioni sulla Terra, e in Africa è esclusa la sola Nigeria. “Chiaramente la
maggior parte degli aspiranti immigrati africani non condivide la tesi della
sinistra secondo cui l'America è un paese razzista”, commenta Seminara. “Perché
dovrebbero? Secondo la maggior parte delle misure, gli immigrati africani hanno
successo. Pew Research riporta che gli immigrati africani hanno più probabilità
degli americani complessivamente di avere una laurea e un recente studio
dell'Università del Kansas rivela che il loro tasso di partecipazione alla forza
lavoro è del 73%, 10 punti superiore a quello della popolazione complessiva.
Secondo alcune misure, i nigeriani sono il gruppo di immigrati di maggior
successo nel paese. Il cinquantanove per cento ha una laurea, più del doppio
della popolazione nel suo complesso; e nel 2018 il loro reddito familiare medio
era di quasi 7.000 dollari in più rispetto alla media. Se la sinistra credesse
davvero che l'America è un luogo ostile e pericoloso per i non bianchi, perchè
non avverte i potenziali immigrati dall'Africa e da altri paesi che sarebbe
meglio non venire?” ironizza Seminara. La verità è che non solo gli USA non sono
una società sistematicamente razzista, ma che Trump, bistrattato come xenofobo,
è il presidente che ha fatto, a favore della comunità afro-americana,
sicuramente molto di più di Barack Obama. Dalla riforma giudiziario-carceraria
alla minor disoccupazione di sempre. Dalla riduzione della povertà alla
promozione delle Zone di Opportunità economiche. E gli afro-americani di oggi se
ne sono accorti. Nel 2016, Trump aveva avuto l’8% del voto dei neri, ma “nel
novembre 2019, un sondaggio dell’Emerson College dava a Trump un rating di
approvazione tra i neri del 34,5%, bissato da una rilevazione della Rasmussen
(34%)”, ho scritto nel capitolo 8 - Il razzista che piace sempre più ai neri -
del mio libro “Il Guerriero Solitario- Trump e la Mission Impossible” (Mind
Edizioni), da fine agosto nelle librerie e in versione digitale su amazon.it.
“Un sondaggio Harvard caps/Harris di febbraio 2020 ha rilevato che il rating
favorevole tra i neri è al 22%, e una stessa percentuale ha registrato Zogby
Analytics, che ha scoperto consensi crescenti anche tra le altre minoranze: per
Trump sarebbero il 36% degli ispanici e il 38% degli asiatici”.
“È finita l’America di JFK”, l’accusa di Furio Colombo.
Umberto De Giovannangeli su Il Riformista il 4
Settembre 2020. Se c’è un giornalista e scrittore che conosce ogni sfaccettatura
del “pianeta Usa”, questi è Furio Colombo. Negli Stati Uniti è stato
corrispondente de La Stampa e di La Repubblica. Ha scritto per il New York
Times e la New York Review of Books. È stato presidente della Fiat Usa,
professore di giornalismo alla Columbia University, direttore dell’Istituto
Italiano di Cultura di New York. In questa conversazione con Il
Riformista, storia e politica s’intrecciano indissolubilmente nelle riflessioni
di Colombo, dalle quali emerge con grande nitidezza il ritratto di un’America
divisa, incattivita, chiamata tra due mesi ad eleggere il suo presidente.
Un’America segnata dalla violenza e dal moltiplicarsi di casi di afroamericani
morti in circostanze drammatiche, come Daniel Prude, un trentenne di colore con
problemi psichiatrici, incappucciato dalla polizia e morto asfissiato nello
stato di New York.
Joseph Kennedy III, nipote di Bob Kennedy e pronipote del
presidente John Fitzgerald assassinato nel 1963, è stato sconfitto nelle
primarie democratiche per il seggio senatoriale del Massachusetts, roccaforte di
famiglia. Neppure un Kennedy siederà nel prossimo Congresso. Non accadeva dal
1947, con l’eccezione di due soli anni. È il tramonto di una dinastia che ha
fatto la storia degli Stati Uniti d’America?
«Io non credo che in questo caso sia
successo qualcosa di straordinario. Qualcosa di straordinario è successo negli
Stati Uniti: il Paese è radicalmente cambiato. I titoli di riferimento morale,
psicologico, storico e anche di orgoglio americano, si sono trasformati in una
latente, seminascosta tendenza al suprematismo bianco e al sovranismo populista,
che ha creato un cambiamento profondo. Questi Kennedy che si presentano ora in
un certo senso non sono nessuno. Basti pensare che Stati come New York e
California sono ostili e in guerra con il presidente degli Stati Uniti.
L’America sta cambiando, è cambiata in peggio. Ed è cambiato in peggio anche lo
Stato del Massachusetts che non è più quello che racconta con la sua tradizione
di liberalismo e kennedismo. Il Massachusetts ha avuto incidenti razziali seri,
non recentissimi ma li ha avuti. Il cambiamento riguarda quello Stato come gli
altri Stati dell’Unione. Ed è un cambiamento profondo, di peggioramento, di
caduta. E questa caduta continua. In questa campagna elettorale non si manifesta
l’insorgere del Paese nei confronti della terribile qualità politica ma anche
amministrativa di Trump nel fare il presidente degli Stati Uniti. Avrebbero
dovuto dar luogo ad una sorta di insurrezione morale, e invece hanno dato luogo
ad una sorta di insurrezione stradale, di combattimento e di scontri che sono il
capolavoro della destra».
Un capolavoro della destra, perché?
«Perché quando tu posizioni la
polizia in modo da umiliare, offendere e ricacciare le persone di colore, in un
Paese che ha una storia drammatica, brutta e bella, perché c’è stato anche
Martin Luther King, una storia comunque drammatica di rapporti razziali, non c’è
dubbio che quel ginocchio sul collo di George Floyd, non avviene per caso, non
succede perché un poliziotto è di cattivo umore quel giorno. Sarebbe
complottista e fuori posto immaginare che sia tutto organizzato dalla gente di
Trump affinché queste cose accadano, ma non vi è dubbio che il clima che si è
creato è quello che tutto ciò è possibile. Se tu riesci a scardinare la tenuta
della gente nera e della gente ispanica, se riesci a scardinarla e fare perdere
l’equilibrio, in modo che attacchino, in quel momento tu hai creato delle
condizioni di notevole favore per una campagna elettorale, quella di Trump,
tutta basata sulla sicurezza, sulla paura, sul timore che il Paese perda
l’equilibrio. Del resto Steve Bannon, che oggi se la vede in prigione per altri
motivi, ci aveva insegnato che s’inventa radicalmente questo tipo di destra.
Quindi sono stati bravi, veramente bravi a inventare la lotta, la guerra con i
neri e con gli ispanici. Purtroppo la notizia triste è che una grande parte di
americani che ti dicono la loro costernazione, non sono però insorti. E così,
per tornare alla domanda iniziale, non c’è da stupirsi che un Massachusetts del
tutto sconnesso con quello che ha eletto e mantenuto con una dinastia
interrompibile la figura di JFK, questo Massachusetts profondamente cambiato,
abbia mostrato disinteresse per una continuità di quel tipo di moralità nella
politica e di umanità nel potere, ed abbia ignorato del tutto ciò che ad alcuni
di noi, andando indietro nel tempo ma neanche troppo, sembra ancora un periodo
straordinario e che tristemente è giunto alla fine».
In questa situazione, in un’America che tra due mesi eleggerà
il suo nuovo presidente mentre si moltiplicano i casi di afroamericani morti per
mano della polizia, non c’è il “rischio” di una rielezione di Donald Trump?
«Il rischio è altissimo. La
probabilità e il rischio in questo caso sono due parole molto diverse. Da un
punto di vista di puro e semplice esame delle cose così come sono, delle
possibilità che la gente scelga, che la gente si orienti, che i cittadini
decidano, resta ancora una buona, seria, solida speranza che la rivolta contro
Trump ci sia e funzioni. Resta il fatto, però, che queste elezioni ci hanno
fatto scoprire che i sentimenti di ripulsa verso il trumpismo, che dovrebbero
essere estremi e fortissimi, sono meno estremi e meno forti di quanto avevamo
creduto. Ci siamo detti, e quando dico “ci” intendo gli americani liberal ma
anche gli europei liberal, sulla base di una fiducia lunga molti decenni, che
l’America può fare pure, e ne ha fatte, cadute rovinose, ma prontamente si
riprende perché ha delle istituzioni molto solide e raramente danneggiate,
mentre l’Europa rovina le proprie istituzioni rendendosi più debole per una
problematica ripresa. L’America a noi sembrava capace di brutte cadute, ma che
avevano la caratteristica di non intaccare le istituzioni: Costituzione, Corte
suprema, i principi fondamentali dei Federal papers, la tradizione delle grandi
presidenze, ci era sembrata sempre in grado di ritornare a curare i mali, anche
gravi, che di tanto in tanto abbiamo visto scoppiare. Il “fenomeno Trump” è
stata una sorpresa enorme, quando si è manifestato. Girando per l’America
durante tutto quell’anno, non ho incontrato una sola persona che mi abbia
predetto come ovvia, ma anche solo come possibile, la vittoria di Trump. Io
ricordo una meraviglia grandissima negli Stati Uniti per quello che era
accaduto. Sembrava che gli americani non si rendessero conto di come era stato
possibile, ma chi era questa gente, ma da dove veniva questo sostegno a Trump.
C’è stato un periodo intermedio, durato meno di quello che avrebbe dovuto
durare, in cui il New York Times apriva ogni giorno, con la scritta “la notte è
calata sulla Repubblica”, in cui gli americani sembravano non adattarsi a questa
follia che non avevano capito e non avevano previsto. Gradatamente si è
verificato un fenomeno di adattamento, e poi, in questo ultimo periodo, nel
peggioramento di comportamento di Trump durante la campagna elettorale, una
sorta di fatalistica accettazione, di una parte dell’America che ci sembrava
sicuramente estranea e sicuramente contraria. Di conseguenza, l’ansia è
giustificata».
Guardando il versante democratico, come valuti la campagna
presidenziale di Joe Biden e la scelta di Kamala Harris come vice presidente?
«La scelta della sua vice è
perfetta. Il limite semmai è che arrivata tardi, non abbastanza in tempo per
disegnare la fisionomia politica della presidenza così come essa sarebbe se
vincessero i Democratici. Il fatto è che in un tempo di possenti passioni,
negative o positive, l’America ha avuto un leader, ma non l’altro. In Trump
continuo a vedere l’astuzia nel mantenersi feroce, mentre il leader democratico
viene avanti con una serenità e una quiete che purtroppo non sono affatto
all’altezza della situazione tremenda che l’America sta vivendo. Ed è una
situazione molto simile a certi fatti europei, certo simile all’Italia. D’altro
canto, abbiamo avuto sempre delle analogie con l’America. Quella che manca
nell’America anti-Trump è la passione. Non c’è passione in questa campagna
elettorale, così come non c’è passione nella vita politica italiana in questo
momento. L’analogia ci serve solo per dire che la mancanza di passione è di per
sé perdente. La passione è altra cosa dalla rabbia. Se queste fossero delle
previsioni organiche e basate su una migliore conoscenza di quelle che io ho
oggi dall’Italia, ci sarebbe da essere allarmati per quello che potrebbero
essere i risultati, perché non mi sembra che si stia arrivando sulla corsia
giusta. È come quando in tutti i tipi di corse, ti accorgi che il secondo sta
perdendo un millimetro, ne sta perdendo due, e si sta posizionando in un ritardo
che potrebbe anche essere minimo ma intanto non è risalibile. È così come dico
io? Spero di no, però, purtroppo, non c’è dubbio che l’aver impostato come hanno
fatto i Democratici, la loro campagna elettorale sulla base della vecchia
persuasione, che non vale più, che si vince al centro, ha atto sì che persino
Sanders è apparso debole di fronte a un Trump che, bene avvisato, ha capito che
non si vince affatto al centro, ma si vince all’estremo. Debole nei confronti
della violenza e della aggressività forsennata di Trump, e del legame che per
forza c’è tra quel ginocchio sul collo del nero Floyd e il profondo della vita
americana in questo momento».
In un suo libro di successo, Trump power, come sottotitolo c’è
questa affermazione: “Un corpo estraneo è entrato dentro la Casa Bianca. Ed è
cominciata una crisi di rigetto”. Il libro è del 2017. Oggi lo riaffermerebbe?
«Sì. Per capire quanto forte sia
stato quel rigetto, occorre considerare due fattori: il primo è il numero
altissimo di collaboratori che Trump ha continuamente cambiato. Il secondo è il
fatto che molti di questi collaboratori che Trump ha continuamente e rapidamente
cambiato, erano repubblicani della più stretta osservanza conservatrice. Tutto
questo ci dimostra che Trump è andato al di là di quella che chiamiamo il
percorso reazionario-conservatore tipico di certi settori della destra
americana. Poi, però, è accaduto che il rigetto che la Casa Bianca stava
mostrando di fare, si è ritirato a confronto con il potere che Trump è stato in
grado di esercitare. È una storia molto simile alle storie tremende delle destre
europee. Diciamo che non è la storia di Mussolini, ma è certamente la storia di
Hitler, nel senso che ai suoi tempi era ragionevole scrivere che era in corso
una crisi di rigetto. Basta pensare ai diari di Christopher Isherwood, che
prevedeva addirittura una crisi di rigetto, e ha avuto delle difficoltà notevoli
ad essere accettata, poi però Hitler ha vinto. Non dico che Trump abbia vinto,
non lo sappiamo ancora e speriamo che non sia il caso, speriamo di aver
esagerato nel pessimismo, ma resta il fatto che la crisi di rigetto, che è
avvenuta proprio alla Casa Bianca ed è avvenuta proprio nei settori conservativi
del Partito repubblicano, non ha agganciato davvero l’opinione pubblica come ci
saremmo aspettati».
La caduta degli dei. I Kennedy fuori dal Congresso.
Orlando Sacchelli il 2 settembre 2020 su Il Giornale. Potrebbe sembrare una
notizia insignificante ma non lo è, visto il cognome di uno dei protagonisti. Il
senatore Edward Markey (75 anni) del Massachusetts ha sconfitto il deputato
dem Joseph Kennedy III (39 anni) nelle primarie per un seggio al Senato. Molti
parlano di “sconfitta storica” perché è la prima volta che un esponente della
famiglia di JFK viene sconfitto nel Massachusetts. Pronipote del presidente John
Fitgerald, assassinato nel 1963, e nipote di Robert F. Kennedy, avendo scelto di
partecipare al ballottaggio per il Senato non potrà correre per riconfermare il
proprio seggio alla Camera. Per questo motivo il prossimo Congresso Usa non avrà
alcun esponente della storica famiglia di origini irlandesi. Con un buco di soli
due anni dal 1947 i Kennedy hanno sempre avuto propri eletti al Congresso. Al
Senato dal 2013 ma con 37 anni di esperienza alla Camera, Markey ha vinto il
ballottaggio grazie anche al sostegno della senatrice liberal Elizabeth Warren e
di Alexandria Ocasio-Cortez, la più giovane deputata al Congresso, sostenitrice
di Sanders. Nato a Boston il 4 ottobre 1980, studi alla Stanford University
(ingegneria gestionale), Kennedy ha fatto esperienza nella Repubblica Dominicana
con i Corpi di Pace occupandosi di ecoturismo. Tornato in patria ha studiato
Legge alla Harvard Law School, con Elizabeth Warren tra i suoi docenti.
Avvocato, nel 2012 è stato eletto alla Camera dei rappresentanti. Nel gennaio
2018 il Partito democratico scelse lui come oratore nella replica al discorso
sullo stato dell’Unione che ogni anno il presidente tiene davanti al Congresso
riunito in seduta comune. Un riconoscimento importante che conferisce una grande
visibilità alla personalità prescelta. Segno, questo, che il cognome Kennedy ha
ancora molta presa in casa dem. Ma il risultato del ballottaggio testimonia che
la storia va avanti e che la dinastia (forse) è finita.
Il cuore di un'America rampante.
Storia di Jfk e di come è arrivato al potere grazie al papà Joseph. Paolo
Guzzanti su Il Riformista il 9 Settembre 2020. Scusate, cari lettori – e sempre
ammesso che abbiate l’età per ricordare – se parlerò male di Kennedy. Lo
ammetto: questa l’ho rubata a Giorgio Gaber. Ricordate la canzone “Scusate se
parlo di Maria”? No, non specificamente di Maria Vergine, ma di tutto ciò che fa
da sfondo vago e indistinto, chiamatelo banalità, tutta quella fuffa che prende
il posto delle idee e non parliamo degli ideali. Perché proprio di Kennedy?
Spiego ai più giovani. Sapete come comincia la favola: c’era una volta… un re?
Sì, ragazzi, stiamo parlando di un vero re americano, che abitava in una Casa
Bianca chiamata Camelot dove incarnava il mito di Re Artù, e la sua Ginevra era
una fatina anni Sessanta algida ed elegante che si chiamava Jacqueline, di buona
origine, e che molti anni dopo sarebbe diventata una puttanona da rotocalco (i
media di allora) fra le braccia del petroliere Onassis sui suoi yacht. Erano i
primissimi anni Sessanta, l’America era lontana e partoriva milioni di baby
boomers, i figli dei soldati tornati dalla guerra. Il presidente era ancora per
poco Dwight “Ike” Eisenhower, il generalissimo calmo e calvo che aveva vinto la
guerra. Brulicava allora una dinastia irlandese nel Massachusetts, veri duchi di
Boston e dintorni ed era questa tribù dei Kennedy, belli, spesso rossi e con un
marker genetico. In quanto cattolici, erano prolifici come conigli. Il loro
papi, Joseph, in quanto irlandese tifava per i tedeschi anche mentre era
ambasciatore americano a Londra. E, già che c’era, arrotondava le entrate
contrabbandando alcool ai tempi per valigia diplomatica, collocandosi più in
prossimità di Al Capone che di Franklin Delano Roosevelt. Dopo la guerra si
ritrovava con due figli da esposizione, John Fitzgerald e Robert, pronti per la
scalata finale che poi finì nel sangue e nella maledizione. Molti Kennedy furono
assassinati o fecero qualche altra brutta fine in incidenti assurdi. Il primo fu
il nuovo Re Artù, l’affascinante maschio alfa John Fitzgerald, uno dei più
grandi seduttori di uomini e donne di tutti i tempi. Suo fratello Robert, “Bob”
Kennedy, aveva intrapreso la carriera politica per via giudiziaria, e si faceva
le ossa come giudice antimafia, il castigamatti dei wise guys, ovvero dei
mammasantissima italo-americani che spargevano pallottole e cocaina ovunque
piantassero un casinò e un bordello, fra Miami e Cuba. Tra questi mafiosi
d’influenza, il più grande figlio di puttana era Giancana. La mafia dominava sui
sindacati perché i contratti di categoria si facevano usando mezzi anche
brutali. Giancana sguazzava nel jet-set e se la faceva con tutti gli italiani di
spicco fra cui Frank Sinatra – The Voice – che poi avrebbe sposato (e divorziato
da) Mia Farrow che avrebbe regalato al marito odiato Woody Allen un pupo che è
il ritratto di Sinatra, oggi famoso giornalista supporter sfegatato delle
femministe #Mee-Too. Le storie sono grandiose e terribili perché ci troviamo nel
cuore di un’America rampante, gaudente e che allo stesso tempo incarna la
cattiva coscienza dei democratici nei confronti dei neri, liberati dalla guerra
di secessione e relegati nel ghetto della discriminazione. La base democratica
del Sud odiava Kennedy per questo. Tutti i democratici del Sud lo odiavano e fra
loro ci fu qualcuno che gli fece la pelle, probabilmente. Insomma, top jet set.
Alla sinistra europea non pareva vero. I Kennedy erano indubbiamente di
sinistra. John, che d’ora in poi chiameremo come il suo aeroporto JFK, era
fichissimo, eroe di guerra e come insegnano i libri di storia batté il giovane
Richard Nixon (il futuro presidente del Watergate) nel primo dibattito
televisivo del Pianeta. Ma non vinse solo per quello. Vinse perché papi si
chiamò Tom Giancana e gli disse: mio figlio corre da Presidente e tu comandi
sulle Unions, i sindacati. John non può farcela senza i sindacati. Vuoi fare un
deal, un patto? Ok, disse Giancana: il patto è questo: tu, Joseph, richiami tuo
figlio Robert che vuole far carriera a mie spese e gli dici di darsi una calmata
e che mi lasci in pace. Ai ragazzi del sindacato diremo chi votare. Do we have a
deal, siamo d’accordo? Deal, rispose Joseph che chiamò Robert per dirgli della
nuova strategia. Se lo fa, le Unions saranno tutte per John, e lo portiamo
dritti e insieme alla Casa Bianca. E così fu. Robert accettò, un po’ di
malumore, ma suo fratello JFK gli promise il posto di Procuratore generale e
implicitamente la successione dinastica. Poveretti, finirono ammazzati tutti e
due e ricordo perfettamente come chiunque dove ero e che cosa facevo quando
ammazzarono JFK a Dallas e Robert nel 1968. JFK aveva una amante che era la più
bella donna del mondo e di tutti i tempi: Marilyn Monroe. Che però si spartiva
anche con suo fratello Robert e un pochino anche con Giancana che era nel giro.
Marylin dette molto fastidio alla principessa Jackie quando cantò con voce da
pre-orgasmo Happy birthday mister President al compleanno di JFK. In Italia la
sinistra in cerca di idee si trovò le immagini già pronte di una nuova
fantastica invenzione, la nuova vergine Maria: Kennedy, il kennedismo, i
kennediani, tutta la truppa coccolata dall’età della prima elementare fino alla
prima campagna elettorale. Ricordo personalmente l’imbarazzo che provai
quando Walter Veltroni, che credeva nel kennedismo importato come i trotzkisti
credevano nella rivoluzione, moltissimi anni dopo, esibì una cucciolata di
discendenti della famiglia, radunati al cinema Mignon di Roma come a una
esposizione canina. La sinistra italiana poteva finalmente liberarsi del
decaduto fascino della Rivoluzione d’ottobre, perché abbiamo noi la gente
giusta, almeno finché durano. Com’erano carini e kennedini. Tali e quali al
piccolo Joseph III (hanno i numeri dopo il nome come i re di Francia e
certamente non arriveranno a sedici come i Luigi) pochi giorni fa se la prese
nelle terga per aver fatto lo sbruffone con un’America che non c’è più: si è
presentato alla convenzione democratica per reclamare un seggio da senatore, pur
essendo un congressman, e l’hanno fatto fuori. Gran dolore e gran pena in Italia
fra tutti i reduci di un sogno altrui. Avete presente il racconto di Jorge
Borges in cui un uomo per anni costruisce nel sogno un figlio inesistente e lo
porta alla vita e ad accendere un fuoco sul monte di fronte, salvo scoprire
subito dopo di essere lui stesso il sogno sognato di un altro sognante? Così. I
Kennedy, un sogno altrui. Ma i kennediani all’amatriciana si moltiplicavano: che
vuoi di meglio per essere di sinistra senza stare con i russi ed essere per
l’America, sì, ma attenzione: per “l’altra” America. Cominciò il periodo
dell’altrismo. Siamo per l’altro da noi, purché alla fine vinciamo un pochino
anche noi. L’ideale di JFK era nobile e lo realizzò il suo successore Lyndon
Jhonson che era il suo vicepresidente quando Lee Harvey Oswald gli fece saltare
le cervella a Dallas e Jackie si allungò sul cofano per raccogliere i pezzetti
di cranio del marito. JFK voleva chiedere la segregazione razziale che era
seguita alla liberazione degli schiavi un secolo prima. Da allora i neri erano
segregati. Kennedy si giocò tutto e non si sa alla fine chi l’ammazzò. Forse i
segregazionisti, o forse anche Fidel Castro il quale aveva scoperto diversi
killer speditigli da Kennedy per farlo fuori, dopo che lo stesso JFK appena
insediato aveva autorizzato l’avventurosa invasione degli esuli cubani alla Baia
dei Porci, ma negando loro l’appoggio aereo. Fidel Castro ne fece polpette. O
forse a farlo fuori i sovietici, furiosi per l’umiliazione dei missili a Cuba
che costò la testa al successore di Stalin, Nikita Krusciov che perse al tavolo
da poker di JFK quando quello gli disse: o portate via i missili da Cuba o è la
guerra. Kusciov si infuriò e sbatté le scarpe sul leggio dell’Onu e quando tornò
a casa gli fecero la festa. Lee Harvey Oswold, colui che sparò a Kennedy dopo
essere tornato dall’Unione Sovietica con una moglie russa, fu messo a tacere da
una revolverata (la prima ripresa in diretta davanti alle telecamere) di Jack
Ruby, un barista malato di cancro terminale e il mondo – e tutti noi allora
comunque entusiasticamente kennediani, anche se non di carriera – per anni visse
la saga dell’inchiesta del giudice Warren sull’omicidio di Kennedy. I kennediani
italiani intanto facevano carriera. Si erano ben inseriti nel gruppetto di
comando del partito democratico che cercava alleati nella sinistra ex o
post-comunista (non solo italiana, ma specialmente italiana) offrendo cattedre
prestigiose in gentile concessione ad alcuni opinion leader e ai loro protegé,
creando così una schiatta immortale di we few, we happy few, we band of
brothers. L’America kennediana d’altra parte aveva scoperto il fascino delle
“teste d’uovo”. Il primo fu Adlai Stevenson, peraltro un genio, che univa
all’esser di sinistra l’eleganza, la forbitezza, la cultura, ciò che oggi
chiamiamo radical chic o gauche caviar. Allora si diceva teste d’uovo. Però
Stevenson era anche un anticomunista feroce. Era quello che inventò il detto più
smagliante: «Finché voi seguiterete a mentire sul nostro conto, noi seguiteremo
a dire la verità sul vostro». I Kennedy erano una stirpe e correvano tutti per
un seggio al senato, i più sfigati alla House, la camera bassa dove Nancy Pelosi
ha dato il bacio della morte all’ultimo rampollo Kennedy, tutti in adorazione
della teca in cui splendono nel neon della storia, le ossa degli avi
assassinati. Ma, come a Bisanzio, i ragazzi della stirpe erano via via sempre
più esangui e insignificante, presuntuosi e scollati dalla realtà. Oggi i
Kennedy perdono – e i kennediani con loro – perché non hanno capito nulla di
quel che succede in America, nello stresso modo in cui non capiscono
testardamente nulla i loro adepti italiani e francesi: ottusi, capricciosi,
testardi e ciechi, ma di una arroganza commovente. I Kennedy sono rimasti
aggrappati alla middle class bianca di centrosinistra, che ammette soltanto dei
neri che riconoscano la supremazia dell’uomo bianco e che stanno totalmente
sulle palle alla nuova sinistra dei Sanders e della Ocasio Cortez, tutti
allegramente neo-leninisti, guevaristi, anticapitalisti, nel migliore dei casi
socialisti che non vogliono saperne delle mediazioni offerte dalla vecchia
dinastia perché oggi sono i tempi in cui si abbattono le statue, si saccheggiano
le vetrine, si incendiano le auto. E poi, scusate (hanno gridato le folle di
sinistra all’ultimo rosso Joseph III) ma non siete voi che avete cominciato la
guerra nel Vietnam? Non siete voi che avete portato il mondo sull’orlo della
terza guerra mondiale per far levare i missili russi da Cuba mentre mantenevate
i vostri in Turchia dietro il giardino dei russi? Tutto vero. Il leader del
sogno della sinistra mondiale fu colui che mandò di nascosto (senza informare il
Congresso) i primi plotoni di berretti verdi in Vietnam e in Cambogia e fu
Kennedy a imporre l’embargo alla Cuba di Fidel e del “Che”. E, a dirla tutta, i
guai combinati da JFK furono parzialmente rappezzati dal più odiato presidente
repubblicano prima di Trump, ovvero Richard Nixon, detto “Tricky-Dicky”,
l’imbroglione, il quale chiuse la guerra nel Vietnam, aprì alla Cina di Mao e
riportò la pace là dove i fantastici Kennedy avevano inflitto, con i loro sogni
privati e viziati, grandi lutti pubblici. E i “kennediani de noantri”? Immobili,
tetragoni, la piega del disprezzo sul labbro esangue, scansano con cura la
verità come una intolleranza alimentare. Ma la loro memoria è sensata: hanno
fatto parte, da fuori le mura, del regno di Camelot. Hanno respirato l’aria
respirata da chi conta. E si sono dati moltissime cattedre e arie. Vanno capiti
e salutati con l’ammainabandiera, ora che l’ultimo Kennedy è stato mandato a
lavorare e che la pratica può considerarsi chiusa, anche perché quasi tutti
coloro che potevano ricordare brucano ormai nei grandi pascoli del cielo.
Trump, Biden e il declino della democrazia americana.
Daniele Zaccaria su Il Dubbio il 30 settembre 2020.
Interruzioni, insulti e parolacce: per i media d’oltreoceano il primo duello
televisivo in vista delle presidenziali è «il peggiore di sempre». C’è qualcosa
di crepuscolare nel confronto televisivo tra Donald Trump e Joe Biden andato in
scena la scorsa notte. A partire dall’età dei protagonisti: 150 anni in due,
fieri esponenti entrambi della generazione dei boomer, maschi bianchi che, alla
soglia degli 80 anni, si contendono la poltrona più ambita del pianeta. Quel
confronto ruvido, a tratti sguaiato, quasi sempre sul filo del grottesco è
sembrata una rappresentazione plastica del potere che per oltre mezzo secolo è
rimasto saldamente nelle mani di una generazione. Una generazione di granito che
ancora oggi continua a dettare i tempi della politica mondiale e che si avvicina
al canto del cigno senza freni inibitori. Lo dimostrano i toni violentissimi di
un di battito che la gran parte dei media d’oltreoceano ha definito «vergognoso»
e che sembrava uscito dal soggiorno del Grande Fratello Vip. Mai prima d’ora due
candidati alla presidenza americana si erano affrontati con una tale batteria di
insulti: «pagliaccio», «bugiardo», «idiota», «cagnolino di Putin»; le
interruzioni continue, le volgarità, l’irrilevanza dei contenuti politici hanno
dominato gli oltre 90 minuti di duello. I media progressisti dicono che ha
«vinto» Biden, quelli più conservatori affermano il contrario, una confusione
generata non solo dalla faziosità fisiologica dei vari organi di informazione,
ma dalla stesso caotico incedere delle polemiche. Anche il conduttore Chris
Wallace di Fox Tv, non proprio un boy scout, è rimasto scosso dal livello,
infimo, del confronto. Le sue domande, alcune davvero ficcanti e tempestive,
sono state solo un pretesto per disinnescare la zuffa dei due anziani signori,
irascibili e sfrontati come due vecchietti che litigano in coda al supermercato
o alla posta. C’è però da dire che il presidente nuotava nel suo elemento e
nessuno, né i suoi fan né i suoi detrattori, è rimasto stupito dal fragore delle
sue sortite. Sbruffone, teatrale e arrogante come sempre, ha messo in campo
tutto il campionario “trumpiano”, tutta la candida indifferenza di fronte alle
manifeste bugie che ha regalato al pubblico. In particolare quando si è parlato
della sua lunare dichiarazione dei redditi. Anche la strizzata d’occhio ai
suprematisti bianchi che si è rifiutato condannare fa parte del repertorio,
della propaganda a cui il tycoon ci ha abituati negli ultimi 4 anni. Diversi
osservatori, soprattutto europei, hanno sottolineato quanto poco sia carismatico
Joe Biden, un tratto costante che lo accompagna dalla gioventù e dalle brucianti
sconfitte rimediate alle primarie del partito democratico, quando timidamente
provò la scalata alla Casa Bianca. Il corpo a corpo con il rivale è stata una
evidente forzatura, come se nel suo staff gli avessero imposto di congelare il
carattere mite e tranquillo per scendere al livello di The Donald, modalità
”lotta nel fango”. L’effetto è straniante, quel che doveva apparire bellicoso e
“virile” è stato stridulo e incerto, un attore minimalista costretto a recitare
sulla cresta dell’enfasi con risultati a tratti imbarazzanti. Ci ha pensato il
suo antagonista a facilitargli il compito. Sembra quasi un destino: andare
avanti per i demeriti altrui e non per le proprie qualità. Anche la candidatura
alla presidenza è figlia dell’assenza di avversari. Bernie Sanders è stato
liquidato come «troppo a sinistra» dal corpo intermedio del partito e le nuove
stelle liberal come Alexandria Ocasio Cortez ancora troppo inesperte, mentre tra
i dignitari dem e tra le vedove di Hillary Clinton nessuna personalità di
rilievo è emersa a contrastare la corsa di Biden. Che alla fine del dibattito,
in uno slancio di sincerità e di realismo ha detto l’unica cosa sensata da dire
nella sua posizione: «Se non volete altri 4 anni di Trump votatemi». I sondaggi
pare che gli diano ragione: oltre dieci punti di vantaggio. Gli stessi che aveva
Hillary nell’ottobre del 2016 tanto per intenderci.
Trump-Biden, durante il dibattito un misterioso oggetto spunta
dalla giacca del dem: beccato in flagrante? Libero
Quotidiano il 30 settembre 2020. Un auricolare segreto che gli suggeriva le
risposte? E' questa l'ultima teoria dei social sul candidato dem alla Casa
Bianca Joe Biden, che ieri 29 settembre è stato impegnato nel dibattito con il
presidente Usa Donald Trump prima delle elezioni di novembre. Alcune foto su
Twitter mostrano una sorta di microfono che fuoriesce dalla manica della camicia
di Biden. Il dispositivo si è notato quando il candidato ha alzato la mano per
chiarire un punto o per tossire. Allo stesso tempo, gli utenti hanno intravisto
anche un filo nero nascosto all'interno della sua giacca. Gli screenshot sono
diventati subito virali. Ed è qui che si è iniziato a sospettare che Biden
potesse avere un auricolare segreto per ricevere le risposte dalla sua squadra
durante il dibattito. A commentare l'accaduto è stato anche il deputato della
Lega Claudio Borghi, che su Twitter ha scritto: "Ma che suggeritori elettrici,
chi ha giocato ad Assassin Creed sa benissimo di che si tratta...Sono le famose
LAME CELATE", riferendosi così al famoso videogioco di genere action adventure.
Trump-Biden, quando la comunicazione è strategia politica.
Libero Quotidiano il 30 settembre 2020. Milano, 30
set. (askanews) - Donald Trump e Joe Biden. Da una parte un maestro
dell'improvvisazione, dall'altra uno che usa le parole giuste e il "noi" e "voi"
inclusivo. Il primo confronto dal vivo tra i due candidati alla Casa Bianca è
stato descritto dai media americani come un momento di caos, con attacchi e
interruzioni continue. Ma la politica è comunicazione. E dietro alle parole,
agli atteggiamenti e alla gestualità si nascondono strategie. Lo spiega Patrick
Facciolo, giornalista e dottore in tecniche psicologiche. "Metodo è la parola
che possiamo individuare nella strategia comunicativa di Joe Biden. Il suo
linguaggio non verbale è stato rivolto alla telecamera e al pubblico. Le poche
volte che si rivolge a Trump lo fa per indicarlo col braccio o per sorridere
ridimensionando l'interlocutore. Trump, sia per la comunicazione non verbale sia
per il linguaggio ha scelto una via diversa: sguardo sempre distribuito tra
l'intervistatore e l'avversario. Solo per un secondo ha incrociato lo sguardo
con la telecamera". Biden ha usato frasi brevi e incisive; la strategia di Trump
è stata tutta votata all'attacco dell'avversario. "Trump interviene, interrompe
Biden. Biden soffre molto le interruzioni. Guarda verso il basso e le
inquadrature non perdonano. L'abitudine verso il basso non lo premia", ha
spiegato Facciolo. In sintesi a Trump mancherebbe quell'aspetto fondamentale
della comunicazione politica che è l'empatia con l'elettore che segue il
dibattito in tv. Ma sono altre le frecce al suo arco: "Se da un lato su questo
punto Biden è più performante, manca a sua volta della capacità
d'improvvisazione di cui Trump è un maestro. E le tendenze della comunicazione
politica contemporanea negli ultimi anni ci hanno insegnato quanto è importante
nei meccanismi della persuasione e nella creazione della dinamica del consenso",
ha concluso Facciolo.
Donald Trump e Joe Biden, il primo dibattito è uno scontro tra
metodo e improvvisazione. Notizie.it il 30/09/2020.
Parole, ma anche sguardi, gesti ed espressività: quanto è stata efficace la
comunicazione di Trump e Biden durante il primo confronto TV? Metodo contro
improvvisazione: possiamo riassumere così gli stili comunicativi di Joe Biden e
Donald Trump durante il primo confronto televisivo, che si è concluso nella
notte tra il 29 e il 30 settembre negli Stati Uniti.
Il metodo di Joe Biden. “Metodo” è la parola che possiamo
individuare nella strategia comunicativa del candidato democratico, Joe Biden:
il suo linguaggio non verbale (gesti, uso dello sguardo, espressività facciale)
è più volte rivolto direttamente alla telecamera e al pubblico. Nei pochi casi
in cui si rivolge direttamente a Trump, lo fa prevalentemente per sorridere
delle sue affermazioni (scelta efficace in comunicazione politica, poiché
permette di ridimensionare il contenuto espresso dall’interlocutore attraverso
un semplice indicatore para verbale /non verbale, senza l’uso di parole). Anche
il lessico che usa Joe Biden dimostra un buon orientamento al pubblico: “How
many of you”, (“Quanti di voi”), “You folks at home”, (“Voi gente a casa”), “For
you all at home” (“Per tutti voi a a casa”). Joe Biden durante tutto il
confronto propone un tripudio di frasi brevi, con poche subordinate: “People
want to be safe” (“Le persone vogliono sentirsi sicure”), “People out there need
help” (“Le persone là fuori hanno bisogno d’aiuto”). E ancora: “You’re the worst
President America has ever had” (“Sei il peggior Presidente che l’America abbia
mai avuto”).
Donald Trump punta sull’improvvisazione. Donald Trump, sia per
quanto riguarda la comunicazione non verbale, sia per quanto riguarda
il linguaggio verbale, sceglie una via diversa: il suo sguardo è sempre
distribuito tra l’intervistatore e l’avversario, e solo al minuto 71, per
qualche secondo, incrocia il suo sguardo con quello della telecamera. Nessun
riferimento al pubblico, tranne per un passaggio: “You’ll have the vaccine
sooner than that” (“Avrete il vaccino prima” – rispetto alla data indicata da
Joe Biden, nda.). Donald Trump interviene, interrompe Biden, che soffre molto le
interruzioni, ed esita più volte con la voce, spesso non riuscendo a terminare
frasi e parole, a causa delle continue interruzioni di Trump.
L’importanza dello sguardo. Joe Biden volge frequentemente lo
sguardo verso il basso, prende appunti. Le inquadrature, in questo senso, non
perdonano. Sebbene molte televisioni utilizzino inquadrature ampie che indugiano
di più su chi sta parlando, altre tv usano i due primi piani affiancati dei
contendenti. L’abitudine di Biden di guardare spesso, troppo spesso, verso il
basso, non lo premia. Il volto è la base della relazione con il pubblico, e
guardare troppo verso il basso diventa un comportamento non
verbale incoerente con l’orientamento al pubblico che proprio Joe Biden ricerca
attraverso le parole, durante molti altri passaggi.
Il voto finale. Il sintesi, il mio voto finale per la performance
comunicativa di Donald Trump è 5, per quella di Joe Biden, 6. A Donald Trump
manca completamente l’orientamento al pubblico. Il pubblico è costantemente in
terza persona nei suoi discorsi, e questo è un limite importante nella
comunicazione politica contemporanea. Per quanto un personaggio politico possa
ritenere di avere il polso della situazione, di essere padrone del contesto in
cui si trova, è agli elettori che si rivolge, ed è del consenso degli elettori
che ha bisogno. Se non richiama il coinvolgimento attraverso le sue parole, il
rischio di fare da solo (e però anche di restare, da solo, nella
rappresentazione che dà della realtà) è alto. Quanti siamo quando comunichiamo?
Se nel mio linguaggio il pubblico è in terza persona, l’immagine mentale che ne
deriva è di me, da solo, che parlo a un pubblico terzo. Se uso il “noi”, o
meglio ancora il “voi”, sto descrivendo una relazione in cui siamo in tanti. E
l’immagine mentale che ne deriva evoca una moltitudine di persone. Esattamente
il proposito che dovrebbe proporsi qualsiasi forma di comunicazione politica
inclusiva (ed efficace). Se da un lato su questo punto Joe Biden è più
performante, manca a sua volta della capacità di improvvisare che invece ha il
suo avversario. Donald Trump, su questo è un maestro. E le tendenze della
comunicazione politica contemporanea, negli ultimi anni, ci hanno insegnato
quanto è importante nei meccanismi della persuasione, e nella creazione della
dinamica del consenso.
Donald Trump contro Joe Biden, primo dibattito tv per le
presidenziali: "Vuoi chiudere il becco?", il democratico perde la calma.
Libero Quotidiano il 30 settembre 2020. "Vuoi chiudere il
becco?". Primo infuocato faccia a faccia tv tra Donald Trump e Joe Biden, e il
più nervoso sembra proprio il candidato democratico. Il presidente uscente è in
risalita nei sondaggi nonostante l'ultimo polverone alzato da sinistra, con il
New York Times che lo ha accusato di non aver pagato le tasse da 10 anni, salvo
750 dollari sul reddito nel 2016 e nel 2017. "Tutte fake news", replica Trump.
"Sanno tutti che è un bugiardo", è la controreplica di Biden, che attacca il
presidente sul coronavirus ("Non ha un piano per fronteggiare l'emergenza") e
sulla questione razziale ("Quello che ha fatto per gli afroamericani è un
disastro"). Ma proprio il tema Black Lives Matter, con la coda di violenze di
piazza, potrebbe essere una carta a favore del repubblicano: "Io credo nella
legge e nell'ordine, tu no", è l'asso calato da Trump. Biden è sulle spine,
forse perché sente di giocare "in trasferta": il dibattito va in scena a Western
Reserve University di Cleveland, Ohio, e il moderatore è Chris Wallace,
anchorman della "trumpiana" Fox News. E alla fine, quando Donald va sul
personale ("Non c'è nulla di intelligente in te, in 47 anni non hai fatto
niente"), l'impressione è che l'America ancora una volta possa essere
conquistata dagli "uomini del fare", più che da quelli dell'establishment.
(ANSA l'1 ottobre 2020) - La commissione responsabile per i
dibattiti presidenziali valuterà delle modifiche al format e annuncerà a breve
le sue decisioni al riguardo. Ringraziando il moderatore Chris Wallace per la
sua "professionalità", la commissione mette in evidenza che una impostazione più
chiara deve essere attuata per i prossimi confronti in modo da "assicurare
un'ordinata discussione sui temi". La commissione punta ad adottare misure che
consentano uno svolgimento più ordinato dei prossimi dibattiti dopo la debacle
del primo scontro, dove il caos ha regnato nonostante i ripetuti tentativi del
moderatore Chris Wallace di far rispettare le regole. La commissione si impegna
a valutare e aggiungere nuovi "strumenti per mantenere l'ordine". "La
commissione per i dibattiti presidenziali sponsorizza i dibattiti televisivi a
beneficio degli americani. Il dibattito della scorse notte ha messo chiaramente
in evidenza che ulteriori misure dovrebbero essere aggiunte al format dei
restanti dibattiti per assicurare un'ordinata discussione sui temi. La
commissione per i dibattiti presidenziali - si legge in una nota - esaminerà
attentamente le modifiche da adottare e le annuncerà a breve. La commissione è
grata a Chris Wallace per la sua professionalità e intende assicurare che ci
siano ulteriori strumenti per mantenere l'ordine".
Paolo Mastrolilli per “la Stampa” l'1 ottobre 2020.
Che impressione le ha fatto il dibattito?
«Sembrava di vedere il film "Grumpy Old Men", due anziani che
litigano come bambini. Non ne abbiamo ricavato nulla di produttivo, ma non è
andato bene per Trump, perché non è apparso presidenziale. Si è comportato come
se fosse lo sfidante, arrabbiato, accusatorio. Voleva una "food fight", quando i
ragazzini si tirano il cibo, e a volte è riuscito a trascinare Biden in basso,
ad esempio quando gli ha dato del clown».
Quindi il dibattito lo ha aiutato?
«No. Il suo obiettivo era spingere Biden a fare qualche gaffe e
dimostrare la propria incompetenza mentale, ma non è riuscito».
Di chi è la colpa?
«Il presidente voleva la battaglia, Biden ha cercato di
resistere, però non ha potuto. E' stato risucchiato. Imbarazzante».
Trump ha evitato di condannare i suprematisti.
«È stato l' errore più serio che ha commesso. Sono estremisti, ma
se stanno dalla sua parte non li condanna. Orribile, è la frase che avrà più
conseguenze».
Contestando l' integrità delle elezioni minaccia la democrazia?
«Certo. La democrazia è in pericolo e l' America non è mai stata
così spaccata, dai tempi della Guerra Civile. Trump vuole la divisione, pensa
che lo farà vincere come nel 2016, mobilitando la destra e i conservatori, ma
sbaglia».
Perché?
«Quattro anni fa a molti democratici non piaceva Hillary, e visti
i sondaggi non erano andati a votare, pensando che lei avrebbe vinto comunque.
Quest' anno non ripeteranno l' errore».
I sondaggi stavolta sono giusti?
«Sì. Nel 2016 erano sbagliati negli Stati per ragioni tecniche.
Li avevano condotti i media locali senza grandi mezzi, e non avevano tenuto
abbastanza conto del fattore istruzione, che invece è decisivo, perché i
sostenitori di Trump sono in prevalenza banchi senza laurea. Stavolta i sondaggi
negli Stati li hanno fatti grandi organizzazioni, e sono affidabili».
Biden è avanti di 7 punti a livello nazionale, ma meno negli
Stati chiave. Il dibattito cambierà qualcosa?
«Non credo. I sostenitori di Trump amano la battaglia, e quindi
un dibattito che somigli al wrestling. Quelli di Biden non sono entusiasti di
Joe, ma sono furiosi con Trump, e le scenate di Cleveland li spingono a votare».
Quali temi saranno decisivi?
«Il Covid peserà più dell' economia».
Biden deve andare ai prossimi due dibattiti?
«Sì, ma senza cadere nelle trappole del presidente. Deve
sollevarsi sopra il suo infantilismo».
Trump ha sempre puntato sulla base, perché non dovrebbe bastare?
«I dati sui voti postali in arrivo dimostrano che i democratici
sono mobilitati. La variabile è come saranno contati. Il processo sarà lento, e
la sera del 3 novembre Trump dirà di aver vinto, perché solo il 18% dei
repubblicani vota per posta e quindi avrà la maggioranza tra chi andrà ai seggi.
Così provocherà una crisi costituzionale, perché l' elezione non sarà finita
fino a quando verranno contati milioni di voti postali, cioè dopo 2 o 3
settimane. I suoi sostenitori scenderanno in strada, ma Biden non riconoscerà il
risultato fino alla fine completa dello spoglio».
Deciderà la Corte Suprema?
«È probabile, ma non sono sicuro che si schiererà con Trump, come
lui crede. La maggioranza dei giudici è stata nominata dai repubblicani, ma la
loro missione è applicare la Costituzione, e sul voto danno la precedenza alle
autorità elettorali. Nel 2000 la Corte intervenne in Florida perché le autorità
locali non erano riuscite a risolvere la disputa, e non c' era più tempo per
ricontare tutti i voti, ma stavolta sarà molto più cauta».
Dibattito
tra Kamala Harris e Mike Pence, un’analisi della comunicazione verbale e non
verbale.
Notizie.it l'08/10/2020. Dal linguaggio del corpo al coinvolgimento del
pubblico: chi, tra Kamala Harris e Mike Pence, è stato il miglior comunicatore
nel dibattito in TV? Kamala Harris parla dritto alla telecamera rivolgendosi
alle persone a casa, e per questo si aggiudica ai punti il dibattito televisivo
tra i candidati alla vicepresidenza degli Stati Uniti. È lei che durante il
confronto con il suo antagonista Mike Pence cita di più il pubblico, si rivolge
agli elettori, un po’ come se ogni volta dicesse alle persone: “Ci siete nelle
mie parole”.
Il linguaggio
del corpo nel dibattito Harris-Pence. Ma andiamo con ordine: rispetto
al dibattito della settimana precedente tra Donald Trump e Joe Biden cambiano
innanzitutto le posture: in questo confronto gli interlocutori sono seduti.
Questo modifica di conseguenza la posizione del loro corpo e il loro comfort
durante il confronto. Basti pensare a come cambia la posizione delle braccia, il
fatto di poterle appoggiare su un tavolo, o di non doversi piegare troppo con il
busto per prendere appunti: l’impatto alla telecamera è senz’altro diverso. Ci
sono però vantaggi e svantaggi: se da una parte la sedia può permettere una
posizione più confortevole, e un dibattito che può apparire più rilassato,
dall’altra parte non permette a noi spettatori di accedere a un piano più ampio
dell’inquadratura: con i relatori in piedi l’inquadratura raggiunge il piano
medio, con i relatori seduti l’inquadratura è poco più ampia del mezzobusto, e
limita in parte la possibilità dei relatori di comunicare attraverso il
linguaggio del corpo.
I contenuti.
Passando ai contenuti, la frase che forse ricorderemo di più di questo dibattito
è quella che più volte Kamala Harris ha rivolto a Mike Pence: “Mister
vicepresident, I’m speaking” (“Signor vicepresidente, sto parlando”). Si tratta
di una variante molto più morbida del “Will you shut up, man?” (“Vuoi stare
zitto, amico?”) pronunciata da Joe Biden la settimana precedente nei confronti
di Donald Trump. Il vicepresidente Mike Pence in questo dibattito è l’uomo dei
rituali. Si ricorda della presentatrice, la chiama spesso per nome, guarda la
sua interlocutrice (Kamala Harris), ringrazia quasi a ogni domanda che gli viene
posta. Kamala Harris, al contrario, ogni volta che risponde è già immersa nella
risposta, senza troppi convenevoli: non saluta in apertura, non fa introduzioni
specifiche. Si rivolge direttamente, quasi a ogni risposta, al pubblico a casa,
esattamente come aveva fatto più volte Joe Biden nel confronto della settimana
scorsa.
Il contatto
col pubblico. La struttura delle risposte di Kamala Harris si ripete con una
certa costanza: l’attacco (la prima frase in particolare) serve per
contestualizzare, solitamente con un aneddoto o una piccola storia, che permetta
al pubblico di familiarizzare con l’argomento. Incrocia lo sguardo della
conduttrice, poi quello di Mike Pence. Quando dalla narrazione Kamala Harris
passa ai propositi, il suo sguardo si sposta verso la telecamera, e si rivolge
al pubblico a casa. La gestualità della Harris accompagna e rafforza la sua
stessa comunicazione verbale: le mani e le braccia, a differenza di Mike Pence,
vengono usate in modo marcato per rafforzare ritmicamente i concetti. Alla
telecamera Kamala Harris sorride spesso quando parla di sé e di Joe Biden, che
cita moltissime volte durante il dibattito. E i riferimenti al pubblico a casa,
come già dicevamo, sono frequentissimi. Non si può dire la stessa cosa per Mike
Pence, che si rivolge per la prima volta al pubblico dopo una decina di minuti
dall’inizio del dibattito, parlando alle famiglie americane vittime
del coronavirus: “You’ll always be in our hearts and in our prayers” (“Sarete
sempre nei nostri cuori e nelle nostre preghiere”). Nelle poche altre occasioni
in cui si rivolge direttamaente al pubblico, Mike Pence tende spesso a parlare
degli americani in terza persona (“The American people deserve to know”, “Il
popolo americano merita di sapere”, anziché “voi meritate di sapere”). Comincia
a rivolgersi più frequentemente al pubblico attorno all’ultimo terzo del
dibattito. Talvolta guarda in camera, ma è questione di pochissimi secondi, per
poi distogliere lo sguardo. È comunque troppo tardi: è come se durante una festa
facessimo amicizia con una persona che ci ha parlato amichevolmente per diversi
minuti (in questo caso, fuor di similitudine, Kamala Harris), e a un certo punto
si intromettesse un altro nel discorso (Mike Pence), per dirci che il nostro
interlocutore si sta sbagliando: ormai è passato troppo tempo. Mike Pence è
tuttavia abile a creare immagini attraverso le parole, e a evocare scenari
futuri. Il tempo verbale dominante nella coniugazione dei verbi all’interno del
dibattito è proprio il futuro. In particolare Pence accusa più volte la coppia
Biden-Harris di voler aumentare le tasse (“They want to raise taxes”), accusa a
cui la Harris risponde con una negazione (“Joe Biden will not raise taxes”, “Joe
Biden non aumenterà le tasse”). Sull’efficacia di questa modalità della Harris
ho qualche perplessità: una negazione potrebbe infatti rischiare di amplificare
ancora di più l’effetto dell’attacco precedente. È per questo che di fronte a
un’affermazione di questo tipo (“aumenterete le tasse”) la modalità migliore per
uscirne potrebbe non essere la semplice negazione, ma un’argomentazione in senso
positivo (per esempio: “Io e Joe Biden ci impegneremo a lasciare le tasse
esattamente come sono oggi”).
Considerazioni
finali. Per concludere: il mio voto finale per la comunicazione di Kamala Harris
in questo dibattito è 7, per quella di Mike Pence, 6. Kamala sa aiutarsi molto
bene con la gestualità mentre parla, fa un uso sapiente delle pause, modula bene
il linguaggio paraverbale (l’uso della voce): passa in modo agevole da toni
gravi a toni più acuti, in funzione degli argomenti. Sa rivolgere lo sguardo
alla telecamera e agli interlocutori nei momenti appropriati, e sorride quando
l’interlocutore parla e lei non concorda. Attraverso questo semplice indicatore
non verbale, riesce così a ridimensionare il contenuto del suo avversario, senza
interromperlo in modo esplicito. Alla stessa maniera Mike Pence è capace di
mantenere e di rispettare di più il rituale della comunicazione che avviene in
studio, valorizzando ciò che succede e descrivendo le interazioni, anche
semplicemente ringraziando per la domanda, o salutando e citando la moderatrice.
Sfumature che per Kamala Harris restano un po’ in secondo piano: per lei, così
come per Joe Biden, è fondamentale l’invito all’azione, la call to action
finale. Quella di Kamala Harris è stata chiara e concisa: “Please, vote”: il
linguaggio di Kamala Harris ha saputo sottolineare questo aspetto più di altri,
all’interno del dibattito.
Igor
Pellicciari per formiche.net l'11 ottobre 2020. A ogni elezione presidenziale
americana, più si avvicina la fatidica data della consultazione e più i toni si
fanno accesi, al limite – a momenti anche oltre — dell’offesa personale. Ce ne
sorprendiamo ogni volta come se fosse la prima; così come ci meravigliamo della
repentina ricomposizione nel post-elezioni di fratture che sembravano solo poche
ore prima insanabili. È una delle principali forze della democrazia
statunitense. Forse più riconducibile alla antropologia politica americana che a
complesse alchimie istituzionali. Non serve essere esperti degli Stati Uniti per
notare che a queste escalation dello scontro, alimentate volentieri dai media
stessi, gli spettatori assistono con un coinvolgimento controllato. Come a un
incontro di wrestling (non a caso sport popolare oltre oceano) dove, nonostante
la violenza messa in scena sul ring, sugli spalti non scoppia mai la rissa tra i
tifosi dei vari lottatori. Eppure oggi di nuovo abbiamo l’impressione che i toni
di queste elezioni 2020 siano di una violenza verbale senza precedenti, dovuta
sia alla retorica sopra le righe di Donald Trump che alla drammatizzazione
portata dalla coincidente crisi pandemica del Covid-19. A occhio, lo scontro
con Joe Biden sembra avere superato per intensità quello già molto pesante
con Hillary Clinton del 2016 (“la peggiore campagna elettorale di sempre”, si
disse all’epoca). Qualunque tema entri nell’arena elettorale ne esce ancora più
estremizzato rispetto alle ultime presidenziali. L’unica, sorprendente,
eccezione in controtendenza sembra riguardare il Russiagate. Nonostante le
premesse (Biden è uomo della vecchia guardia, come i temi di cui si fa
portatore) l’argomento sembra essersi sgonfiato rispetto a quattro anni fa,
almeno nel campo democratico (Trump lo ha riesumato ma in modalità spin off, nel
tentativo di provare che è stata una manovra ordita contro di lui). Ci hanno
provato nella primavera 2020 alcuni tra i falchi democratici, come Victoria
Nuland e Susan Rice, a ridare vita al Russiagate duro e puro ma, come scritto a
suo tempo su Formiche. Il tutto è sembrato un passaggio tattico volto a
promuovere la candidatura della stessa Rice a vice di Biden. Tanto che, dopo la
scelta di Kamala Harris, il tema è di nuovo passato in secondo ordine, almeno
nella sua accezione originaria più grave. Ovvero l’accusa rivolta a Mosca di
volere condizionare il risultato elettorale americano. Se un argomento
potenzialmente così di impatto (lo abbiamo visto nello scontro Trump-Hillary) ha
oggi perso vigore retorico, significa che si è indebolito il suo fondamento di
logica politica. Non è chiaro infatti quale sarebbe il risultato sperato da
Mosca nelle nuove presidenziali americane giacché il Cremlino giudica entrambi i
candidati difficili da gestire per i propri interessi in politica estera. Nel
caso di Trump, se le presidenziali del 2016 e il Russiagate si erano basati sul
teorema che egli, neofito della politica, fosse manipolato (quando non
ricattato) dai russi e che questo ne avrebbe fatto una marionetta nelle mani del
Cremlino, i quattro anni passati alla Casa Bianca hanno dimostrato una realtà
radicalmente diversa. La riduzione dell’attenzione americana su Ucraina e Siria
(ovviamente positiva per il Cremlino) non ha compensato una lunga serie di atti
di politica estera ostili alla Russia. Dall’inasprimento delle sanzioni contro
Mosca, all’attacco frontale al progetto Nord Stream, al gravissimo
smantellamento del trattato Intermediate-Range Nuclear Forces del 1987
(sopravvissuto dai tempi di Michail Gorbacëv e Ronald Reagan), allo scontro
diretto con Iran, Cuba e, soprattutto, Cina. Alla sistematica delegittimazione
del livello multilaterale dell’Onu, terreno su cui Mosca, dai tempi di Yevgeny
Primakov ha sempre fatto molto affidamento per rafforzare la sua attività
diplomatica. Senza dimenticare che l’arrivo di Trump alla Casa Bianca ha portato
a un cambio generalizzato della squadra di governo nella politica estera (si
tratta di centinaia di posizioni), con l’arrivo di persone del tutto nuove,
sconosciute, molte provenienti dal settore privato, per lo più senza esperienza
e impreparate sui singoli file. Scelte per criteri di affidabilità più che per
competenza. A una diplomazia di carriera molto tecnica come quella russa che si
basa sui rapporti personali maturati e punta sulla continuità (negli ultimi 30
anni ha avuto in tutto solo quattro ministri degli Affari esteri, incluso
l’attuale Sergej Lavrov), questo ha rappresentato un salto nel buio e una chiara
difficoltà operativa. Per quanto riguarda le reticenze di Mosca su Biden, basta
rifarsi al giudizio tranchant espresso nel messaggio video del 7 ottobre
da Vladimir Putin, dove esprime irritazione per la classica “retorica antirussa”
del candidato democratico che richiama al clima da nuova guerra fredda che ha
caratterizzato la amministrazione di Barack Obama. Anche se nei corridoi del
ministero degli Affari esteri a Mosca si fa notare che un Biden presidente
riproporrebbe una politica americana sì antirussa ma secondo direttrici
pragmatiche e prevedibili che lo renderebbero un devil you know con cui sarebbe
più facile trovare un accordo, rispetto alla imponderabile azione di Trump. Con
Mosca che, scottata dal 2016 quando fu colta di sorpresa dalla vittoria di
Trump, ora sembra prepararsi a entrambi i possibili esiti elettorali, come
conciliare questo quadro con l’indiscrezione del Washington Post che riferisce
di un rapporto segreto della Cia che accuserebbe il Cremlino di tramare contro
Biden? Ammesso che sia notizia vera e non una mossa del deep state a Washington
per indebolire Trump, verrebbe da dire che per l’ennesima volta si cade
nell’errore di caricare delle attività “istituzionali” di uno Stato avverso,
soprattutto se superpotenza, di significati e obiettivi specifici; anche quando
non sono automatici. Il mainstream di Stato (termine elegante per dire
Propaganda 2.0), ovvero il tentativo di sottolineare paradossi e incongruenze
(politiche, sociali, economiche) nel campo avverso per demitizzarlo e
indebolirlo agli occhi dell’opinione pubblica interna ed internazionale, non ha
bisogno di altre finalità politiche nell’immediato per attivarsi e
giustificarsi. È simile a quanto avviene con l’attività di intelligence che
viene portata avanti di default sugli avversari a prescindere dall’uso che si
farà (o non si farà) delle informazioni riservate raccolte; utili a prescindere.
Che Mosca investa, ora come e più che in passato, risorse mediatiche per
sottolineare le contraddizioni del versante statunitense e che svolga una
intensa attività di intelligence sui principali attori statunitensi, tanto più
se presidenti attuali o futuri, è normale. Quasi una banale verità storica. La
vera novità sta nel fatto che etichettare tutto questo come Russiagate oggi paga
elettoralmente meno che nelle presidenziali del 2016.
Da leggo.it il 16 ottobre 2020. Un altro dibattito vinto da Biden
su Trump sia pure a distanza. «Lei è così bello quando sorride...»: lo slancio
dell'elettrice di nome Paulette, prima di formulare la domanda, è forse l'unica
nota lieta della serata di Donald Trump. Per il resto la scelta di dire no al
dibattito virtuale e di sfidare Joe Biden a distanza allo stesso orario in
diretta tv si è rivelata un boomerang per il presidente americano. Mai The
Donald, impulsivo e spavaldo, era apparso così in difficoltà. Merito soprattutto
di Savannah Guthrie, 48 anni, anchorwoman della Nbc divenuta la vera
protagonista della serata.
Biden batte Trump a distanza. Sui social è la nuova eroina dei
dem, colei che per qualcuno potrebbe addirittura aver cancellato le ultime
chance di vittoria di Trump, a poco più di due settimane dal voto. Così mentre
in onda sulla Abc da Philadelphia Biden mostrava una calma serafica nel demolire
la presidenza Trump, l'attuale inquilino della Casa Bianca veniva messo sotto
torchio da una Guthrie agguerrita, determinata, e non disposta ad accettare
risposte evasive sulla gestione della pandemia, sulla minaccia dell'estremismo
di destra, sulle dichiarazioni fiscali mai pubblicate dal presidente. «Quando è
risultato negativo l'ultima volta al test anti-Covid prima del primo dibattito
con Biden?», la prima domanda della serata. «Non ricordo...forse il giorno
prima..», la risposta tentennate di Trump, che ha ammesso di non aver fatto i
test tutti i giorni. «Comunque io sono il presidente, devo vedere la gente, e
non posso restare chiuso in un seminterrato», ha tentato di attaccare,
riferendosi al famoso basement dove Biden è rimasto rinchiuso nelle settimane
più critiche della pandemia. Ma il peggio doveva ancora venire. Così mentre
Biden accusava Trump di non aver fatto e di non fare niente per contenere la
diffusione dei contagi, il presidente sosteneva candidamente che «l'85% delle
persone che indossano la mascherina si becca il coronavirus», difendendo così i
suoi bagni di folla nei comizi. E un momento dopo, l'ennesimo rifiuto di
condannare esplicitamente il suprematismo bianco e il movimento cospirazionista
QAnon: «Non li conosco, non so niente di loro», ha affermato, nonostante la
Guthrie gli ricordasse come spesso abbia rilanciato su Twitter le loro teorie
del complotto. «Lei è il presidente, non uno zio pazzo qualunque», la reazione
della moderatrice che ha poi incalzato il presidente sulle dichiarazioni fiscali
mai pubblicate: «I numeri usciti sono sbagliati, e comunque il fisco mi ha
trattato molto male», ha detto Trump, nonostante il New York Times abbia svelato
che il presidente ha pagato 750 dollari l'anno sia nel 2016 che nel 2017.
Intanto arriva una notizia che mette in ansia anche Biden: le autorità federali
indagheranno sulle presunte email del figlio Hunter svelate dal New York Post.
Lo riporta Nbc, citando alcune fonti secondo le quali gli investigatori
esamineranno se le missive sono legate a un'operazione di intelligence
straniera. Ma una tegola arriva pure su Trump: il Washington Post infatti
riporta come gli 007 Usa lo scorso anno misero in guardia la Casa Bianca sul
fatto che Rudolph Giuliani, il legale personale di Trump, fosse nel mirino
dell'intelligence russa che voleva influenzarlo per alimentare disinformazione
in vista del voto. E dietro alle email pubblicate dal Nyp c'è proprio lui,
Giuliani.
Raffaella Scuderi per "repubblica.it" il 17 ottobre 2020. Il
volto più familiare d'America ha messo al tappeto Donald Trump. Savannah
Guthrie, co-conduttrice del talkshow Today, ha moderato il town hall di Nbc con
il presidente, con una ostinazione che non si era mai vista prima. Semplice e
precisa, con le sue domande Guthrie ha fatto tentennare la sicumera di Trump,
facendolo apparire confuso e poco credibile. "È stato testato il giorno
dell'ultimo dibattito presidenziale, a Cleveland, che si è svolto appena due
giorni prima del suo test positivo sul coronavirus? Quanto spesso viene testato?
Perché ci sono voluti due giorni per denunciare la supremazia bianca? Intende
denunciare QAnon?". "Non lo so, forse, non li conosco", rispondeva evasivo il
presidente. "Ha twittato un post in cui si mette in dubbio l'uccisione di Bin
Laden". E Trump, "ma era un retweet, l'opinione di qualcun altro". "Ma lei è il
presidente, non lo zio pazzo di un tizio qualsiasi", ha replicato Guthrie
conquistandosi i titoli di tutti i media americani e internazionali. Ma chi è
questa donna tosta in tailleur rosa che ha spiazzato Donald Trump? Uno dei volti
più popolari d'America, la conduttrice del Today show in onda sulla Nbc. Entra
ogni mattina nelle case di milioni di americani. Nata in Australia, 48 anni,
Guthrie lavora da 13 anni per l'emittente Usa: ex avvocato, ha iniziato come
analista legale e cronista di giudiziaria, prima di passare a coprire la Casa
Bianca dopo aver seguito la campagna elettorale di Sarah Palin nel 2008. Dopo
qualche anno è passata alla conduzione del popolare programma del mattino, prima
con Matt Lauer e poi Hoda Kotb. È sposata e ha due figli con Michael Feldman, ex
consigliere politico dei Democratici, capo dello staff di Al Gore durante la
campagna elettorale nel 2000. Autrice di un libro per bambini con Allison
Oppenheim: "Le principesse indossano i pantaloni", Guthrie è al suo secondo
matrimonio. La sua performance è stata accolta da feroci critiche e profonde
lodi: da Fox News la commentatrice Lisa Boothe l'ha definita "di parte" e si è
chiesta se "mai qualcuno dei media abbia sfidato Biden come lei ha fatto con
Trump", mentre il giornalista Jon Favreau ha proposto "un town hall con Trump
moderato da Savannah Guthrie ogni sera da adesso fino al giorno del voto".
"L'intervista che aspettavamo da anni", titola Vox. "Alleluia, il miracolo dei
miracoli", ha twittato Frank Luntz , noto consulente politico Usa. E mentre
l'anchor di Nbc "interrogava" Trump, sulla Abc andava in onda il dibattito con
Joe Biden. "Ho appena girato sulla Nbc perché sulla Abc c'era la pubblicità -
commenta su Twitter Ari Fleischer di Fox News - In questi 60 secondi Savannah
Guthrie ha interrotto Trump più di quanto abbia fatto Stephanopoulos con Biden
in 40 minuti. Nbc è un interrogatorio, Abc è un picnic".
La giornalista tv batte Biden. La "vera" sfidante per Trump.
Sleepy Joe non incanta, ma la presentatrice Nbc mette
alle strette il presidente Usa: "Non faccia lo zio pazzo". Valeria Robecco,
Sabato 17/10/2020 su Il Giornale. New York. Più che Joe Biden, la vera sfidante
di Donald Trump nel duello a distanza in diretta tv è sembrata la conduttrice
Savannah Guthrie. Il presidente americano e il rivale democratico hanno
incrociato i guantoni allo stesso orario ma su due canali diversi - il primo su
Nbc da Miami, il secondo su Abc da Philadelphia - con la formula del town hall,
ossia rispondendo alle domande del pubblico. Per diversi osservatori Biden ha
vinto ai punti, con un atteggiamento calmo e studiato, più a suo agio senza
l'avversario che lo incalzava, mentre il tycoon che è parso meno aggressivo del
solito. La campagna di Trump, tuttavia, ha immediatamente fatto notare il
trattamento decisamente differente dei due moderatori nei confronti dei
candidati: «Anche se la commissione ha cancellato il dibattito che avrebbe
dovuto esserci stasera, il Comandante in Capo ha sonoramente battuto Savannah
Guthrie nel suo ruolo» di rappresentante di Biden. «Su Abc la scena era
completamente diversa, con domande a Joe per non metterlo in difficoltà - ha
proseguito la campagna - Gli americani vedono che il presidente in 47 mesi ha
fatto di più che Biden in 47 anni di politica». Nel corso della serata, The
Donald ha ribadito i suoi dubbi sulle mascherine, ma è parso in difficoltà alla
richiesta della conduttrice su quando è stato negativo l'ultima volta al test
per il coronavirus. «Non ricordo... forse il giorno prima... Comunque io sono il
presidente, devo vedere la gente, non posso restare chiuso in un seminterrato»,
ha risposto in riferimento all'avversario che nei mesi della pandemia era
praticamente scomparso. A suscitare nuove critiche, invece, è stato il suo
rifiuto di condannare esplicitamente il suprematismo bianco e il movimento
cospirazionista QAnon: «Non li conosco, non so niente di loro», ha affermato,
nonostante Guthrie gli ricordasse come spesso abbia rilanciato su Twitter le
loro teorie del complotto: «Lei è il presidente, non uno zio pazzo qualunque che
può ritwittare qualsiasi cosa». La moderatrice ha poi incalzato Trump
sull'argomento tasse: «I numeri usciti sono sbagliati, e comunque il fisco mi ha
trattato molto male», è stata la sua replica. Biden, da parte sua, ha ribadito
gli attacchi all'inquilino della Casa Bianca sulla cattiva gestione della
pandemia, ma è risultato vago evitando di prendere posizione sull'allargamento
della Corte Suprema. All'ex numero due di Barack Obama, invece, non è stato
chiesto nulla in merito alle presunte e-mail del figlio Hunter pubblicate dal
New York Post. «Sleepy Joe ha dato un pessimo spettacolo nonostante George
Stephanopoulos non gli abbia fatto domande sul suo essere un politico corrotto -
ha commentato il tycoon all'indomani - I Big Tech e gli squallidi media stanno
lavorando duramente per nascondere questa corruzione». A fare chiarezza
potrebbero essere le autorità federali, che secondo l'Nbc indagheranno per
verificare se i messaggi sono legati ad un'operazione di intelligence straniera.
Ma non c'è pace neppure per Trump, con il Washington Post che ha riportato come
gli 007 Usa lo scorso anno misero in guardia Pennsylvania Avenue sul fatto che
Rudy Giuliani, il suo legale personale, fosse nel mirino dell'intelligence russa
che voleva influenzarlo per alimentare disinformazione in vista del voto.
Ricordando che dietro alle e-mail pubblicate dal Post c'è proprio l'ex sindaco
di New York.
Da "tgcom24.mediaset.it" il 17 ottobre 2020. "La famiglia Biden è
un'impresa criminale, una delle più corrotte della storia americana": Donald
Trump, in Georgia per l'ultimo comizio di una lunga giornata elettorale, torna
all'attacco chiedendo che Biden e il figlio Hunter rispondano delle loro azioni.
Il riferimento è alle presunte email pubblicate dal New York Post. "E' il
più grande scandalo politico dopo lo spionaggio sulla mia campagna da parte di
Obama - ha detto Trump -. Arrestateli". "I Biden sono una famiglia del crimine
organizzato", ha insistito Trump, "una famiglia che nel suo partito ha passato
il potere ai marxisti". Citando poi Hillary Clinton, Trump ha innescato il coro
tormentone della campagna del 2016: "Lockh her up", imprigionatela. "Sono
d'accordo con voi al 100%", ha detto il presidente americano: "Di solito sto
zitto su questo, ma sono d'accordo con voi al 100%". Emerse mail figlio Joe
Biden su Ucraina - Lo scandalo a cui si riferisce Trump riguarda Hunter Biden,
figlio del candidato dem alla Casa Bianca Joe, il quale ha presentato suo padre,
ai tempi della vicepresidenza, a un alto dirigente della società energetica
ucraina Burisma dove lavorava, meno di un anno prima che l'ex vice di Obama
facesse pressioni sui funzionari del governo ucraino per licenziare un
procuratore che stava indagando sulla società. Un episodio riferito dal New York
Post, il quale ha citato delle mail ottenute dalla testata. La difesa di Biden:
"Episodio mai accaduto" - "Le indagini da parte dei media e di due commissioni
del Senato a guida repubblicana sono giunte tutte alla stessa conclusione, ossia
che Joe Biden ha portato avanti la politica ufficiale degli Stati Uniti
nei confronti dell'Ucraina e non ha commesso alcun illecito. I funzionari
dell'amministrazione Trump hanno attestato questi fatti sotto giuramento". Lo ha
detto il portavoce della campagna del candidato democratico alla Casa Bianca,
Andrew Bates, ha commentato la storia sulle email di Hunter Biden, figlio di
Joe, pubblicata dal New York Post. Inoltre, "abbiamo rivisto i programmi
ufficiali di Joe dell'epoca e nessun incontro ha mai avuto luogo", ha aggiunto.
DAGONEWS il 26
ottobre 2020. È arrivato il
sex+drug-tape di Hunter Biden? Una serie di video e immagini che sembrano
mostrare il figlio del candidato democratico mentre si accoppia con una serie di
donne, condite dall'uso di droghe pesanti sono stati condivisi sulla piattaforma
video cinese GTV. Si tratta di una sussidiaria di GTV Media Group, fondata
dall'ex consigliere di Trump Steve Bannon e dal miliardario cinese Guo Wengui
nell'aprile 2020. Il governo cinese sostiene che Wengui - immobiliarista che ora
vive negli Stati Uniti - è colpevole di frode, ricatto e corruzione. Accusa che
lui ha ribaltato nei conftonti dei funzionari cinesi quando ha presentato
domanda di asilo negli Stati Uniti. Il suo socio Bannon è stato incriminato con
l'accusa di frode ad agosto e arrestato a bordo dello yacht di Wengui, un
gioiellino da 28 milioni di dollari. Le clip sono state caricate da un singolo
utente sabato sera e in uno dei video si accusa Joe Biden di essere "controllato
al 100% dal partito comunista cinese". Non è chiaro se il filmato provenga
dal laptop from hell, il computer portatile che Hunter Biden lasciò a un negozio
di riparazioni e che è stato poi riacquistato dal New York Post che ne ha
rivelato alcuni contenuti scottanti. Alcune immagini sembrano provenire da un
laptop di altri soggetti. Bannon sostiene che le notizie-scandalo emerse dal
laptop di Hunter sono tutte vere, e ha accusato Joe Biden di aver preso il 10%
sugli affari che il figlio ha realizzato in Ucraina e Cina mentre lui era
vicepresidente e soprattutto delegato da Obama a gestire rapporti con potenze
straniere. I filmati sono poi stati rimossi da tutte le piattaforme, da Youtube
a Reddit. Non ci sono conferme che si tratti di Hunter Biden, ma la somiglianza
è notevole e soprattutto è stato lui stesso ad ammettere di aver fatto uso di
droghe pesanti (in uno dei filmati si vede mezzo addormentato con una pipa da
crack in bocca) e di aver frequentato parecchie prostitute (questo è emerso
anche dagli atti del divorzio dalla moglie).
Da liberoquotidiano.it il 27 ottobre 2020. Nuove accuse sul figlio di Joe Biden,
Hunter Biden, finito già al centro già dello scoop del New York Post che ha
pubblicato presunte sue mail che proverebbero come abbia favorito contatti
illeciti tra il padre quando era vice presidente ed un uomo d'affari ucraino.
Ora è spuntato un video pubblicato da The Gateway Pundit, sito di estrema
destra, in cui Hunter fuma crack con una prostituta e messaggi in cui ammette di
essere stato accusato di comportamenti impropri con una minorenne. Nei giorni
scorsi il sito, noto per essersi fatto voce di molte tesi complottiste, aver
attivamente sostenuto la campagna elettorale di Donald Trump nel 2016,
guadagnandosi poi per la prima volta un accredito alla Casa Bianca per i suoi
report, ha scritto che il video, di cui ha pubblicato solo un fermo immagine,
sarebbe stato pubblicato da una televisione cinese, Gtv. Mentre ieri ha
pubblicato schermate di messaggi sms e copie di mail attribuite ad Hunter che,
parlando con un amico di famiglia, con lo zio e con un suo socio nella società
Burisma, Devon Archer, racconta che una persona l'ha accusato di avere avuto
comportamenti impropri con la figlia minorenne. E che, sostiene ancora il sito
sulla base di queste schermate, sia il padre che la madre Jill erano al corrente
di queste accuse ed avrebbero aiutato Hunter ad evitare le conseguenze. Intanto
Vladimir Putin ieri ha liquidato le accuse di Donald Trump, relative all'Ucraina
e alla Russia, rivolte Hunter Biden. "È vero, in Ucraina Hunter Biden ha avuto,
o ha tuttora, interessi economici. Non so, non ci riguarda. Riguarda gli
americani e gli ucraini. Ma sì, ha avuto almeno una società, di cui era di fatto
il capo, e complessivamente ha guadagnato tanto. Non c'è niente di criminale in
questo e non abbiamo informazioni che ci sia stato nulla di criminoso", ha
dichiarato il Presidente russo, anticipando la sua disponibilità a lavorare con
entrambi i candidati, se eletti, pur notando la "dura retorica anti russa" di
Biden. Quanto ai legami di Putin con l'ex sindaco di Mosca Yuri Luzhkov e al
presunto pagamento effettuato in favore di Hunter Biden dalla vedova, Putin ha
risposto con evidente irritazione. Precisando di non essere a conoscenza di
alcun elemento circa i rapporti fra Hunter e la donna. Anche Biden senior è
intervenuto nel dibattito difendendo il figlio. La persona che ha avuto problemi
in Ucraina è lui", ha detto Joe Biden puntando il dito contro Trump, "per aver
tentato di corrompere il governo ucraino perchè dicesse qualcosa di negativo su
di me", ha risposto, riferendosi all'impeachment. "E l'unico che ha fatto soldi
con la Cina è questo tizio", ha aggiunto Biden indicando il rivale durante
l'ultimo dibattito presidenziale.
Francesco Semprini per ''la Stampa'' il 16 ottobre 2020. È
rivolta contro le sospette censure dei social media sull'Ucrainagate, le
presunte relazioni pericolose tra Joe Biden, il figlio Hunter e il gigante
energetico Burisma. Una vicenda tornata a galla sul «New York Post» che ha
pubblicato nei giorni scorsi alcune e-mail secondo cui il figlio del candidato
democratico presentò il padre ad un alto dirigente di Burisma, la società
energetica ucraina con sede a Cipro di cui il secondogenito dell'ex vice di
Barack Obama era consigliere. Il punto è che l'allora vicepresidente qualche
tempo dopo - secondo alcune registrazioni tra lo stesso Biden e l'ex presidente
ucraino Poroenko - avrebbe esercitato pressioni affinché Kiev licenziasse un
procuratore che stava indagando sull'azienda stessa. L'incontro, mai rivelato
prima è menzionato in una e-mail che un membro del Cda di Burisma, Vadym
Pozharskyi, ha inviato a Biden Jr. nell'aprile 2015, circa un anno dopo che
Hunter era entrato nel consiglio. Ebbene, dinanzi a quello che potrebbe
diventare un caso di non poca rilevanza a meno di venti giorni dal voto
presidenziale, Facebook e Twitter hanno deciso di censurarlo in attesa di
verificarne la veridicità. Il sito di microblogging si è spinto oltre bloccando
l'account della portavoce della Casa Bianca, Kayleigh McEnany, per aver postato
l'articolo. Bloccato anche l'account Twitter della campagna di Trump. Una
censura che ha sollevato una rivolta tra le fila del Grand Old Party. «Sono
fuori controllo, sono un braccio del partito democratico e in mano alla sinistra
radicale, terribile...», tuona Trump lanciando la campagna «Abolire la Section
230!!!», la norma che stabilisce l'immunità dei social media dai contenuti
postati da terzi sulle piattaforme. I repubblicani della commissione giustizia
del Senato ora vogliono convocare il Ceo di Twitter, Jack Dorsey, per avere
spiegazioni in merito. I democratici replicano mettendo in dubbio la correttezza
della fonte, ovvero Rudy Giuliani. Le e-mail fanno parte dei dati recuperati da
un pc inviato ad un centro riparazioni il cui gestore le avrebbe consegnate
all'ex sindaco di New York il quale le ha girate al Post. Secondo lo stesso
Dorsey è stato uno sbaglio bloccare l'inchiesta senza dare una spiegazione,
arrivando a parlare di decisione «inaccettabile». L'offensiva dei social ha
visto protagonista anche YouTube che ha bloccato tutti i contenuti di QAnon, la
comunità pro-Trump nota per le sue teorie del complotto, perché «alimentano la
violenza nel mondo reale». Il «New York Post» intanto ha rincarato la dose
pubblicando altre mail che proverebbero come Hunter abbia cercato di spuntare
accordi con il gigante energetico cinese, Cefc Chian Energy, che lo stesso
rampollo definisce «interessanti per la mia famiglia». Secca la replica di
Trump: «Se Biden vince, la Cina si comprerà il nostro Paese».
Glauco Maggi per ''Libero Quotidiano'' il 16 ottobre 2020.
C'erano una volta i media faziosi, giornali e TV, che orientavano la copertura
delle notizie nel senso del mainstream, ossia inclinato a sinistra. Poi sono
arrivati i colossi dell'high tech, quelli delle grandi piattaforme online su cui
la gente poteva scambiarsi di tutto, notizie commenti e foto, e ci si era illusi
di essere entrati nell'era della conoscenza universale senza restrizioni.
Facebook e Twitter, con i loro milioni di utenti gente comune, promettevano di
dribblare le informazioni dei regimi oppressivi e giocavano la parte dei
paladini della civiltà moderna occidentale. Ricordate le primavere arabe? Bene,
anzi male, le bandiere del "Libero Internet" sono state ammainate. Adesso
Facebook e Twitter sono diventati i pretoriani di Joe Biden, dei Democratici,
della sinistra, e praticano la censura, proprio come i partiti comunisti cinese
o cubano zittiscono la loro opposizione interna. Ieri, quando il New York Post
ha sbattuto in prima pagina la "pistola fumante" che incastra Joe Biden a
proposito degli affari sporchi del figlio Hunter in Ucraina, le due piattaforme
di Mark Zuckerberg (Facebook) e Jack Dorsey (Twitter) hanno concordemente
applicato l'incredibile decisione di impedire la diffusione della notizia. Che,
in verità, è devastante per la campagna Dem. Mentre Joe aveva sempre sostenuto
di non aver mai parlato con il figlio Hunter del lavoro di quest' ultimo (a
50mila dollari al mese) per la ditta ucraina di gas Burisma, ora sono spuntate
le email in cui un dirigente della società di Kiev, Vadym Pozharskyi, chiede a
Hunter di «usare la sua influenza» sul babbo. E poi lo ringrazia per l'incontro,
avvenuto a Washington, con l'allora vicepresidente con la delega per l'Ucraina.
«Caro Hunter, facendo seguito ai nostri colloqui durante la visita sul lago di
Como e in successive occasioni, vorrei portare la seguente situazione alla tua
attenzione Urgentemente ci serve il tuo consiglio», gli scrive Pozharskyi nel
maggio 2014, «su come tu possa usare la tua influenza per far arrivare un
messaggio e stoppare ciò che noi consideriamo azioni politicamente motivate». Un
anno dopo, 17 aprile 2015, altra email: «Caro Hunter, grazie per avermi invitato
a Washinghton e per aver dato l'opportunità di incontrare tuo padre e di passare
un po' di tempo insieme». Non solo Joe sapeva tutto di Hunter, ma lo ha aiutato
nel suo business: conflitto di interesse? corruzione? I due social filo sinistra
sono andati nel panico. Non solo hanno vietato all'articolo del New York Post,
postato dal redattore Sohrab Ahmari, di finire in rete. Hanno addirittura
impedito la pubblicazione del tweet di Kayleigh McEnany, capo ufficio stampa
della Casa Bianca, che aveva riassunto in un tweet la vicenda. «Abbiamo
stabilito che questo account ha violato le regole contro la distribuzione di
materiale hackerato», ha comunicato Twitter. Ridicolo, se si pensa a quanto
pubblicato contro Trump in passato. E, comunque, le email non sono frutto di
hackeraggio. Il laptop che contiene le email porta il contrassegno della "Beau
Biden Foundation", intitolata al fratello di Hunter morto anni fa, era stato
portato per essere riparato in un negozio del Maryland, lo stato di Biden, e poi
mai reclamato dal cliente. Il proprietario del negozio aveva tentato invano di
rintracciare il cliente e alla fine aveva consegnato il Mac Pro alle autorità,
conservando copia dell'hard disk poi arrivato all'avvocato di Rudy Giuliani, che
da tempo indaga sulle mosse affaristiche dei Biden in Ucraina, in Iraq e in
Cina. E da qui al New York Post. Normale percorso di uno scoop, se a farlo sono
CNN o New York Times. «È veramente terribile che Facebook e Twitter hanno
silenziato la notizia», ha twittato Trump. «Non c'è nulla di peggio di un
politico corrotto». Intanto, il senatore repubblicano Josh Hawley ha formalmente
convocato i Ceo di Facebook e di Twitter, Zuckerberg e Dorsey, davanti al
sottocomitato sul Crimine e il Terrorismo della Commissione Giustizia del
Senato.
Sfida Trump-Biden, ultimo dibattito in tv prima del voto.
Notizie.it il 23/10/2020. Sfida Trump-Biden, ultimo
duello in tv con lo sfidante che attacca Trump sui morti Covid e il presidente
in carica che incolpa la Cina. Joe Biden lancia un nuovo attacco al suo
rivale Donald Trump e lo fa sul tema della pandemia, che del presidente in
carica Usa è un po’ il "tallone d’Achille" . Lo fa nel rush finale della
campagna elettorale per la Casa Bianca. “Chiunque sia responsabile di così tante
morti non dovrebbe rimanere a fare il presidente degli Stati Uniti d’America”.
Biden: “Trump non ha un piano”. L’attacco di Biden è avvenuto nel
corso dell’ultimo faccia a faccia rigorosamente televisivo fra i due candidati.
Un Faccia a faccia che prelude il voto cruciale di martedì 3 novembre prossimo,
quando l’America deciderà fra il tycoon repubblicano in carica e lo sfidante
democratico accreditato dai sondaggi. Ovvio che il tema cruciale fosse Covid.
Secondo Biden Trump non ha un piano chiaro per fronteggiare l’attacco del virus
alla popolazione americana. E purtroppo i numeri sembrano dargli ragione: negli
Usa la pandemia ha già fatto più di 230mila morti. Biden ha poi incalzato il suo
avversario, affermando che porrà fine “a tutto questo” e che Trump “crede di
avere il controllo, ma noi stiamo per perdere altre 200mila persone”. Il
presidente repubblicano in carica ha replicato a muso duro. E lo ha fatto da un
lato assumendosi “piena responsabilità”, dall’altro additando ancora una volta
la Cina come causa prima ed assoluta della pandemia. “Questa malattia passerà,
non avremo un inverno buio, ma dobbiamo proteggere i nostri anziani”. Poi lo
scontro fra i due, che non è mai stato "sottile" in questi mesi, è entrato nella
fase della condanna dei rispettivi atteggiamenti personali nei confronti della
minaccia Covid. Nel corso della sfida Trump-Biden, con l’ultimo duello in tv il
presidente ha affermato che l’America “non può continuare a chiudersi in un
sotterraneo come fa Joe”. Biden infatti era stato accusato di essersi
nascosto nel “basement”, lo scantinato anti tornado così comune negli Usa, della
sua casa in Delaware. “Presto arriverà il vaccino, i picchi spariranno e il
virus andrà via”, ha detto Trump, che ha ribadito di essere “immune” dopo il suo
ricovero per positività al virus. Biden gli ha risposto ironicamente che invece
così “la gente sta imparando a morire di Covid”.
Il faccia a faccia a Nashville. USA
2020, ultimo duello Trump-Biden: animi caldi su coronavirus e interferenze
straniere. Redazione su Il Riformista il 23 Ottobre 2020. Le scintille sono
partite su tasse, immigrazione, sanità e corruzione. Con toni e botta e risposta
all’insegna della correttezza. Tutta un’altra storia rispetto al primo, e unico,
dibattito tra i due candidati presidenti degli Stati Uniti a Cleveland (il
secondo è stato annullato a causa della positività al coronavirus di Donald
Trump). È andato in scena nella notte l’ultimo faccia a faccia prima del voto, a
Nashville, Tennessee. È andato in onda quando 47 milioni di elettori hanno già
votato via posta. Il Presidente in carica prova la rimonta sui sondaggi. Lo
sfidante democratico punta a non farsi sopraffare da un comunicatore consumato.
Stile e tempi del duello li ha dettati comunque Trump: non ha mai interrotto,
assertivo in diversi passaggi, ha argomentato e non parlato solo per slogan, ha
ascoltato e si è riferito allo sfidante come a “Joe”. Biden ha sempre fatto
riferimento a un generico “Lui”. A moderare il dibattito Kristen Welker, della
rete NBC. Tutt’altro che faziosa, come aveva lamentato Trump prima del
dibattito, ha tenuto in pugno tutto il dibattito. Il colpo di scena della
serata: gesto inatteso e piuttosto criticato di Biden che a un certo punto a
dato uno sguardo al suo orologio, come aveva fatto anche l’ex presidente George
H. W. Bush.
COVID – Joe Biden ci è andato giù duro sull’emergenza covid. Non
ha risparmiato critiche al Presidente in carica. Gli Stati Uniti sono il Paese
con più contagiati e morti a causa del coronavirus. “Un presidente responsabile
di tante morti non può rimanere al potere – ha detto – il presidente Trump ha
mentito e mente al paese, la gente sta morendo”. Biden ha dato anche una serie
di soluzioni per fermare il virus: “Per aprire il paese servono misure standard,
le mascherine, il rispetto del distanziamento sociale, il plexiglas ai tavoli
dei ristoranti”, ha spiegato. Trump ha ribattuto, sottolineando i costi della
proposta di Biden: “New York è una città fantasma, il plexiglas nei ristoranti
non è la risposta, la cura non può essere peggiore del problema”. Il Presidente
è tornato ad autocelebrare la sua politica di "contenimento" del virus, senza
riuscire tuttavia a essere convincente.
INTERFERENZE – Altro tema caldo. Per Biden qualsiasi straniero
interferisca dovrebbe pagare un prezzo. Trump lo attacca di essersi fatto pagare
da Mosca, anche attraverso gli affari del figlio che accusa di aver ricevuto 3,5
milioni di dollari dalla moglie dell’ex sindaco della capitale russa. E
stupisce, mentre il presidente continua ad accusare lo sfidante anche sul piano
familiare, che i toni rimangano pacati. “Non preso un penny da un’entità
straniera – ha respinto il candidato democratico – tu invece hai un conto in
Cina dove hai pagato tasse 50 volte superiori a quelle pagate in Usa e non hai
reso note le dichiarazioni dei redditi, cosa mai c’è lì?”. Biden fa riferimento
anche alle tasse non pagate per anni da Trump, come ha documentato un’inchiesta
del New York Times.
SANITA’ – Biden ha messo il carico sull’Obamacare, la riforma
sanitaria realizzata dall’ultima amministrazione democratica. “La sanità non è
un privilegio, è un diritto”, ha detto Biden, accusando Trump di voler abolire
la riforma sanitaria che ha dato la copertura assicurativa a milioni di
americani e lancia la ‘Bidencare’: “una Obamacare più un opzione pubblica”, ha
spiegato l’ex vicepresidente.
IMMIGRAZIONE – Nuove scintille sul tema. Trump e Biden intendono
la questione da posizioni praticamente opposte. Trump si è vantato di aver fatto
per gli afro-americani più di qualsiasi altro presidente. Per Biden, invece,
quello attuale è “uno dei presidenti più razzisti della storia moderna”. Un
sentimento che ha alimentato e quindi reso “istituzionale”, per il democratico.
Biden ha poi definito “criminale” la separazione dei bambini dai genitori
immigrati al confine col Messico praticata dall’amministrazione Trump. “Non li
abbiamo separati”, ha tentato di difendersi il presidente, sostenendo che i
bambini sono portati dalle gang di trafficanti di persone e che le gabbie usate
per tenere i clandestini furono costruite nel 2014 durante la presidenza Obama.
Come ha fatto in diverse altre occasioni Trump ha fatto notare al pubblico
televisivo che Biden aveva avuto otto anni per realizzare le sue politiche:
“Joe, sei tutto chiacchiere e nessun fatto” è stata la conclusione del
presidente in carica.
LA RESA DEI CONTI – L’ultimo faccia a faccia si è tenuto a meno
di due settimane dal voto. Le elezioni si terranno martedì 3 novembre. Intanto
procede il voto postale. I duelli non hanno dato ragione a Trump: troppo blanda,
con frequenti picchi di negazionismo, la risposta alla pandemia da parte del
Presidente. Gestione sospetta e sospettosa anche del focolaio alla Casa Bianca.
Poco convincente anche nelle risposte alle discriminazioni razziali, e quindi ai
casi Floyd e Blake. Biden, tuttavia, non è riuscito a “mettere a posto il bullo”
come aveva anticipato in diverse occasioni. I sondaggi lo danno in netto
vantaggio. Per Cnn ha vinto anche il dibattito di Nashville, con il 53% delle
preferenze degli americani, contro il 39% di Trump.Lo stesso valeva per Hillary
Clinton, nel 2016, e poi Trump ribaltò il risultato. Entrambi i presidenti, 74 e
78 anni, diventerebbero il più anziano dei Presidenti americani.
Dall'articolo di Francesco Semprini per ''la Stampa'' il 22
ottobre 2020. Affari con la Cina a vantaggio della famiglia Biden. E questa
l’ultima tegola caduta sulla testa del candidato democratico alle presidenziali
raccontata dalla seconda tranche di e-mail pubblicate dal New York Post. Scambi
di posta elettronica che proverebbero come Hunter Biden, il secondogenito di
Joe, avrebbe cercato di spuntare accordi redditizi con la maggiore società
energetica cinese, incluso uno "interessante" anche per la sua famiglia. È in
particolare una mail datata 13 maggio 2017 dal titolo “Aspettative” che contiene
sospetti "pacchetti di compensi” relativi a diverse cariche nell’ambito di un
possibile affare. Hunter nell'email veniva identificato come
"presidente/vicepresidente a seconda dell'accordo con la CEFC", l'ex
conglomerato cinese con base a Shangai CEFC China Energy. Una vicenda che getta
ulteriori ombre sulle relazioni pericolose con l’estero dei Biden dopo quelle
sul presunto Ucrainagate, e che arrivano a meno di venti giorni dal voto per
l’elezione del presidente. "La vittoria di Joe Biden sarebbe una grande vittoria
per la Cina. Se Biden vince, la Cina si comprerà il nostro Paese”, afferma
lapidario Donald Trump durante un'intervista a Fox Business, spiegando anche di
non voler parlare con il presidente Xi Jinping. "Biden - ha proseguito
l’inquilino della Casa Bianca - è un politico corrotto, tutti lo sanno a
Washington. E suo figlio Hunter è un disastro”.
Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera” il 22 ottobre 2020.
Che un immobiliarista con ambizioni planetarie che stava cercando di entrare
anche in Asia avesse un conto bancario in Cina, non può scandalizzare. Ma se
quell' immobiliarista, che poi è diventato presidente degli Stati Uniti, in
America non ha pagato le tasse per anni, mentre in Cina ha versato 188 mila
dollari pur non avendo mai realizzato alcuna attività, la cosa cambia aspetto.
Ancora di più alla luce degli attacchi di Donald Trump al suo rivale Joe Biden,
accusato dal leader repubblicano di essere troppo morbido con la Cina -
avversario strategico degli Usa - per via degli affari che suo figlio Hunter
stava cercando di concludere in quel Paese. L' inchiesta del New York Times sul
rapporto tormentato di The Donald col Fisco americano («mi trattano molto male»,
si lamenta, come se non fosse una branca della sua Amministrazione), è arrivata
fino a questo curioso capitolo cinese. Che getta nuova luce sui disinvolti
comportamenti fiscali del presidente: prima di arrivare alla Casa Bianca, dal
2013 al 2015, ha dichiarato versamenti per 188 mila dollari al governo cinese
sotto forma di imposte, pur non essendo mai riuscito a sviluppare alcuna
attività in Cina. Poi, nel 2016 e nel 2017, ha pagato appena 750 dollari di
tasse al Fisco Usa, presumibilmente grazie a un uso massiccio delle detrazioni.
I dati raccolti dal quotidiano non consentono collegamenti diretti ma si sa, ad
esempio, che la THC China Development Llc, una delle società create da Trump,
con un ufficio a Shanghai, nel solo 2012 ha detratto dall' imponibile 84 mila
dollari per viaggi e spese legali. Erano gli anni in cui premeva per entrare nel
mercato cinese e, pur essendo sempre stato non solo anticomunista, ma anche
antistatalista, aveva stretto una partnership con la State Grid Corporation,
grossa conglomerata di proprietà dello Stato cinese. Secondo un' inchiesta del
2016 dell' Afp , la joint venture avrebbe dovuto realizzare e gestire
insediamenti immobiliari a Pechino, ma poi i vertici della società cinese furono
travolti da un' inchiesta per corruzione. Stasera, nell' ultimo dibattito tv,
probabilmente Trump tornerà ad accusare Biden di essere al servizio della Cina,
anche se ora preferisce attaccarlo - chiedendone perfino l' arresto - per i
rapporti del figlio Hunter con l' Ucraina: accuse basate su email quasi
certamente false, probabilmente costruite a tavolino da esperti (russi?) di
disinformazione. Eppure anche Trump, prima di scoprirsi nemico del la Cina (ma
non di Xi Jinping del quale continua a parlare bene), aveva fatto di tutto per
mettervi radici. Del suo conto bancario cinese si sa poco, ma è significativo
che l' unico Paese straniero nel quale Trump aveva e ha conti bancari, oltre a
Gran Bretagna e Irlanda (dove possiede vari campi da golf), sia la Cina.
Duello finale Trump-Biden: scontro su tutti i fronti.
Il Corriere del Giorno il 23 Ottobre 2020. Dal dibattito è
emersa la profonda differenza nella visione tra i due candidati, dall’ambiente
alla politica estera , dall’economia al Covid , dall’immigrazione alle tensioni
razziali. Secondo un sondaggio a caldo della Cnn, il 53% degli spettatori pensa
che il dibattito lo abbia vinto Biden, e solo il 39% Trump. Nel dibattito finale
di Nashville questa volta si è potuto capire qualcosa. Il dibattito tra il
presidente uscente degli Stati Uniti d’ America Donald Trump e lo sfidante
democratico Joe Biden è stato più corretto e civile della precedente rissa
verbale di Cleveland, grazie anche al prezioso lavoro dei consiglieri del
presidente che lo hanno convinto che sarebbe stato meglio e nel suo interesse
lasciar parlare l’avversario, sperando in qualche scivolone. I repubblicani sono
soddisfatti, perché Trump è riuscito a spiegare meglio le sue posizioni, anche
se non c’è stato il colpo del ko , ed ora si chiedono se a dieci giorni dal
prossimo voto del 3 novembre c’è ancora il tempo per invertire i sondaggi, che
lo danno perdente a livello nazionale e nella maggior parte degli Stati chiave.
E’ emersa dal dibattito la profonda differenza nella visione tra i due
candidati, dall’ambiente alla politica estera , dall’economia al Covid ,
dall’immigrazione alle tensioni razziali. Come facilmente, Trump è partito
subito all’attacco accusando Biden di aver ricevuto soldi dalla Cina e dalla
Russia, attraverso gli affari del figlio Hunter. Ma Joe Biden gli ha risposto
così: “Io non ho mai preso un penny da alcuna entità straniera. Tu invece hai un
conto bancario in Cina, non paghi le tasse, e nascondi la tua dichiarazione dei
redditi. Perché non la pubblichi? Cos’hai da nascondere?“. La discussione si è
subito concentrata sull’epidemia del Covid-19, e Trump ha cercato di difendere
la sua gestione: “Non è colpa mia, ma della Cina. Io però ho bloccato subito i
voli dalla Repubblica popolare, mentre Biden mi accusava di essere uno xenofobo.
I vaccini verranno annunciati a breve, così come le cure. Stiamo svoltando
l’angolo, stiamo imparando a vivere con il virus“. Ma Biden ha replicato:
“Stiamo imparando a vivere col Covid? Ma per favore! Stiamo morendo per il
Covid. In America hanno perso la vita oltre 220.000 persone: chiunque sia
responsabile di una cosa del genere non merita di continuare a fare il
presidente“. Sull’economia il capo della Casa Bianca ha ripetuto di aver creato
la più ricca di sempre negli Usa, prima che “la peste cinese la bloccasse. Ora
però stiamo ripartendo, e se Biden vincerà le elezioni ci farà precipitare in
una recessione mai vista“. Il candidato democratico allora ha replicato così:
“La verità è che le famiglie americane stanno soffrendo, e voi repubblicani
state bloccando al Senato il passaggio del pacchetto economico per aiutarle“.
Sulla razza, Donald ha detto che “sono il presidente che ha fatto di più per gli
afro americani, forse dopo Lincoln“. Biden allora lo ha preso in giro: “Abramo
Lincoln qui è il presidente più razzista mai avuto dagli Usa. Nega anche
l’esistenza del problema. Io invece ho un programma per dare a tutti le stesse
opportunità“. Trump allora gli ha replicato: “Ma se avevi tutte queste belle
idee, perché non le hai realizzate quanto eri vice presidente?” ricevendo
immediata risposta: “Perché i repubblicani avevano la maggioranza al Congresso e
bloccavano tutto“. Il momento forse più memorabile è però quando si parla dei
bambini separati dai genitori al confine e ancora in dei centri di contenimento,
molti dei quali ora non si trovano più. Almeno 500 di loro, hanno perso ogni
traccia dei genitori: “Li avete strappati alle madri e ora sono soli, non sanno
dove andare“. E Biden ha caricato: “Questo è criminale“. Trump invece a sua
volta ha accusato lo sfidante di voler nazionalizzare la sanità, togliendo le
assicurazioni private a 180 milioni di americani. Trump è risultato meno
aggressivo, Biden più lucido. Ma nel finale di un confronto soprattutto
difensivo, sono tutti e due stanchi. Le dichiarazioni finali del presidente
risultano fumose: “Ho dato lavoro a tanti afroamericani, so come mettere a posto
le cose“. L’avversario si rivela soprattutto retorico: “Sarò il presidente di
tutti…” . Secondo un sondaggio a caldo della Cnn, il 53% degli spettatori pensa
che il dibattito lo abbia vinto Biden, e solo il 39% Trump. Di sicuro il
presidente è uscito da Nashville meglio che da Cleveland, ma con circa 50
milioni di americani che hanno già votato, non è facile immaginare come questo
confronto possa cambiare la dinamica delle elezioni.
DAGONEWS il 24 ottobre 2020. Chi è l’attrice che, insieme a Sacha
Baron Cohen, ha incastrato Rudy Giuliani con le mani nel sacco… ops sul pacco?
Lei è Maria Bakalova, attrice 24enne bulgara semisconosciuta, diventata già una
piccola celebrità con le anticipazioni del film “Borat” in cui interpreta la
figlia dello svalvolato protagonista. Maria Bakalova è nata a Burgas nel 1996,
ha studiato alla Bulgarian National School of Arts ed è una flautista di
formazione classica oltre che un'attrice. Ha frequentato l'Accademia Nazionale
di Teatro e Arti Cinematografiche di Sofia e si è laureata nel 2019. Ha recitato
in lungometraggi bulgari, guadagnandosi due premi per la sua interpretazione in
"Transgression" nel 2018, interpretando l'amante di un vecchio rocker e anche
come protagonista nella commedia del 2020, “Last Call”. È apparsa anche in
diversi programmi televisivi ed è comparsa anche in un episodio di "Gomorra" tre
anni fa. È una sostenitrice del movimento Black Lives Matter e, dopo il successo
certo con “Borat”, spera in una carriera a Hollywood.
Da "repubblica.it" il 24 ottobre 2020. La reputazione di Rudy
Giuliani potrebbe rischiare un duro colpo a causa del surreale personaggio
cinematografico "Borat", il famoso "reporter kazako" alla scoperta dell'America,
reso celebre dall'attore inglese Sacha Baron Cohen nel primo film, uscito nel
2006. L'ex sindaco di New York e avvocato personale di Donald Trump, aveva
denunciato in estate l'incontro in hotel con un "personaggio vestito come una
Drag Queen" che lo aveva messo in fuga, interrompendo un'intervista concessa a
una giornalista. Adesso, con la presentazione del sequel di "Borat", che uscirà
negli Stati Uniti venerdì su Amazon Prime, le riprese delle telecamere mostrano
l'altra parte della storia: Giuliani ripreso mentre si tocca le parti intime. Il
7 luglio scorso, l'avvocato di Trump aveva accettato di rilasciare un'intervista
a una ragazza, Maria Bakalova, in realtà la co-protagonista del film in cui
interpreta la figlia di Borat: l'incontro era stato fissato in un hotel di
Manhattan. Durante l'intervista, caratterizzata da toni lusinghieri e ricca di
complimenti per Trump, l'ex sindaco "le tiene le mani", "fa complimenti galanti"
e poi, invitato dalla "giornalista", finisce per seguirla in una suite, che è
attrezzata con telecamere nascoste. La ragazza finge di perdere tempo nel
liberarsi del microfono e spogliarsi, e a quel punto Giuliani si sdraia sul
letto e si infila le mani dentro i pantaloni con gesto inequivocabile. E' in
quel momento che irrompe nella stanza, nel famoso stile travolgente di "Borat",
l'attore che comincia a urlare come un pazzo "Ha 15 anni, è troppo vecchia per
te". Bakalova nel film ha 15 anni, interpreta il ruolo della figlia di Borat, ma
nella vita vera ne ha 24. Sulla rete è finito il fermo immagine della scena: si
vede l'avvocato di Trump, in completo blu, sdraiato sul letto, con la mano
sinistra infilata ad armeggiare dentro i pantaloni e la ragazza a pochi passi.
Dopo l'episodio, Giuliani aveva denunciato l'episodio alla polizia, pensando di
essere stato vittima di una trappola per essere ricattato. In realtà, non aveva
riconosciuto nella persona vestita in modo estroso, Baron Cohen, uno degli
attori cult del cinema demenziale. Adesso, dopo l'uscita del film, probabilmente
Giuliani non lo dimenticherà più. "Borat", nel corso dei suoi blitz, ha
incrociato anche il vicepresidente degli Stati Uniti, Mike Pence, ma su come sia
andata bisognerà aspettare la proiezione. Il film, che esce su Amazon Prime a
meno di due settimane dal voto, si conclude con le istruzione per votare ai
telespettatori.
Elezioni Usa 2020, Trump e le promesse non mantenute in
quattro anni d’amministrazione. Milena Gabanelli e
Francesco Tortora su dataroom de Il Corriere della Sera il 29 ottobre 2020. «Non
andrò mai in vacanza», «Sarò politicamente scorretto» e «Farò tornare grande
l’America». Era il 2016 e Donald Trump a colpi di slogan e strabilianti promesse
(Il Washington Post ne contò a fine campagna 282) conquistava l’America profonda
diventando il 45esimo presidente degli Stati Uniti. I «nemici» dichiarati: gli
immigrati irregolari, la Cina, la sinistra del detestato predecessore Barack
Obama. Quattro anni dopo, il capo di Stato più divisivo della storia Usa si
ricandida. Non è più l’outsider che contesta l’establishment, ma il
presidente-tycoon messo in ginocchio dalla pandemia (8,9 milioni gli americani
contagiati, tra cui lo stesso Trump, e oltre 228 mila i morti). Il leader della
Casa Bianca ha mantenuto gli impegni presi con gli elettori?
Immigrazione illegale. Trump aveva promesso di espellere 11
milioni di «clandestini» che vivevano da anni negli Stati Uniti, di costruire un
muro di cemento armato lungo 1.600 km al confine meridionale e farlo pagare al
100% dal Messico. Dopo un duro scontro al Congresso, nel luglio 2020 la Corte
Suprema ha dato il via libera al prelievo di 6 miliardi di dollari dal bilancio
del Pentagono e finora sono state costruite 371 miglia (quasi 600 km) di muro.
Una barriera di acciaio alta in media tra i 6 e i 9 metri, e il Messico non ha
sborsato nemmeno un centesimo. Per quel che riguarda la lotta all’immigrazione
irregolare, nel settembre 2017 l’amministrazione Trump ha abrogato il programma
Daca (Deferred Action for Childhood Arrivals) voluto da Obama a protezione degli
immigrati entrati illegalmente quando non avevano ancora compiuto 16 anni. Il 18
giugno scorso la Corte Suprema ha stabilito che non si può annullare un
provvedimento grazie al quale 700 mila persone già frequentano scuole americane
o si sono integrate nel mondo del lavoro. Trump non ha mai messo sotto
sorveglianza le moschee come dichiarato in campagna elettorale, ma nel 2017 ha
emesso due ordini esecutivi noti come «Muslim Ban», poi trasformato in «Travel
Ban», per negare l’ingresso ai cittadini di sette Paesi a maggioranza musulmana:
Somalia, Sudan, Iran, Iraq, Siria, Yemen e Libia (Sudan e Iraq sono stati
cancellati successivamente dalla lista). Nel corso del tempo il Travel Ban è
stato esteso prima a Ciad, Yemen, Corea del Nord e Venezuela e lo scorso 31
gennaio ai cittadini di Eritrea, Kirghizistan, Myanmar, Nigeria, Sudan e
Tanzania.
Ambiente. Trump ha sempre definito il riscaldamento globale «una
fantasia». Durante la campagna elettorale ha dichiarato di voler sciogliere la
«Environmental Protection Agency» (EPA), l’agenzia per la tutela ambientale. Non
ha osato farlo una volta diventato presidente, ma ha nominato amministratori
dell’EPA due noti «negazionisti»: il primo, Scott Pruitt, è stato costretto a
dimettersi nel 2018 sotto il peso di ben 15 inchieste federali. Il secondo,
Andrew R. Wheeler, è l’attuale capo dell’agenzia. Secondo i dati del «Climate
Deregulation Tracker» della Columbia University l’amministrazione Trump ha
varato 162 atti e provvedimenti per ridurre le misure contro il riscaldamento
climatico, ritenute troppo gravose per l’industria dei combustibili fossili. Tra
i provvedimenti più significativi l’abrogazione del «Clean Power Plan» (il piano
di Barack Obama per l’abbattimento delle emissioni di CO2 da parte delle
centrali elettriche a carbone), la cancellazione dei controlli sugli sversamenti
di arsenico e mercurio in acqua e il congelamento dell’obbligo per l’industria
automobilistica di produrre auto che consumano meno carburante entro il 2025 .
Nel novembre 2019 ha notificato all’Onu il ritiro degli Stati Uniti dall’accordo
di Parigi sul clima siglato nel 2015.
Politica interna. Una delle sconfitte più sonore è arrivata
dall’Obamacare. Trump aveva promesso di abrogare la riforma Obama che aumenta la
platea delle persone tutelate dal sistema sanitario (32 milioni in più). In
pratica si tratta di agevolazioni fiscali per incentivare le persone ad
assicurarsi, e del divieto per le compagnie assicurative di negare l’assistenza
ai pazienti con patologie gravi. Tra maggio e luglio del 2017 la proposta di
cancellare la norma, prima completamente e poi parzialmente, è stata respinta
dal Senato a maggioranza repubblicana.
Economia e tasse. Per rilanciare l’economia Trump aveva promesso
di tagliare le tasse alle imprese (flat tax al 15%), e niente imposte per chi
guadagna meno di 25 mila dollari l’anno. Una politica che avrebbe consentito di
«raggiungere una crescita annua del 6%, azzerando in 8 anni il debito pubblico
di 18 trilioni di dollari». Nel dicembre 2017 il Congresso ha approvato la sua
riforma fiscale: nessuna flat tax al 15% , ma l’aliquota per le imprese di tutte
le categorie e dimensioni scende in modo permanente dal 35% al 21%. Per chi
guadagna meno di 25 mila dollari restano due percentuali d’imposta: 10% sotto i
9.525 dollari e 12% sotto i 38.700 dollari. A beneficiare della riforma sono
soprattutto i ricchi: le tasse scendono dal 39,6 al 37% per chi guadagna più di
300 mila dollari. Trump ha mantenuto la promessa di donare il suo stipendio
annuale (400 mila dollari) alle agenzie governative, ma – a differenza di quanto
dichiarato – non ha mai reso pubbliche le proprie dichiarazioni dei redditi. Ci
ha pensato il New York Times, che a fine settembre ha pubblicato i documenti del
tycoon dal 2000 al 2017: Trump ha pagato appena 750 dollari di tasse federali
nei primi due anni di presidenza e zero nei 10 anni precedenti.
Il ritorno in patria delle aziende Usa. Severo critico della
globalizzazione, Trump aveva anche promesso di riportare negli Usa le aziende
manifatturiere che avevano delocalizzato all’estero. Durante il primo dibattito
tv con Biden, lo scorso 30 settembre, il presidente ha dichiarato di aver creato
«700 mila nuovi posti di lavoro nel manifatturiero». In realtà, nonostante le
norme pro-business, i risultati sono più bassi. Prima che la pandemia
falcidiasse l’economia statunitense, l’aumento effettivo dei posti di lavoro nel
comparto manifatturiero era di circa 450 mila unità. Dopo la recessione del 2020
l’occupazione manifatturiera è crollata e oggi conta 237 mila unità in meno
rispetto al 2016.
Pil e debito pubblico. La crescita economica è stata sostenuta
dal 2016 al 2019, ma non ha raggiunto le vette auspicate da Trump, fermandosi a
una media di 2,5% (2,3% nel 2017; 3% nel 2018; 2,2% nel 2019). Il crollo è
arrivato nel 2020 (a inizio ottobre disoccupazione al 7,9%). Le stime più
ottimistiche prevedono una caduta del Prodotto interno lordo del 3,7% nel 2020.
Il debito pubblico ha continuato a crescere raggiungendo a fine 2019 il record
storico di quasi 23 mila miliardi di dollari, pari al 107% del Pil americano (a
inizio 2017 era al 103,1%). Dopo il crollo economico dovuto alla pandemia, il
debito Usa ha raggiunto i 27 mila miliardi di dollari. Ma questo riguarda tutti
i Paesi del mondo (ad esclusione della Cina).
Cina. Trump aveva promesso di «sfidare apertamente il potere
economico della Cina nel mondo». Il 6 luglio 2018 sono entrati in vigore dazi
del 25% su 1.300 prodotti cinesi, per un controvalore di 50 miliardi di dollari.
Pechino ha risposto con contro-dazi equivalenti. A gennaio 2020 Usa e Cina hanno
firmato una mini-tregua che prevede un riequilibrio della bilancia commerciale
(fino ad allora nettamente a favore di Pechino). Il governo comunista si è
impegnato a ulteriori acquisti per 197 miliardi di dollari di prodotti e servizi
americani. In cambio gli Usa hanno allentato la stretta sulle importazioni
cinesi. Il deficit commerciale con la Cina è sceso dai 419,2 miliardi di dollari
del 2018 ai 345 miliardi del 2019, ma molte aziende che negli ultimi 20 anni
hanno delocalizzato in Cina hanno preferito aggirare i dazi dislocando in altri
Paesi come Vietnam e Messico. Lo scontro è anche geopolitico: Trump ha
rafforzato come promesso la presenza militare nel Mar Cinese Meridionale,
facendo pattugliare dalla flotta americana gli arcipelaghi intorno alle Paracel
e Spratly, atolli naturali e artificiali rivendicati dalla Cina e dagli alleati
degli Usa (Filippine, Vietnam, Malesia, Brunei e Indonesia). Le isole «di
Paracelso» sono state occupate dalla Cina nel 1974, ma sia Taiwan sia il Vietnam
ne reclamano la sovranità. Sulle Spratly, invece, nel 2016 una sentenza della
Corte permanente Onu di arbitrato sulla Legge del Mare ha stabilito che nel
contenzioso territoriale con le Filippine la Cina ha torto e viola il diritto
internazionale. Pechino ha risposto che «non accetta e non riconosce» alcun
valore alla sentenza. Nell’estate 2020 Washington ha inviato due portaerei nella
zona mentre i cinesi erano impegnati in esercitazioni militari. Non sono mancati
gli incontri ravvicinati tra navi da guerra.
Politica estera. Le linee guida in politica estera annunciate
riguardavano la lotta all’Isis, il ritiro dall’Afghanistan, maggiori legami con
Israele e la rottura dell’accordo sul nucleare iraniano. Tra i più importanti
successi del mandato, l’eliminazione del leader del sedicente Stato islamico Abu
Bakr al-Baghdadi, portata a termine dalle truppe americane nel raid del 27
ottobre 2019 a Barisha. La guerra contro l’Isis è stata vinta soprattutto grazie
al coraggio delle truppe curde (alleate degli Usa) e all’intervento della Russia
(alleata della Siria di Assad). Trump ha successivamente abbandonato gli alleati
curdi, lasciando campo libero al regime di Assad. Gli Usa si sono poi ritirati
dalla Siria, finita sotto la completa influenza di Iran, Turchia e Russia.
Mantenuta la promessa di lasciare l’Afghanistan: il 29 febbraio 2020 gli Stati
Uniti hanno firmato un accordo di pace con i talebani a Doha per porre fine al
più lungo conflitto della loro storia (oltre 18 anni). L’accordo prevede il
ritiro di 13 mila soldati americani entro 14 mesi. Trump ha rafforzato i
rapporti con Israele riconoscendo Gerusalemme come capitale ed è stato il
principale sponsor degli accordi di pace tra Emirati Arabi e il Paese guidato da
Benjamin Netanyahu. Ha infine stracciato l’accordo sul nucleare, faticosamente
costruito da Obama nel 2015 con l’Iran, e reintrodotto le sanzioni economiche
contro il grande nemico di Israele. Un’altra prova di forza è arrivata il 3
gennaio 2020, quando Trump ha lanciato un attacco missilistico in Iraq uccidendo
il generale iraniano Qasem Soleimani. Circostanze mai completamente chiarite e
tensione altissima con l’Iran.
Conclusioni. Il protezionismo di Trump ha portato una fase di
crescita, ma non ha permesso di raggiungere gli ambiziosi (forse impossibili)
obiettivi annunciati. La dura presa di posizione sui temi ambientali rende
difficile la lotta ai mutamenti climatici, dove è indispensabile una
cooperazione globale per la sopravvivenza del pianeta. In politica estera il
presidente è stato «di parola», ma la strategia del pugno duro contro i
principali avversari (Iran e Cina) ha esacerbato i rapporti, isolato Washington
e destabilizzato la scena mondiale. Le divisioni interne e lo scontro con le
minoranze hanno reso l’America più debole. Poi è arrivata la pandemia: la
pessima gestione ha aumentato le tensioni e le disuguaglianze.
Kennedy-Nixon, sessant’anni fa il padre di tutti i confronti Tv che cambiò la
politica.
Daniele Zaccaria su Il Dubbio l'8 ottobre 2020. Sessant’anni fa,
l’evento che ha cambiato per sempre la comunicazione politica, proiettando la
politica stessa nella modernità. «Quel figlio di puttana ci ha appena fatto
perdere le elezioni!». Cabot Lodge, candidato alla vicepresidenza per il patito
repubblicano aveva capito tutto: il primo confronto televisivo nella storia
delle presidenziali americane aveva segnato il trionfo di John Friztgerald
Kennedy e la completa disfatta per Richard Nixon. Doveva essere un autentico
orco delle favole JFK per Lodge che, otto anni prima, era stato umiliato proprio
dal giovane democratico alle senatoriali del Massachussett. E adesso aveva
malmenato anche il povero Nixon davanti quasi ottanta milioni di americani.
Accadeva esattamente sessant’anni fa ed è stato il padre di tutti i confronti
televisivi, l’evento che ha cambiato per sempre la comunicazione politica,
proiettando la politica stessa nella modernità. Oggi, nell’era dei social
dominata da slogan, meme, messaggi emozionali e tanta spazzatura ci sembra una
cosa normale, ma nel 1960 era come lo sbarco di un’astronave aliena al centro di
una metropoli, Nervoso, impacciato, la fronte imperlata di sudore, un vestito
grigio topo che si confonde con la tappezzeria dello studio, Nixon viene fatto a
pezzi dalla sfrontata scioltezza del rivale, sicuro di sé, sorridente,
abbronzato. Kennedy non ha bisogno di colpire duro e rimane nel recinto della
disputa cordiale, è sufficiente sfruttare le goffe sortite del rivale che appare
stanco, quasi malato, un pesce fuor d’acqua in quel ring elettronico che per la
prima volta avrebbe deciso la battaglia per la Casa Bianca. Dal suo entourage
provano a balbettare qualche giustificazione; aveva avuto un forte raffreddore
la sera precedente, anzi no, la settimana prima era stato in ospedale per una
ferita ad una gamba che lo aveva fiaccato. I comunicatori di Nixon non si
accorgono di scavare una fossa ancora più profonda al loro protetto che appare
alla nazione come un uomo debole, dalla salute precaria. E poiché non aveva il
carisma pazzesco di Franklin Roosevelt il popolo non era disposto a farsi
guidare da un comandante malfermo. Eppure Nixon era un uomo politico esperto e
navigato, lo chiamavano “Tricky Dick”, “Dick il furbetto, nomignolo che si
conquista con le prime spregiudicaste manovre all’interno del Gop e che si porta
appresso per tutta la carriera, fino all’inglorioso epilogo del Watergate,
Mentre Kennedy era un giovanotto di belle speranze, membro però della minoranza
cattolica in un paese protestante fino al midollo, e fino a quel giorno era
indietro nei sondaggi rispetto al l’avversario. Contro ogni previsione bucò il
piccolo schermo con la stessa forza dirompente e rivoluzionaria con cui il primo
soldato utilizzò la polvere da sparo contro le lance e le spade del nemico. La
vecchia politica viene rivoltata come un calzino; non sono più i contenuti, il
merito, la sostanza delle proposte a tenere banco ma la loro confezione,
l’empatia silenziosa che si stringe tra Kennedy e gli elettori, colpiti dalla
freschezza e dai sorrisi del candidato che guarda dritto nell’occhio della
telecamera, All’epoca non esisteva alcuno studio sull’influenza della
televisione nei comportamenti dell’elettorato, sulla necessità di “vendere” un
personaggio politico come un qualsiasi prodotto, di promuoverlo come accadeva
alle nascenti rockstar che, un fenomeno assieme all’invenzione dei “giovani”
segnò l’inizio degli anni 60. Da quel 26 settembre i sociologi e gli studiosi
delle società di massa hanno trovato un nuovo e fecondo campo di ricerca. Un
territorio vergine, occupato interamente dal corpaccione e dai lineamenti
irlandesi di JFK. Per Nixon l’esperienza è traumatica al punto che, nel 1968 e
nel 1972, quando sarà nuovamente candidato alla presidenza, rifiuta
categoricamente ogni dibattito in tv. L’ultimo duello tra Donald Trump e Joe
Biden sembra il figlio deforme di quel primo confronto, una versione distopica e
marcita della democrazia telematica, con i due sfidanti che si sono affrontati a
colpi di insulti, contumelie e continue interruzioni, quasi a scimmiottare il
bullismo che impera nei social. La prima elezione di Trump, il referendum sulla
Brexit e l’affermazione di forze politiche che utilizzano la rete come un
oggetto contundente sono tra gli effetti più tangibili di questa traformazione,
È stata scena avvilente che in qualche modo potrebbe marcare un ulteriore balzo
in avanti della comunicazione politica moderna, ormai in completa balìa dei
capricci e del livido malanimo del web. La televisione non è più la scatola
magica che può causare le fortune e le sfortune dei predatori politci, ma un
sipario stanco che rimastica malamente modelli di informazione nati su altri
media, Secondo tutti gli istituti di ricerca d’oltreoceano, oltre a disgustare
gli elettori, la rissa verbale tra il tycoon e l’ex vice di Barack Obama non ha
infatti spostato di un millimetro le loro intenzioni di voto. Oltre che ad
essere fastidioso e sgradevole, il dibattito presidenziale in diretta tv si
rivela anche un esercizio inutile.
QAnon, i complottisti in Italia contro Le Iene: “Avete usato
una comparsa di Forum”. Le Iene News il 24 ottobre
2020. Ci siamo ritrovati in una shitstorm innescata dai complottisti del QAnon,
la setta pro Trump che sta spaventando gli Usa di cui ci ha parlato Roberta Rei.
Solo che loro non sono in America, ma in Italia. Ci accusano di aver spacciato
una comparsa di Forum per una vittima di questa setta che dice di aver ricevuto
minacce davvero pesanti. “Avete spacciato una fantomatica vittima per Brianna
Wu, ma in realtà è la stessa attrice che ha partecipato a Forum”. Questo è
solo uno dei tantissimi messaggi (tra i più comici) e insulti che sono arrivati
a Le Iene e a Roberta Rei dopo il suo servizio su QAnon, la setta pro Trump che
sta spaventando gli Usa. “Taglierò il piccolo pene asiatico di tuo marito e ti
stuprerò con esso finché non sanguini”: questa è solo una delle tante minacce
che Brianna dice di aver ricevuto. Anche lei è vittima di una teoria del
complotto che si sta rapidamente trasformando in una vera e propria
allucinazione collettiva. Secondo questo assurdo “culto” esisterebbe un piano
del deep state e del nuovo ordine mondiale per spodestare dalla Casa Bianca
Donald Trump, il “guerriero Q” che lotta contro questi “poteri forti” accusati
di essere collusi con reti sataniste e di pedofili. Nel nostro servizio, Brianna
ci racconta che oltre alle parole, si sarebbe presa anche i mattoni lanciati
contro la sua casa. “QAnon non sono solo parole su un sito internet, è qualcosa
in grado di creare violenza nel mondo reale. E la decisione dell’America di non
agire sta causando instabilità in tutto il mondo”. Proprio come dice lei, i
complottisti non sono solo in America. Li abbiamo anche in Italia, tanto che
hanno innescato una shitstorm contro Le Iene. Così c’è chi è arrivato a
sostenere che la testimone intervistata altro non sia che una comparsa di Forum.
Certo, magari ai più distratti il viso squadrato che hanno le due donne
accompagnato dai capelli castani e dagli occhiali con montatura nera può aver
fatto cadere in errore. Ma scambiare Brianna per la protagonista di una storia
di Forum, poi diventata virale per il tormentone social “Tu ami le vecchie”, ce
ne passa. Soprattutto se si urla al complotto: “Questa fantomatica testimone
vittima parla in inglese mentre in realtà è doppiata”, si legge in uno dei tanti
messaggi arrivati negli ultimi giorni. “Quando il mainstream scredita un
argomento è sicuro che lo fa perché ha paura e Le Iene sono maestre in questo”,
si legge in un altro messaggio su Instagram. “Se cercate meglio trovate ancora
più prove: tipo le mail di Obama che ordina 65mila dollari di hot-dog alla Casa
Bianca, Hillary che gli risponde che se continua così li beccano oppure
che Michelle Obama è un trans”. Tutto questo viene scritto in Italia.
Complottisti del QAnon, la comparsa di Forum: “Non c'entro con
il servizio de Le Iene”. Le Iene News il 25 ottobre
2020. Laura Dotto Rosso risponde ai complottisti italiani del QAnon. Lei è una
comparsa di Forum che da qualche ora viene accusata di essere stata utilizzata
in un servizio de Le Iene sulla setta americana. Anche Laura risponde a loro
smentendo questa improbabile teoria. “Con questa storia del complottismo non
c’entro niente”. Anche Laura Dotto Rosso smentisce su Instagram i complottisti
del QAnon. Lei è la comparsa di Forum diventata famosa per il tormentone “Tu vai
con le vecchie”, ma da qualche giorno è stata presa di mira. In tantissimi ci
hanno accusato di aver intervistato lei anziché una vittima della setta pro
Trump che sta spaventando gli Usa, come ci ha raccontato Roberta Rei nel suo
servizio. “Avete spacciato una fantomatica vittima per Brianna Wu, ma in
realtà è la stessa attrice che ha partecipato a Forum”, ci ha scritto uno dei
complottisti italiani. Certo, anche Laura ha il viso squadrato, i capelli
castani e gli occhiali con montatura nera come Brianna, ma non c’entra nulla con
la vittima del QAnon. “Taglierò il piccolo pene asiatico di tuo marito e ti
stuprerò con esso finché non sanguini”: questa è solo una delle tante minacce
che Brianna dice di aver ricevuto. Lei è vittima di una teoria del complotto che
si sta rapidamente trasformando in una vera e propria allucinazione collettiva.
Secondo questo assurdo “culto” esisterebbe un piano del deep state e del nuovo
ordine mondiale per spodestare dalla Casa Bianca Donald Trump, il “guerriero Q”
che lotta contro questi “poteri forti” accusati di essere collusi con reti
sataniste e di pedofili. Nel nostro servizio, Brianna ci racconta che oltre alle
parole, si sarebbe presa anche i mattoni lanciati contro la sua casa. “QAnon non
sono solo parole su un sito internet, è qualcosa in grado di creare violenza nel
mondo reale. E la decisione dell’America di non agire sta causando instabilità
in tutto il mondo”. Qualcuno sarebbe arrivato addirittura a lanciare mattoni
contro la sua casa. Ma questo fenomeno non sta solo dall’altra parte del mondo,
è anche tra noi. “Questa fantomatica testimone vittima parla in inglese mentre
in realtà è doppiata”, ha scritto uno dei complottisti italiani. Anche la
comparsa è dovuta intervenire per smentire la loro teoria: “Sono andata a fare
una trasmissione televisiva e mi sono divertita”, dice Laura in una storia su
Instagram riferendosi a Forum. “Le Iene lavorano molto bene quindi non so che
cosa sia successo, ma non c’entro niente”.
Il nuovo ordine mondiale contro Trump? QAnon, la setta che
spaventa gli Usa. Le Iene News il 21 ottobre 2020.
QAnon non è una semplice teoria del complotto, è una vera allucinazione
collettiva che sta dilagando in parte degli Stati Uniti. Secondo i seguaci
esisterebbe una trama nascosta del deep state che mira a spodestare Donald
Trump. Roberta Rei ci porta a conoscere chi è riuscito a uscire dalla setta e
chi invece è sprofondato nella “tana del Bianconiglio”. “Sta arrivando a
prendervi, sta arrivando nel vostro Paese”. Roberta Rei, nel servizio che potete
vedere qui sopra, ci porta a conoscere una teoria del complotto che si sta
rapidamente trasformando in una vera e propria allucinazione collettiva: si
chiama QAnon ed è una setta che sta giocando un ruolo importante nella campagna
per le elezioni presidenziali di novembre. Secondo questo assurdo “culto”
esisterebbe un piano del deep state e del nuovo ordine mondiale per spodestare
dalla Casa Bianca Donald Trump, il “guerriero Q” che lotta contro questi “poteri
forti” accusati di essere collusi con reti satinaste e di pedofili. L’Fbi ha
iniziato a considerarlo una minaccia terroristica questo culto, a cui stanno
aderendo tantissime persone e che diventando sempre più estremista. Ma com’è
iniziato tutto? Con lo scandalo delle email di Hillary Clinton pubblicate da
Wikileaks alla vigilia della campagna presidenziale del 2016. Secondo alcuni
siti dell’alt right americana, in quelle conversazioni ci sarebbero dei messaggi
segreti legati al mondo della pedofilia e del satanismo: Hillary Clinton e il
suo staff avrebbero abusato, violentato e divorato bambini in una nota pizzeria
di Washington che in realtà sarebbe un ritrovo di satinasti. La nostra Iena i ci
porta a conoscere questo assurdo mondo, parlando con chi è riuscito a uscire da
questa setta e chi invece è fermamente convinto delle teorie del culto QAnon:
siete pronti a immergervi con noi nella “tana del Bianconiglio”? Guardate il
servizio di Roberta Rei in testa a questo articolo.
Qanon, i
mille volti di un complotto.
Matteo Carnieletto su Inside Over l'11 ottobre 2020. Cimitero nazionale di
Arlington, Virginia. Qui, non lontano dalle lapidi bianche che accolgono i
caduti americani, è sepolto John Fitzgerald Kennedy, il presidente americano
ucciso il 22 novembre 1963 a Dallas. Una morte ancora assediata da mille dubbi e
sospetti. Una morte sulla quale è facile – e a volte non a torto – ricamare
intrighi e complotti. È proprio da qui che dobbiamo partire per comprendere il
mistero di Qanon, una teoria del complotto americana che si sta diffondendo
anche in Europa. Non bisogna soffermarsi sul fuoco eterno che brucia sul corpo
del presidente e neppure sulla sua lapide. Bisogna sforzarsi e guardare tutto
dal cielo. Quello che per molti è un semplice cerchio che ruota attorno alla
tomba, diventa una Q per tanti. Un suggerimento per i seguaci di Qanon. E se Jfk
non fosse morto? E se, in qualche modo, c’entrasse anche lui in questa storia? E
se suo figlio, John Fitzgerald Kennedy Jr. avesse inscenato la propria morte per
esser portato in salvo e tornare, un giorno, per rifondare il vero governo degli
Stati Uniti? Follia, ne conveniamo, ma il “fenomeno Q” si sta ritagliando nuovi
ed ampi spazi, anche all’interno delle istituzioni americane. Alcuni dati:
quando, il 2 ottobre scorso, la Camera dei rappresentanti americana ha votato
per condannare questa teoria del complotto, 18 esponenti repubblicani si sono
opposti; il 56% dell’elettorato Gop, secondo i dati riportati da Forbes, crede
in Q e sono diversi i candidati repubblicani che appoggiano, più o meno
indirettamente, Q. Anche il presidente americano Donald Trump, che pure non ha
mai sostenuto tale teoria, ha più volte ritwittato stati di profili legati a Q.
Ma com’è possibile che un utente anonimo sia riuscito a influenzare così tanto
il popolo americano? Com’è possibile che una teoria così strampalata sia
riuscita ad ottenere un successo simile?
Sono tre i
motivi principali dietro il successo di Q:
Mischia
“sapientemente” il falso con il vero. Il suo è un contenitore molto ampio al
quale si possono aggiungere e togliere tasselli. Tutti coloro che aderiscono a
questa teoria possono svolgere una parte attiva. Possono, in poche parole,
diventare protagonisti, anche nel peggiore dei modi, come dimostrano alcune
aggressioni che si sono registrate negli ultimi mesi.
Q è una specie
di oracolo. Non parla mai chiaramente, lancia il sasso e poi nasconde la mano.
Anzi, sarebbe meglio dire che, quelle lasciate dall’anonimo, sono breadcrums,
briciole di pane, che dovranno poi essere messe insieme dai bakers, i
“panettieri”, ovvero i suoi seguaci, che dovranno interpretare i messaggi. Ora,
però, è arrivato il momento di entrare nella tana del coniglio bianco – altra
immagine cara a questo mondo – e vivisezionare il fenomeno Qanon. Partiamo
dall’inizio, dal 28 ottobre di tre anni fa. Su 4Chan, un utente scrive: “Hillary
Clinton sarà arrestata lunedì dalle 7:45 alle 8:30, la mattina del 30 ottobre
2017”. Nulla di più. La persona che lancia questa rivelazione, che ovviamente
non si realizzerà, si firma con una sola lettera: Q. Un riferimento a Q
clearance, il livello massimo di autorizzazione all’accesso di fonti top secret.
Questo messaggio viene visto e rilanciato da migliaia di persone. Ci si chiede
chi sia l’autore di un simile annuncio. Certamente deve essere ben inserito nel
sistema politico americano, deve conoscere quello che gli altri possono
solamente intuire. Nulla di più falso, ovviamente. Il 30 ottobre passerà come un
giorno qualunque e la Clinton non verrà arrestata. Il seme del dubbio, però, era
stato piantato e cominciava già a dare i suoi frutti. Il 3 novembre, a soli
cinque giorni dall’esordio di Q, la giornalista Tracy Beanz, come fa notare Der
Spiegel, legittima questa teoria. La rilancia e le dà spazio. Il pubblico della
reporter non è ancora enorme (ad oggi conta 120mila iscritti) ma tanto basta.
Poca favilla gran fiamma seconda, dice Dante. Basta una piccola scintilla per
creare un vasto incendio. E così fu. Del resto, Tracy era riuscita a crearsi un
suo pubblico di riferimento parlando, pochi mesi prima, dello scandalo che
diverrà noto con il nome di “Pizzagate“, un presunto giro di pedofili attivo
nella pizzeria Comet Ping Pong di Washington, che vedeva coinvolta, tra gli
altri, la candidata alla Casa Bianca Hillary Clinton. Era, quella, la punta
dell’iceberg della cabala: la setta satanista e pedofila che, secondo i
sostenitore di Qanon, governerebbe gli Stati Uniti. L’obiettivo di Trump, e il
vero motivo per cui è stato eletto, è di porre fine a questa dittatura satanica.
La teoria di Q era dunque perfetta per Beanz.
Dice e non
dice, l’anonimo. Lascia solamente intuire e questo è il suo punto forte. Walter
Kirn, che si è occupato a lungo di questa teoria, ha affermato che Q riesce ad
affascinare i suoi lettori perché offre loro indizi e non teorie: “Il pubblico
delle narrazioni su Internet non vuole leggere, vuole scrivere. Non vuole
risposte fornite, vuole cercarle”. Ed è quello che, quotidianamente, accade sui
social. Chiunque si sente legittimato a leggere e ad approfondire il pensiero di
Q. Anzi, a volte ci si spinge anche più in là, vedendo false flag ovunque. Il 2
ottobre scorso, per esempio, il presidente americano annuncia di esser positivo
al Covid. Per gli utenti che si rifanno a Qanon, però, ci troviamo di fronte a
una finzione: “In primo luogo, preghiere per il presidente Trump e Flotus
(Melania Trump, Ndr). Ti vogliamo bene. Stai bene e stai al sicuro. In secondo
luogo, ci sono tutte le possibilità che non abbiano COVI_D e questo fa parte del
Piano dell’Alleanza. Ci si aspettava che il presidente Trump ‘scomparisse’ una
volta iniziati i grandi arresti. Saranno entrambi al sicuro in ‘quarantena’. Oh,
e il loro COVI-D sarà magicamente curato da HCQ (Idrossiclorochina, Ndr),
aprendo la strada all’apertura dei paesi in tutto il mondo. Non più la malattia
‘mortale’. Potremmo assistere all’inizio dei tanto attesi ‘Dieci giorni di
buio'”.
I grandi
arresti riguarderebbero i rappresentanti dem e gli attori di Hollywood che
abuserebbero migliaia di bambini con un duplice obiettivo: ottenere da loro
l’adenocromo, una sostanza prodotta dall’ossidazione dell’adrenalina, dalla
quale si ricaverebbero droghe e sieri per ritardare l’invecchiamento. Secondo
diversi sostenitori di Qanon, sotto alcune importanti città americane, sarebbero
presenti enormi tunnel in cui sarebbero stati nascosti i minori da offrire
alla cabala. Q rappresenta la distopia perfetta perché fornisce la possibilità
di costruirsi la propria visione (distorta) del mondo. Ognuno può vedere ciò che
preferisce nei grandi stravolgimenti che stanno accadendo in America. È la nuova
teoria del complotto. Questa volta, fai da te.
Trump:
orgoglioso per non aver iniziato alcuna guerra.
Piccole Note
su Il Giornale il 2 novembre 2020. Ultimo giorno prima delle elezioni Usa.
Domani si vota, ma in alcuni Stati i voti inviati via posta potranno arrivare
anche giorni dopo, con tempistica allungata e travagliata. In attesa, da
rilevare la dichiarazione di Trump: “Sono orgoglioso di essere il primo
presidente dopo decenni a non aver iniziato nessuna nuova guerra”. Vero, egli è
riuscito a fare, nei limiti del possibile, quel che a Obama non riuscì e che
pure gli era valso un Oscar per la pace. Trump ha ereditato le guerre infinite,
trovandosi l’esercito americano impegnato in Afghanistan, Libia e Siria, oltre
che a fianco dell’Arabia Saudita nella guerra in Yemen. E di fatto ha ridotto, e
di molto, l’impegno in tali teatri di guerra.
Il disimpegno
globale. L’impegno in Libia è svaporato. In Siria ha più volte cercato di
ritirare le truppe, trovando fiera opposizione tra i falchi, che l’hanno
costretto a lasciare sul campo una forza residuale (presenza comunque nefasta,
perché suggella la sottrazione di parte del territorio siriano e di tutto il suo
petrolio). In Afghanistan, teatro di guerra meno di interesse per i falchi, è
riuscito a fare addirittura un accordo di pace con i talebani, che potrebbe
portare a un disimpegno quasi completo delle truppe. Inoltre, ha posto fine alla
guerra dei droni che contraddistinse l’era Obama nell’approccio al rebus
afghano, che ha causato uno stillicidio di vite innocenti, passato sottotraccia,
ma non per questo meno criminale. Non solo, ha tentato in tutti i modi di
concludere un accordo di pace con la Corea del Nord, con un impegno che è stato
bombardato con successo dai falchi, ma che potrebbe essere ripreso più
agevolmente di altri in caso di rielezione. Certo, c’è l’impegno in Yemen,
l’unica vera guerra proseguita durante il suo mandato, ma sul punto non poteva
far molto, stante l’irrevocabilità dei sauditi, che sperava di piegare con una
manovra aggirante, cioè con un nuovo accordo con Teheran.
Le guerre
evitate. Proprio il dossier Iran resta una macchia oscura del suo mandato,
avendo revocato l’accordo sul nucleare raggiunto da Obama e aprendo un
contenzioso ad alto rischio. Ma tale passo era chiesto a gran voce da Netanyahu,
voce che egli non poteva ignorare, in concerto con i falchi Usa. Ha tentato di
resistere, prorogando per due volte l’accordo, ma si è dovuto piegare sotto la
sferza del Russiagate. Infatti, per ottenere l’appoggio dei falchi repubblicani,
indispensabile a ottenere i voti necessari a sventare l’impeachement, ha dovuto
cedere. Detto questo, quando tali ambiti hanno cercato di spingerlo a una guerra
aperta contro Teheran, ha resistito. Dopo l’abbattimento di un drone Usa sui
cieli iraniani, sembrava impossibile fermare tale spinta, ma Trump, all’ultimo
minuto, ha negato il suo appoggio. Qualcosa di simile è accaduto dopo
l’assassinio del generale iraniano Qassem Soleimani da parte degli Usa, crimine
che Trump ha subìto più che voluto, come dimostra anche lo sforzo diplomatico
successivo, quando i suoi inviati chiesero all’Iran di dare una risposta
contenuta per evitare che a sua volta l’America fosse costretta alla guerra.
Come accadde in Siria nel 2018, dopo un asserito attacco chimico attribuito ad
Assad (ennesimo pretesto creato ad arte per forzare l’attacco Usa), quando
l’amministrazione Trump si accordò con Mosca per portare un raid simbolico e
isolato.
I
regime-change frenati. Non solo le guerre vere e proprie. Trump ha frenato le
spinte per realizzare regime-change in giro per il mondo, cosa che avvenne sotto
l’amministrazione Obama in Egitto, Tunisia e altrove. Inoltre, ha dato un freno
ai regime-change pregressi, come nel caso della conflittualità ucraina. Ed è
evidente che l’attuale spinta per un regime-change in Bielorussia è meno
efficace per la palese assenza americana, che lascia l’Europa sola a tentare di
forzare la mano. Di fatto, l’unico regime-change registrato sotto la sua guida è
stato quello boliviano, che però è stato ribaltato di recente con il ritorno al
potere del Mas di Evo Morales (e anche qui per un’evidente assenza Usa), mentre
quello venezuelano ha visto Trump porre un freno ai suoi falchi. Discorso
diverso va fatto per il conflitto israelo-palestinese, che ha visto Trump
soccombere ai desiderata di Netanyahu, né poteva essere diversamente. Possibile
che il filo del dialogo con i palestinesi sia ripristinato con Biden, ma di
certo la normalizzazione tra arabi sunniti e Israele, ormai irrevocabile, cambia
tutto, date le inevitabili ricadute sul rapporto tra israeliani e palestinesi.
Le variabili
nuove. Né va addossata all’amministrazione Trump la responsabilità dell’acceso
scontro con la Cina: in realtà egli intendeva trovare un accordo con Xi Jinping,
ma l’America, sia l’apparato militar industriale, sia l’imprenditoria e la
tecno-finanza, vuole il redde rationem. Ciò rende quasi impossibile frenare tale
spinta, destinata a proseguire con un’eventuale amministrazione Biden, che a
differenza di Trump tenterà di coinvolgere in maniera “più convincente” l’Europa
nella manovra di accerchiamento. Trump avrebbe potuto lasciare il mondo un po’
meno in disordine di quando ha preso il potere, ma la pandemia e il confronto
con la Cina hanno travolto tutto, aprendo nuove prospettive destabilizzanti. Ma
è probabile che la vittoria di Biden, anche al di là delle sue intenzioni,
ripristinerebbe il volto più aggressivo dell’Impero, con un’aggressività
accentuata dal terreno perso in questi anni. Vedremo.
DAGONEWS il 30 ottobre 2020. Se le scappatelle
di Bill Clinton e Donald Trump vi hanno appassionato, non avete idea di cosa
hanno combinato i Presidenti americani che prima di loro si sono susseguiti allo
Studio Ovale. Un viaggio negli appetiti sessuali di questi uomini viene servito
nel libro “Sex with Presidents” di Eleanor Herman. Warren Harding, presidente
degli Stati Uniti dal 1921 al 1923, si chiudeva nel guardaroba con debuttanti,
attrici, mogli, vedove, prostitute e adolescenti “per attutire il rumore” di una
trombata. Scriveva lettere volgari alle sue amanti e amava quando lo facevano
strisciare a terra, insultandolo. Thomas Jefferson, presidente dal 1801 al 1809,
ebbe relazioni con una delle sue schiave e mise al mondo una prole di razza
mista alla quale lasciò le fibbie delle scarpe, gli occhiali e un calamaio.
Aaron Burr, il suo vice presidente, era noto a Washington per “deflorare
vergini, sedurre mogli, violentare schiave e prendere tangenti”. Grover
Cleveland, presidente dal 1885 al 1889, fu un altro stupratore. Invitò Maria
Halpin - una vedova alta, giovane e carina - a cena e, non appena furono soli,
"con la forza e violenza" abusò di lei. Nella cultura brutale di quel periodo,
la resistenza della donna era considerato un "vivace preliminare". La gravidanza
era solo "un segno sicuro che aveva apprezzato il sesso". Il bambino nato dalla
violenza venne messo in un orfanotrofio. Maria iniziò a bere e alla fine venne
rinchiusa in matrimonio contro la sua volontà. Con somma ipocrisia, Cleveland
andava in giro a parlare di “onestà e responsabilità”. I suoi sostenitori, che
sapevano di Maria, definirono la donna una “prostituta ubriaca”. Lei morì nel
1902, all'età di 62 anni, di polmonite. Il figlio divenne un medico e morì nel
1947. Woodrow Wilson, presidente dal 1913 al 1921, era un altro a cui piaceva la
compagnia delle donne "argute e vivaci". Peccato che la moglie fosse interessata
solo ad aiutare i poveri. Wilson preferiva Edith, la sua amante: «Andavano in
campagna, parcheggiavano e chiudevano le tende dei finestrini dell’auto». La
polio non ha frenato le attività di Franklin D. Roosevelt. Ha avuto una lunga
storia d'amore con Lucy Mercer e la sua giustificazione era che sua moglie
Eleanor "non amava il sesso". Almeno fino a quando Lorena Hickok non le fece
capire che le piacevano le donne. Per inciso, questo è non l'unico esempio di
relazioni omosessuali nel libro: James Buchanan, il presidente responsabile
della guerra civile nel 1861, "ebbe una relazione di 13 anni con un uomo". La
seconda guerra mondiale ha certamente avuto un impatto su Dwight Eisenhower. Si
innamorò della sua autista, Kay Summersby, ma fu ostacolato dalla sua
"disfunzione erettile legata all'età". John F. Kennedy è sempre considerato un
donnaiolo che affermava di avere l'emicrania se non dormiva ogni giorno con una
ragazza fresca. Con JFK, nessuna donna era al sicuro, "non tua moglie, tua madre
o tua sorella". Le prostitute dovevano essere sempre a disposizione per tirarlo
su prima delle apparizioni pubbliche. Eppure Kennedy era affetto da clamidia ed
eiaculazione precoce. Marilyn Monroe raccontò: «Un minuto ed è già fuori.
Brutale e superficiale a letto». Angie Dickinson, tuttavia, lo ricordò come «i
migliori 60 secondi della mia vita». Con Marlene Dietrich durò il lusso di sei
minuti: «Ho guardato il mio orologio…» Lyndon B. Johnson era un uomo volgare
che, urinando sotto gli occhi di un legislatore, disse: «Hai mai visto qualcosa
di così grande?». Johnson apprezzava le belle donne: «Non sopporto di vedere in
giro una donna brutta o grassa». I registri mostrano molti lunghi incontri nello
Studio Ovale con le donne. I servizi segreti avevano installato un cicalino per
avvertire Johnson dell'arrivo di sua moglie, dandogli il tempo di tirarsi su i
pantaloni. Gerald Ford, Jimmy Carter, Ronald Reagan, la dinastia Bush e Barack
Obama non sono menzionati nel libro di Herman, anche se di Richard Nixon si dice
abbia avuto un'avventura, nel 1966, con una cameriera di Hong Kong «che l'FBI
credeva fosse una spia dei cinesi». Di Bill Clinton e della relazione con Monica
Lewinsky si sa praticamente tutto mentre per quanto riguarda Donald Trump, a
parte "due minuti di pessimo sesso" con una pornostar chiamata Stormy Daniels
alla quale sono stati dati 130.000 dollari per tacere, le prove delle sue
scappatelle sono scarse.
LA
BUONUSCITA DI JACKIE.
DAGONEWS il 20 marzo 2020. Il contratto del 1975 firmato da Jackie Kennedy e da
Christina, figlia di Aristotele Onassis, sarà messo all’asta il prossimo 26
marzo alla International Autograph Auctions Europe, di Malaga, in Spagna.
Nell’accordo Jackie lasciava nelle mani della figliastra la fortuna del marito
di 500 milioni di dollari, accettando di ricevere poco più di 20 milioni.
L'accordo di 23 pagine, che dovrebbe essere battuto all’asta per 22mila dollari,
è stato firmato dall'unica figlia in vita del magnate e dalla seconda moglie,
Jackie, il 7 maggio del1975. Onassis è morto all'età di 69 anni nel marzo del
1975, due anni prima il figlio Alexander era rimasto ucciso in un incidente
aereo. La sua prima moglie Tina è morta per sospetta overdose nel 1974. Jackie
e Christina, indicate rispettivamente come "moglie" e "figlia" nell'accordo,
hanno sottoscritto l’accordo in cui si legge: «A titolo di compromesso e di
regolamento e su base forfettaria, la figlia, in quanto rappresentante della
proprietà del padre, paga alla moglie del padre la somma di $ 20.500.000. Nei
confronti della figlia, la moglie rinuncia a ogni pretesa, diritto, titolo e
interesse a ricevere o ereditare qualsiasi parte del patrimonio. Sebbene lei
(Jackie) sappia che suo marito era un uomo molto ricco, è soddisfatta delle
disposizioni e non desidera rivendicare nulla». Prima di morire Onassis aveva
lasciato alla moglie 2 milioni in obbligazioni.
Paolo
Valentino per corriere.it l'11 marzo 2020. Che John Fitzgerald Kennedy avesse un
incontenibile appetito sessuale è cosa risaputa. La vulgata vuole che non gli
bastassero tre donne in una sola notte. Al premier britannico Harold Macmillan
confessò una volta che gli venivano «fortissime emicranie quando non faceva
sesso per tre giorni di seguito».
Le
«confessioni». La lista delle conquiste e delle avventure extraconiugali del
presidente americano è affollata e, diciamo così, socialmente trasversale:
celebri attrici e stagiste, donne dell’alta società, segretarie e pupe del
gangster, escort e perfino una militante del Partito comunista della Ddr. Ma fa
un certo effetto che sia lo stesso Kennedy a darne conferma postuma. Un
centinaio di pagine di appunti personali dell’allora senatore del Massachusetts,
scritti a mano tra l’aprile e l’ottobre del 1960 durante la campagna
presidenziale che lo avrebbe portato alla Casa Bianca, andranno all’asta in
aprile alla Heritage Auctions di Dallas, la stessa città del Texas dove venne
assassinato il 22 novembre 1963. Non che il diario riveli nomi di amanti o
amiche di una notte, in questo JFK rimane vecchio stile.
Sesso (o)
potere? Scritte a causa di una fastidiosa laringite, che aveva spinto i medici a
ordinargli il silenzio durante i viaggi per risparmiare la voce, le note aprono
una straordinaria finestra sulla personalità e la vita di JFK, spaziando dalla
strategia politica alle idee per i discorsi, dal suo rapporto con la stampa alle
opinioni sugli avversari politici. E soprattutto contengono ammissioni senza
filtri sulle sue fregole: «Penso che se vinco, i miei giorni col sesso siano
finiti». La sua paura, poi rivelatasi del tutto infondata, era che i media lo
avrebbero messo sottopressione per le sue frequenti e regolari scappatelle:
«Prima che questa campagna sia finita, mi colpiranno con qualcosa».
«Matto per le
bionde». Sul retro dello stesso foglio, lui che aveva sposato la bruna
Jacqueline, il futuro presidente annota: «Vado matto per le bionde». In realtà
l’attività predatoria di Kennedy non si fermò sulla soglia dello Studio Ovale.
Anzi, la presidenza probabilmente moltiplicò le sue avventure sessuali. Di
tutto, di più: Pamela Turnure, l’addetta stampa di sua moglie; Judith Campbell
Essner, la pupa del boss della mafia di Chicago Sam Giancana, che gli era stata
presentata da Frank Sinatra; l’intellettuale americana di origine tedesca Ellen
Rometsch, che aveva fatto parte della Sed, il Partito comunista della Germania
Est; Mimi Beardsley, una Monica Lewinsky ante litteram, stagista diciannovenne
alla Casa Bianca; Mary Meyer, la cognata di Ben Bradlee, allora giornalista
politico a Newsweek e futuro direttore del Washington Post durante lo scandalo
Watergate; Priscilla Ware e Jill Cowen, due segretarie della West Wing
conosciute come Fiddle e Faddle, che sembra non sapessero neppure scrivere a
macchina. Su tutte, la bionda delle bionde, la grandissima Marylin Monroe, di
cui rimase immortale la performance del 19 maggio 1962, quando al Madison Square
Garden di New York fece gli auguri al presidente inguainata in un vestito color
carne che le era stato letteralmente cucito addosso, cantando una sensualissima
e allusiva versione di «Happy Birthday to You». A quanto pare il presidente e
l’attrice avevano fatto l’amore poco prima. Secondo un libro uscito nel 2018,
tuttavia, Kennedy non riuscì a sedurre Sophia Loren, di cui era invaghito ma
dalla quale ricevette ben due rifiuti.
Il «rimedio»
alla laringite. Non è chiaro come le note siano giunte all’incanto. A
raccoglierle e custodirle in prima battuta era stata Janet De Rosiers, a lungo
assistente personale di JFK e anche lei sua amante. Fu lei, dopo l’ordine dei
medici di non parlare per curare la laringite, ad avere l’idea di dare al
senatore dei blocchi per appunti gialli, perché rispondesse per iscritto alle
domande durante i voli. Ma Kennedy cominciò a utilizzarli anche per mettere giù
impressioni e pensieri. Del suo rivale nelle primarie, Hubert Humphrey, JFK
dice: «Sarà molto duro con noi e dobbiamo prepararci. Non dobbiamo dire che non
può vincere, ma che non può essere nominato». E di un giornalista del quale non
fa il nome, scrive: «È un bastardo figlio di puttana». Certi pensieri dei
politici non cambiano mai.
"Ecco
perché andai con la Lewinsky".
Le rivelazioni di Bill Clinton sull’affare-Lewinsky fanno parte di un
documentario sulla vita della moglie Hillary, in uscita oggi negli Usa. Gerry
Freda, Venerdì 06/03/2020 su Il Giornale. Bill Clinton ha ultimamente rilasciato
delle dichiarazioni sui motivi che lo indussero a consumare rapporti sessuali
con Monica Lewinsky. Tale confessione dell’ex presidente Usa è stata fornita
nell’ambito di un documentario sulla vita della moglie Hillary, in onda oggi sul
servizio di video in streaming Hulu. La pellicola in questione, intitolata
semplicemente Hillary e diretta dalla regista Nanette Burstein, mette in
sequenza spezzoni di ben 35 ore di interviste concesse alla prima dalla stessa
ex first lady e da molti collaboratori dell’esponente democratica. Il racconto
della vita della Clinton parte dai suoi anni di scuola fino alla sconfitta
contro Trump nel 2016. Tra le testimonianze che compongono il documentario vi è
appunto, sottolinea il Daily Mail, anche quella di Bill, in cui quest’ultimo
mette a nudo le pulsioni che lo indussero, dal novembre del 1995, a intrattenere
rapporti intimi con la Lewinsky. L’allora inquilino della Casa Bianca, riporta
il giornale britannico citando le parole di Clinton contenute nella pellicola in
questione, avrebbe deciso di fare sesso con la stagista per "sentirsi
meno stressato dal proprio lavoro" e per trascorrere un po' di tempo "senza
pensieri per la testa". A detta dell’ex capo di Stato, la scappatella con la
giovane donna era infatti un’occasione per rilassarsi e per non sentire
momentaneamente il peso delle responsabilità di uomo più potente del mondo.
Sempre nelle dichiarazioni citate dalla testata londinese, Clinton giustifica la
sua condotta precisando che, nell’anno in cui tradiva la moglie, egli sarebbe
stato talmente stressato a causa della pressione derivante dall’essere il
presidente Usa da sentirsi “come un pugile che ha appena combattuto in trenta
round”. Di conseguenza, avere rapporti intimi con la giovane Monica gli
consentiva di “staccare la spina” per qualche minuto dal lavoro di
commander-in-chief. L’ex capo di Stato dichiara poi che, negli attimi in cui era
solo con la stagista, non rifletteva affatto sulle conseguenze che la condotta
sessuale incriminata avrebbero prodotto sulla sua serenità familiare e sulla sua
immagine pubblica, ma pensava soltanto a “distrarsi”. Clinton, nella propria
testimonianza commentata dal Daily Mail, prosegue giurando di sentirsi
“devastato” nel pensare che la vita della Lewinsky sia ormai segnata per sempre
da quello scandalo a luci rosse esploso più di venti anni fa. Nel medesimo
documentario analizzato dal quotidiano d’Oltremanica, l’ex presidente passa
quindi a descrivere i penosi attimi in cui confessò a Hillary di averla tradita,
affermando che, dopo tale scabrosa rivelazione, gli allora coniugi presidenziali
decisero di sottoporsi a delle “dolorose” sedute di terapia di coppia. Oltre al
franco confronto con la moglie e all’ammissione di essere un marito infedele,
un’altra straziante situazione che Bill si trovò a vivere per colpa della
propria condotta sessuale, racconta lo stesso esponente dem nel documentario, fu
quella in cui egli confessò la scappatella con la Lewinsky alla figlia Chelsea
Clinton, che al tempo dei fatti aveva diciotto anni. Malgrado la gravità dello
scandalo che lui aveva fatto piovere sulla sua famiglia, Bill, sempre nella
pellicola in questione, assicura che sia Hillary sia la figlia, dopo una
comprensibile esplosione iniziale di rabbia e di delusione nonché dopo un breve
ritiro di riflessione sull’isola di Martha's Vineyard, si strinsero allora al
suo fianco e presero a sostenerlo con forza durante il tentato impeachment del
1998 contro di lui. L’ex first lady, conclude il Daily Mail, avrebbe autorizzato
la realizzazione di tale documentario pieno di rivelazioni esplosive da parte di
Bill in quanto lei, quest’anno, non sarebbe in corsa per alcun incarico pubblico
negli Usa.
Così inchiodano Clinton: "C'era pure lui nella villa delle
orge di Epstein". Clinton sarebbe stato avvistato una
volta mentre si rilassava in compagnia di Epstein nei pressi del portico della
villa del magnate-pedofilo. Gerry Freda, Mercoledì 27/05/2020 su Il Giornale.
Una recente rivelazione ha smentito quanto aveva affermato finora Bill
Clinton in merito alle sue frequentazioni della “villa delle orge” di Jeffrey
Epstein, magnate della finanza americano suicidatosi in carcere nell’agosto
dell’anno scorso e su cui pendevano gravi accuse di abusi sessuali su minori.
L’ex presidente Usa aveva reiteratamente negato di avere mai messo piede nella
famigerata residenza privata del finanziere, ammettendo esclusivamente di avere
viaggiato per quattro volte con il chiacchierato imprenditore a bordo dell’aereo
personale di quest’ultimo, il Lolita Express. Una testimonianza rilanciata in
questi giorni dai media Usa, tuttavia, lo contraddice platealmente riguardo alla
sua presenza nella residenza-postribolo del milionario-pedofilo. Le frasi-choc
in questione sono state rilasciate da Steve Scully, settantenne ex dipendente di
Epstein. Il testimone in questione, riferisce l’Ansa, ha affidato il suo
racconto ai creatori di una miniserie Netflix che sarà mandata in onda oggi
negli Stati Uniti, intitolata Jeffrey Epstein - Soldi, potere e perversione. A
detta di Scully, l’ex presidente democratico frequentò effettivamente Epstein
anche nella tristemente famosa villa del magnate-pedofilo, situata sull’isola
caraibica di Little St James, ubicata nell’arcipelago delle Isole Vergini
americane ma proprietà privata del milionario-orco. Tale residenza, ricostruisce
l’agenzia di stampa, era un “notorio luogo di orge”. Il settantenne, già
responsabile delle linee telefoniche e dei collegamenti Internet sull’atollo
incriminato, ha dichiarato, nell’intervista Netflix citata dalla versione Usa
del Sun, di avere avvistato una volta Clinton mentre si rilassava in compagnia
di Epstein nei pressi del portico d’ingresso della residenza caraibica. Lo
stesso testimone ha poi precisato che, durante la visita dell’esponente liberal
presso la villa del magnate, non vi erano altri ospiti sull’isola. Oltre all’ex
inquilino della Casa Bianca, ha aggiunto il settantenne, tanti altri personaggi
importanti hanno fatto capolino in questi anni nel buen retiro del
milionario-pedofilo e, sempre Scully, ha poi denunciato il fatto di avere scorto
lì, a dimostrazione dei festini osceni organizzati dal finanziere, un ospite
anonimo di quest’ultimo girovagare per Little St James “completamente nudo” e
attorniato da “tre ragazze in topless”. Il Sun ci ha tenuto però subito a
sottolineare che dal racconto del settantenne in merito alla capatina di Clinton
nella villa del milionario non sarebbero finora emersi dettagli tali da indurre
a sospettare l’ex leader dem di avere commesso su quell’isola atti osceni o
penalmente rilevanti. In realtà, ricorda l’organo di stampa Usa, la presenza di
Bill a Little St James era stata già evidenziata all’interno degli incartamenti
processuali presentati ai magistrati americani, giusto poche ore prima del
suicidio di Epstein in un carcere newyorchese, da Virginia Gueffre.
Quest’ultima, oggi trentacinquenne, aveva intentato l’anno scorso una causa
contro il finanziere affermando di essere stata una sua “schiava del sesso”. In
un passaggio della citazione avanzata dalla ragazza, rimarca il Sun, si fa
infatti riferimento proprio alla presenza di Clinton sull’atollo privato di
Epstein, ossia, per la precisione, a una cena organizzata presso la famigerata
villa, a cui avrebbero partecipato l’esponente progressista, il padrone di casa,
la Gueffre, l’ex amante del magnate e altre due donne. Al termine di tale cena,
il politico dem si sarebbe ritirato nella sua stanza da letto “accompagnato a
braccetto” da quelle due bellissime commensali non meglio identificate. La
recente testimonianza di Scully e l’imminente messa in onda della miniserie
Netflix hanno subito spinto lo staff dall’ex presidente a rigettare come
infondate le affermazioni in procinto di essere rilanciate dalla piattaforma
digitale americana. Angel Urena, portavoce dell’ex commander-in-chief, ha
rilasciato, riguardo alle parole dell’ex dipendente di Epstein, le seguenti dure
frasi, riportate dal New York Post: “Quell’affermazione era una bugia la prima
volta che è stata detta e resta anche oggi una bugia. Non servirà ripeterla
all’infinito per farla diventare vera”.
Monica Monnis per "elle.com" il 6 marzo 2020. Quest'anno saranno
22 gli anni trascorsi da quella conferenza stampa in cui Bill Clinton ammetteva
di aver avuto una relazione extra coniugale con la sua stagista, segnando per
sempre il suo destino (lontano dalla Casa Bianca), ma il Monica Lewinsky
affaire continua a incuriosire e a tenere banco sul fronte mainstream, forse
perché la sensazione comune è che non sia ancora stata detta tutta la verità. E
così, del nuovo documentario trasmesso da Hulu incentrato sulla vita di Hillary
Clinton, ecco che le parti più salienti riportate dai media riguardano
proprio quell'impeachment che nel 1998 scosse l'America intera e non solo. Dal
perché del tradimento alle bugie alla moglie, passando per la "dolorosa" terapia
di coppia e la difficoltà nel dover raccontare tutto alla figlia Chelsea, Bill
Clinton oggi parla per la prima volta del sexgate (abbozzando tra l'altro una
"mezza scusa" per la Lewinsky). "Non ha mai sentito parlare del Prozac?",
esordisce così (tranchant) il New York Post in risposta alle dichiarazioni di
Clinton, oggi 73 anni, fatte nel documentario Hillary sulla sua relazione durata
due anni (dal 1995 al 1997 ndr) con l'allora stagista 22enne della Casa
Bianca, Monica Lewinsky. Perché l'ex Presidente degli Stati Uniti, ammette in
favor di camera di aver ceduto alla tentazione "per gestire la sua ansia" in un
periodo della sua vita pieno di "pressioni, delusioni, inquietudine e paura di
qualunque cosa". Paragonandosi a un pugile sul ring, poi, definisce la liaison
qualcosa in grado di farlo "distrarre per un po'" in un momento particolarmente
stressante della sua esistenza. Nel doc diretto da Nanette Burstein, che sarà
diviso in quattro episodi, anche Hillary torna indietro nel tempo e ricorda come
il marito abbia inizialmente negato il tradimento ("Mi ha detto: 'Non c'è niente
di vero. Forse sono stato troppo gentile con lei, forse le ho prestato troppa
attenzione, ma non c'è stato niente', era così irremovibile che mi ha convinto",
ammette) e di come lei lo abbia sostenuto fino a prova contraria. Poi un giorno,
quando il vaso di Pandora stava per essere scoperchiato, è arrivata
l'ammissione. "Sono andato a sedermi sul letto e le ho parlato. Le ho detto
esattamente cosa è successo e quando è successo", spiega sempre Bill, "le ho
detto che mi sentivo male per quello che avevo fatto, che era ingiustificabile e
non avevo scuse". Hillary confessa di essersi sentita "ferita e devastata", idem
la figlia Chelsea particolarmente scossa dall'intera vicenda ("Certamente ciò
che ho fatto è stato sbagliato. Odiavo solo l'idea di farle del male ma tutti
noi a volte facciamo cose che non dovremmo fare", le parole precise di papà
Bill). Grazie alla terapia di coppia e tanta buona volontà, la famiglia è
riuscita a rimanere unita. "Non avrebbe dovuto fare quello che ha fatto, non
avrebbe dovuto cercare di nasconderlo, ma non si è trattato di un reato
invalicabile", afferma Hillary in difesa del marito. E poi il colpo di scena. Mr
Clinton, che afferma di essere oggi "una persona completamente diversa", si
scusa parzialmente con la Lewinsky per quello che dal sexgate in poi ha dovuto
sopportare (da 22 anni a questa parte, Monica continua a essere dipinta dalla
stampa e dalla opinione pubblica come arrivista, sfasciafamiglie, arrampicatrice
sociale etc). "Mi dispiace per il fatto che la vita di Monica Lewinsky sia stata
definita dalla nostra relazione, penso che sia ingiusto, nel corso degli anni
l'ho vista tentare di avere di nuovo una vita normale", ha spiegato l'ex
inquilino della Casa Bianca nel suo primo mea culpa pubblico. Scuse che la
Lewinsky, 46 anni, aspetta da sempre. Perché per lei, quella "relazione fisica
impropria" (come definita dallo stesso Clinton nel corso della sua testimonianza
di fronte al Grand jury il 17 agosto 1998 ndr) è stata un "abuso di potere" da
parte di un superiore con 27 anni in più. In più di un'occasione, Monica ha
dichiarato di aspettarsi delle scuse dall'ex Presidente, che lo avrebbero reso
"un uomo migliore, e noi, a sua volta, una società migliore". The (happy) end?
Usa, dopo 200 anni il linciaggio diventa reato federale.
Il Dubbio il 28 febbraio 2020.Il Congresso approva una
legge che lo equipara ai crimini d’odio. Fino ad oggi era competenza dei
tribunali locali. E il 99% degli omicidi è rimasto senza autore. Tra il 1882 e
il 1968 circa 5mila afroamericani sono stati linciati negli Stati Uniti, tutti
negli stati del sud, Alabama, Sud e Nord Carolina, Texas, Arkansas, Georgia,
Louisiana, Mississippi. Il 99% di quei crimini odiosi è rimasto senza autore e
nella gran parte dei casi non è stata aperta neanche un’ inchiesta giudiziaria.
Questo perché fino ad oggi il linciaggio non era riconosciuto come un reato
federale, se ne sono sempre occupati i tribunali locali, e per più di un secolo
tutti i tentativi per cambiare la giurisprudenza si sono arenati. Inizialmente
per l’opposizione delle frange più reazionarie della classe politica americana e
poi perché i casi di linciaggio sono gradualmente spariti dalle cronache. Magari
sostituiti dal terrorismo suprematista che, fortunatamente, non gode della
stessa impunità de razzisti dantan negli stati meridionali. Ora il Congresso ha
approvato l’Emmett Till Antilynching Act, presentato dai democratici Bobby Rush,
Khamala Harris e Cory Booker che equipara il linciaggio ai “crimini d’odio”. La
legge prende il nome da Emmett Till, un ragazzino nero brutalmente torturato e
ucciso nel 1955, quando aveva 14 anni, dopo che una donna bianca lo accusò di
averla afferrata e fischiata in un negozio di alimentari nel Mississippi. Manca
soltanto la ratifica del presidente Trump, ma non dovrebbero esserci problemi.
Impegnato in campagna elettorale, il tycoon non ha alcun bisogno di inimicarsi
ulteriormente l’elettorato afro-americano. “Non si tratta solo di un atto
simbolico Oggi ci avvicina di un passo alla riconciliazione di un capitolo
oscuro nella storia della nostra nazione”, ha dichiarato Booke.
Paperino?
Incarna l'anima reazionaria degli Stati Uniti.
Un saggio del barese Alessandro Barbera "rilegge" Walt Disney e il suo mondo a
fumetti. Michele De Feudis il 21 Febbraio 2020 su La Gazzetta del Mezzogiorno.
Si può indagare e approfondire il mondo del fumetto secondo categorie legate
alla politica, o meglio alla metapolitica? Su questa rotta si muovono gli
scritti di filosofi come Giulio Giorello, di giornalisti come Mariuccia Ciotta
(il manifesto), Giuseppe Pollicelli (La Lettura) e Luciano Lanna (Secolo
d’Italia). Spesso i media hanno indugiato nel posizionare in un immaginario
parlamento le icone più pop del mondo delle nuvolette: qui si colloca il saggio
dello studioso barese Alessandro Barbera con il volume Paperino reazionario
(edito da l’Arco e la corte, pp. 157, euro 15) che ha come sottotitolo
esplicativo Nuove note sull’ideologia di Walt Disney. Il risultato è una
radiografia sorprendente delle visioni sul creatore americano espresse negli
anni da Ejzenstein, Dalì, Benjamin e Adorno (che considerava l’inventore di
Mickey Mouse «l’uomo più pericoloso d’America»). Barbera, già autore del cult
Camerata Topolino per Stampa Alternativa (2001), considera - andando contro un
certo conformismo - i fumetti letteratura non minore, e le opere disneyane una
delle massime espressione di arte, nonostante le ritrosie ben spiegate dallo
scrittore Roberto Alfatti Appetiti in I fumetti che hanno fatto l’Italia: «I
fumetti sono stati sdoganati (…). Mal tollerati, in ogni caso. Facciamocene una
ragione: per i sacerdoti della cultura ufficiale resteranno macchie d’inchiostro
destinate a fermarsi nella trafficata anticamera della narrativa». Il ritratto
di Disney che traccia Barbera inquadra il disegnatore di Chicago come «un
conservatore-rivoluzionario con uno specifico interesse per la magia»,
riconducendo le sue fascinazioni e suggestioni - sia nel fumetto che nella
cinematografia - ad una declinazione «dei valori tradizionali», usando in
maniera artistica miti e fiabe, spesso considerati inutili astrazioni nella
società del consumo. «La cosa rilevante - aggiunge Barbera - è che Disney
ripropose mito e fiaba attraverso mezzi di comunicazione all’avanguardia,
facendone gli strumenti di una nuova pedagogia». Incasellare Disney o le sue
creazioni come Topolino o Paperino spinge Barbera a perimetrare la sua
speculazione: «Walt Disney - chiarisce - non ha mai nutrito l’idea di lanciare
messaggi politici nelle sue creazioni, a prescindere da quelle che potevano
essere le sue concrete simpatie o avversioni. Tuttavia egli ha espresso
spontaneamente da artista, nel complesso di tutta la sua produzione, una
articolata visione del mondo che non può in alcun modo giustificarne una
collocazione “rivoluzionaria”, nel senso ideologico del termine. Il suo
conservatorismo era certamente di qualità diversa da quello prevalente in
America, ieri come oggi. Ma è proprio questa volontà di stare fuori agli schemi
unita alla capacità di toccare tutte le sensibilità ciò che ha reso la sua opera
suggestiva e convincente». Ampio spazio è dedicato anche ai rapporti tra Disney
e Mussolini. La relazione è costruita sui documenti risalenti alla pubblicistica
del tempo, nonché alle testimonianze della moglie Rachele e del figlio Romano:
nel 1935 Disney, durante un viaggio in Italia, incontrò ben due volte il leader
fascista, da sempre appassionato dei suoi fumetti e dei suoi film. Infine c’è un
interessante focus su Paperino, definito, in antitesi a chi ne tratteggiava
un’anima illuminista, «un soggetto che non si adatta alla modernità nelle sue
varie espressioni. Insomma, sembra piuttosto un reazionario, un ribelle: lui non
“feticizza” l’esistente, lo avversa».
·
Quei razzisti come
gli Australiani.
Australia, il Paese che sa chiedere scusa.
Nel 1998 è stato istituito il “Sorry Day”: il giorno in cui tutta
la nazione chiede scusa ai nativi per i maltrattamenti subiti. Cleto Corposanto
il 6 settembre 2020 su Il Quotidiano del Sud. Mi ha sempre affascinato, da
bambino, questa idea che – essendo la terra tonda, all’incirca – bucando
ipoteticamente sotto i nostri piedi e attraversandola per intero in un
immaginario tunnel, si potesse sbucare dall’altra parte del mondo. “E dove ci
troveremmo?” chiedevo estasiato. “In Australia” era la risposta più frequente.
Ho poi scoperto che forse in realtà sarebbe più appropriato pensare alla Nuova
Zelanda come territorio “dall’altra parte” (che comunque si trova in zona,
all’incirca), ma insomma alla fine stiamo parlando di un grande, lontanissimo
continente. Di quello che viene solitamente identificato come il nuovissimo
mondo. Grande perché, per il solito problema della distorsione delle cartine
geografiche dovute alla necessità di rendere piana una superficie sferica, la
nostra idea di Australia non rende conto dell’effettiva larghezza di questa
isola/continente. Ci aiuta a coglierne la grandezza reale, forse, valutare che
un aereo impiega, per esempio, circa 3 ore e mezza per andare da Roma a Mosca,
ma ce ne vogliono 4 e mezza per andare da Perth, sulla costa ovest, a Sydney su
quella est. Sempre in Australia. Con quasi 7 milioni e mezzo di chilometri
quadrati (in gran parte desertici), l’Australia è il sesto Paese più esteso al
mondo, ma ospita solo poco più di 25 milioni di abitanti, quasi tutti sulle
coste (in particolare quella est). Abitata dai nativi (che si chiamano anche
aborigeni, anche se è un termine che a loro non piace perché velatamente
dispregiativo) per più di 40 mila anni, l’Australia è stata colonizzata dal
Regno Unito a partire dal XVIII secolo; lo stesso nome attuale è dovuto alla
colonizzazione dopo la pubblicazione nel 1814 a Londra del libro “A voyage
around Terra Australis” dell’esploratore Matthew Flinders. I britannici, a
differenza di olandesi e portoghesi che avevano avvistato e visitato la grande
isola per primi, rinunciando alla sua colonizzazione in quanto priva di
territorio valutato interessante, approvarono invece nel 1786 la costruzione di
una colonia penale a Botany Bay, nella meravigliosa baia di Sydney, destinata a
ergastolani e gente ritenuta comunque pericolosa per la società. E da “Terra
Australis Incognita” (“terra australe sconosciuta”, ndr), continente la cui
presenza era stata ipotizzata già da Greci e Romani, nel 1824 il nome fu
semplificato in Australia. Nonostante avessi viaggiato già molto, non ero mai
stato nell’emisfero australe quando mi arrivò la notizia della conferma
dell’invito al Convegno mondiale di Sociologia di Brisbane. Un evento, insomma,
e finalmente l’opportunità di un viaggio lungo, veramente lungo, che mi avrebbe
portato dall’altra parte del mondo, senza passare per il tunnel immaginario dal
centro della terra su cui avevo fantasticato da bambino. In un afoso pomeriggio
di luglio, è un mercoledì, ci imbarchiamo dall’aeroporto di Verona con
destinazione Roma: dalla capitale, un volo della Quantas, la compagnia di
bandiera, ci avrebbe portati a Sydney. Per lo più nella mia vita i grandi viaggi
li ho fatti in solitaria: questa volta sono con A.S., amico e collega, pure lui
diretto al convegno. Mercoledì sera ci imbarchiamo quindi su un volo Quantas,
destinazione Singapore. Un volo di circa 11 ore che ci catapulta nel bel mezzo
di una notte (quale?) al trafficatissimo scalo asiatico. Abbiamo 3/4 ore di
sosta, e allora una birra e un paio di sigarette nello strepitoso “cactus
garden”, un meraviglioso giardino all’aperto. Sono circa le 3 di mattina e ci
saranno circa 35 gradi umidi. Rientrare a bordo dell’aereo è un toccasana; altro
strappo di circa 12 ore e ci troviamo nella meravigliosa Sydney; è venerdì
mattina in Australia, sono all’incirca le 7. Siamo partiti mercoledì
pomeriggio…. Sydney è una delle città più belle del mondo; il suo inconfondibile
skyline con l’Opera House è una meravigliosa cartolina. Al tramonto, tutto si
colora di una luce oro che non ho mai più rivisto da nessuna parte. La sera ci
concediamo la prima cena australiana, e scegliamo un bel posto sulla baia: si
mangia pesce, e la scritta BYO ci appare – ahinoi! – di buon auspicio. Ne
comprendiamo appieno il significato quando, con un piatto a base di pesce,
chiediamo del vino. In Australia le licenze per vendere alcol sono molto
costose, e quindi molti ristoranti e supermercati non lo vendono. BYO, impariamo
così nella nostra prima lezione australiana, sta per “Bring Your Own”, ovvero…
“portati da bere”. Si risolve subito, comunque; accanto al ristorante, un
negozio di alcolici provvede a vendere vino e altro. Si acquista, si entra, e la
bottiglia di vino te la aprono a tavola. Due o tre giorni dopo, siamo in
partenza per Brisbane, sempre sull’affollata (si fa per dire…) costa est
australiana. Lì si tiene il convegno mondiale di Sociologia, nel quale incontro
Alberto Izzo (uno dei maestri italiani) e illustro la mia relazione su Big Data
e Reti Neurali Artificiali come nuovo paradigma della ricerca sociale. Brisbane
è una città moderna, senza una grande storia alle spalle: va ricordato che
stiamo parlando del nuovissimo continente, e tanto per essere chiari qui diventa
sito turistico uno dei primissimi edifici della città, al porto, oggi un
ristorante. Stiamo parlando di una costruzione del 1900 circa. Nei dintorni
della città un bellissimo, enorme parco dove vengono curati e allevati alcuni
degli animali più caratteristici dell’Australia; al Daisy Hill Koala Center
l’incontro con numerosi Koala appollaiati su alberi e con altrettanti wallabies,
canguri di stazza medio-piccola. Finito il convegno, è ora di volare ancora più
a Nord, verso quella barriera corallina che è certamente una delle meraviglie
naturali del mondo. Si dice che due siano le cose dallo spazio che si vedono
sulla terra a grandissima distanza: la muraglia cinese e la barriera corallina
australiana. Non so se sia vero, non sono mai andato nello spazio. Ma le ho
viste da vicino entrambe. Un volo ci porta a Cairns, cittadina sulla costa poco
sotto Cape Tribulation (?!) che sarà la base dei prossimi spostamenti
australiani. Uno per visitare appunto la grande barriera, il reef (“barriera
corallina”, ndr), uno spettacolo che merita da solo il lungo viaggio in aereo. E
poi un percorso in treno verso l’interno, un treno panoramico che sale fra gole
e montagne nella zona della foresta pluviale fino a Kuranda, un antico paese
abitato prevalentemente da nativi. Qui abbiamo finalmente l’occasione per
parlare di questa meravigliosa cultura locale, di osservare la grande abilità
delle donne nella realizzazione di opere d’arte bellissime, e di toccare con
mano il didgeridoo, lo strumento tipico dei nativi australiani, ad ancia
labiale, uno dei primi aerofoni: è Djalu il nostro interlocutore che ci spiega
il significato dello strumento e del suono nella sua cultura di nativo
australiano, prima di esibirsi in un mini-concerto. I nativi australiani hanno
subito molti torti allorché la civilizzazione è arrivata sull’isola-continente.
Oggi il rapporto con i nuovi australiani è abbastanza tranquillo: pochi nativi
vivono nelle periferie delle grandi città (e quasi sempre in condizione di
emarginazione), mentre quello che resta della popolazione originaria continua a
vivere nelle zone interne dell’Australia. Lì, simbolicamente quasi al centro,
immersa nel “bush” (nella “boscaglia”, ndr) si erge Uluru, nota anche come Ayers
Rock, la montagna sacra per i nativi. Un territorio che il Governo australiano
ha formalmente riconsegnato agli aborigeni solo nel 1985. E dal 1998, il 26
Maggio in Australia si festeggia il “Sorry Day”, il giorno in cui tutta una
nazione chiede scusa ai nativi per i maltrattamenti subiti. Ecco, sia pure con
grande ritardo, un atto di grande civiltà che tende all’integrazione e al
recupero di culture tradizionali e valori autentici. Una lezione che arriva da
un grande, lontanissimo, Paese.
·
Quei razzisti come
i Sudafricani.
Carlo Nicolato per "Libero Quotidiano" il 12 giugno 2020.
«Sappiamo dal Sudafrica che abbattere le statue non è un proiettile d'argento,
ma è un inizio» titolava un paio di giorni fa il Guardian intendendo per
"proiettile d'argento" ("silver bullet") una soluzione facile a un problema
difficile. Il Sudafrica dunque per il prestigioso giornale inglese di sinistra è
l'esempio e non potrebbe essere altrimenti visto che è stato l'ultimo Paese a
conoscere la segregazione razziale e sistematica dei neri, l'apartheid per
l'appunto. Il problema però è che in Sudafrica il razzismo non si è concluso con
la fine dell'apartheid né con l'abbattimento delle statue di Cecil Rhodes. In
Sudafrica il razzismo non si è mai concluso, si è semplicemente ribaltato con i
bianchi che sono diventati perlopiù vittime e i loro carnefici i neri, la cui
rabbia si è rivolta anche contro altri neri ma di diversa nazionalità, ovvero
gli immigrati. Qualcuno potrebbe anche suggerire che in fin dei conti hanno
anche le loro buone ragioni, ma dovremmo piuttosto essere d'accordo tutti che il
razzismo non ha mai una buona ragione, né tantomeno una giustificazione. La
storia e i tribunali avrebbero dovuto aver già fatto giustizia, ma non è
bastato. «Uccideremo tutti i bianchi insieme ai loro figli, le loro donne, i
loro cani, i loro gatti e tutto ciò che troveremo sulla nostra strada» è lo
slogan (dal 2018) enunciato in un discorso parlamentare il deputato Andile
Mngxitama, leader del BLF, quel partito che già solo con il nome chiarisce in
tre parole quale sia il semplice programma da mettere in atto nel Paese: "Black
first, land first". Ovvero espropriazione delle terre dei bianchi senza
indennizzo, principio che mette insieme razzismo nero di stampo vendicativo con
alcune confuse basi del marxismo-leninismo di cui Mngxitama e i suoi sono
convinti seguaci. L'impianto rimane lo stesso solo che al posto dei proletari ci
sono i neri e al posto dei capitalisti i bianchi. Mentre la lotta di classe è
stata sostituita dalla lotta per la supremazia razziale. «Per ogni africano
ucciso uccideremo cinque bianchi» aggiunse Mngxitama nello stesso discorso che
in realtà prendeva spunto essenzialmente da motivazioni di carattere molto
pratico, ovvero dalle proteste dei conducenti di minibus africani che lamentano
la concorrenza delle grosse aziende di trasporto pubblico possedute da bianchi.
Ma se credete che quelle di Mngxitama siano solo le farneticazioni di un pazzo
vi sbagliate, il clima in Sudafrica se non è quello ci si avvicina molto e lo
dimostrano i puntuali assalti alle fattorie di bianchi in qualche caso uccisi e
in diversi altri costretti a fare le valige e a emigrare all'estero. Violenze
tra africani E questa è solo una faccia della medaglia, perché l'altra è
occupata dai linciaggi le cui vittime sono altri neri provenienti dai Paesi
vicini o del nord. Ricordate i Mondiali del 2008? In quell'anno di grandi
festeggiamenti si contarono 67 africani morti vittime di linciaggi la cui sola
colpa era quella di non essere sudafricani. Veri e propri pogrom che da quell'anno
non sono mai terminati, in particolare a Johannesburg e Pretoria dove continuano
a contarsi a decine i morti. No, abbattere le statue non è mai un "silver bullet",
e nemmeno un inizio. Chiedetelo ai sudafricani.



 Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge.
Denuncio al mondo ed ai posteri con
i miei libri
tutte le illegalità tacitate ed impunite compiute dai poteri forti (tutte le
mafie). Lo faccio con professionalità, senza pregiudizi od ideologie. Per non
essere tacciato di mitomania, pazzia, calunnia, diffamazione, partigianeria, o
di scrivere Fake News, riporto, in contraddittorio, la Cronaca e la faccio
diventare storia. Quella Storia che nessun editore vuol pubblicare. Quelli
editori che ormai nessuno più legge. PRESENTAZIONE SU
PRESENTAZIONE SU

 Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta)
Via Piave, 127, 74020 Avetrana (Ta) 3289163996
3289163996

 FACEBOOK:
(personale)
FACEBOOK:
(personale)
 WEB TV:
WEB TV:
 NEWS:
NEWS: